La violenza nel cinema e nei mass-media
[Il saggio di Haneke apre il libro La violenza allo specchio. Passione e sacrificio nel cinema contemporaneo, Transeuropa edizioni]
di Michael Haneke
Le discussioni sul tema della violenza nei mass-media hanno generalmente come obiettivo l’individuazione di un responsabile, di un capro espiatorio. A seconda dei diversi punti di vista, i mezzi di comunicazione di massa o sono considerati semplicemente “lo specchio oggettivo della società” – e per tanto non fanno altro che riflettere la sua realtà -, oppure la violenza da essi costantemente rappresenta diventa inevitabilmente la diretta responsabile dell’aumento della violenza che riscontriamo nella società e nella nostra vita quotidiana. Volendo per forza isolare un responsabile, viene spontaneo domandarsi se nasca «prima l’uovo o la gallina», e il fatto che la domanda non abbia una risposta univoca giustifica di fatto entrambe le posizioni, ognuna delle quali può considerasi corretta.
Ma forse è proprio la domanda a non essere formulata in maniera adeguata. Coloro che criticano i mass-media dovrebbero forse richiedere la censura delle immagini più efferate che intossicano il piccolo e grande schermo? Chi cura la programmazione dei palinsesti televisivi o delle sale cinematografiche dovrebbe forse lasciare ai tabloid e ai loro titoli sensazionalistici le brutalità della vita quotidiana, sulla base dell’assunzione che le immagini e gli slogan della carta stampata incoraggerebbero la violenza molto meno delle immagini dello schermo televisivo?
In realtà una riflessione sulla necessità o meno di rappresentare la violenza attraverso i mass-media è malposta e già scavalcata dai fatti, visto che l’informazione è ormai unanimemente considerata un bene di consumo e pertanto il problema non può venire discusso in questi termini. Penso che abbia più senso quindi discutere delle forme di questa rappresentazione, dal momento che il problema non si pone sulle sue istituzioni- perché difficilmente è possibile ricondurre la responsabilità direttamente a un individuo – ma si rivolge nondimeno direttamente e con rigore a una persona: il produttore, il giornalista, lo scrittore, il regista e, infine, ma non da ultimo, il pubblico.
Possiamo dire che fin dall’origine la rappresentazione della violenza fa parte della storia del cinema, ed è addirittura parte della sua natura. I film western, i legal thriller, i film di guerra, di avventura e dell’orrore sono tutti generi definiti in base al modo in cui rappresentano la violenza, e la parola “Azione!” che dà inizio alla ripresa di ogni scena, e che nella mente dello spettatore viene automaticamente associata alla parola “film”, è considerata ormai sinonimo di spettacolo violento.
Il film è una forma intensa di comunicazione che stimola di concerto vista e udito: la dimensione delle immagini, i nostri tempi di reazione determinati dal ritmo del film, la capacità di riprodurre quasi fedelmente la realtà o una realtà immaginaria e la capacità dell’opera cinematografica di farci sperimentare realtà attraverso i sensi, fa sì che il cinema non sia comparabile a nessun’altra forma di rappresentazione – e il carattere dominantedi questo mezzo di comunicazione non lascia allo spettatore lo spazio per riflettere sulle convenzioni in atto nell’opera.
Contrariamente all’opera letteraria e a quella artistica, la rappresentazione filmica di eventi in sé violenti, alla luce di una implicita responsabilità morale, si muove su un terreno difficile. L’opera cinematografica viene valutata in base a criteri diversi da quelli usati per le opere statiche, sia da chi la guarda che da chi la produce. L’immagine statica rappresenta il risultatodi un’azione, mentre il film rappresenta l’azione in sé. In genere un quadro instaura una relazione di solidarietà fra lo spettatore e la vittima, mentre di solito chiguardail film si trova a guardarlo dal punto di vista di chi perpetrala violenza. Ogni volta che vediamo Guernica di Pablo Picasso, per esempio, vediamo il dolore delle vittime che si ripete in eterno; il tempo di osservazione ci permette di solidarizzare con le vittime senza scontrarci con blocchi morali. La mancanza di movimento permette allo spettatore di dare tempo e spazio alla contemplazione del soggetto rappresentato accrescendo la propria consapevolezza. Nel massacro di Apocalypse Nowdi Francis Ford Coppola, al contrario, noi ci troviamo con i soldati americani a bordo degli elicotteri e, mentre la Cavalcata delle Valchirie in sottofondo, assieme a loro spariamo ai presunti Vietcong che scappano terrorizzati in cerca di un riparo, e il tutto senza dover fare i conti con la nostra coscienza, perché – almeno nel momento dell’azione – non ci rendiamo conto del nostro ruolo pseudo-attivo.
È a questa complicità spogliata di ogni senso di colpa che dobbiamo la crescente presenza della violenza nei film. La vicarietà dell’azione dello spettatore allontana la paura insita nella realtà, come la narrazione mitica e l’esteticizzazione dell’opera d’arte ci permettono di dare piena libertà alle nostre paure e ai nostri desideri pur lasciandoci al sicuro. L’eroe sullo schermo trascende con successo la disperazione e l’impotenza dell’osservatore.
Il produttore che tratta il film come un bene di consumo e come tale lo produce, sa che solo la violenza vende, ma che vende ancora meglio quando è privata della realtà o quando sono comunque assenti gli elementi essenziali che la costituiscono: la paura della sofferenza e del dolore, che in noi hanno ovviamente radici profonde. Se escludiamo il caso del voyeur patologico, questi elementi restano inconsumabili o, come dire, “rovinano il prodotto”.
È stato sviluppato un intero vocabolario critico e teorico per parlare di come la realtà venga eliminata dai generi cinematografici che inscenano la violenza. Anche se non è il caso di approfondire nel dettaglio l’argomento in questa sede, credo che, a grandi linee, si possano fare tre ipotesi drammaturgiche a riguardo, dove almeno una di esse deve sussistere perché si possa mostrare la violenza al pubblico:
§ operando una dissociazione fra la situazione da cui scaturisce la violenza e il campo d’azione con cui lo spettatore s’identifica (film western, di fantascienza, dell’orrore…);
§ oppure, sviluppando una situazione che mette in crisi stile di vita dello spettatore, e al contempo inserendo delle minacce che gli facciano approvare una reazione violenta sentita come liberatoria, positiva, come unica soluzione possibile (così nei film di guerra, nei polizieschi o, si pensi a classici americani come Il giustiziere della notte Michael Winner,o Un giorno di ordinaria follia Joel Schumacher);
§ o ancora inserendo l’azione in un contesto di satira, di parodia o di humour (dalla comicità fisica dei primi film muti fino alle scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill, dagli “spaghetti western” passando per le parodie dei film di guerra fino a Comma 22di Mike Nichols e al cinismo postmoderno di Pulp Fictiondi Quentin Tarantino).
Ognuna di queste ipotesi ha poi sviluppato una propria forma del genere e il produttore, l’autore e il regista hanno il compito di rispettare con precisione le particolarità formali del genere che hanno prescelto. Mescolare i generi, come alcuni film europei e alcuni film americani cosiddetti “indipendenti” hanno provato a fare, può risultare artisticamente stimolante, ma comporta di solito una caduta d’interesse da parte del pubblico.
Come già osservato, parlare di violenza nei mass-media presuppone poi un rischio, in particolar modo il rischio della potenziale connessione causale fra la violenza sociale rappresentata e la violenza che realmente esiste nella nostra società.
Il criterio che abbiamo appena individuato, e che ha mantenuto la sua validità sin dagli albori del cinema, ha a che fare con questa interazione solo indirettamente. L’omicidio e la morte, le atrocità della guerra e lo spargimento di sangue sono da sempre parte naturale dell’opera cinematografica, molto prima che le sue conseguenze pericolose si mostrassero con l’intensità raggiunta oggi.
Allora cos’è cambiato?
C’è stato forse un salto di qualitàdell’orrore grazie alle potenzialità dei nuovi mezzi tecnici, dovuta a un enorme incremento nella quantità, e soltanto ora, e troppo tardi, coloro che sono responsabili della creazione di queste immagini stanno aprendo gli occhi?
O la somiglianza delle forme di questa rappresentazione – attraverso le quali la violenza vera e quella falsa sono oggi rappresentate sullo schermo – ha influenzato la nostra percezione e soprattutto il nostro sentire a tal punto che siamo ormai incapaci di distinguerne il contenuto? I cadaveri di Grozny e di Sarajevo hanno lo stesso valore delle vittime di Terminator? La differenza fra Guerre stellari di George Lucas e la guerra vista al telegiornale (ad esempio le immagini della guerra lampo in Kuwait) è solo l’ora in cui sono messe in onda? Com’è possibile riuscire a mescolare le due cose? Come si può accettare questa assenza di distinzione?
Fino a qualche anno fa chiunque con un minimo di cervello era in grado di farlo. Non mi soffermerò in questa sede sulla capacità dei bambini – che al giorno d’oggi nei paesi industrializzati fanno esperienza del mondo attraverso lo schermo della televisione o del cinema – di sviluppare la capacità di distinguere fra finzione e realtà, piuttosto mi chiedo in senso generale a cosa si debba questa incapacità di differenziazione.
Come tutti sappiamo, il cinema ha da poco compiuto i suoi primi cent’anni. Per la maggior parte di questo tempo il cinema è stato il sovrano incontrastato delle immagini in movimento e ha al contempo tentato di costruirsi una grammatica che gli permettesse di interpretare le forme narrative, del tutto inedite, da lui stesso create. Due dispositivi, la macchina da presa e il nastro magnetico, gli hanno permesso di riprodurre e simulare un’impressione quasi completa della realtà. I resoconti storici dell’incredibile impatto sul pubblico avuti dai nuovi media sono conosciuti, a partire dal panico scatenatosi fra il pubblico alla prima parigina di L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat(1896) dei fratelli Lumière fino alle reazioni terrorizzate delle popolazioni indigene della foresta amazzonica mezzo secolo più tardi alle prime proiezioni cinematografiche cui assistevano.
Non è ovviamente mia intenzione di proporre un’analisi sociologica, né una dettagliata analisi dei mass-media, ma piuttosto di pormi dal punto di vista del produttore, come un rappresentante – almeno nel contesto di questo discorso – di questo genere artistico. Qui la parola arte mi affiora sulle labbra con difficoltà, e alla luce di quanto ho appena detto, mi sarebbe difficile gestire una tale definizione. Che cosa possiamo dire di un genere artistico che, pur essendo il più giovane e quindi si presume ancor pieno di speranze, entrato nei ranghi cent’anni fa, oggi già si spaventa, anche se con le migliori intenzioni, della propria mutazione? Si merita ancora questo nome, e se sì, quale sarebbe il suo compito?
Dunque se non vogliamo degradare ogni spiegazione a cinica ipocrisia, bisogna trovare delle forme espressive adeguate, in virtù di un obbligo verso l’umanità di cui soprattutto i mass-media parlano senza troppo riguardo. E mi spingerei a parlare di ARTE nel caso dei mass-media, solo quando vi sia contenuto quell’atto di autoriflessione immanente dell’opera che in tutte le altre forme dell’arte moderna è da tempo diventato conditio sine qua non. Le innovazioni tecniche apportate al medium tecnologico hanno cambiato il mondo, e già da tempo e su ampia scala hanno posto fine alla comprensione della realtà come era intesa e percepita nel diciannovesimo secolo: è ora che chi decide quali programmi mandare in onda registri questo cambiamento e si adegui al suo contenuto.

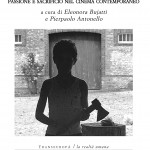

Storia antica quella di accusare il cinema di spingere alla violenza, Arancia meccanica è solo il caso più famoso.
Ne ho parlato giusto l’altro giorno qui: http://www.soloparolesparse.com/2009/07/il-cinema-influenza-gli-spettatori/
[…] approfondire consulta la fonte: La violenza nel cinema e nei mass-media posted under Documentari, Film, Rai, Sky, […]
haneke è uno dei pochissimi registi che colpisce fino in fondo, che va all’osso delle cose.