Overbooking: Gennaro Pollaro

Nel labirinto del quotidiano
di
Luigi Toni
“Non esiste una relazione di causa ed effetto tra gli avvenimenti della mia vita. Semplicemente cadono su di me come pietre”.
(Frank Kafka, Diari)
Café Panthéon (Fallone Editore, collana Gli Specchi Mercuriali) Café Panthéon, esordio narrativo di Gennaro Pollaro, si colloca in una zona d’ombra della narrativa italiana contemporanea, quella che si ostina a interrogare il reale attraverso le sue deformazioni, i suoi cortocircuiti, le sue implosioni. In questo territorio liminale, appare come una voce sorprendentemente lucida su una società contemporanea dominata dall’assoluta atomizzazione dell’individuo.
Napoletano trapiantato a Parigi, ingegnere per formazione, animatore di atelier di scrittura, l’autore ha attraversato linguaggi tecnici per approdare alla letteratura portandosi dietro un’attitudine alla precisione, al delirio del particolare, oltre che alla costruzione e all’architettura del significato. E proprio come un ingegnere che studia le tensioni dei materiali, sottopone la lingua italiana a torsioni, pressioni, scarti sintattici che la rendono insieme familiare e perturbante.
Nove racconti che esplorano l’immobilità contemporanea e la “credenza fideista in divinità effimere”, recita la quarta di copertina. Svelare il mondo non libera affatto, anzi: alimenta un’angoscia ancora più profonda. È in questo spazio claustrofobico, in un’immobilità che si trasforma in vertigine, che si muovono i personaggi dei racconti.
Fin dal racconto d’apertura, Moscerini, il lettore è gettato in un universo in cui le coordinate abituali del realismo vengono sovvertite attraverso una metamorfosi che evoca Kafka ma che si risolve in una direzione radicalmente diversa. Non c’è qui l’angoscia metafisica quanto piuttosto il divenire-animale come unica possibilità di linguaggio. L’avvenuta trasformazione diventa una paradossale liberazione: “Eravamo quattro insetti che, con l’alcol che scorreva nelle vene, stavano inventando una nuova lingua”. È in questo slittamento – dalla parola umana al ronzio degli insetti, dalla comunicazione alla pura vibrazione sonora – che troviamo il nucleo tematico della raccolta. Si ha costantemente la sensazione di un’assenza d’aria, come se il linguaggio non fosse più capace di reggere il peso dell’esistenza. I personaggi cercano disperatamente di afferrare il senso delle cose ripetendosi ossessivamente “causa-conseguenza, causa-conseguenza, causa-conseguenza”, salvo scoprire che “tutto è in disordine e questo ci dà soddisfazione”. È l’assurdo quotidiano che diventa l’unica dimensione possibile, il microscopico che si dilata fino a diventare mondo.
“Quello che vorrei è che tutto, punto per punto, avesse un senso”, confessa il protagonista di Oltre la finestra, ma questa aspirazione alla coerenza, all’ordine, alla comprensibilità è destinata a restare sistematicamente frustrata. I personaggi dei racconti si muovono su superfici scivolose, cercando appigli che non reggono, abitando spazi che si deformano sotto i loro piedi. Sono figure della precarietà ontologica, dell’essere sempre sul punto di cadere, precipitare o dissolversi. “Il mio peso sei tu”, dice Francesca al compagno in uno dei passaggi più toccanti del libro, svelando come l’identità stessa sia sempre appoggiata sull’altro, mai autonoma, mai solida.
Il perturbante irrompe senza preavviso in situazioni apparentemente banali. Nel racconto Il vicinato, tutto inizia come una semplice curiosità verso una vicina di casa ma si trasforma presto in ossessione voyeuristica e, infine, in tragedia. Il protagonista confessa: “Volevo capire perché si fa così fatica ad avvicinarsi agli altri senza precipitare in relazioni artificiali”. La risposta che trova è terribile: non si può. Esiste un confine invisibile tra noi e gli altri, un muro trasparente ma invalicabile. Tutto quello che ci resta da fare è spiare. Ma questa intrusione non porta conoscenza, solo un’escalation di violenza che culmina in un atto autodistruttivo.
La lingua stessa qui non è strumento di comunicazione ma una sorta di ostacolo, una superficie opaca. “La lingua è un mezzo”, recita lapidariamente una delle “governanti” di Obelius, il racconto più borgesiano della raccolta. In questo labirinto claustrofobico, il protagonista si scopre prigioniero di una struttura che lui stesso ha costruito. È la rivelazione vertiginosa dell’autoreclusione, del fatto che le gabbie più impenetrabili sono quelle che ci si fabbrica da soli attraverso il linguaggio, le abitudini, le paure. Qui emerge con maggiore forza il tema dell’oblio. Non c’é salvezza, non c’è memoria che tenga, non c’è identità che resista al tempo. Siamo tutti, sempre, già morti e già rinati, stranieri a noi stessi, assassini e vittime di questo continuo dissolversi.
È questi senso di gratuità assoluta dell’esistenza, di mancanza di fondamento, che permea tutti i racconti. Le cose accadono senza ragione, i personaggi agiscono senza scopo, le storie si interrompono senza risoluzione. È un universo ballardiano per certi versi, ma qui il distopico è già presente, incorporato nel quotidiano, nelle relazioni fallite, nei gesti incompresi, nelle parole che non riescono mai a raggiungere l’altro.
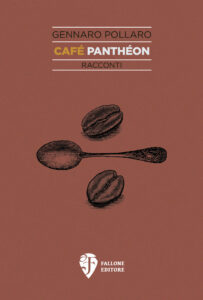
In Cono o coppetta, la gelosia paranoica del protagonista trasforma ogni dettaglio insignificante (il sorriso del gelataio, i quarantasette secondi impiegati dalla moglie per trovare il gatto) in una serie di indizi di un ipotetico tradimento. Ma più che una storia di infedeltà coniugale, il racconto è l’esplorazione di una mente che non riesce più a distinguere il reale dall’immaginario, che proietta sul mondo le proprie ossessioni fino a contemplare l’omicidio. “Lo spazio definisce il tutto”, pensa il protagonista mentre segue in taxi il presunto amante. È una frase chiave: non esiste interiorità separata dall’esteriorità, non c’e psicologia individuale slegata dalla topografia dei luoghi. I suoi personaggi sono letteralmente plasmati dagli spazi che abitano, schiacciati da essi.
La frammentazione qui sembra procedere organicamente dalla materia stessa dei racconti, dalla difficoltà dei personaggi di tenere insieme i pezzi della propria esperienza. La sintassi si spezza, le metafore si accumulano in modo apparentemente casuale, il tempo narrativo si dilata e si contrae senza logica evidente.
Il racconto che dà il titolo alla raccolta, Café Panthéon, è una summa delle ossessioni dello scrittore. Ambientato in un bar parigino, vede un protagonista leggere una serie di lettere assurde firmate da improbabili “ministri” che comunicano attraverso un linguaggio burocratico-poetico completamente svuotato di senso. È una satira feroce della retorica del potere, ma anche una riflessione metaletteraria sulla crisi del linguaggio, sull’impossibilità di comunicare in un mondo in cui le parole hanno perso ogni riferimento alla realtà. Eppure, in mezzo a questa dissoluzione, c’e un gesto di resistenza: il protagonista riga il tavolo del bar con una chiave, incide la sua firma. È un atto di vandalismo ma anche di affermazione: io esisto, io sono stato qui, lascio un segno. Per quanto precario, per quanto destinato all’oblio, questo segno testimonia di una presenza, di un tentativo disperato di opporsi alla sparizione.
Forse è proprio in questo gesto che si nasconde la chiave di lettura dell’intera raccolta. Tutti i personaggi cercano di lasciare un segno, di afferrare qualcosa, di vedere oltre. “Oltre la finestra” diventa metafora di questa aspirazione impossibile: guardare oltre quella finestra, sfondare il vetro che non permette di vedere o di respirare, andare oltre, vedere oltre.
Ma il vetro non si rompe mai davvero. Resta sempre una barriera trasparente, un limite invisibile ma invalicabile. I personaggi possono solo premere il viso contro di esso, cercare di intravedere qualcosa, spiare la vita degli altri senza mai potervi accedere davvero. È una condizione tragica ma anche, paradossalmente, l’unica che renda sopportabile l’esistenza. Perché, se davvero il vetro si rompesse, se il confine cadesse, cosa resterebbe? Il vuoto assoluto, forse.
L’autore ci costringe a guardare oltre la finestra, a cercare di sfondare il vetro, anche sapendo che forse non ci riusciremo mai. Ma il tentativo stesso, ci dice, è tutto quello che abbiamo. Ed è, forse, già abbastanza.

