Musica a Delfi senza redenzione
di Elio Matassi
In una lunga ed argomentata lettera, datata 28 aprile 1952, Adorno scrive a Thomas Mann per tentare di sollevarlo dalle difficoltà del “Krull”. Tali difficoltà – Adorno prova a capovolgere l’argomentazione – in fondo sono il contrassegno di una concezione “feconda”, dal momento che un’opera d’arte penetra davvero a fondo nel proprio materiale solo nel momento in cui si fa carico delle sue “contraddizioni”. Oggi – recita Adorno – tale consapevolezza deve essere diversa e tener conto di quel “senso di frammentarietà” che sconvolge la compiutezza della forma drammatica e sinfonica. A risultare dominante è il concetto di epicità “allargata”, “frammentata”: “E’ forse diverso, e qui estendo il concetto di epicità molto al di là del genere assunto in senso letterale, nel ‘Meister’, nel ‘Faust’, nel ‘Ring’. Non si può rimanere prigionieri di formule puramente ‘nominalistiche’; la presunta ‘frammentarietà’ lungi dall’essere un limite è, invece, il pregio del romanzo novecentesco, un pregio che si fonda proprio su una contaminazione esplicita con la musica”. Il terrorismo di una presunta “unità stilistica” non potrà resistere al processo dissolutivo innestato da una autentica concezione artistica come auspicava, per esempio, un musicista dallo spessore di Schönberg. Del resto, tutto il “Mahler” adorniano è costruito su questa analogia col romanzo; dalla “musica” al “romanzo”, ma anche, in maniera biunivoca, “dal” romanzo “alla” musica, senza ovviamente commettere l’ingenuità di fraintendere l’idea di narratività musicale. Una simile suggestione è stata certamente introiettata e metabolizzata da Sandro Dell’Orco nella strutturazione complessiva del suo ultimo romanzo, “Delfi”, pubblicato dalla raffinata casa editrice Hacca (Halley Editrice, Matelica – Mc -, 2007, 372 pp, 13,50 euro). La sequenza narrativa prevede, infatti, una prima parte (Uno) (pp. 13-24) ed un’altra (Due) (pp. 27-372) e non la partizione, secondo la consueta legge della successione seriale, in capitoli. Sandro Dell’Orco si è impadronito genialmente della tipica struttura musicale: un proemio-preludio, ouverture, densissimo in cui si racchiude il mistero-segreto di tutto il romanzo e le variazioni, concepite come cerchi concentrici che progressivamente si allargano da quell’unità-cellula originaria. Per attenersi all’analogia, stabilita da Adorno, con il “Ring” wagneriano, si può affermare che tutto ciò che “accade” è affidato all’incipit e la “semantica della predestinazione” è tutta assolta dalla musica. Se nelle parole del testo, messe sulle labbra dei personaggi, sobbalza talora l’illusoria speranza che il destino possa essere eluso (così Brünhilde risoluta a far vincere Siegmund nel duello contro Hunding, o Siegfrid stesso in “Götterdämmerungen” poco prima di essere trafitto dalla lancia di Hagen), la musica si assume il compito di annientare ogni illusione e di scandire, mediante l’evidenza anticipatrice dei “Motive” e del loro intreccio eloquente e sinistro, il corso immutabile del Fato. Ma le analogie tra il romanzo di Dell’Orco, “Delfi” e la musica non si arrestano certamente qui. L’unico riferimento “colto” del romanzo, in cui ad un certo punto si parla del “Felix Krull” di Thomas Mann e della predilezione da parte di Tommaso Partenis per “Morte a Venezia”, mentre la lettura de “La montagna incantata” è approdata ad una noia assoluta (p. 109), non può in alcun modo essere considerato casuale. Come non ricordare l’“infortunio” in cui cade Thomas Mann quando all’inizio dell’ultimo capitolo de “La montagna incantata” arriva a postulare che la narrazione, rispetto alla musica, dovrebbe godere di un primato: mentre il piano temporale (della musica) sarebbe scandito esclusivamente dalla irreversibilità della successione (il tempo “musico-reale”), quello della narrazione contemplerebbe “un’ulteriore opzione”, il tempo immaginario non necessariamente coincidente con il primo. Ho usato il “condizionale” perché quest’analisi di Thomas Mann (il “narratore” de “La montagna incantata”) non è convincente in quanto restringe banalmente il tempo della musica alla convivenza con il destino dell’irreversibilità, una tesi spesso messa radicalmente in discussione, penso in particolare alla “Fiaba del santo ignudo”, narrata da Wackenroder, ed alla sua riscrittura contemporanea nel suggestivo romanzo di José Saramago, “Le intermittenze della morte”. Plausibilmente uno dei personaggi di Sandro Dell’Orco ricusa “La montagna incantata” forse proprio in ragione di tale fuorviante restrizione dello spazio della musica e approva “Morte a Venezia” perché, di contro, ne esalta il ruolo (come non pensare all’utilizzazione spregiudicata della V di Mahler da parte di Luchino Visconti nella trasposizione cinematografica che darà luogo ad un vero e proprio “culto” mahleriano). Ed ancora altro dato non “occasionale”: il nome di una delle protagoniste del romanzo, “Castalia”, che rinvia necessariamente al grande romanzo di Hermann Hesse, il “Giuoco delle perle di vetro”, dove viene immaginato un piccolo stato interamente spirituale, Castalia, appunto, (paese di castità). Una parte dei giovani vi coltiva la musica, l’astronomia, la matematica, rinunciando al matrimonio e ad ogni guadagno: gli stranieri vi possono abitare per poi ritornare di nuovo nel mondo; lo stesso ‘giuoco’ di cui si parla nella titolazione del romanzo esprime la ricerca di un linguaggio universale anche se segreto che sottolinei, mediante un’algebra simbolica, la qualità distillata delle arti (in particolare della musica) e delle scienze, come nei sogni di Novalis. La musica, dunque, come quintessenza strutturale del romanzo di Sandro Dell’Orco. Non solo, il ruolo della musica, quello che ho definito prima, a proposito di Wagner, “semantica della predestinazione”, interviene direttamente nel tessuto connettivo dello stesso romanzo e della sua dialettica. Il cedimento progressivo di Egon Hereafter, il protagonista, alla società del Controllo, un cedimento che comincia “dal di dentro”, poco a poco, come la Cura goethiana, l’unica delle quattro donne grigie che osi sfidare Faust nel suo Palazzo reale (“Faust”, parte seconda, V atto), non comporta redenzione alcuna. Questa graduale rinuncia alla propria identità, quest’andare volontariamente incontro alla spersonalizzazione non può essere arrestato neppure dall’arte né tanto meno dalla musica, la nemica per eccellenza del destino, secondo la formula adorniana. Quel “totalitarismo diffuso” che convive con la nostra identità più profonda – l’effrazione iniziale del Controllo, l’incipit del romanzo, da addebitarsi forse allo stesso protagonista, Egon Hereafter, diventa solo un “accidente” da rimuovere al più presto – risulta alla fine vincente, ingoiando dentro di sé tutto e tutti e dando la netta impressione che non sopravvivranno neppure le custodi, le figlie del Reno, Woglinde, Wellggunde e Flosshilde, neppure loro che sono il principio, la fine e forse di nuovo il principio di tutte le cose: “Il sogno improvvisamente svanì, ed Egon benché cosciente, si ritrovò nel nulla. Non riusciva a trovare altre parole per quello che provava. Sentiva di non esistere più, ma di non essere ancora morto” (p. 372). Il cerchio che progressivamente si stringe, raggiungendo ogni volta un equilibrio più basso, ha trovato il suo punto zero, la sua curvatura definitiva.
(Pubblicato su Avanti! il 6.06.2007)

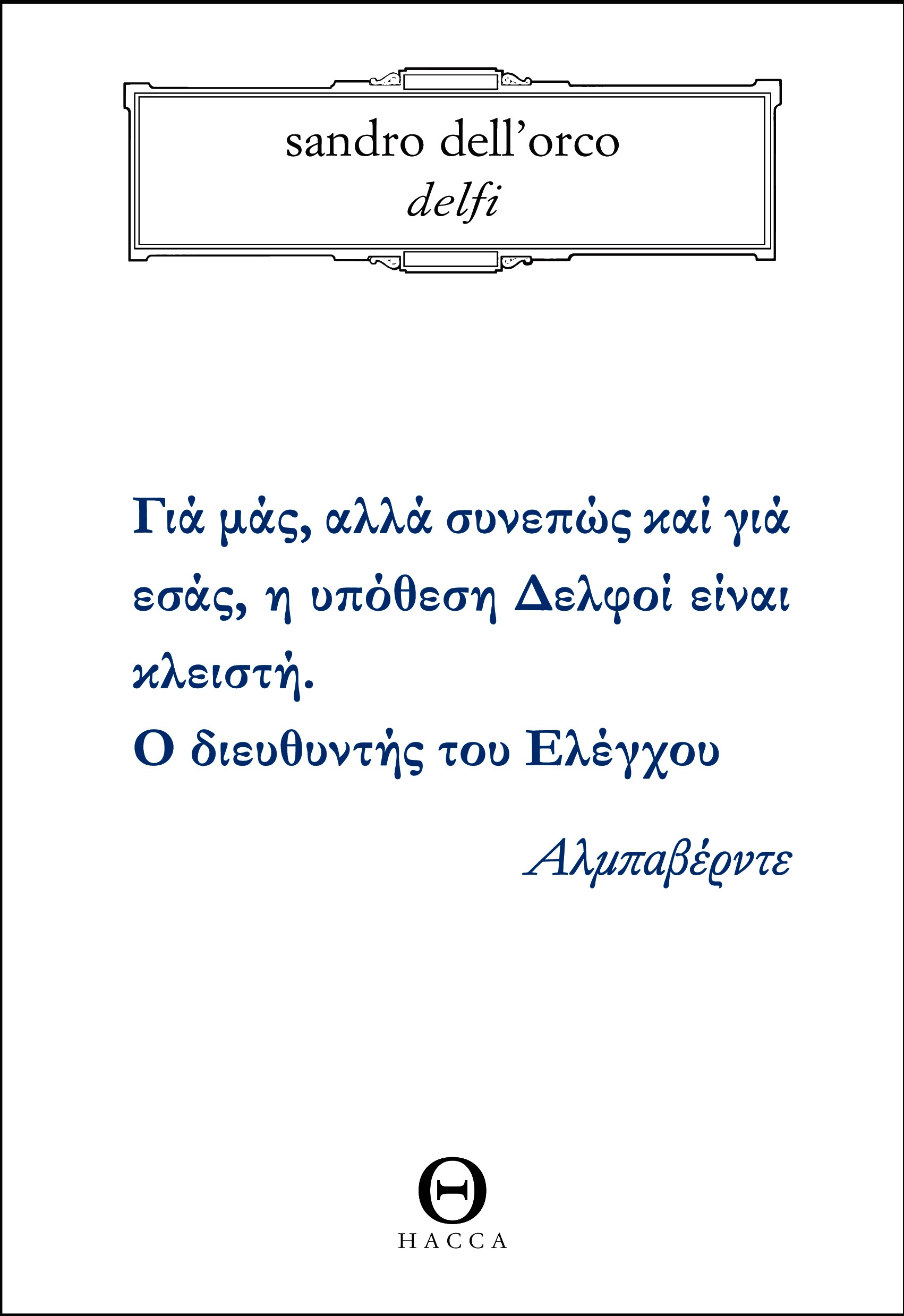

Thomas Mann e Hermann Hesse hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora lo spirito tedesco, quello più realistico ma non per questo lontano da fondamentali tarde tracce di romanticismo spirituale. E’ pure presente un idealismo impossibile, come è disegnato ottimamente nella soluzione finale de “Il giuoco delle perle di vetro” di Hermann Hesse, che vede il protagonista morire annegato, forse a causa d’un malore (esistenziale, dello spirito). In Thomas Mann c’è uno spirito blandamente wagneriano, però lontano dalle strutture nicciane; in Hesse no, se non nel primo Hermann, il giovane ragazzo che minacciava il suicidio e che chiedeva soldi al padre almeno per comprare una rivoltella; dopo, Hesse ha abbracciato diversi filoni spirituali, il cui acme è nel già citato “Il giuoco delle perle di vetro”, che vede una Castalia perfetta, di sogno, ma dominata dalla presenza di personaggi i cui conflitti interiori sono forti e perlopiù irrisolti. In questa Castalia proiettata in un futuro non ben delineato, abbiamo un ordine monastico, solo all’apparenza perfetto, e che è sintesi di tutto lo scibile umano. Una società utopistica, dove la musica si lega ai principi dell’eleganza matematica.
Mi accorgo solo ora – e il commento di Iannozzi lo dimostra – che la dotta e bella recensione di Elio Matassi (docente di Filosofia morale ed Estetica musicale all’Università Roma 3), proprio per la complessità e la ricchezza dei suoi riferimenti culturali, rischia di essere autoreferenziale, nel senso che il mio romanzo Delfi, invece di esserne illuminato ne risulta un po’ oscurato, specie per quanto attiene alla trama, ai personaggi e allo stile. Ciò è dovuto al fatto che il recensore ha voluto concentrare tutta la sua attenzione sulla “caratteristica struttura narrativa del romanzo” (come dice il sottotitolo della recensione originale) trascurando tutto il resto. Mi si impone dunque un intervento che renda in qualche modo comprensibile ciò di cui “parla” Delfi. Lo farò riportando un’altra recensione: quella di Anna Mattei su Libri e riviste d’Italia. Eccola.
La trama di Delfi si sviluppa e si perde nei labirinti di una misteriosa cittadina greca fino a sembrare quella di un giallo incompiuto. Invece è una sorta di parabola che narra la perenne inchiesta in cui si perde la ragione quando presume di venire a capo dell’insensatezza del vivere.
Il caso in questione è quello di un uomo e di una donna, i quali, sfuggendo al Controllo che sorveglia l’area del tempio e dell’intero territorio ad esso circostante, penetrano indisturbati nei sacri sotterranei dove lasciano visibili tracce di un loro fugace e intenso rapporto sessuale. Il Controllo è un complesso sistema trasversale di complicità e servitù che chiude tutti gli attori della storia in una mostruosa tela di ragno al centro della quale tesse le fila un uomo, né morto né vivo, immerso nel buio e nella totale inazione, una sorta di motore immobile.
Egon, il brillante investigatore al quale viene affidata l’inchiesta, è convinto di potersi muovere autonomamente, di essere libero e di sfuggire alle regole del Controllo, ma, per la sua dichiarata estraneità al sistema che invece tutti gli altri condividono, verrà respinto sempre più ai margini ed espulso. Incaricato dapprima dell’indagine con tanto di lettera formale, scopre di lì a poco che in realtà non è affatto autorizzato a portarla avanti e da quel momento si scontra con il limite, con il divieto inconoscibile, quello assoluto, che blocca la ragione convalidandone il fallimento.
Nel prologo il pensiero astratto del protagonista, momentaneamente sopravvissuto all’annientamento e alla morte del suo corpo, parla in prima persona in uno stato di sognante perplessità. La vicenda di Egon comincia, infatti, dove finisce, come una specie di ouroboro, a rappresentare l’inutile avvolgersi del pensiero sulle sue spire logiche. Poi comincia il racconto in terza persona. Egon porta avanti l’inchiesta addentrandosi in una miriade di spazi dall’ingannevole apparenza quotidiana, tra personaggi primitivi che si muovono secondo una occulta regia, che parlano e raccontano e sembrano saper bene quel che fanno pur non avendo alcuna consapevolezza. La bella Castalia, mito inafferrabile di compiutezza, appare e scompare più volte senza essere mai Beatrice. Finché Egon non si perderà nel mezzo di una fitta boscaglia dopo avere invano tentato di trovare una via d’uscita lungo “sentieri interrotti”. Evidente allegoria dantesca rovesciata e svuotata di risposte secondo il modello kafkiano.
Certamente Egon assomiglia all’agrimensore e a K., mossi entrambi, anzi pressoché occupati, da una mente incapace di interferire con il reale e di modificare il loro destino che è già scritto altrove e predeterminato. Un romanzo, dunque, questo secondo di Dell’Orco, dopo I benefattori, di nuovo sulla dualità insanabile tra la cieche pulsioni della materia e la mente che la abita cercando di venire a capo del mistero della sua inappartenenza.
Egon concentra in sé le contraddizioni ontologiche dell’io. Indaga il mondo al di fuori di sé e non indaga su di sé ignorando la massima del tempio di Delfi. Abita in sé senza sapere nulla di sé come se il suo stesso corpo fosse un mistero impenetrabile, equivalente a quello del tempio dove la voce del Dio non si manifesta più. Egon si addentra infatti nelle viscere del tempio consumando un rapporto sessuale con una donna misteriosa che potrebbe essere l’incarnazione di Gea. Ma la comunione non si realizza e Apollo cotinua a tacere senza passare più attraverso le viscere della nuova Sibilla che resta muta, inconoscibile, sterile.
Elio ha scritto un gran bel pezzo, con tantissimi spunti. Forse un po’ troppi. Un ottimo pezzo, ma forse un po’ inadeguato per essere definito recensione.
Ah, ecco, pareva anche a me.
Grazie Dell’Orco, ho appena ordinato il romanzo presso l’editore e lo leggerò con grande interesse.
:siccome non ho pudori di sorta pubblico la mia lettura…
b!
Nunzio Festa
da BOOKS AND OTHER SORROWS poi su Il Quotidiano della Basilicata eccetera…, recensione di Nunzio Festa
23 aprile 2007
La Grecia dell’investigatore Hereafter. Egon Hereafter, nel meraviglioso romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, riceve il compito di indagare sull’anomala intrusione al tempio di Apollo. L’illustre esperto, di fronte a meraviglie che creano altre meraviglie e che a loro volta ovviamente fanno meraviglie nei lettori, impara a conoscere le bellezze e il carattere forte di una Delfi occupata dalle forze visibili e invisibili del Controllo. Un potere superiore e supremo che tiene in mano le redini della vita sociale della antica Delfi. Sandro Dell’Orco è alla sua seconda prova letteraria; infatti aveva già pubblicato per Manni il romanzo I Benefattori (finalista al Premio Feronia), e questo autore calabrese che vive a Roma, dove lavora presso l’Istituto per il Libro del ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha anche pubblicato diversi racconti e saggi di critica letteraria per riviste e antologie italiane e straniere, oltre a essere redattore del bimestrale Libri e riviste d’Italia. Lo scrittore invita a prendere alla lettera la storia e le vicende, a conteggiare le parole così come sono e quindi senza tentare di giocare nelle viscere della metafora. Ma non sempre è facile. Anzi è difficilissimo. Soprattutto quando il rotondo dato surreale cinge i fianchi della fluidità del testo. Il romanzo va verso il mare, come un piccolo fiume. Dunque dobbiamo necessariamente guardare alla grande metafora, per la quale lo specchio dice che Delfi è anzitutto l’opera che racconta dell’essere umano che non si arrende all’arrivo impellente della parola fine. La trama offre l’immagine dell’investigatore Hereafter che per ben due volte sbarca in Grecia per farsi carico del caso del tempio di Apollo, nel quale una bellissima ragazza, la Castalia che fa innamorare tutti e pure l’esperto straniero infine, è riuscita a entrare di nascosto per appartarsi con un uomo in un cunicolo sotterraneo. Il gesto della ragazza non passa inosservato, perché appunto il Controllo per una volta è stato beffato e vuole riparare. Tramite il direttore del museo, questo potere occulto finanzia l’impresa dell’investigatore che deve scovare i colpevoli, compreso certamente l’uomo che nonostante le ricostruzioni non è stato del tutto riconosciuto. A un certo punto della magnetica storia l’assomiglianza estrema proprio fra l’uomo senza identità e lo stesso investigatore privato è così plateale che porta il Controllo a, nonostante il fatto che Hereafter non fosse in Grecia al momento dell’intrusione scioccante, indicarlo quale colpevole dell’accaduto anziché indagatore. Nel frattempo Egon Hereafter incontra una serie di personaggi, ciascuno dotato di bellezza appagante. Originali e spesso misteriosi sono personaggi che si meritano l’attenzione a loro riservata. L’indagine dell’investigatore straniero ha per lui senso quasi di sfida, diventa ragione di esistere, di resistere. Eppure la soluzione vera all’enigma non esiste. E. Herafter è addirittura espulso prima e condannato a morte poi. E deve fuggire. L’ultimo incontro dell’uomo avviene in una zona limite. L’investigatore incontra un altro soggetto che è lui stesso allo specchio, una persona a sua volta cacciata da Delfi e innamorata di una bella ragazza. Il popolo di Delfi accetta senza sentirne il peso i dettami del Controllo, mentre lui pure di fronte alla morte alle porte si rifiuta di accettare i verdetti. Herafter è un uomo che ha ancora la forza di battersi.
di Nunzio Festa
Sandro Dell’Orco, il Kafka italiano
(così c’è scritto – ridicolmente – sulla fascetta del ibro).
Anche nella bandella di La nostra presenza di Giovanni Martini c’è scritto il nuovo Salinger, ridicolmente. Sarà un vezzo della Hacca, dal momento che anche Pierantozzi fu gridato come nuovo Dostoevsckij! :)
Hacca, che orrore! Avrò fatto una c***ata?
Ho trovato riuscito l’equilibrio che dell’Orco ha saputo creare tra la forma-intrattenimento e il contenuto del testo. Chi vuole approfondire può leggere la mia intervista all’autore, qui:
http://ilibrintesta.splinder.com/post/11817310
Quanto alla fascetta, beh, sì, anche a me è sembrata un po’ sopra le righe. Ma business is business e credo che sia più una scelta dell’editore che dell’autore. E poi si dice: don’t judge a book by the cover, figuriamoci dalla fascetta…
Sandro dell’Orco è uno scrittore che si può amare o detestare, ma è autore da leggere. Intanto perché riesce a coniugare basso e alto, mi spiego meglio, riesce a scrivere una spy story senza cadere negli stilemi del genere. E poi racconta un amore travagliato e splendito, con un distacco da cinico del tremila.
“Delfi”, va, mi ripeto, letto e regalato.
E’ un gioco letterario senza esserlo, un gioco che si gioca volentieri. Si beve come un buon cocktail. Insomma al mare o in montagna, di giorno o di notte buon “Delfi”!
Sandro dell’Orco è uno scrittore che si può amare o detestare, ma è autore da leggere. Intanto perché riesce a coniugare basso e alto, mi spiego meglio, riesce a scrivere una spy story senza cadere negli stilemi del genere. E poi racconta un amore travagliato e splendito, con un distacco da cinico del tremila.
“Delfi”, va, mi ripeto, letto e regalato.
E’ un gioco letterario senza esserlo, un gioco che si gioca volentieri. Si beve come un buon cocktail. Insomma al mare o in montagna, di giorno o di notte, buon “Delfi”!
Mi fa piacere che il romanzo di Dell’Orco susciti un così ampio dibattitto; si tratta di un romanzo insolito, nella struttura e nei contenuti che solo superficialmente possono far pensare al genere del “giallo”. Quella di Dell’Orco è una struttura narrativa molto sofisticata adatta alla rappresentazione della progressiva spersonalizzazione ed omogenizzazione cui va incontro l’individuo nelle società contemporanee. Non è casuale se il suo protagonista ha compiuto l’atto ‘scandaloso’ con Castalia, la donna che allude ad un mondo totalmente altro. Anche la sensualità corporea del romanzo ha una funzione alternativa al dominio del Controllo. Il Controllo che riesce a far sopravvivere un suo funzionario efficiente, nonostante il suo corpo non viva più, perchè il totalitarismo del Controllo si esercita sul pensiero, sulla volontà e non sul corpo, che finisce con l’avere un valore eversivo.
…Delfi è un bel libro…non è scritto da Kafka ma neppure da Piperno/Scurati/Savianoholettotuttomanonsochecosaecomunquenonimporta…ha un inizio folgorante e un procedere onoestamente interessante…è un libro felicemente apocalittico (nel senso rivelatore)dove io cerca se stesso per amarsi ed accettarsi e si trova come nulla creatore e quindi distruttore…è scritto popolarmente e non annoia mai…tiene pagina dopo pagina…è divertentemente inattuale perchè qui non si grida e non si strepita…qui si prova ad ascoltare le visioni…Dell’Orco non mi sembra un cialtrone simpaticamente italiano che cerca paragoni o trova affettuosità pelose…non urla ed è abbastanza…
Sono felice che si parli di questo libro di Sandro Dell’Orco: la buona letteratura merita tanta attenzione, oggi più che mai. Esiste tra le pagine magiche di Delfi una musica ardente, che riesce a trascinare il lettore in un universo parallelo, carico di tensione emotiva, di tragicità. Quella tragicità che è propria della vita, avvolta in un velo miosterioso, capace di escludere l’uomo dalla verità, senza troppi sforzi. Questo perché, come incide sul foglio Sandro Dell’orco, ogni attimo di vita umana è un inseguire l’eternità, che nietzscheanamente parlando vuol dire attraversare infinite volte la porta carraia che conduce alla consapevolezza della necessità di appartenere a un destino collettivo. Delfi è un tribunale e sul banco degli imputati c’è l’uomo con le sue stringenti contraddizioni e le sue misteriose utopiche aspirazioni.
Mi sono riconosciuto totalmente nello stupendo romanzo di Sandro Dell’Orco. Il dramma, antico ed eterno, della condizione umana, è rappresentato magnificamente in questo capolavoro. Chi siamo veramente? Siamo liberi di scegliere? Siamo capaci di catturare veramente la vita oppure ci alieniamo nel “controllo” del nostro essere? E la vita rimane veramente vita all’interno di questa gabbia culturale fatta di convenzioni, costrizioni, moralismi, ordini, oppure il modo di vivere che ci imponiamo e ci facciamo imporre alla fine “uccide” gli equilibri più profondi del nostro essere trasformandoci in degli automi?
Quando la mattina andiamo al lavoro e facciamo sempre lo stesso tragitto, ormai non guardiamo più la strada, i segnali, le persone e tutto quello che ci circonda; questo è semplicemente agghiacciante, non è vita ma è “antivita” (”Che io non sia morto è evidente, perché continuo a pensare, ma che io non sia vivo è altrettanto evidente, privo come sono di ogni percezione sensibile.”)
L’autore è stato magnifico a trasfondere questo dramma esistenziale in un romanzo raffinato, strutturato superbamente, godibilissimo, pieno di colpi di scena, degno di un film di Luc Besson.
La lacerazione tra l’essere è il dover essere, tra l’istinto e la ragione, tra la razionalità e l’irrazionalità raggiunge il culmine nel personaggio di De Marco imprigionato nel “confine” tra la vita e l’antivita.
A mio parere, il disagio, il nichilismo, il vuoto della civiltà attuale è causato da questa frattura insanabile, da questa follia odierna di schematizzare tutto, di programmare tutto, di organizzare tutto. E’ impossibile imprigionare il flusso vitale in delle sovrastrutture costruite, bloccate, rigide. Eppure è questo che facciamo sempre di più ogni giorno. Domandiamoci perché oggi l’infelicità dilaga. L’autore è stato inarrivabile a rappresentare questa lacerazione, questo male di vivere. “Castalia” si allontana, diventa irraggiungibile; “il controllo” domina e noi non sappiamo ribellarci ad esso. Non sappiamo neanche capire se siamo vivi o morti e, essendo assoggettati al “controllo”, che senso avrebbe capire se siamo vivi o morti? Quale sarebbe la differenza?
Marco Palladino, Reggio Calabria.
Ho letto il libro di Sandro e ne ho scritto bene. Ora però vorrei muovere una critica allo stesso autore che stimo moltissimo personalmente. Ho ascoltato una sua intervista al TG2 dove affermava che gli scrittori contemporanei sono troppo innamorati della “realtà”. E di Realtà e Realismo parlo. Caro Sandro: magari gli scrittori fossero innamorati della realtà! dico questo perché c’è un gravissimo fraintendimento terminologico. Realtà non è società. In questo mi sento profondamente pasoliniano. Ho potuto parlare di “assurdità” e di “relazione assoluta” del tuo romanzo perché è profondamente legato alla realtà, se così non fosse stato, probabilmente lo avrei ignorato. C’è un populismo oggi corrente che ha la convinzione di fare dell’opera d’arte uno strumento attraverso cui tutto si può denunciare. Ovvero lo scrittore si riduce ad individuo socialmente utile. Questo significa che anche lui, come i personaggi del tuo romanzo, è parte integrante e fondante del famoso Controllo. Qui entra in gioco un elemento che mi discosta persino da Elio Matassi che parla di Potere – di quello si parla con il termine Controllo – come qualcosa che ha una struttura piramidale. Non è così. Il potere, oggi, è totalmente orizzontale, per questo è riproducibile e non ripetitivo (ovvero non ha un movimento spirituale che rende l’individuo UNICO, ma meccanico, totalitario, una sorta di scialba democrazia che ci vorrebbe tutti uguali). Nazione Indiana fa spesso questo errore, ovvero quello di confondere la realtà al “socialmente utile”. Dico questo perché se l’arte non accetta di Cantare ciò che non conosce, se non accetta di relazionarsi con l’Assoluto, se non dimentica che è l’opera il risultato di un totale abbandono del corpo che ha generato un corpo Nuovo – la linea verticale che lega l’io all’Altro, l’io alle cose – allora tutto è morto.
Sandro, ti cito per farmi capire meglio:
“Tutto è esattamente come appare, roccia, colonne, massi, eternamente sotto le eterne leggi cui non posso sfuggire”
Ecco, se non si accetta che la realtà, la cosa, è contenuto e contenitore di tutto, allora non c’è alcun motivo di scrivere. Per questo Dante è più realista di Saviano, Kafka più realista di tutta la letteratura gay, femminista ecc, ecc (in questo accetto l’assurdo e non il falso anticonformismo di molti, ovvero accetto la realtà, perché amo la poesia)
Se non si accetta che è la realtà stessa assurda, incomprensibile, ma allo stesso tempo la sola con la quale l’artista può relazionarsi, conoscere e ri-conoscersi per un bi-sogno (un doppio sogno: l’uno terreno e l’altro celesta ma che, nel momento in cui coincidono, diventa CANTO, voce attraverso cui tutto passa e si fa chiarezza: CORPO ALTRO); se non si capisce che è la stessa realtà ad essere SANTA (Pasolini diceva per bocca del Centauro “Tutto è santo, Tutto è santo, Tutto è santo”) non c’è alcun motivo di scrivere.
Il tuo libro è realista, Sandro, perché ha accettato che le cose fossero lo stupro di noi stessi, nonostante e malgrado noi stessi. Per questo Egon (il protagonista) è salvo nel momento in cui coincide e si lascia vincere dalle cose. Questo significa che ha accettato una GIUSTIZIA divina, nongià il “giudizio” – legge che si fa pietra e che è per sua natura immodificabile. Egon ha accettato malgrado l’autore il suo DESTINO. In arte, solo di destino si può parlare, di null’altro, a voi lascio il resto e mi scuso per il lungo commento.
Andrea.
a me pare che la Hacca abbia fatto finora un ottimo lavoro, con Dell’Orco (bravissimo) e sopratuutto con pierantozzi
Ciao Andrea, vorrei risponderti, ma ho pochissimo tempo: sto correndo alla presentazione dell’ultimo libro di Walter Pedullà. Stasera tardi o domani affronterò qui gli importanti quesiti che poni, come del resto gli argomenti avanzati dagli altri interventi. Un caro saluto. Sandro.
Non credo che in questa stanza si stia discutendo della bandella del romanzo di Dell’Orco né delle recensioni fatte su Alcide Pierantozzi.
Di Hacca che dire…è una casa editrice che sta facendo una buona selezione e che sta offrendo ai lettori romanzi di altissimo valore letterario…ce n’era bisogno.
Verissimo, senza dimenticare – sempre di Hacca – oltre allo splendido Uno indiviso, il progetto curato da Mancassola di Kids e revolution
Ho letto “Delfi” due volte. Che meraviglia, quando un romanzo riesce a darti la stessa emozione che la lettura suscitava in te negli anni di apprendistato.
Emozione e divertimento, dato da quell’umorismo sottile che si intreccia costantemente a una tragicità senza aggettivi. E’ certo che la scelta della fascetta “il Kafka italiano” è una scelta dell’editore e non di Sandro, però, ragazzi, non prendetevela con Hacca, che sta facendo un eccellente lavoro, e che ha pubblicato un libro come questo: leggendo il quale ho pensato a Kafka quel tanto che è giusto, ma mi sono lasciato prendere e trasportare in un mondo assurdamente “reale” che è quello di un signore che si chiama Sandro Dell’Orco, e non è un epigono di Kafka né tantomeno un suo imitatore. Diciamo, è un’ipotesi di lavoro, che da Kafka non si può prescindere quando si intraprende la via del “romanzo fantastico”, chiamiamolo così per pura comodità. Allora direi che Sandro ha assimilato la lezione kafkiana portandola a un alto livello di incandescenza.
Ho letto il libro di Dell’Orco e posso assicurarvi che è un romanzo di grande spessore e raffinatezza. Splendida la copertina!
Tanto incomprensibile e assurda appare la vicenda umana, quanto struggente e visionaria è l’ingenuità con cui Egon l’affronta. Un’innocenza, la sua, che fa da contraltare ad un meccanismo che domina l’uomo e non gli lascia alcuna possibilità di salvezza. Da “I benefattori” a “Delfi”, però, Sandro Dell’orco ha fatto sua la lezione Kafkiana e in questo suo plendido romanzo è riuscito a raccontare la vicenda umana con un tocco di assoluta originalità. La vita filtrata dall’occhio dell’artista prende il sopravvento su qualsiasi forma o vicenda letteraria e diventa metafora di qualcosa che ci accomuna tutti. La sua ingenuità diventa struggimento per qualcosa che sentiamo di possedere ma che continuamente ci sfugge. Castalia e Egon sono il sogno con cui noi sogniamo noi stessi. Ed è grazie a questo sogno che ognuno di noi riesce a misurarsi con la dimensione di assurdo e di tragedia nella quale l’uomo è immerso. Nel leggere il libro di Sandro Dell’orco (l’ho letto due volte) mi sono emozionato e divertito allo stesso tempo. E questo capita di rado. Ancora grazie e complimenti per avere scritto un libro così bello.
IL KAFKA ITALIANO. AH AH AH.
Perdonatemi, ma alla ventesima riga del dotto articolo di Elio Matassi sono svenuto: colpa mia, sia ben chiaro, e della cialtronesca, borgatara faciloneria con la quale mi approccio alla pagina scritta.
Di ben altra pasta il buon Dell’Orco, uomo colto e rigoroso come si evince facilmente da un’intervista che mi ha gentilmente concesso qualche tempo fa: http://mangialibri.com/?q=node/877
Quando mi sono rianimato, sferzato dal bollore dello scirocco romano, ho letto tutti i commenti che precedono il mio, trovandomi d’accordo con i complimenti alla Hacca, che in un anno e poco più è cambiata da così a così, e che rappresenta a mio modo di vedere un modello per la piccola editoria nostrana.
Quanto a Delfi, un romanzo davvero insolito e fuori dal coro (sempre ‘sta Grecia che ritorna, fateci caso), nel bene e nel male. Più nel bene, ovvio.
Caro Ilio, credo che soffermarsi così a lungo sulla fascetta di un libro, pergiunta non scelta dall’autore, sia una cosa superficiale e senza senso. Le altre persone che stanno seguendo questo dibattito hanno
– giustamente – ignorato le tue provocazioni, cosa che io non sono riuscito a fare.
Ho letto Delfi di Sandro Dell’Orco e mi è sembrato splendido, complimenti all’autore e alla sua casa editrice. Giuseppe
Molti parlano di Kafka a proposito di Sandro Dell’Orco. Io penso piuttosto a certa letteratura fantastica sudamericana, Bioy Casares, ad esempio. Come “L’invenzione di Morel”, anche “Delfi” è un romanzo “di finzione e di allucinazione”. L’occasione del giallo, dell’indagine, è soltanto un modo per entrare nel vero tema del libro: la presenza e l’immortalità, una sorta di vita galleggiante ai confini della morte. Del resto tutto il romanzo è percorso da questo tema. Spesso i personaggi sembrano delle ombre e si muovono come sospesi in una delirante irrealtà. La scrittura è incalzante, fino alla fine, così che il lettore non rimane deluso. Troverà forse ciò che non si aspetta. Ma Dell’Orco non intende essere rassicurante, piuttosto vuole suscitare riflessioni intorno al mistero. Vita e amore e il doppio che è in noi.
Il problema, caro Ilio, è che Dell’Orco E’ il nuovo Kafka. Lo è davvero! Più di quanto Piperno sia stato il nuovo Proust o Pierantozzi il nuovo Pasolini!
L’argomento di Andrea Caterini – se non mi sbaglio del tutto – è il seguente. Il vero realismo non è quello che riflette la facciata della realtà, ma quello che ne svela la ragion d’essere, l’essenza, la legge che la governa. Così il realismo conseguente sfocia necessariamente nell’Assoluto. Ora, poiché religione, filosofia e scienza non sono state in grado di attingere quest’ultimo, resta solo l’arte per raggiungerlo, o comunque per esprimere la tensione verso di esso, verso la verità. Di questo ragionamento è apprezzabile la tensione a strappare il velo di Maya dalla realtà, ad andare oltre i bruti fatti, per spiegarne la causa; meno apprezzabile che si identifichi la verità ancora una volta con un principio fisso, al di fuori di noi, trascendente, che la magica forza dell’arte ci permetterebbe di avvicinare, se non di raggiungere. In realtà l’arte può in questo campo ancor meno della scienza e della filosofia, che hanno almeno la forza dei concetti e della loro connessione razionale, mentre essa ha solo la forza dell’espressione, la forza di rappresentare il dolore e il desiderio degli uomini. La cosa beckettianamente comica, cioè tragicomica, di tutta la questione, è che l’attuale caos morale, sociale e politico, che genera il bisogno di Assoluto, e contro cui si invoca l’Assoluto, è l’Assoluto stesso a generarlo: l’Assoluto concreto che gli uomini creano da sé stessi rinunciando alla propria autodeterminazione.
Mi sembra che il romanzo di Dell’Orco – seconda parte di un dittico molto coeso, la cui prima pala è costituita da “I benefattori” -, di là dai pregi illustrati da numerosi intervenuti, abbia il merito di spaginare il macrotesto della narrativa italiana contemporanea, blindato in generi e stili di scrittura saldamente istituzionalizzati da critica accademica, militante e giornalistica (ciascuna a modo suo; ciascuna a protezione dei propri codici di comunicazione e dei propri sistemi di autopropagazione, starei per dire, seriale). Dell’Orco, con “Delfi”, è fuori delle righe e costringe a interrogarsi sul canone del Realismo in letteratura, per esempio; costringe a sforzi di individuazione di antecedenti e a tentativi approssimati di collocazione all’interno di una tradizione; costringe a riflettere sull’uso degli stereotipi della letteratura di genere (per il giallo, suggerisco di accostare “Delfi” ad “Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution” di Godard). Insomma, ci obbliga a un impegno ermeneutico che ha rari riscontri nella letteratura italiana dei nostri tempi. Non mi pare poco, per un romanzo che si fa leggere a più livelli, compreso quello dell’immediata godibilità dell’una-pagina-tira-l’latra.
Romanzo illuminante, quello di DDellorco
Rispondo in particolare a Caterini sulla concezione piramidale del potere; forse ho ingenerato un’ idea sbagliata ma con il riferimento goethiano (spero che non svenga nessun altro) alla Cura volevo proprio riferirmi alla orizzontalità del controllo. Credo che su questo punto siamo perfettamente d’accordo. Ritengo inoltre che la casa editrice Hacca sia una casa editrice molto selettiva e raffinata e la sua Direttrice culturale, Tiziana Cristin una donna di grandissimo spessore e, mi si perdoni (sono per l’intelletualismo greco ed anche per questo riferimento spero di non far svenire nessuno) di fascino irresistibile.
Caro Ilio,
Provocazione sciocca la tua e forse anche troppo ripetitiva. Allo stile narrativo e ai contenuti del romanzo di Dell’Orco nessun accenno. Mi coglie un dubbio, hai forse letto solo la bandella? O la tua è una crociata personale contro HACCA.
Cordialmente, Giovanni.
Caro Kafka italiano, vorrei tanto conoscerti. Milena.
Sandro sono costretto a ripetere ciò che ho già scritto, ovvero ciò che si è fatto già corpo e che è stato già riconsegnato. Nulla ci appartiene, nemmeno i nostri figli figuriamoci quello che scriviamo. Abramo portò il figlio sul monte per sacrificarlo al Signore, perché così era “scritto”. Quando Isacco chiese al padre dov’era l’agnello che avrebbero dovuto sacrificare, Abramo rispose che sarebbe stato Dio stesso a donare l’agnello per il sacrificio. Abramo uccise Isacco. Per questo padre e figlio scendono insieme dalla montagna. Il sacrificio si è compiuto e ciò che ci è stato donato (il figlio) allo stesso tempo ci è stato sottratto per essere riconsegnato NUOVO al mondo. Questo per dirti che quello che scriviamo non è nostro e che il mio non è un discorso ottimista. L’ottimismo è FASCISTA, appartiene alla tecnica delle cose, al suo consumo, io parlo di spirito e ogni giorno non faccio che ricordarmelo, cercando di non giustificare mai le miserie dell’uomo per rendere plausibili a me stesso le mie. Parlo quindi di Assoluto come un lavoro evangelico, religioso, sulla realtà (perché è la realtà ad essere religiosa), quindi sull’uomo. Per questo devo riscrivere ciò che ho già detto, anche rischiando di essere preso per un superbo e un presuntuoso. Ma credo nella chiarezza. I miei ventisei anni cercano solo di strappare la gioia ai giorni futuri, perché vivere è di gran lunga più difficile che morire. Perché la letteratura, l’arte, alla fin fine, Sandro, non contano nulla, essendo uno degli infiniti mezzi (non “fini” quindi) per essere liberi, per essere salvi, per vivere nella verità.
“Ecco, se non si accetta che la realtà, la cosa, è contenuto e contenitore di tutto, allora non c’è alcun motivo di scrivere. Per questo Dante è più realista di Saviano, Kafka più realista di tutta la letteratura gay, femminista ecc, ecc (in questo accetto l’assurdo e non il falso anticonformismo di molti, ovvero accetto la realtà, perché amo la poesia)
Se non si accetta che è la realtà stessa assurda, incomprensibile, ma allo stesso tempo la sola con la quale l’artista può relazionarsi, conoscere e ri-conoscersi per un bi-sogno (un doppio sogno: l’uno terreno e l’altro celesta ma che, nel momento in cui coincidono, diventa CANTO, voce attraverso cui tutto passa e si fa chiarezza: CORPO ALTRO); se non si capisce che è la stessa realtà ad essere SANTA (Pasolini diceva per bocca del Centauro “Tutto è santo, Tutto è santo, Tutto è santo”) non c’è alcun motivo di scrivere.”
Andrea
La parola sembra adesso passata all’arte, più che ai commentatori. In Delfi c’è l’arte, ed esiste tra le sue pagine un periodare tra l’arte e la vita. Non sono del tutto concorde con chi afferma che filosofia e religione hanno ceduto il passo all’arte, non perché non sia vero, ma perché è sbagliato l’assioma che pone delle nette differenze tra loro. La religione è arte e viceversa, la filosofia è arte e viceversa, non c’è una identificazione tra le tre, se non una partenza comune, quella che vuole la parola come differenza tra coloro che percepiscono l’essenza e coloro che non la possono percepire. Tenendo conto che chi parla considera parola anche l’abbaiare di un cane. Se l’arte (la parola) è, come afferma Heidegger, la casa dell’essere e l’uomo ne è il suo custode, allora la scrittura, che è parola incisa, diviene un parafrasare l’infinito, la filosofia un commentarlo e la religione un impararlo a memoria.
Oltre alla temperanza lo scrittore vero, per tornare più direttamente a Delfi, deve possedere memoria del mondo, capacità di analisi e arte di raccontarlo, e Dell’Orco possiede queste qualità.
Per quanto riguarda chi si è scandalizzato nel sentir paragonare Dell’Orco a Kafka voglio solo dire che non bisogna essere ipocriti… oggi come nel passato i grandi scrittori esistono, forse sono le case editrici che non li ricionoscono. Io non voglio paragonare Dell’Orco a Kafka, non perché penso che abbia minor talento, ma perché penso che i due non si assomiglino. Dell’Orco è uno scrittore originale, che può aspirare ad essere grande, poiché scrive come un grande scrittore. Non come Kafka, Hesse, Pirandello, ma come loro, cioè con la stessa passione e penetrazione…
Perché questo timore di nominare i grandi? Via il senso di inferiorità: leggendo i grandi proseguamo verso il futuro, convinti che l’arte vincerà sempre, anche quando il nostro piccolo Sole esploderà, fra 5 mldi di anni, e ridurrà in polvere tutte le pagine della letteratura terrestre. Le parole ormai volano nell’aria e non si possono più fermare: Pannichis ce lo insegna da migliaia di anni. Bravo Sandro Dell’Orco, nuovo Kafka.
Borges diceva che la parola è quella farfalla che può apparire all’improvviso e raramente. Dobbiamo essere molto attenti quando arriva la nostra farfalla, perché non sempre siamo disposti a lasciarci toccare da lei… Sandro Dell’Orco, con il suo Delfi ha colto il momento: e quella farfalla, parola, si è trasformata in scrittura, che abbiamo avuto la fortuna di poter leggere.
Per poter capire la vita, la morte, il sesso, domande sull’essere, dalla Grecia fino ad oggi, Dell’Orco è andato sull’altare degli Dei nutrendosi delle sostanze, quelle che possono divenire risposte o altre domande.
Ho conosciuto per la prima volta dell’Orco attraverso il suo libro, e lo ringrazio per l’opportunità, che mi ha consentito di viaggiare per tante ore nelle acque calde del godimento e della Verità…
Ho appena finito di leggere il libro di Sandro Dell’Orco, consigliatomi da un amico… ancora lo ringrazio. Una trama intricata che mi ha riportato alla mente le ragnatele di Aracnide… tutta la passione che l’autore mette in ogni parola, tuttavia, libera le parole e le porta al cuore. Grazie Sandro.
La parola scorre verso il mattino e trascina con sé le passioni dell’uomo.
La parola e l’arte non sono strumenti, ma forme assunte dalla luce per raggiungere il cuore dell’uomo, per portarlo oltre la sua bestialità. E questo è un dono e non un mezzo, questo è il compito di chi scrive… raccogliere durante le sue “notti buie”, con coraggio e spargere i semi il mattino seguente, quando la brina rende fertile il terreno. Dell’Orco bravo Contadino della parola.
Dell’orco ci ha regalato un capolavoro assoluto! mauro
Ho appena letto le parole di Francesco Idotta. Sono d’accordo: da sempre penso, e il mio lavoro di psicanalista me lo conferma quotidianamente, che qualsiasi forma assunta dall’arte è un atto d’amore.
Ogni artista ci offre le miserie umane sublimate: alleggerite, come fa Dell’Orco nel suo Delfi.
eva-francesco-carmela, non ti pare di esagerare? il libro di dell’orco sarà sicuramente bello, ma se ci si mette la stessa persona che si ipostatizza in tre scrivendo le stesse magniloquenti cose – l’autore non ne riceve un gran beneficio…
Mhm… Tutti questi nomi e cognomi qui sopra, ben avvicendati e talvolta intrecciati, e così prodighi di elogi sperticati tutti uguali l’uno all’altro, hanno qualcosa di strano… Sospetto la mano di un goffo regista, o un troppo ingenuo esperto di marketing… Ma chi, dannazione, chi? Il signor Hacca? L’autore stesso? Brutto affare, Watson, brutto affare…
fatina e detective, nomi strani per presentarsi… ho letto tutti i commenti, perchè veramente mi è piaciuto il libro e la discussione sull’arte, voi potete pensare ciò che volete: per fortuna mi sento libera di esprimere le mie idee…
Ognuno vede negli altri quello che è disposto a fare. Chi si vende, di solito, pensa di essere in un mercato. Per questo e contro di questo esiste l’arte e i buoni libri. Penso che tu, che non ti firmi nemmeno, non hai letto il libro. Io mi firmo con nome e cognome senza timore alcuno, da Reggio Calabria.
va bene, evafrancesco. buona notte. ricomponiti.
Il romanzo di Dell’orco può sembrare assurdo, ma è proprio questo che ci insegna l’autore: nell’assurdo cogliamo il nostro vero essere, svestito finalmente da inutili maschere; mentre è la normalizzazione imperante ad essere veramente assurda, perchè le piccole certezze convenzionali di ogni giorno ci creano degli alibi, dei limiti, per non cogliere il vero senso di noi stessi, e vivere con gli occhi chiusi.
Mi sembra che il dibattito intorno al romanzo di Dell’Orco stia sempre più avvicinandosi alla sostanza del romanzo, proprio come nell’ultimo intervento. L’assurdo è rappresentato dalla presunta normalità, mentre le lacerazioni a tale condizione costituiscono la sostanza e la straordinarietà stessa di Delfi.
Da piccolo lettore quale sono queste piccole diatribe tra scrittori che sotto pseudonimo mostrano tutta la propria acredine mi lasciano sconcertato.
La mancanza di onestà intellettuale e di correttezza professionale danno l’impressione che anche il mondo della sublime scrittura è pervasa dalla mediocrità.
Dunque la causa del proliferare di “banalità rilegate” esposte nelle vetrine delle nostre librerie può essere ritrovata nella mancanza di amore per le buone lettere e nelle piccole vendette tra fazioni.
Deludente scoprire che dietro tutto si nasconde il piccolo interesse personale. Basta un nickname, un nome di fantasia per togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza essere identificati e in un futuro magari penalizzati.
La cena degli ipocriti raccoglie intorno alla sua tavola i tanti detective, le tate fatine e gli Olio e gli Ilio di turno.
Cari amici vi auguro una buona lettura e che le vostre emozioni siano autentiche.
Cordialmente.
La recensione di Elio Matassi rileva e rivela una dimensione, quella musicale, che, quando non è palese a livello tematico, viene raramente messa in luce dalla critica, ma che costituisce spesso una fondamentale chive di lettura, sia per la struttura narrativa sia per l’orizzonte simbolico del romanzo.
A quale tristezza è approdato questo thread!
Non vedo l’ipocrisia di cui parla Giovanni, questo no, ma vi aleggia una disonestà – secondo me ancor più negli elogi che nei dileggi – che mi auguro non finisca per danneggiare l’autore, o meglio, il suo libro.
(Perché scusate, ma dell’autore chi se ne importa se il libro è di valore? Con rispetto parlando per il signor Dell’Orco.)
A due giorni dall’inizio del blog sono veramente sorpreso e felice per l’impatto positivo del mio libro, e per gli entusiastici commenti che ha suscitato. Ringrazio perciò di cuore Franz Krauspenhaar, che mi ha ospitato in NI, e tutti gli intervenuti. Quelli che già si sono occupati di “Delfi”con recensioni e interviste, cioè Andrea Caterini de “il crise”, Nunzio Festa di “Books an other sorrows”, Federico Platania di http://www.samuelbeckett.it , David Frati di “mangialibri” ed Elio Matassi. Poi gli scrittori Angelo Ronsivalle, Alberto Toni, Francesco Idotta, Eva Gerace, Silverio Novelli. Infine Marco Palladino, Marisa e tutti quelli che non conosco o si sono firmati con il nome o uno pseudonimo. Spero ovviamente che il blog continui con questo slancio e si allarghi alla partecipazione di altri lettori e nuovi commenti. Certo, la cosa non può non piacermi, narcisisticamente, ma vi assicuro che la maggiore soddisfazione mi viene dal successo del lucido progetto estetico che sta dietro “Delfi”, dell’ ipotesi letteraria sulla quale ho lavorato, in solitudine, per molti anni. Grazie a tutti.
Dimenticavo. Un grazie di cuore per il suo intervento anche al caro Antonio Veneziani, autore, per Hacca, del recente, bellissimo volume di racconti “Cronista della solitudine”.
Grazie Ludovica per il tuo intervento! Pure tu, riveli un’autentica sensibilità letteraria. Condivido totalmente ciò che scrivi.
Il pensiero si basa su un ritmo, che si traduce a sua volta in un linguaggio, e quello musicale ne è forse la matrice più profonda di ogni struttura narrativa, che se pura, attiene a ciò che noi intendiamo per arte. Ora, la possibilità di leggere e quindi provare a trovare chiavi di comprensione allargando l’orizzonte dei potenziali significati, in questo caso di un romanzo, ci permette non solo di approfondirlo, il romanzo, ma di entrare noi, come lettori, in risonanza con le diverse dimensioni linguistiche che sono inevitabilmente coinvolte nell’elaborazione creativa e perciò di entrare in contatto con l’infinita interdisciplinarità della Cultura. E’ con questa convinzione che mi sono spinta a chiedere una lettura del romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, al Professore Elio Matassi, che qui ringrazio ancora e per lo sguardo attento, serio e inedito nello scovare alcune appartenenze e associazioni del romanzo e per le parole “esagerate” che ha voluto dedicarmi. E ringrazio anche tutti coloro che stanno apportando spunti, critiche, visioni con entusiasmo vitale e sincero.
Grazie Ludovica per il tuo intervento! Pure tu, riveli un’autentica sensibilità letteraria. Condivido totalmente ciò che scrivi.
Il pensiero si basa su un ritmo, che si traduce a sua volta in un linguaggio, e quello musicale ne è forse la matrice più profonda di ogni struttura narrativa, che se pura, attiene a ciò che noi intendiamo per arte. Ora, la possibilità di leggere e quindi provare a trovare chiavi di comprensione allargando l’orizzonte dei potenziali significati, in questo caso di un romanzo, ci permette non solo di approfondirlo, il romanzo, ma di entrare noi, come lettori, in risonanza con le diverse dimensioni linguistiche che sono inevitabilmente coinvolte nell’elaborazione creativa e perciò di entrare in contatto con l’infinita interdisciplinarità della Cultura. E’ con questa convinzione che mi sono spinta a chiedere una lettura del romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, al Professore Elio Matassi, che qui ringrazio ancora e per lo sguardo attento, serio e inedito nello scovare alcune appartenenze e associazioni del romanzo e per le parole “esagerate” che ha voluto dedicarmi. E ringrazio anche tutti coloro che stanno apportando spunti, critiche, visioni con entusiasmo vitale e sincero.
Scusi tanto, Dell’Orco, ma i suoi amici e/o colleghi scrittori scrivono tutti allo stesso modo? Non faccia strani scherzi, neh, proprio adesso che l’idea di leggere il suo romanzo cominciava ad entusiasmarmi… Ossequi, StZ
Non capisco la sua domanda. Si spieghi meglio e le risponderò.
Ma sì che ha capito, non faccia lo gnorri: accoglievo la tesi di chi più sopra, in buona- o malafede, ha creduto di individuare in vari commentatori la stessa persona, basandosi su una più o meno palese identità stilistica, sintattica e lessicale. Così, uno più uno, mi sono domandato se lei per caso non ne sia al corrente e, da buon romanziere ma poco elegante, non sia il primo a godere di simili giochi e mascheramenti a favore del suo lavoro letterario e, forte del suo insopprimibile spirito ludico ma debole nel narcisismo, non se la stia ridendo al di qua dello schermo.
Sempre che la tesi colga il vero. In caso contrario, ci sarà materiale sufficiente per uno studio sull’omologazione espressiva degli scrittori italiani delle ultime generazioni.
Comunque sia, come ho già lasciato intendere, la sua persona, per cui nutro tutto il rispetto che si deve agli sconosciuti, mi interessa meno della sua penna, che invece opera in pubblico, e mi interesserà ancora meno qualora dovessi trovare di valore il suo libro; in quest’ultimo caso, sarò ben contento di accodarmi alla presunta personalità multipla qui sopra.
Cordiali saluti.
Chi ha creduto di vedere la stessa mano dietro gli interventi di cui sopra basterebbe che facesse una ricerca su internet, e si potrebbe rendere conto che le persone che hanno scritto sono reali e non hanno paura di esprimere un apprezzamento. Fuor di ogni polemica si può apprezzare un libro a tal punto di parlarne bene. Questo non è un reato. Sin dalla notte dei tempi le opere migliori hanno creato opposte fazioni, i favorevoli e i contrari. Un nome per tutti Moravia. Chi scrive ha una identità, una personalità, un indirizzo e una testa e non nutre pregiudizi. Perché se un collega scrittore è bravo bisogna temere di dirglielo? Un blog non è altro che un luogo in cui confrontarsi. Posso capire anche i sospetti della farfalla e dell’investigatore… per fortuna questa volta non sono fondati. Ho letto due volte il libro di Dell’Orco, per recensirlo e per piacere e confermo l’entusiasmo che ho espresso negli altri miei interventi. A volte c’è del marcio in Danimarca, a volte solo nei nostri occhi, che purtroppo non si fidano più di nessuno e non riescono più a vedere la buonafede. Su questo c’è da riflettere. Non condanno nessuno, ma credo che è bello confrontarsi e poter dire la propria, con serenità, senza malanimo o pregiudizio. Leggere, Prima. Poi Parlarne. Anche male, se questa è l’opinione, ma per parlare bisogna conoscere. Io Delfi l’ho letto e mi è piaciuto. Così come ho letto Saviano in tempi non sospetti (appena uscito) e dopo una mia recensione entusista, ho ricevuto delle critiche… ma poi i lettori mi hanno dato ragione. Spero che succeda lo stesso anche a Delfi, perché se lo merita. Francesco Idotta.
Gentile Stefano,
ora le posso rispondere. Che i vari commentatori – scrittori non siano la stessa persona potrà agevolmente verificarlo cercando i loro nomi su Internet, e in particolare sui siti delle loro case editrici. Cosicché si renderà conto che Angelo Ronsivalle scrive per la casa editrice “Fermento”, Alberto Toni per la EDUP, per Manni ecc., Francesco Idotta ed Eva Gerace per “Citta del sole edizioni, Silverio Novelli per Mobydick editore. Di Antonio Veneziani ho già detto. Quanto agli altri intervenuti anonimi o a me sconosciuti, non ho purtroppo i mezzi per dimostrarle che non siano la stessa persona.
Cordiali saluti
La recensione di Matassi e l’appassionante discussione che si è sviluppata intorno al libro – critiche comprese – mi hanno convinto a leggere il romanzo di Dell’Orco… Vi farò sapere!
In effetti bastava andare sul sito di Hacca, nei commenti all’uscita del libro, senza ricorrere a Google, per ritrovare le firme qui sopra. Che figuraccia! Mi assento da NI per qualche anno:-/
Io parto dal principio che non tutto di un’opera possa essere spiegato o capito. Ma quando si tenta questa impresa, la cosa che mi interessa è la semplicità delle parole usate a tale scopo. Lo sfoggio di cultura personale non fa per me. Spesso i critici per parlare di “me”, di “te”, di “noi” non fanno altro che parlare di “sé” in una autocelebrazione che non giova certo all’opera o all’autore in questione. Ma andiamo avanti.
So anche che non basta certo l’emozione palpabile sulla pelle e nell’anima del lettore per definire un’opera “grande”, però i conti con l’emozione vanno comunque fatti e Delfi, a mio parere, emozioni ce ne regala tante, al punto tale che alla fine della lettura non si è certi dove inizi il romanzo e dove finisca. Forse perchè inizio e fine hanno un loro significato intrinseco che racchiude sentimenti e vicende dei protagonisti che si alternano in un gioco quasi asfittico e la loro presenza spesso diviene ombra dentro un tessuto narrativo di tutto rispetto, ma ombra di una realtà che Egon, fanciullo nel cuore e nell’anima, crede di poter tenere in pugno, fino allo scontro, brutale, con il mistero che governa la nostra povera umanità. Ma accanto alle “ombre” ci sono pur sempre,e ogni tanto ritornano, quelle mutandine di Castalia stese ad asciugare, simbolo di pulsioni e passioni che non possono essere concretizzate ma che per questo muovono Egon alla ricerca di una soluzione possibile.
Emozioni dunque, passioni, scontro frontale con la realtà del “controllo”, mistero, sacrificio. Ma non sono forse queste le coordinate dentro le quali giorno per giorno tentiamo di muoversi?
Ben venga dunque un romanzo come “Delfi” perchè, oltre al piacere immenso della lettura, produce una sensazione talmente benefica da aprire l’anima a nuovi mondi, lasciando il lettore pressocchè senza fiato. Bravo Sandro e complimenti per l’acume della Hacca Edizioni.
Ma ora desidero farti una domanda: “Delfi” sta volando ad alta quota e lontano, e certo tu non soffri di vertigini. Ma uno scrittore come te avrà mai un approdo?
Jolanda Catalano
Rispondo immediatamente perchè non sono omogeneo alla casa editrice Hacca nè tantomeno ad alcuna altra lobby piccola o grande che sia.
Voglio riprendere alcune delle considerazioni argomentate nella replica della Tizian a Ludovica sull’origine sonoro-musicale del linguaggio. Mi sembra un giudizio appropriato e che andava di moda nella cultura romantica. Penso in particolare all’appendice ai Frammenti postumi di un giovane amico della natura di J.W.Ritter.
Infine mi compiaccio del fatto che se ci sono svenimenti ci sono anche incoraggiamenti, sempre mediati dalla lettura della mia recensione, all’acquisto di Delfi.
adesso basta ragazzi! uff…
Io vivo dei sogni miei. Anche gli altri vivono di sogni, ma non dei propri, e questa è la differenza. (H. Hesse)…
proprio perché su Hacca si era già scritto, in tempi non sospetti, i commenti qui sopra acquistano autenticità e valore… La parola vince e la passione conduce sulla strada della verità, quella che in Delfi è frutto di pressante ricerca.
(Fuggendo a gambe levate e braccia al cielo) «Che figuraccia! Che figuraccia!»…
ciao fatina,
sei passeggera o della cìa?
Sono abituato a leggere molti libri per mestiere. Proprio per questo negli anni ho imparato a distinguere tra vita e letteratura. Il fatto di conoscere un autore e di condividere certi percorsi, non vuol dire niente. La stima reciproca, anzi, nell’ambiente letterario è cosa assai rara. Può anche capitare, è successo a me, che a volte l’amicizia si interrompa. Proprio di recente mi è capitato di recensire un bel romanzo, non faccio il nome dell’autore con il quale non mi sento più da molto tempo. Diciamo che i rapporti si sono interrotti e aggiungo non certo per causa mia. Ebbene, avrei potuto non recensire il libro e invece l’ho fatto lo stesso con molto piacere. La mia coerenza e il mio stile lo imponevano. Volevo soltanto dire con questo mio intervento che rivendico un’assoluta autonomia di giudizio, al di là dei rapporti personali. “Delfi” è un romanzo che mi è piaciuto molto. Mi piace dire la verità e mi sottraggo per questo all’ipocrisia che spesso trovo tra gli scrittori. Frequento questo ambiente da un bel po’ di anni per essere piuttosto disincantato. E non tutto ha valore allo stesso modo, al di là delle apparenze. E credo fermamente nell’onestà intellettuale. Colgo così anche l’occasione per ringraziare Sandro, perché mi ha fornito preziosi suggerimenti per il mio libro di racconti “L’anima a Friburgo”, pubblicato dalle edizioni Edup in una collana da lui diretta. Ma ripeto, cerchiamo di separare l’amicizia dal lavoro. Mi rivolgo in particolare ai giovani di questo blog. Altrimenti si rischia sempre di cadere nel sospetto come è accaduto a Stefano. Ho imparato dai miei maestri, la Rosselli, D’Arrigo, Bellezza, Pecora e tanti altri che c’è una coerenza in primo luogo, l’opera riuscita parla da sé. E datemi retta, salviamo anche l’umanità, la serietà, l’impegno della scrittura, perché dietro un’opera riuscita c’è tutto questo. E il vero scrittore si riconosce sempre. E’ inutile barare, inutile lasciarsi abbagliare da facili pubblicità di mercato.
Un saluto,
Alberto Toni
Confermo l’impressione già emersa in alcuni dei precedenti interventi che la “recensione” di Elio Matassi è così sottile e ricca di suggestioni da costituire in sé una piccola opera. Che ha come tema chiave la domanda se la musica sia il fattore utopico che mina la saldezza della legge della necessità e del tempo o piuttosto la potenza che più di ogni altra (ri)dice e ratifica quella legge.
Per un verso, infatti, la musica è, secondo Adorno, l’avversaria del destino. E, se il tempo è, come scrive Simone Weil, il nemico che ghermisce l’uomo e lo trascina ineluttabilmente verso qualcosa di terribile e di irreparabile, ebbene, come ebbe a scrivere Tito Perlini in pagine ispirate da Wackenroder, la musica, proprio l’arte più debitrice al tempo, pare in certi attimi “immensi” compiere il miracolo di arrestarlo-di sospenderlo.
Ma, per altro verso, come Matassi ricorda riferendosi al “Ring”, la musica è-può essere memento e “commento”-ribadimento inflessibile del destino e della sua ineluttabilità. E anzi, nel dispositivo musicale del passaggio dalla “ouverture” al dispiegamento del tema attraverso le sue variazioni, dispositivo che Matassi vede operante e decisivo in “Delfi”, la ouverture appare come l’inizio che, contenendo neppure troppo crittografata l’interezza e la verità di ciò che sarà-accadrà, realizza un gioco di anticipazione tale da indicare che il soggetto agente sta nella quasi derisoria illibertà di colui al quale sembrerà di decidere via via la propria vita ma per il quale tutto è in realtà “scritto” fin dal principio (va da sé che i difensori a oltranza della libertà, memori del mito platonico di Er che sceglie il sé che sarà, possono arrischiarsi a sostenere che l’inizio in cui tutto è prescritto sia stato esso stesso voluto e scelto dal soggetto che poi lo svilupperà). Non possono non venire in mente le pagine di “Correzione”, capolavoro assoluto di un autore – Thomas Bernhard – che so essere molto caro a Matassi, nelle quali si dice che, dalle pur minime esperienze e dai pur impercettibili “incontri” occorsi all’io narrante, a Roithamer e a Hoeller nel tragitto attraverso il bosco che compivano insieme per raggiungere la scuola elementare, sarebbe già stato possibile quasi “dedurre” ciò che ognuno di loro sarebbe stato e avrebbe vissuto. E quindi l’uomo più chiaroveggente e insieme più disperato è forse quello che, nel suo inizio, cioè ancora bambino o al più tardi al momento del passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, in virtù di un’eccezionalmente lucida e penetrante capacità di autovisione coglie con inesorabile esattezza il bagaglio già definitivo delle sue caratteristiche, delle sue doti e soprattutto delle sue manchevolezze e così “sa” una volta per tutte che cosa potrà realizzare e soprattutto quali limiti gli risulteranno per sempre inoltrepassabili.
La chiosa di Marco Fortunato alla mia recensione è veramente sottile ed entra dentro il tessuto narrativo di Delfi, un romanzo senza speranza e senza redenzione, perchè ormai la spersonalizzazione dell’individuo è giunta fino ai limiti estremi. Dinanzi a tale sfida neppure la musica può più nulla.
La lettura della bella recensione di Elio Matassi al “Delfi” di Dell’Orco ha suscitato in me due reazioni: la prima è che mi ha fatto venire voglia di leggere il libro (il che, per quanto mi riguarda, per è un ottimo risultato per una recensione); la seconda è che ha ingenerato in me (sono filosofo) un dubbio che più filosofico non si può.
Nel romanzo, dunque, un cieco fatalismo pare determinare il destino dei personaggi di cui si narra. Come Edipo, o come Clitennestra, essi nulla possono per mutare una sorte che per loro è ineluttabile. Sullo sfondo di questo modo di concepire le vicende dei protagonisti del libro c’è, ovviamente, l’idea che la libertà umana, il “libero arbitrio”, siano nulla più di un’illusione. Una tesi, questa dell’impossibilità della libertà, condivisa sia dal pensiero mitico sia da buona parte del pensiero religioso (persino da qualche cattolico, come i giansenisti) sia da molte voci della filosofia di matrice naturalistica contemporanea (in quest’ultimo senso la minaccia alla libertà non verrebbe dai misteriosi decreti del Fato né dall’insondabile volontà divina, ma dalle ineludibili leggi del mondo della natura).
Alla ferma negazione della libertà umana, alcuni (per esempio Adorno, come hanno notato Matassi e Fortunato) hanno però tentato di opporre la libertà della musica. Anche questa residua libertà, però, viene negata, se capisco, nel romanzo — almeno nella lettura che ne dà Matassi. In questa luce, insomma, anche l’arte musicale pare obbedire a una sorta di invincibile determinazione: non può che seguire cammini già tracciati, vie che non possono essere modificate. Se è così, allora, l’idea della libertà è definitivamente vinta? E’ insomma vero che, come diceva Lichtenberg, l’uomo è il miracolo della creazione proprio nella misura in cui si illude di essere libero?
Non necessariamente. C’è un terzo livello da considerare, dopo quello della narrazione e quello, implicito, della riflessione sulla destinalità della musica. E’ quello della creazione letteraria. E’ Dell’Orco che mette in scena la sua rappresentazione duplicememente deterministica (rispetto agli eventi narrati e rispetto alla musica). Possiamo veramente dare senso all’idea che l’atto creativo della narrazione possa essere solo illusoriamente un atto di libertà?
Non sono pochi, oggi, i fautori di visioni scientistiche che provano a porre le cose proprio in questo modo: esiste persino una nuova disciplina, la neuroestetica, che punta decisamente nella direzione della riduzione dell’arte a fenomeni (plausibilmente) deterministici come sono quelli neurali.
L’onere della prova, però è di quanti negano ciò che all’intuizione pare ovvio. E a me non pare proprio che la creatività artistica (né la morale, se è per questo) sia stata ricondotta al determinismo naturale, sia stata cioè ridotta senza residui al determinismo delle scienze naturali. Possiamo dunque continuare a pensare che Dell’Orco, nel rappresentare letterariamente la mancanza di libertà dei suoi personaggi e della musica, abbia compiuto un atto *libero*.
E’ in quanto siamo liberi, allora, che possiamo immaginare che potremmo non esserlo.
La grande tensione teorica degli interventi di Andrea Caterini, Elio Matassi e Marco Fortunato mi obbliga ad una risposta. Una risposta che chiarisca il mio punto di vista sui temi da loro sollevati. Innanzitutto: è vero che la composizione del mio romanzo “mima” la composizione musicale? E se è vero in che modo? Rispondo subito che è vero, ma spiegarlo è tutt’altro che semplice. Così mi farò aiutare da Adorno – un filosofo molto citato dai miei commentatori – che a pagina 262 di Teoria Estetica (1975) scrive “…ciò che le creazioni linguistiche dicono, non è ciò che dicono le loro parole…” E intende dire: in un’opera d’arte linguistica, i significati immediati dalle parole (in un romanzo la storia in primo piano, il plot, ciò che effettivamente accade al protagonista, ai personaggi, i loro dialoghi, l’ambientazione, ecc.), che devono necessariamente esistere ed essere coerenti, non coincidono con l’essenza del romanzo stesso. La ragion d’essere del romanzo, ciò per cui viene composto e che deve raggiungere il lettore, è altrove. Con questo non si rimanda affatto ad una visione esoterica del linguaggio, ad un qualche Assoluto che la poesia potrebbe magicamente attingere, ma al momento mimetico – espressivo che egemonizza il processo creativo e subordina a sé il momento comunicativo, logico – concettuale. Cioè: il narratore ha un nucleo interiore di energia espressiva , di emotività compressa, di dolore, di desiderio, e lascia che siano queste forze interne a governare, momento dopo momento, la composizione (il plot, l’ambientazione, i personaggi, i dialoghi ecc.). Cosicché il racconto che ne sortisce è sempre, e prima di tutto – al di là del particolare mondo di figure creato, fantastico o realistico che sia – rappresentazione della sua emozione, della sua espressività, del suo desiderio. Anzi, meglio, rappresentazione della liberazione, tramite un’ azione drammatica, della sua passione, del suo dolore. Tutto questo distrugge, in certo modo, la visione volgare e illusoria del patto narrativo: non c’è più uno che comunica ad altri una storia per allietarli, istruirli, informarli, politicizzarli, intrattenerli, e amenità simili – che sono il succo dell’industria culturale -, ma c’è uno che, pressato dal suo dolore, dal suo problema, lo esprime – per sopravvivere – nel mezzo linguistico. Se gli riesce, il suo testo avrà, come una spugna, assorbito la sua genuina emozione, e chiunque altro lo leggerà la risentirà tutt’intera. Questo, ripeto, indipendentemente dal particolare fatto che viene narrato, dalla sua plausibilità, realtà, credibilità ecc. La connessione di una scena romanzesca all’altra, non essendo diretta dall’autore, ma dal suo nucleo espressivo, dalla sua “anima”, può essere assurda secondo i canoni della realtà empirica, ma assolutamente adeguata all’emozione che vi si esprime. L’assurdo ha una sua logica ferrea, solo che è riferita all’essenza dell’opera, al nucleo espressivo, e non ai concetti indicati dalle parole. Dice Adorno a questo proposito, non so più dove: “…La logica dell’arte è paradossale se si giudica secondo le regole dell’altra logica… E’ un procedimento deduttivo senza concetto e senza giudizio… Sebbene le opere non siano concettuali né giudichino esse sono logiche… In esse niente sarebbe enigmatico se la loro immanente logicità non venisse incontro al pensiero discorsivo, mentre tuttavia finiscono per deluderne regolarmente i criteri. Più vicine che a ogni altra cosa esse lo sono alla forma del sillogismo, e al modello del sillogismo nel pensiero contenutistico.”
Ed ora, finalmente, posso tentare di delineare uno degli elementi che accomuna musica e narrativa. Si è appena mostrato che i concetti, i significati, trasportati dalle parole, per il (mio) narratore sono assolutamente inessenziali: l’importante è che siano in grado di farsi carico del momento espressivo, emotivo che preme in lui e che appunto sceglie immagini e parole. Per il musicista, che affida ai puri suoni il dispiegamento del proprio nucleo espressivo, essi sono semplicemente inesistenti.
Risponderò poi a Mario De Caro,a Jolanda Catalano e agli altri
E’ interessante vedere come la composizione musicale venga spesso assunta per chiarire e, per quanto possibile, spiegare le dinamiche della composizione artistica in genere, come mi sembra di poter scorgere nell’ultimo intervento di Dell’Orco e come hanno fatto, più o meno esplicitamente, i già citati Thomas Mann e Thomas Bernhard. La peculiarità tutta musicale di far coincidere, senza mediazione, il “contenuto espressivo”, che da solo non basta a costituire un’opera, con il più rigoroso primato formale conferisce alla musica, senza volerla porre al vertice di una presunta gerarchia delle arti, un privilegiato carattere paradigmatico.
ah, come siete tutti colti, anzi coltissimi, supercoltissimi!, e probabilmente anche belli, e io vi invidio e ammiro e mi sento piccola, stupida e brutta.
Cara “fiammiferaia indiana”,
ti ringrazio di partecipare questo blog che, lo riconosco, può sembrare, in qualche intervento, un po’ arduo da seguire. Ma ti assicuro, quei discorsi un po’ complessi, quel linguaggio sofisticato non sono uno sfoggio vano di “cultura”, ma il tentativo di esprimere con i mezzi (limitati) del linguaggio dei fenomeni che hanno luogo nell’interiorità dello scrittore, e di cui mai si parla, e di cui forse non esiste nemmeno la possibilità di parlare, ma di cui bisogna parlare. Ciò che tu, troppo precipitosamente, declini come vuoto intellettualismo e vanità, è invece l’onesto sforzo dello scrittore che vuole rendere comprensibile e razionale, un processo interiore il cui carattere è proprio l’irrazionalità. Io mi sforzo con tutto me stesso di evitare al lettore la sensazione che purtroppo hai provato:lo faccio – puoi leggere il mio pezzo – esemplificando continuamente i concetti. Scusami se non ci sono riuscito abbastanza. Un’altra cosa: ciò di cui stiamo parlando è quanto di più vicino al tuo essere: sono le tue emozioni, le tue pulsioni, i tuoi desideri, che sono anche i miei e quelli di tutti. E’ un peccato che la critica e la filosofia non sappiano rappresentarli bene come fa l’arte. Scusami ancora.
l’orco è ingenuo
A’ Kafka italianooooooooooooooooooooo, vai per librerie e strappa tutte quelle fascette ridicole, poi ne riparliamo – parliamo del libro. Quando l’editore ha avuto questa bella pensata avresti dovuto dire: “Ahò, ma che sei scemo? Kafka de che? ‘sta fascetta ce la metti sul libro tuo, quando ne scriverai uno. sul libro mio una falsonata del genere non ce la voglio!”. E invece no, non l’hai detto, e hai permesso una simile stronzata. Segno che un po’ ce credevi pure te de esse’ il Kafka italiano. Ridicolo.
ps. e poi smetti di scriverti da solo commenti come: “il libro di dell’orco è un capolavoro!”. Pensi che la gente non se ne accorge?
La questione posta da Mario De Caro mi intriga molto. E proprio da un punto di vista filosofico. Non si sorprendano o si stanchino i partecipanti a questo blog letterario se continuiamo a parlare di filosofia, perché essa, se intesa nel suo vero senso, adempie, su un piano diverso, allo stesso scopo della letteratura e dell’arte, quello di placare o abolire il dolore umano. La filosofia ne cerca razionalmente le cause, l’arte e la letteratura lo esprime, togliendolo dall’interiorità invisibile dell’anima, e rendendolo visibile a tutti, obbiettivandolo nell’opera d’arte. L’arte non è conoscenza della realtà, ma conoscenza del dolore che dà la realtà. Per questo il pensiero l’ha messa talvolta al di sopra della scienza, della religione e della stessa filosofia, perché ciò che veramente importa, della realtà, non è la sua conoscenza, ma se dà gioia o dolore all’uomo.
Perciò il giudizio più attendibile su una società, su un sistema politico, su una qualsiasi forma di convivenza umana, è dato sempre dalla letteratura e dall’arte.
Ciò detto torno al tema posto da Mario De Caro. Al centro del quale compare di nuovo il filosofo Adorno. Ma come mai questo filosofo, annoverato tra “i cattivi maestri” del sessantotto e di quel che ne è seguito, e dichiarato assolutamente superato dal mondo accademico e dalla cultura ufficiale, continua ad essere citatissimo in ogni analisi sociale o culturale di un certo respiro, oltre che ristampato in Italia? Non sarà che quel superamento non è mai avvenuto, e che si è trattato solo dell’eliminazione di un autore ingestibile dall’establishment politico e culturale dell’occidente? Vediamo.
Colui che per primo ne ha decretato la fine, seguito in questo dai suoi allievi, in Germania e nel mondo, è Habermas. E il punto nodale della sua critica ad Adorno ruota proprio intorno all’idea della libertà umana, del “libero arbitrio”, della autonomia dell’Io, della spontaneità umana ( idea introdotta appunto nell’attuale discussione da Mario De Caro). Per Adorno l’esistenza dell’Io, della libera coscienza e volontà dell’uomo, ancorché storica e deperibile, è un fatto indubitabile e assolutamente da difendere e sviluppare. Per lui, dove il singolo Io umano viene “dedotto”, come nella metafisica, o più semplicemente accantonato quale concetto falso e mitologico, come accade nello scientismo, si tratta sempre di tentativi di oggettivizzare l’uomo, in modo esplicito nella metafisica, in modo implicito e inconsapevole nello scientismo. Ed è precisamente a quest’ultimo esito che approda il pensiero di J. Habermas, il quale, al di là della esplicita professione di prosecutore della teoria critica, l’affossa nei fatti aderendo alla volatilizzazione scientista dell’Io.
Se non ho frainteso del tutto il suo pensiero – io non sono un filosofo di professione – , Habermas non si rassegna all’impossibilità di una teoria oggettiva del reale, impossibilità rilevata da Adorno. Egli sembra credere che senza una teoria oggettiva che dimostri scientificamente la possibilità di una società libera, solidale e conciliata, non si abbia alcun diritto di criticare la società esistente. Non so se sia operante in lui il genuino bisogno della fondazione razionale dell’utopica “associazione di uomini liberi”, oppure il riflesso condizionato dell’uomo di scienza che rifiuta la dialettica come oscura minaccia all’assetto sistematico dei suoi pensieri e del mondo. Ciò che è certo è che Adorno non ha mai legato la teoria critica della società alla “fondazione” razionale di un assetto futuro del mondo, ad una sua formulazione in termini di teoria scientificamente verificabile. Per lui, più una teoria sociale è vera scientificamente, più è falsa. Più essa è verificabile e predittiva, più è mistificante. In effetti, una vera teoria della società ne rispecchia la reale legge di funzionamento, una legge cui tutti uomini devono obbedire. Ma proprio per questo essa è falsa, poiché i singoli uomini – che sono sempre, nonostante tutto, soggetti autodeterminantisi – , sono sussunti ad un universale (la legge sociale) che invece li determina. Il termine ‘teoria critica della società’ significa letteralmente che la teoria sociale vera è vera solo come critica, critica di se stessa, della sua “verità”, della sua cogenza. In parole povere, la teoria sociale è vera perché effettivamente un universale domina e riduce i singoli uomini a sue mere appendici, ma è falsa perché tale universale sono gli uomini stessi a crearlo e a potenziarlo giorno dopo giorno con la propria attività vitale.
Comunque, sia che Habermas non condivida tale prospettiva, sia che non la comprenda, egli – fin dagli anni ‘60 – ritiene di poter costruire una teoria generale che fondi scientificamente una forma di interazione umana che giustifichi un assetto migliore della società. Gli si oppone però il discorso appena fatto sull’aporeticità della teoria sociale – aporeticità basata a sua volta sulla realtà dell’Io. Conseguentemente è costretto a dichiarar superato il “paradigma della filosofia della coscienza” e a procedere nel tentativo di smantellamento dell’Io, della volontà e della coscienza secondo la tradizione scientista, come fa appunto in “Teoria dell’agire comunicativo”.
Se le cose stanno così, Adorno non è affatto superato, come, ovviamente, non è superata la realtà della libertà umana, cioè dell’Io autonomo, cosciente e volontario.
Passa la domenica a strappa’ le fascette, da’ retta.
non ho ancora letto il libro di Dell’Orco, ma indubbiamente l’interessantissima recensione di Matassi mi ha stimolata a farlo; mi suscita enorme interesse quando la letteratura, opera della fantasia, riesce ad aprire con più forza e violenza di qualsiasi analisi sociologica, squarci sugli eventi anche contemporanei. Anche se dalla lettura anche di altre recensione si accresce un’angoscia che già forte alberga in me, la consapevolezza dell’illusione di una autodeterminazione del singolo che quanto più si convince della sua libertà, tanto più è vittima del meccanismo perverso che fa dell’introiezione del consenso d da parte ella “società del controllo” contemporanea, il mezzo idoneo a forgiare soggettività “unidimensionali”.
Appassionante questione quella dell’alternativa fra libertà e determinismo. Appassionante e di ben difficile dirimibilità. Il minimo che si possa dire è che l’atteggiamento di chi si pronunci in modo tranchant a favore di uno dei due termini può avere tutt’al più il senso di una replica esasperata a chi faccia incondizionata retorica dell’altro. Come uno storico della filosofia acuto come Loewith non manca di rilevare, nel celebre esempio dell’uomo che intraprende la scrittura di una lettera nemmeno Spinoza, uno dei massimi cantori della necessità, presenta il soggetto come totalmente eterodeterminato.
Personalmente, mi sento molto vicino alla solo apparente boutade di Cioran che dice: sento-mi pare-ho l’impressione di essere libero, ma so di non esserlo. Mentirebbe il fautore della necessitazione che non riconoscesse come sia comune e generale esperienza quella di sentire più e più volte di adire la via dell’azione liberamente. “Sovrapporre” alla propria azione l’automemento della sua porzione di illibertà appare esercizio innaturale fino all’impossibilità; e, se non fosse praticamente impossibile, pensare, mentre si agisce, di stare compiendo qualcosa di già “scritto” risulterebbe psicologicamente insostenibile e produrrebbe probabilmente effetti paralizzanti.
Ma se esser libero significa – come deve rigorosamente significare – essere incondizionato/indipendente o almeno condizionato/dipendente esclusivamente da se stesso, si deve riconoscere che il soggetto sta in condizioni di ampia illibertà, tanto palesi quanto è lontano dalla condizione, che Spinoza attribuisce alla sua Sostanza, di essere fondamento di se stesso. Nessuno si autoorigina. E, poi, nessuno sfugge alla legge-verità (il cui onesto e, proprio in quanto tale, impietoso insegnamento costituisce “la” lezione di ogni grande della dialettica, Adorno incluso) per cui tutto-tutti sono relati con tutto-tutti in una rete di infiniti e onnilaterali condizionamenti, tali che appare ingenuo pensare che a qualunque soggetto sia consentito il “guizzo” di prenderne le distanze emancipandosene o almeno scegliendo a quali inchinarsi. E il primo condizionamento è quello imposto dal passato proprio e altrui. Solo Sartre, ossia un grande esponente della tradizione speculativa – quella francese – di tutte più “maniaca” della libertà, poteva inventare quel che dice in “L’essere e il nulla”, cioè che, tra il soggetto nel momento in cui accede all’azione e il passato, è come se ogni volta s’interponesse un nulla che in certo modo “disinnesca” il potere condizionante del passato. In realtà, tanto più se si pensa con Nietzsche che chiunque in qualsiasi momento della storia abbia “dietro” di sé tempo infinito, si deve riconoscere che nessuno e nessun atto ha mai i caratteri di un vero, fresco, assoluto, incondizionato inizio.
Certo, esistono condizioni e sensibilità personali che destinano molto più nettamente di altre a “sentire” il proprio coefficiente di illibertà. Una di esse è senz’altro la condizione ossessiva-dell’ossessivo, che costituisce uno dei temi portanti del mio ultimo libro (“Alternative alla vita. Esistenza e filosofia”), e circa la quale ancora Cioran dice che chi è presto visitato dalle ossessioni, presto “tocca con mano” la quasi-chimericità della libertà. Un’altra è quella cui accennavo alla fine del mio precedente intervento, ossia la condizione di chi, in virtù di una potenza di autovisione e di autoanalisi insolitamente matura nell’infanzia o al momento del trapasso dall’infanzia all’adolescenza, già al proprio inizio può scorgere distintamente il bagaglio fondamentale delle proprie qualità e soprattutto delle proprie debolezze e così in qualche modo (pre)vedere-(pre)sentire quello che la vita gli confermerà puntualmente, cioè a quali realizzazioni potrà innalzarsi e soprattutto quali altre, per quanto possa diuturnamente lavorare al proprio miglioramento e arrivare così effettivamente a spostare faticosamente in là di qualche centimetro i propri limiti, gli rimarranno per sempre precluse, per quanto intensamente possa desiderarle. E quale prova più chiara di illibertà, o almeno di una libertà fortemente ostruita, del non potere avere-raggiungere ciò che pure intensissimamente si vorrebbe?
Ma un’altra prova egualmente capitale (ma è poi realmente un’altra e non piuttosto la stessa?) mi viene adombrata dall’intervento in cui Dell’Orco descrive così incisivamente il suo scrivere e il suo libro come l’effetto-il precipitato di un pathos e di un’urgenza “interna” inarginabili, e si avvicina molto a parlare di questo grumo che gli “ditta dentro” come di qualcosa da lui (certo con fecondi esiti creativi) subìto. Voglio cioè dire, generalizzando e anche prescindendo dal “casus” della produzione artistica: quale prova più chiara di illibertà, o almeno di una libertà radicalmente limitata, del fatto che le determinazioni caratteriali e umorali più proprie e peculiari di ciascuno, ciò che costituisce il nucleo più inalienabile della “sua” persona, sono qualcosa di a lui dato e, quasi, da lui trovato-ricevuto?
fumisterie devoglianti
Viva Federico Moccia e i lucchetti a Ponte Milvio!
non mi schernire, Giovanni, il fatto è che non ho ancora capito cosa va aggiunto al composto perchè precipiti il pathos, è una vita che provo, aber nichts, non precipita. E sì che prescindo dal casus
gli interventi di De Caro e Fortunato hanno posto al centro dell’attenzione il problema della libertà rispetto alla mia recensione in cui si parla di un cieco determinismo cui non riesce a sottrarsi neppure la musica.E’ la condizione,questa,di quello che ho definito “totalitarismo diffuso” o pervasivo rispetto a cui le porzioni della mia libertà personale finiscono gradualmente col diminuire.Anche la libertà della creatività soffre di questo stesso condizionamento;l’unica possibilità di riscatto è identificabile nelle nostre pulsioni corporali che riescono a sottrarsi alla status del Controllo.
Avviene qui, talvolta, quello che avviene regolarmente di fuori: più si parla, si cerca di parlare, onestamente, di ciò che è più semplice, vicino e ben conosciuto da ognuno di noi, cioè della nostra infelicità, della nostra dipendenza, della nostra condizione di povertà economica e spirituale, e più si è accusati del contrario, di parlare di cose astruse, fumose, incomprensibili. La cosa ha un aspetto oggettivo, nel senso che per riuscire a comprendere la nostra particolare sensazione di infelicità, hic et nunc, bisogna risalire alle sue cause, le quali si allontanano, e di molto, dal senso comune e dalla portata della nostra abituale capacità di riflessione. Non c’è una scorciatoia per capire le cose, specialmente le cose che più ci riguardano – le nostre sensazioni di gioia o di dolore -; occorre sforzarsi e sottoporsi alla fatica di pensare, ripercorrere la catena causale fino ad arrivare alla loro vera ragione. Se non si fa questo, con pazienza e umiltà, non potremo mai sperare di mutare il nostro particolare dolore, la nostra particolare insoddisfazione. L’astrattezza che ne risulta non è quindi colpa di chi cerca di capire, ma della cosa stessa. Accusare di astrattezza e di astruseria, chi sta descrivendo una cosa realmente astratta e astrusa (e non c’è niente di più astruso e astratto dell’attuale contesto dei rapporti umani) è da maligni: invece di prendercela con la cosa ce la prendiamo con chi sta cercando di capirla e di farcela capire.
A parte questo, un’altra ragione, soggettiva, congiura contro la piena comprensione dell’infelicità qui e ora, ed è la volontà di non vederla, per non doverla affrontare mettendo a rischio la vita che conduciamo. Ciò provoca di norma odio e risentimento nei confronti di chi, parlandone, ce la mette sotto gli occhi – risentimento che poi si esprime con l’insulto, lo scherno ed il dileggio.
su con la vita e leggiti: Zamjatin Noi Feltrinelli
Rispondo ancora ad Andrea Caterini, Elio Matassi, Marco Fortunato e Mario De Caro. Se c’è un luogo dove la libertà si è cacciata, questa è l’opera d’arte. Ogni opera d’arte, senza distinzioni. Lì l’uomo è libero e insieme responsabile. Lì l’uomo è uomo. Non c’è praticamente altro luogo dove questo sia possibile in forma così pura. Lì vengono accolte tutte le pulsioni vitali, altrove interdette o rimosse, e gli viene finalmente dato ascolto e possibilità di azione nel mondo fittizio dell’opera. A questo atteggiamento di sincerità, di onestà, di umiltà – e di abbandono, nei confronti del nostro corpo, che non può avvenire nel mondo empirico pena l’esclusione dalla società, si aggiunge da parte dell’artista la responsabilità e l’uso rigoroso della ragione, come e più che nel mondo di fuori. Deve assumere, l’artista, simultaneamente, due posizioni contradditorie, laceranti, che a rigore non stanno insieme, perché l’una è la negazione dell’altra: quella del bambino privo di controllo, privo di Io, che ausculta e segue solo i suoi ciechi impulsi, e insieme quella del padre, ma di un padre buono, che non reprime, ma conduce a compimento quegli impulsi che il figlio, irragionevole, non sarebbe mai in grado di realizzare. Deve essere, l’artista, insieme, razionale al massimo e irrazionale al massimo. Per questo è così difficile esserlo. Nella narrativa il momento razionale, “paterno”, sta nella coerenza del discorso, nella sua cogenza: in definitiva nel principio di non contraddizione che deve inerire a un materiale che assolutamente lo rigetta.
Ma andate a lavorare, che è meglio…
E prendersi un po’ meno sul serio, ogni tanto?
La riflessione del Prof. Matassi sulla musica come chiave interpretativa della narrazione, suo “tessuto connettivo” e nemica del determinismo cieco e assoluto nel romanzo di Dell’Orco è sicuramente ricca di suggestioni e mi ha fatto venire voglia di comprare e leggere il libro!
grazie Giulia del contributo definitivo
Io pensavo che fosse tutto orchestrato, compresa la sceneggiata di Stefano Harzit.
Domani compro anch’io il libro, altrochè
Orchestrato sarai tu,
numida. Io per me conosco solo il predicato «calarsi le brache per finta».
matassi non ha letto un’acca del libro e non conosceva prima cristina tizian, la chiama tiziana cristin il 27th june alle 15 12.
cristina, donna di spessore issimo, si appalesa rovinosamente il 28th alle 15 04 ringraziando chi? Ludovica Puretù
A me importa poco di orchestrazioni, finti (finti) dibattiti e importa anche poco di recensioni e commenti che citano tanti autori-correnti-teorie ma che sembrano parlare di tutto meno che del libro di cui dovrebbero parlare.
Ho letto “Delfi”, e non mi è piaciuto. E non mi è piaciuto perché per circa 150 pagine l’ho trovato parecchio noioso. Poi quando si presenta la “svolta”, il “motore” che dovrebbe far prendere i giri alla narrazione (parlo del Controllo), questo motore non mi pare riesca a tenere viva abbastanza l’attenzione. Forse perché questa entità (kafkiana?!) ogni volta che appare misteriosa, viene svelata (molti “le spiegherò tutto”, “ora le spiego”), ogni volta che sembra tacere, parla a gran voce tramite i suoi emissari. Quello che per un attimo penso si andrà a configurare come surreale, diventa un banale irreale. A questo contribuisce il muoversi dei personaggi che mi appare quantomeno arbitrario, cosa che potrebbe al limite giustificarsi per i “guidati” dal Controllo (l’agire senza aver coscienza degli obiettivi), ma per il protagonista è decisamente fuori luogo, visto che dovrebbe essere guidato, anche solo per professione, da una buona dose di razionalità (lo so che ammette di basarsi parecchio sull’intuizione, ma io almeno l’avevo intesa come un “plus” che fa la differenza, rispetto all’agire razionale). Oltre a ciò trovo che la maggior parte dei dialoghi sia un po’ “senza anima”, composti di un parlare un po’ troppo immediato e sincero e allo stesso tempo così poco emotivo: anche qui una specie di irrealtà.
In definitiva “Delfi” non mi ha appassionato, lasciandomi piuttosto indifferente. Se dovessi riassumere quello che credo sia il suo maggior difetto, direi che la narrazione pare ingabbiata a forza all’interno di una struttura (non c’entra niente il tema del determinismo/libero arbitrio etc.., qui parlo proprio del “come” è stato scritto) interpretativa/tematica che ha lo spiacevole contraccolpo di rendere tutto eccessivamente finto, obbligato e innaturale.
A dirla con le stesse parole del libro (p.262, sennò magari qualcuno pensa che non l’ho neanche letto!) “Sembra la trama di un giallo con pretese di originalità”
My two cents
Anch’io ho letto il romanzo e l’ho anche riletto e sono arrivato a conclusioni molto diverse dall’intervento che mi precede. Posso osservare in primo luogo che non è molto affidabile il giudizio di chi si trincera dietro il “non mi piace”, espressione che meglio si adatterebbe al giudizio estetico, per esempio, su una bella fanciulla. In linea di principio sono contrario ad una critica letteraria autoreferenziale ed al contempo estetizzante e sono favorevole invece ad una critica letteraria trasversale, che utilizzi, in altri termini, altri saperi, altre competenze. Questo ha contribuito a far emergere, in primo luogo, la novità del tessuto narrativo di Delfi, la sua strutturazione ‘musicale’, aspetto che non era mai stato mai notato da nessuno e che, invece, l’autore si era proposto di trasmettere. Questo è solo un aspetto; per quanto concerne la realtà, l’irrealtà non mi trovo in alcun modo d’accordo, perchè come ho cercato di chiarire il protagonista, nel momento in cui diventa preda del Controllo (vi era già una chiara predestinazione), finisce con il non discernere più esattamente tra realtà e irrealtà. La dimensione del Controllo sta proprio in questa indeterminazione, in questa sospensione tra realtà e irrealtà.
ok, matassi, you said your bit
le provocazioni mi stimolano e nonostante le ironie (sono dotato di molta autoironia) e intimidazioni più o meno criptiche, continuo a dire la mia. In una occasione ho anche precisato che non appartengo a nessuna lobby precostituita e che quindi parlo solo in quanto individuo.Non è una digressione, ma è anche il grande tema del romanzo di Dell’Orco che tenta di fare proprio dell’individuo il protagonista con tutte le difficoltà che tale progetto comporta. Infatti alla fine il progetto abortisce, ma, nonostante, tale nota di pessimismo, credo che il romanzo meriti rispetto proprio perché dà voce all’individuo.
Ho letto con interesse la suggestiva recensione di Matassi al “Delfi” di Dell’Orco, cosi’ come ho apprezzato alcune delle note del blog. Mi ha colpito soprattutto il tema della impossibilita’ da parte dell’arte di redimere il contingente restituendo la dimensione della liberta’. Lo sapeva bene Ernst Bloch – un autore caro a Matassi – che in tutta la sua opera insiste sullo scarto che inevitabilmente condanna il finito alla contingenza: il pittore non entra nel quadro, lo scrittore non entra nel libro. E se l’arte promette la felicita’, l’assoluto, una simile promessa non puo’ che darsi come mai compiuto, e tuttavia “a venire”. Ma tale irriducibile alterita’ dell’assoluto, ben lungi dal rappresentare un limite per l’esperienza umana, ne costituisce semmai il pungolo esistenziale (cosi’ Levinas a proposito di Bloch): l’anelito verso l’irraggiungibile totalita’ tiene in vita. E’ questo il tema costante di Thomas Bernhard (giustamente chiamato in causa da Fortunato), lo scrittore musicale per eccellenza. Nei suoi romanzi il compiuto, la perfezione data una volta per tutte, toglie terreno all’umano. Emblematico in tal senso e’ il caso del cono in “Correzione”, che provoca la morte della sorella di Roithamer, ma anche l’esempio di Glenn Gould nel “Soccombente”. Cio’ che e’ compiuto non lo sopportiamo – come recita il Leitmotiv di “Antichi Maestri”, e per questo abbiamo bisogno del frammento. Mi pare che all’interno di queste coordinate si possa collocare quell’elogio del frammento che – come ricorda Matassi gia’ dalle prime righe della sua recensione – rappresenta il punto di incontro privilegiato tra musica e letteratura nel Novecento.
leggo… perché, amava ripetere il nostro grande Arnaldo Momigliano, a non leggere non succede nulla.
leggo, dicevo, la bella recensione di Elio Matassi. leggo poi tutti i commenti a seguire.
e alla fine concordo con Mario De Caro: mi è venuta voglia di prendere in mano il libro di Dell’Orco. lo farò.
in attesa, una breve riflessione vincendo personalissime reticenze. sì, perché parlare in prima persona è un atto che espone sempre al pericolo e alle conseguenze della presunzione – alla tentazione, almeno, di considerare oggettivamente valido il proprio lavoro (in questo caso, le proprie impressioni). le quali invece, come le nostre persone, appartengono soltanto alla cronaca quotidiana.
mi limiterò pertanto a indicare due diverse e opposte sensazioni. la prima, leggendo Matassi: il suo commento al libro è esemplare. nonostante (mi ripeto, appelandomi alla “captatio benevolentiae” di ogni lettore) non abbia letto il libro, ho trovato nelle parole di Matassi molti spunti, riferimenti e suggestioni. in una sola espressione, ha suscitato in me ciò a cui ogni buon recensore dovrebbe aspirare: curiosità e interesse. al di là del libro stesso e della sua trama.
arrivo così alla seconda impressione, legata alla prima, ma stavolta nelle parole di Dell’Orco (nel suo primo intervento e anche altrove). l’autore trova il recensore autoreferenziale, poiché anziché “illuminare” il romanzo in qualche modo lo “oscura”. pertanto ritiene necessario “un intervento che renda in qualche modo comprensibile ciò di cui “parla” Delfi”. e interviene sottoponendo una recensione tratta da un mensile del quale, mi par di capire, egli stesso è redattore. ora, licenziando un libro, ogni autore dovrebbe trovarsi accanto l’ombra lunga di Montaigne – severa: “il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu’à interpreter les choses, et plus des livres sur les livres que sur autre subject: nous ne faisons que nous entregloser”!
vede, caro Dell’Orco, io credo che lei non abbia il diritto di renderci comprensibile il suo romanzo. è la bellezza della lettura! nel momento in cui il suo libro è nelle mie mani, non è più suo… lo leggo, e ci trovo quello che voglio. lo troverò bello o brutto, poco importa. il suo compito finisce dove inizia il mio. è la dialettica che vige fra autore e lettore. poi con lei, dopo che avrò letto il libro, potremo discutere magari di quello che lei voleva dire. ma non può rendermelo comprensibile. nel dirle ciò, sono in (buona) compagnia di Proust: “ogni lettore, quando legge, legge se stesso. l’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso”.
perdoni questa mia considerazione. la consideri un atto di vanità in risposta al suo – vanità, giusta la definizione del Tommaseo: opinione del proprio merito congiunta alla smania di porre il proprio merito in cose vane e dappoco (ed. Vallardi del ’53).
Lo riconosco. Tant pis!
E andarsi a fare una partita:
a goffo, a passadieci,
a primiera, a trentuno,
a rubamazzo, a pari e sequenza
a pigliatutto, ai trecento,
a trionfo, ai disgraziati,
a piccardia, alla condannata,
al centro, a carta voltata,
alla spinetta, al malcontento,
alla sfortunata, al lanzichenecco,
alla furba, al cucú,
a chi l’ha lo dica, a tavole intere,
a piglia,niente,gioca,fuori, a tavole abbassate,
a matrimonio, a rinnegadio,
al gallo, al forzato,
all’opinione, a dama,
a chi fa l’uno fa l’altro, a babuino,
a sequenza, a primus secundus,
all’uvette, a piè di coltello,
ai tarocchi, alle chiavi,
a cochinverde, chi vince perde al centro del quadrato,
al belinato, a pari e dispari,
al tormento, a testa e corona,
alla ronfa, alle martore,
al glic, agli aliossi,
agli onori, a bilia,
alla morra, al ciabattino,
agli scacchi, al gufo,
alla volpe, a leprottino,
a campana, a tirlintana,
alle vacche, ad avanti porchetto,
alla bianca, alle gazze,
alla fortuna, al corno,
alla zara, al bue,
alle tavole, alla civetta,
a nicca nocca, a ti pizzico senza ridere,
al lurco, alle beccate,
alla reginetta, a sferrar l’asino,
a sbaraglino, a trotta gregge tru,
al trictrac, a va somaro, su,
a io mi siedo, alle vallette,
alla barba d’oribus, alla verghetta,
alla boschina, alle piastrelle,
a tira lo spiedo, a ci sto anch’io,
alla botte in fiera, a spegnimoccolo,
a compare, prestami il tuo ai birilli,
sacco, al Siam,
alla coglia di montone, a palla piatta,
a buttafuori, al verrettone,
ai fichi di Marsiglia alla lippa,
alla mosca, a rosicamerda,
a dagli, arciere, dagli, ad Angenart,
a scuoiavolpe, alle boccie in corte,
alla granata, al volano,
all’uncino madama, a scondarella,
a vender l’avena, alla pentolaccia,
a soffiare il carbone, a mio talento,
ai responsori, al mulinello,
a giudice vivo e giudice ai giunchetti,
morto, a baston corto,
a trarre i ferri dal forno, a prillavola,
al finto villano, a mosca cieca,
ai quagliettini, al picchetto,
al gobbo di corte, alla bianca,
a San Trovato, al furetto,
a pizzica spugnole, alla seghetta,
al pero, al castelletto,
a pimpompetto, alla fila,
a trallalalella trallalalà, alla fossetta,
al cerchio, alla trottola,
alla troia, alla tromba,
a ventre contro ventre, al monaco,
alle tenebre, a beccalaglio,
allo stupito, alla grola,
al pallone, a gallo canta,
alla spola, a Colin maliardo,
a sculaccioni, a guardargli il muso,
alla scopa, allo spione,
a San Cosimo, vengo ad al rospo,
adorarti, al pallamaglio,
a lumacone il bruno , al pistone,
a vi colgo senza verde, a bilbochetto,
a pian pian bel bello se ne alle regine,
va quaresima, ai mestieri,
a quercia forcelluta, a testa a testa, o testa a
a caval per terra, piè,
alla coda del lupo, al pinotto,
a peto in gola, a mano morta,
a Guglielmino, dammi la ai buffetti,
mia lancia, a lavar la cuffia, madama,
a dondolarsi, allo staccio,
ai fasci di tre covoni, a seminar l’avena,
alla betulla, al ghiottone,
alla mosca, al molinetto,
a migna, migna, bue, a defendo,
agli spropositi, alla giravolta,
a nove mani, a schioppetto arrabbiato,
a testa pazza, a cul per terra,
a ponte caduto, all’aratro,
a bestia morta, alle fiche,
a monta monta la scaletta, alle pernacchie,
al porco morto, a pestamostarda,
a cul salato, a gambadilegno,
a l’uccellin volò, volò, alla ricaduta,
a caccia al terzo, a trar le freccie,
alle piramidi, a salincerchio,
a saltacespugli, alla gru,
a tagliar la strada, a taglia taglia,
alla cutt, ai biscottini sul naso,
al quattrino borsa in culo, agli schiaffi,
al nido di bozzagro, ai buffetti,
al passavanti ecc. ecc.
ogni tanto?
il quarto d’ora di rabelais…!?!
Rispondo a Marco Filoni. Ho apprezzato moltissimo la recensione di Elio Matassi, facevo solo notare che concentrandosi unicamente sulla struttura e sul contenuto filosofico, lasciava un po’ in ombra la trama e lo stile, che invece erano meglio descritti in un’altra recensione, scritta liberamente e autonomamente da una redattrice della rivista su cui anch’io scrivo. Il fatto che io l’abbia riportata non significa assolutamente che essa rispecchia la mia interpretazione del libro – se avessi voluto dare un’interpretazione l’avrei fatto io stesso – ma solo che espone il plot in maniera più perspicua per i visitatori del blog e i futuri lettori (come cortesia impone). Io non do interpretazioni di Delfi, non lo spiego, perché in esso non c’è niente da spiegare, in esso accadono delle azioni, il lettore le riesegue, e questo è tutto. I romanzi non si spiegano: essi non vogliono comunicare nulla, e tanto meno messaggi politico-sociali, morali, religiosi, filosofie, visioni del mondo, essi sono fatti di concetti solo apparentemente, e perché non possono farne a meno, ma in realtà sono composti di espressione e mimesi, cioè di azioni cariche di emozione che a leggerle (a rieseguirle) ridanno emozione – cose che appunto si vivono e non hanno bisogno di spiegazione. Si parlava di musica – appunto, è la stessa cosa, anche la musica esprime, emoziona e non ha bisogno di spiegazione, anche nella musica i concetti – ovviamente – sono inessenziali. E così nell’arte astratta. Quanto dico lo ritroverà confermato, se avrà la pazienza di rileggerli, nei miei interventi precedenti, dove non parlo mai, e non a caso, del mio romanzo.
A proposito del dilemma libertà/determinismo mi sembra che la recensione di Matassi prenda una posizione filosofica (che c’è di male? mica è una brutta parola…) abbastanza chiara: pur apprezzando molto la narrazione di Dell’Orco (certo al di là del mantra “mi piace/non mi piace”), ne indica, implicitamente, anche un limite: indulgere troppo, forse inconsapevolmente, al binomio predestinazione/determinismo, subirlo, accentuare il già dato, il già pre-determinato. E lo fa seguendo il filo conduttore dell’antica (e modernissima) analogia di musica e letteratura, di parola e canto. La musica riassume in sé la felice tensione tra predestinazione, con delle regole, con una partitura, con un inizio e uno sviluppo coerente, e al tempo stesso, come ogni arte, è il luogo di massima libertà, quando non resta nel solco di una succesione temporale unidimensionale. E’ forse proprio questo, attraverso il richiamo a Thomas Mann che il recensore mette in evidenza, salvando apparentemente Dell’Orco: è sufficiente dire che “La montagna incantata” è noiosa?
E’ forse vero poi, come dice Dell’Orco, che nella musica i concetti sono inessenziali, ma questo è altrettanto vero per la letteratura? Analogia, non vuol dire identità.
Dissento poi dall’intervento di Fortunato: basta forse ascoltare il detto delfico, per renderci conto che forse le emozioni della “nostra” persona, date/ricevute/trovate (non ha importanza), sono straordinariamente simili, e che questa somiglianza può essere una felice scoperta di libertà e comprensione degli altri (… è ingenuo tutto questo?)
platitudini noiosissime, ci mancava anche filoni
eppure vengo qui, perchè? cosa mi stuzzica?
Una paloma blanca come la nieve… come la nieve
m’ha rovinato l’alma, come me duele…come me duele…
M’ha rovinato l’alma, come me duele…come me duele,
una paloma blanca come la nieve… come la nieve
Prima di fuggirmene da questa discussione – ché ho avuto il sentore che si stia un po’ giocando al basta che se ne parli – vorrei solo far notare al signor Matassi che il mio intervento era da leggersi come semplice espressione di una opinione personale sull’opera di Dell’Orco e non come un tentativo mal riuscito di critica letteraria. Pensavo fosse abbastanza evidente, visto il mio esprimermi chiaramente nei modi della soggettività. Da questo punto di vista il mio giudizio è affidabile come quello di qualsiasi altra persona. In quanto al trincerarmi dietro al “non mi piace” (certo però stiamo diventando un po’ cavillosi!), non mi pare un’accusa lecita, dal momento che ho argomentato la mia posizione e di conseguenza ho fornito elementi per cui controbatterla.
Se poi questo luogo è esclusivamente deputato alla sottile critica letteraria e non prevede l’espressione di opinioni sul libro, “se l’ombre nostre v’han dato offesa”, chiedo umilmente scusa e me ne vado a testa bassa, in cerca d’aria fresca.
Il signor Matassi risponde e non fugge perchè crede nella libertà di espressione e nell’esercizio critico della ragione. Un dibattito nasce e si sviluppa perchè evidentemente vi sono ragioni solide che questo avvenga. Chi mi precede tende in alcuni casi a sopravvalutarsi, in altri a sottovalutarsi: prima di cercare aria fresca, che di questi tempi fa bene a tutti, è meglio riflettere su quanto si dice, perchè, pur non facendo parte della corporazione dei critici letterari, si possono esprimere opinioni traducibili in tale direzione. Non mi sembra che si tratti di un dibattito autoreferenziale ma piuttosto di un dibattito ricco di implicazioni trasversali che possono interessare tutti. Sono tra coloro che ritengono che si possa arrivare alla filosofia, all’etica, alla politica, anche partendo da un suggestivo romanzo contemporaneo.
A me mi pare che questo romanzo ci interessi a tanti che si parlando addosso tutti uguali, tranne che agli altri signori scrittori che frequentan questo bloggo. Sarà l’invidia o è che hanno mangiato la foglia?
fra tante belinate scolastiche-l’ottimismo è fascista-detta senza piglio, senza contesto, per sfoggiare mal senso, è la più
pietosa
Il cattivo gusto è sì dei poveri di spirito, leggi belin a corto di ossigeno, ma qui in effetti di aria pura se ne respira poca. Io per me mi preferivo Rablé e così avrei seguitato di buona lena a canzonare, ma ora che il libro di Dell’Orco mi è arrivato a casa in contrassegno, con tanto di fascetta aranciata LO SPLENDIDO ROMANZO DEL NUOVO KAFKA ITALIANO, mi ritiro tra i laghi del Brandeburgo in compunta clausura lettorale, per poi poterne render conto con più senno in questa gora di pixel. Bis bald.
(Replay suppergiù: il mio primo ultimo commento non è apparso)
Il cattivo gusto è sì dei poveri di spirito, leggi belin a corto di ossigeno, ma qui in effetti di aria pura se ne respira poca. Io per me mi preferivo Rablé e come tale avrei seguitato a canzonare, ma adesso che mi è arrivato in contrassegno il romanzo di Dell’Orco con tanto di fascia aranciata LO SPLENDIDO ROMANZO DEL NUOVO KAFKA ITALIANO, mi ritiro tra i laghi del Brandeburgo in compunta clausura lettorale, per poi poterne rendere conto con più senno in questa gora di pixel. Bis Bald.
E’ incredibile come nel romanzo di Sandro Dell’orco la suspence si sposi mirabilmente e si fonda in fantasmagoriche interpretazioni, dal sapore vagamente onirico, con l’intreccio di una trama che lascia al lettore qualsiasi soluzione senza, in verità, dare alcuna soluzione. L’autore ha voluto così giocare con il lettore inducendolo ad essere lui stesso parte della intricata trama.
hanno una panchina lunga
La recensione di Elio Matassi coglie, nel contempo, con la wagneriana “semantica della predestinazione”, oltre all’esegesi della pubblicazione di Dell’Orco, anche un aspetto fondamentale della metafisica del pensiero occidentale. Se già in origine il culmine del compimento è contenuto nell’inizio, il destino è un qualcosa che si manifesta sin dal principio. Ed è quello che a mio avviso Matassi mette bene in evidenza con il discorso musicale, a partire dalla critica a Mann e alla “Montagna incantata”, romanzo nel quale l’autore dei “Buddenbroock” definisce in un celebre passo la parola come elemento che definisce a differenza della musica che semplicemete evoca. Matassi invece si inserisce nella scia di Schopenhauer e di Nietzsche, per i quali la musica diventa per l’uno diremmo l’essere dell’essente e per l’altro, in quanto arte, la possibilità, l’unica, affinché l’essere (quindi la verità) sia. Un richiamo, quello di Matassi, e quindi quello della musica, ad un ulteriore (l’ultimo possibile) appello all’essenza della vita.
Dopo aver letto gli ultimi interventi, (per fortuna ho molta pazienza), mi sono chiesta se per caso non fossi capitata in un cortile di comari. Domanda : ma è questo il mondo che oggi ruota intorno alla letteratura? e va bene che anche le malignità a volte servono alla causa, però c’è modo e modo, e quando poi non si conosce ( O SI CONOSCE!) l’autore forse sarebbe cosa buona e giusta tacere piuttosto che dire corbellerie servendosi, vigliaccamente, di pseudonimi. Perchè questi valorosi non si presentano con nome, cognome e volendo anche indirizzo? Ho già detto nel mio primo intervento (28/06/2007 ore 18,23) che un’opera non si può smenbrare in mille pezzi per capire “se” e “perchè” e “da dove” e tutto quello che più vi pare. Qui analisi se ne sono fatte a iosa, dimenticando, a volte, il romanzo di cui si stava o si sarebbe dovuto discutere.
Ben vengano critiche di un certo spessore, ma le stesse non sempre favoriscono la comprensione di un testo. E un testo, si sa, è rivolto a un pubblico di lettori non per forza plurilaureati. Anzi io credo che il successo di un romanzo o di un’opera poetica sia determinato dal lettore “comune”,e non da una marea di critici. Ciò che conta è l’emozione che uno scrittore o un poeta riesce a trasmettere a chi legge; ed è auspicabile soprattutto la ricerca di uno stile proprioche lo renda unico e riconoscibilissimo anche tra cento o mille anni. tutto il resto (stile, contenuto, musica, e altro) sono soltanto lo strumento di cui si serve l’autore per trasmettere, attraverso la parola, ovviamente, i molteplici stati d’animo che lo attraversano nell’atto immediato sell’ispirazione. Così inizia un LIBERO viaggio nella scrittura che a volte neanche lo scrittore stesso sa dove lo condurrà, ma se questo viaggio è “autentico” le emozioni si rispecchiano sicuramente sulla pelle di chi legge. Io sono un poeta sconosciuto ai più, come spesso accade, ma pur sempre un poeta. Per questo il mio approccio con la lettura avviene quasi sempre con un impatto emotivo.
Ora, a mio giudizio, le questioni sono due (sono abituata alla sintesi):
1) “Delfi” può essere amato e apprezzato (dopo averlo letto).
2) “Delfi” può non essere amato e apprezzato (DOPO AVERLO LETTO).
Tutto il resto a me non riguarda e le filastrocche che ho letto possono soltanto concorrere al nobel per la stupidità. So soltanto che quando si è soli, davanti a un foglio bianco, con la penna in mano, conta solo ciò che sei e che realizzi in quell’attimo sublime di estasi e libertà totale, perchè di fronte a un foglio bianco, la propria anima, tutto il proprio essere, non può mentire. Per me questo è il vero significato, il più autentico, della scrittura: essere in grado di riprodurne, quasi in traduzione simultanea, i propri sentimenti in versi, o in pagine di narrativa o attraverso note sublimi su un pentagramma, segni pregnanti su una tela o forma e volumi nella scultura.
Per me il vero autore è colui che non pensa minimamente all’utilizzo di ciò che sta producendo; altrimenti il suo atto non è più creativo, ma semplice esercizio di scrittura.
E adesso desidero lasciarvi con la sintesi di alcuni miei versi che forse più del mio scritto possono spiegare i miei pensieri e le mie riflessioni-emozioni.
Da “Alternanze”, Calabria Letteraria Editrice, 1996
AL POETA
Al poeta non servono
sete e velluti
per incorniciare parole
che sanno di vita.
Il poeta va scalzo
trascinando emozioni
sotto il largo mantello
con intrecci d’ore
con fili d’eterno
fabbricato nel tempo
con stanche visioni
o sprazzi di luce
con memorie passate
rivissute in profondo.
Al poeta non date
la prima poltrona
scomoda e voluttuosa
sul palcoscenico della vita.
Dall’ultima fila
fra giochi di luci
il suo occhio saprà
scrutare le assenze
i palpiti lievi
il sano dolore
l’immane universo
di cui il cuore si nutre.
NON PUOI SFUGGIRE
Non puoi sfuggire, Uomo, alla tua ombra
mentre incedi superbo verso il Tempo.
La vita non è un lapis è una gomma
ma inchiostro indelebile che segna.
Buona fortuna a tutti, buoni e cattivi.
Ciao Sandro, aspetterò con ansia il tuo terzo romanzo.
Jolanda
Errata corrige:il terzo verso della seconda poesia va letto così:La vita non è un lapis e una gomma.Quanta confusione si crea con un semplice accento! Ciao ancora jolanda
“Hoechste Strenge ist zugleich hoechste Freiheit”, Stefan George
Quale libertà sotto l’egida del controllo?
Quale il limite del controllabile?
La paura di essere controllati rende più o meno liberi di agire?
Un grazie al prof. matassi e all’autore per il “la” ricco di suoni (dis)armonici
Succede nel nostro piccolo, anzi piccolissimo, villaggio Italia… esistono persone che effettivamente si divertono a navigare su internet per sfogare le loro frustrazioni. Magari passassero più tempo a leggerli i libri invece di commentarli solo dopo aver guardato le copertine. Succede nel nostro piccolo mondo che si vada in libreria a chiedere libri che abbiano un colore che si possa sposare con quello dei divani di pelle. La musica la ascoltano tutti, ma pochi la sentono. Perfetta la filastrocca che ho letto sopra… un delirio… e se provasse a farla leggere a uno psicanalista?
In Delfi non esistono assiomi né rivelazioni… ma parole che possono orientare e distogliere dalla sovrabbondanza di imbecillità. Continuo a ritenere il romanzo di Dell’Orco un poema provocatorio e spontaneo… continuo a pensare che nell’universo di ipocriti esistono persone serie e benefiche… che possono solo essere di aiuto, affinché questo piccolo villaggio Italia dismetta finalmente le sue assurde pretese di assoluto… pretese, figlie di bigottismo e chiusura mentale.
artigianelli che si pregiano di firmare delle melensaggini anonime
massinissa,massinisso,vigliacca,vigliacco,melensa,melenso,anonima,anonimo,invidiosa,invidioso.Se hai coraggio,fatti riconoscere oppure rimani a crogiolarti nel tuo brodo.
In adagio, ma non troppo, mi accosto al blog in forma-sonata e mi allegro del suo tonico tema dominante (grazie a Elio Matassi per la sua filomusicofila capacità di udire i libri…).
Da musicante-musicologo, trovo che la ricerca di modelli “extraterritoriali” per la costruzione artistica sia sempre interessante. Come in casa di Euterpe la composizione di sinfonie, poemi sinfonici, ouverture ecc. si fa derivare dai modelli narrativi e retorici del romanzo, così tra i letterari sono amatissimi i riferimenti a cadenze musicali: non è che dobbiamo abbattere gli steccati e riconsiderare l’opera d’arte totale??
Scherzi e minuetti a parte, provo invece un certo fastidio nell’ascolto dei motivi secondari, affidati a quel caratteristico strumentario cacoidiotofonico, dagli inconfondibili timbri moralistici, così tanto diffuso nel capriccio italiano dell’esercizio intellettuale.
Perdono per questo assolo, variazione senza sviluppo, quasi una fantasia, toccata e fuga senza recercare.
A presto, anzi prestissimo
sine pennis volare
Non avrei voluto, ma sono costretto ad intervenire ancora, perché chi si cela dietro il nome di massinissa è passato, nel corso dei giorni, impercettibilmente, dall’ironia, all’irrisione, al sarcasmo, allo scherno, fino ad arrivare, negli ultimi commenti, all’insulto e all’offesa aperta e gratuita – cose, queste ultime, che non dovrebbero essere consentite a nessuno in nessun civile dibattito, reale o virtuale che sia. Prego pertanto questa persona di far appello al suo autocontrollo e di mantenere la sua critica entro i limiti della correttezza e del rispetto degli altri.
Avremo presto la Massimessa in latino
è che non sopporto il marketing di gruppo, fosse almeno tralignante
Nei vari melodrammi di cui sei protagonista, caro Massinissa, non sei mai stato un personaggio così aululante!
si stecca anche a casa di euterpe
Ma qui l’obiettivo è arrivare a duecento commenti?
che si vince?
A parziale riparazione delle gratuite e pesanti offese patite ieri, a causa mia, dalla signora Jolanda Catalano, debbo precisare che la stessa è, a mio parere, una delle voci più alte della poesia italiana contemporanea, come dimostrano le raccolte “Alternanze” (già citata dall’autrice), “Lettere a due madri” (Città del sole Edizioni, 2004) e soprattutto il poemetto “Invincibili” (Città del sole Edizioni, 2005), un assoluto capolavoro che che riepiloga poeticamente tutti i motivi della crisi dell’individuo contemporaneo.
Quanto a Francesco Idotta, anch’egli colpito dagli insulti – a chiaro sfondo paranoico – che infestano questo blog, va detto che egli è un giovane e brillante intellettuale reggino attivo nel campo della critica letteraria, della narrativa, della poesia e delle tradizioni popolari. Della sua vasta e varia produzione ho apprezzato in particolare il saggio “Herman Hesse. L’estetica del tentativo” (Città del sole Edizioni) e la raccolta di poesie “Abadir” (iiriti editore,2006) che raccomando vivamente ai lettori.
Colgo infine l’occasione per chiedere al gestore di questo blog se non ritenga di dover cancellare ogni intervento che contenga palesi offese ed insulti alle persone.
sic et provincialiter
quo usque tandem……………………?
Il mondo è stato creato per mezzo della parola, parola libera, venuta da fuori, e ancora oggi… una cosa, per quanto già sussista, non esiste forse realmente quando l’uomo le conferisce esistenza nella parola e la rinomina? E se era così, come poteva una testa bella e graziosa non persuadersi dell’importanza della sapienza espressa in parole? (Thomas Mann – Il giovane Giuseppe).
Questo pensiero è un richamo alla sacralità della parola, che non è certo un’arma, ma un ponte tra individui e generazioni.
Come comprendere la forza di un’opera di narrativa?
Attraverso l’attenta riflessione e l’ascolto di ciò che l’autore intende dire o, meglio, di ciò che l’autore trasfonde, come tramite, dal mondo in cui la parola si origina a quello in cui la parola diviene suono, cresce e si fa significato, desiderio, strada che dirige lontano dalla paura e traduce il soliloquio in dialogo.
La parola dà consistenza al corpo, lo rende vivo e lo conduce alla vita. La morte è quel silenzio che segue all’inganno, alla cospirazione e alla incapacità di accettare sé stessi. Come scrive Dell’orco: ” C’è una massima a cui molti non credono perché la giudicano troppo da fanatici: essa recita più o meno così: il tuo corpo è del Controllo, esiste finché esso vuole che esista, e svanisce quando non vuole più”.
Aggiungo a questo inquietante destino quanto lascia presagire l’autore, che identifica il Controllo con quelle forme egemoni di potere politico e sociale che assalgono le nostre coscienze e le allattano col vittimismo e la paura. La salvezza sta nella parola di cui parla Mann, quella venuta da fuori, quella che Sandro Dell’Orco è stato in grado di cogliere, di sfidare, attraverso una meta-narrazione, cioè una combinazione di filosofia e narrativa. Forma letteraria in cui io riporrei il futuro della letteratura italiana, se essa volesse allontanarsi dal genere thriller americano, dal sensazionalismo filmico, dalla scrittura per commissione. Se gli scrittori smettessero di genuflettersi alle case editrici, se gli scrittori smettessero di sfornare, per contratto, un nuovo libro ogni anno. Tra i grandi scrittori ricordo Francesco Biamonti, che ebbi l’onore di conoscere circa otto anni fa. Sì e no, quattro libri in una vita, perché sulla costa ligure, dove egli viveva, la parola lo visitava mentre contemplava il mare e odorava ginestre e rosmarino. Francesco Biamonti ascoltava i venti francesi d’oltralpe e non si preoccupava di sporcare carte per compiacere un editore. Nell’Opera SILENZIO, dice: “Sto scrivendo, sto cercando di affrontare la realtà del nostro tempo senza più consolazioni, soltanto facendo la musica delle parole stesse, ma senza abbandonarmi alla musicalità dei passaggi temporali e geografici. Voglio andare nel cuore dell’uomo, del suo inferno, musicalmente”.
Per noi occorre questo altro… l’altro che va nel cuore dell’uomo… in Delfi c’è molto di quell’altro al quale mi riferisco…
viva la reggiana
Caro Sandro & Co, l’arte, se vuoi la cultura, per essere viva deve avere corso come i soldi, deve essere scambiabile come i soldi, deve poter essere giocata come i soldi, deve poter essere investita come i soldi, deve eccitare come i soldi, deve divertire come i soldi, deve essere coniabile come i soldi, deve potersi risparmiare come i soldi, deve potersi dilapidare come i soldi, deve essere volgare come i soldi, deve essere infera come i soldi, deve essere dolce come i soldi, deve inebriare come i soldi e insieme essere estranea e indifferente ai soldi.
Mi sono imbattuta in questo forum su segnalazione di un amico e dico subito che non ho letto il libro di Dell’Orco, ma mi sono soffermata sulla recensione di Matassi relativa a questa pubblicazione. Non ho molto da aggiungere a quanto già molti abbiano espresso sul tema, ma il caso ha voluto che proprio qualche ora fa io avessi finito di rivedere, per l’ennesima volta, “2001-Odissea nello spazio” di Kubrick. Non so quanto c’entri con le questioni fin qui agìte in questo forum, ma l’omaggio a Nietzsche, attraverso lo Zarathustra di Strauss, del grande regista inglese, mi ha illuminata su un aspetto. Che anche la musica, come penso che Matassi abbia voluto mettere in evidenza, sia in grado di esprimere le più radicali posizioni filosofiche.
Su consiglio di una mia amica ho acquistato il suo libro “Delfi”. Ho da poco iniziato a leggerlo e devo dire che mi ha davvero appassionato per l’intensità che trasmette : partendo dal fatto che amo le detective stories, attendo sempre il momento in cui posso sedermi alla scrivania per continuare la mia lettura. Dalle risposte da lei date nei vari interventi mi sono anche accorto che non è solo un’opera che si lega a quel genere ma che è in in più intrisa di risvolti psicologici in cui ognuno di noi può rovare spunti di riflessione. L’ambientazione poi in cui si svolge la vicenda, ti immerge in uno psicodramma che vedrei benissimo anche trasposto sul grande schermo per la gioia dei cinefili …Complimenti signor Dell’Orco! mi rifarò vivo alla fine della lettura.
Perché Jolanda Catalano s9i traveste da Vadalà? – lei sa che io so, e non si periti di negare – massinissa, lei ci piglia…. a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. e massinissa, credetemi, ci ha azzeccato.
Perché Jolanda Catalano si traveste da Vadalà? – lei sa che io so, e non si periti di negare – massinissa, lei ci piglia…. a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. e massinissa, credetemi, ci ha azzeccato.
Con l’intervento di Aversano, constato che la Querelle si sta indirizzando verso la giusta prospettiva: Il romanzo di Dell’Orco è fortemente innovativo per l’originalità dell’impianto romanzesco, una originalità contaminata felicemente e profondamente con la sostanza della musica.
costata, costata
ci sentiamo presto
per carità
Delfi si discosta dalla massa dell’editoria attuale. Per questo và letto e riletto.
A mio avviso l’opera d’arte, per essere tale, deve perdere la sua strumentalità (vi deve essere quello stacco al pari della differenza tra l’artista e l’artigiano). Per essere tale non deve servire ad altro, se non a verecondere, custodire, il suo essere. E questo non deve aprire alla possibilità che l’arte debba essere per sé stessa. L’arte per l’arte, infatti, non consente all’artista di essere il facitore dell’opera (non consente la poiesis) e, al tempo, proprio perché dapprima non vi è un facitore, ma solo l’arte (nell’arte per l’arte), non si permetterebbe al fare di entrare nell’oblio, nella dimenticanza, in modo tale che rimanga solo l’esposizione. Ovvero l’opera d’arte. Cos’è, in questo senso, nel senso dell’opera d’arte nella sua essenza, la musica, se non, forse, proprio la suprema tra le opere d’arte?
– Perchè hoo taccàa lit con l’Arturo? Perchè l’è on stupid. Perchè non
capisce la personalità degli altri e el voeur minga rispettare le mie
aspirazioni artistiche.
– Oh bella, perchè ti te gh’hee le aspirazioni artistiche?
– Eh già.
– Ma de quand?
– L’è stàa de quella volta che hoo fàa l’intercolite, che m’è vegnuda quella
fever: quand son guarida e sont vegnuda foeura del lett me son sentida on
quaicoss che… che insomma mi gh’aveva voeuia de fà l’artista.
– Ma varda! E allora? T’hee cominciàa a pitturà?
– Ma cossa te diset? Mi sont minga bonna de pitturà. Hoo semper ciappàa
quatter in disegn.
– E allora come t’hee fàa a fà l’artista?
– Hoo cominciàa a cantà, no?
– La Bohème?
– Macchè Bohème! Le canzoni, i dischi di successo, “Scende la pioggia”,
“Quando m’innamoro”…
– Ah, propi la vera musica, insomma.
– Eh già. Soltanto che i competenti m’hann dìi che devo specializzarmi nelle
canzoni popolari; disen che gh’hoo ona voce un po’ sguaiata, rozza ma
genuina…
– On poo come quella del strascèe, insomma…
– Ma no! Cossa te diset? Una voce non artificiale.. me par che abbian dìi
inscì… o artificiosa..; insomma, una voce… aspetta, l’hoo scrivùu chì in
su on foiett… ah, ecco: una voce venata di graffiante, eccitante
grossolanità, che esprime compiutamente l’animo popolare… T’hee capìi?
– E allora cossa te cantet? “E se sont ciocch, porteem a cà…?
– Ma no: canzoni popolari ma adatte alla sensibilità di una donna.
-Hoo capìi. E per esempi?
– Per esempi: “E mi sont chì in filanda/ aspetti ch’el vegn sira/ ch’el mè
moros el vegna/ per compagnarmi a cà./ Per compagnarmi a letto/ per fare un
bel sognetto/ e poi fare l’amor”.
– Ah, bella.
– O quell’altra: “Vegni giò della sciressa/ sotto l’albero verdesino/ c’è
sotto Teresina/ che piangeva per far l’amor./ La sua mamma alla finestra/ fa
con voce serpentina:/ passa in casa, Teresina/ non dar retta al traditor”.
– Bellissima.
– Oppura: “Ohi mamma, la mia mamma! Il muratore/ l’ha fabbricàa el poggioeu
per far l’amore”. E l’altra: “Ohi morettino mio/ morirai sotta i roeud del
tranvai”.
– Propi bei. E l’Arturo el voreva minga che ti te cantasset?
– No, el voreva minga. El diseva che quand voeuna la canta la va a finì in
sul giornal, e allora adio.
– Adio cosa?
– Mah, che la se monta el coo, che la perd el contatto con la realtà…
Insomma, el m’ha proibìi de cantà.
– E allora?
– E allora hoo fàa el tentato suicidio.
– Ma no!
– Ma sì.
– E come t’hee fàa?
– Voreva toeu i barbiturici, ma te set, mi fin de piscininna sont semper
stada on poo debola de stomegh, e allora hoo decidùu per la lametta: mi sono
tagliata i polsi, che quasi vegniva foeura perfinna el sangh. Gh’era lì
l’Arturo: M’ha streppàa via la lametta e el m’ha dàa on s’giaffon; allora mi
gh’hoo tiràa on piatt che l’è andàa a finì denter in del video della tele.
Insomma dopo des minutt l’è rivada la Volante che m’ha compagnada al pronto
soccorso. El dì dopo me vegn in cà on giornalista, un giovane simpatico,
ch’el me fa: “Ma lei, signorina, ha tentato il suicidio?”. “Mi no! Ma lu
come el fa a savell?” “Me l’ha detto un infermiere”. “Ma l’è minga vera!”
“Mi faccia vedere i polsi!” “Mi ghe foo vedè nagotta” “Suvvia, faccia la
brava, mi mostri i polsi!”. Insomma, l’ha cominciàa a fa on mucc de vers
perchè ghe fasess vedè i polsi; l’era la prima volta in vita mia che on omm
el faseva tucc quij scenn lì per vedermi soltanto i polsi. Tira e molla,
alla fin l’era inscì simpatich che sont pu stada bonna de dì de no. Domà che
mi gh’aveva on vestìi con le maniche strette e riessiva minga a tirai su.
Allora cossa hoo fàa? Hoo tiràa via el vestìii. Intanta che sont lì che ghe
foo vedè i polsi, riva minga l’Arturo ch’el voreva fa la pas? El me troeuva
lì senza vestìi cont el giornalista e inscì la pas l’hemm minga fada.
Delfi si distacca dalla massa amorfa del mercato letterario attuale sia per originalità della forma che per l’intensità dei contenuti.
Va appoggiato con grande convinzione contro il cinismo di chi in linea di principio non crede a nulla limitandosi ad essere un nichilista meramente passivo.
Professore, poichè non riesco a immaginarla che apra tutti i giorni NI per aggiornarsi sulla Gherminella (ma quale Querelle, prof. ), mi interrogavo sull’organizzazione.
Chi è che stabilisce i turni? Le telefonano, guarda che c’è il solito rompicoglioni? Oppure c’è un clock, adesso tocca a XY? Oppure, che ne so, a Giulio, scrivi una fregnaccia qualsiasi, ma scrivi, scrivi, per Dio?
Quanto a gusti, Lei mi ricorda Emile Zola di cui Ambroise Vollard nei suoi Ricordi di un mercante di quadri ebbe a dire che la sua casa era un bric-à-brac di paccottiglia
Devi comprendere con gioia ciò che è puro in senso generale, gli uomini e tutti gli altri esseri, e di questi cogliere “tutto l’essenziale e il caretteristico” e riconoscere uno dopo l’altro tutti i rapporti, ripeterne le parti costitutive nella loro connessione, finché l’intuizione vivente non scaturisca nuovamente in modo più obiettivo dal pensiero, con gioia, prima che subentri la necessità, sia ancora una volta distorto in modo unilaterale (Holderlin “Scritti di estetica”).
In Delfi, Dell’Orco coglie quell’essenziale di cui parla Holderlin. Esteticamente il libro si colloca a metà strada tra tradizione e sperimentalismo. Sposando i due generi con un lessico pungente e mai affidato al caso. Sono pienamente d’accordo con chi vede in quest’opera delle novità… aggiungerei, delle novità che consentono all’intuizione di prevalere sul ragionato, sul costruito, sull’atteso e il controllabile.
Bravo prof.Matassi,bravo Francesco.
Delfi non va letto solo con gli occhi,ma col cuore scevro da qualsivoglia
preconcetto.Basta osservare e vivere la realtà che ci circonda per
rendersi conto che la sroria narrata potrebbe appartenere a una qualunque
fascia della nostra società senza alcun limite geografico.D
Dentro quelle pagine ci siamo anche noi o almeno quella parte giusta di noi
che tenta,attraverso la parola,di attutire il danno che altre parole,prive di
significato possono arrecare .Chi è puro di cuore non teme la cattiveria
degli altri.
la sfinge chiese ad edipo sulla via di tebe:
se dico che manca una i per pronunciarlo alla sarda, sarà un passo falso?
La differenza tra Elio Matassi e Massinnissa è esattamente questa: io parlo in modo trasparente senza nascondermi dietro a uno pseudomino e dico sempre quello che penso, mentre Massinissa si nasconde dietro uno pseudomino. Non credo che si tratti di differenza di poco conto.
Penso che funzioni catartiche, consolatorie, o, più in generale, esistenziali attribuite ad un’opera d’arte dicano poco sul suo senso, sulla sua essenza, possono, a limite, dirne solo qualcosa ‘a posteriori’. Anche queste attribuzioni riguardano quella “strumentalità” di cui parlava Giulio. Bisognerebbe, prima di ogni esercizio critico, rimaner fermi al mistero, che è anche l’autonomia, la verità oggettiva dell’opera d’arte e, per usare una parola inattuale, la sua bellezza.
La chiamo Elio, Le dò del tu.
Potrei darti un appuntamento alla Vettabia qualsiasi ora.
Mi sei simpatico, ma io dico, dico, come fai a miscelarti con cartuccette tipo Duhring, non puoi puntare i piedi?
Massinissa, vedo che anche chi ripete sempre gli stessi suoni riesce a steccare clamorosamente!!
“Do” si scrive come la nota musicale, senza accento.
Dunque, ripetiamo insieme: “Le do del tu”
Quando vi trovate con Matassi, fatemelo sapere.
Nel frattempo, stai in castigo qualche giorno e studiati l’italiano, invece di parlare in latino
ooh, ooh, ài aspettato ma alla fine ce l’hài fatta
se è per quello, la mia dattilo non ha messo l’acuto su Emile
sai, ò sempre pensato che i musicisti siano degli indormenti,
dico quelli di fila
Un bel tacer non fu mai scritto
…e poscritto: già che ci sei, di fila, dopo l’italiano, ripassa anche il francese
e la ureasi su duhring?
e adesso finiamola qui se no il mio endonimo potrebbe pensare che anch’io batto il ferro
Cara Massinissa,
scelgo il femminile perchè ovviamente sono disposto ad incontrare solo una bella sconosciuta.
Grazie per il simpatico.
Sul resto resta il nostro “democratico dissenso”
Ricevo proprio adesso l’ultimo fascicolo, appena uscito, de “Il banco di lettura”, n.33/2007, semestrale edito dall’Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione diretto da Mariuccia Coretti e Tino Sangiglio, contenente una recensione di “Delfi”. Giro immediamente quest’ultima a NI quale utile contributo al dibattito in corso.
E’ un romanzo giallo, un romanzo psicologico, un romanzo erotico, un romanzo d’amore? Tutto questo ed altro, ma soprattutto incombe la cosiddetta Organizzazione del Controllo del territorio, una specie di mafia, dico io, che tutto sa e su tutto si intromette: è in poche parole il cardine di Delfi, la più invasiva struttura di potere di quella terra. Ma il Controllo che pure sa tutto e penetra in ogni anfratto subisce un’inattesa violazione con l’intrusione nel santuario di Apollo di una coppia avvenuta durante lo sciopero degli addetti alla sicurezza. E perciò viene chiamato a risolvere il caso il detective Egon Hereafter, noto come uno dei migliori investigatori del mondo. Viene interpellato dal Direttore del Museo, ma solo più tardi si sa che tutto dipende dal Controllo.
Così l’intero romanzo si snoda all’ombra di questa abnorme investigazione, perché di una strana investigazione si tratta, dove le divagazioni non mancano e tutto ha senso solo se si pensa che il travaglio del romanzo è una grande metafora dove l’individuo cerca di dimostrare la sua libertà e lotta per essa pur sapendo che il suo volere è sempre soggiogato. Perché il Controllo sembra agire con mani di velluto lasciando la libertà all’individuo nel territorio, ma praticamente sovrintendendo a tutto e facendo agire ciascuno come intende lui giacché crede di fare ciò che vuole, ma in realtà osserva le direttive del Controllo, convinto di comportarsi secondo i suoi intendimenti. E non avviene mai che uno si ribelli, e se lo fa, e questo succede per gli stranieri, viene espulso dal territorio. Così avviene per l’investigatore Hereafter quando sussiste il dubbio che egli sia lo stesso intruso anche se si sa bene che egli non poteva essere presente nella zona durante l’effrazione. Così tutto è allucinante e surreale e quindi l’ambientazione non poteva che essere a Delfi, dove ogni cosa può ancora dare un senso di mistero e può appagare in tal modo il lettore che vede il vaticinio della Pizia accostato all’atmosfera del Controllo, nel quale tutti i funzionari hanno in sé qualcosa di strano, e il loro Direttore, Albaverde, è un morto freddo e assurdo su quel tavolo di marmo circondato da tende nere che non lasciano trapelare la luce, ma può ancora pensare e ordinare in quel clima allucinato e perverso.
Allora unica salvezza in queste pagine percorse da brividi continui è la ricerca della fisicità, quasi nel corpo si dovesse trovare ogni felicità perduta. Così ogni divagazione, ogni momento di pausa è trattenuto da un abbraccio o da qualcosa di più, mentre la carnalità mette in ombra qualsiasi altro richiamo. Ma il Controllo agisce anche su questo versante e così persino qualsiasi approccio deve essere dosato e può avere la sua proibizione. L’individuo a questo punto non è mai libero e perciò questo, lo ripeto, è il grande dramma dell’uomo messo in luce dal romanzo di Dell’Orco: l’uomo crede di essere libero ma invece vive sempre avvinghiato dalle maglie di una qualsiasi proibizione, sia palese che creata da se stesso, nelle profondità del suo essere.
Ma tutto il libro è un’allucinazione e un pretesto per conoscere meglio se stesso, è tutto un sogno o un esame di coscienza? L’investigatore è lo stesso intruso o soltanto un suo sosia? Non lo sapremo mai, perché Egon è convinto della sua innocenza e di non essere mai stato nel santuario, ma verrà punito soltanto per questo dubbio. Ma sarà vero? Non ha importanza la risposta ma tutto quel che viene detto in quelle quasi quattrocento pagine del romanzo tra sogno e realtà, in quello sfarinamento surreale dove l’investigazione è solo un pretesto per narrare l’angoscia dell’individuo. Morirà alla fine Egon, ma rimarrà sempre il suo pensiero a lottare contro il Controllo e a cercare una via d’uscita e la risposta a quella abnorme intrusione che deve pur avere una sua definitiva soluzione.
Il libro si presenta in modo molto raffinato, con una copertina sobria nella quale spiccano le parole definitive del Direttore del Controllo scritte in greco, con le quali Egon viene esonerato dal suo compito, mentre lo stile del romanzo di Dell’Orco scorre limpido in ogni sua pagina, privilegiando sempre la storia e le tradizioni greche che dimostrano il suo amore per la terra ellenica e in particolare per il mondo della Focile alle pendici del Parnaso; e anche Castalia, il nome della famosa fonte antica, diventa un nome importante nel libro di Dell’Orco, giacché è quello della protagonista del romanzo stesso.
Secondo me invece è importante capire che investigato e investigatore siano la stessa persona. Questo lo si intuisce praticamente fin dalle prime
indagini. Io vedo in questo particolare la lotta estrema dell’individuo tra
impulso e ragione, insomma il conflitto che patisce l’io tra le istanze dell’es
e i divieti (il controllo ) del super-io.
Sono d’accordo con Sandro Dell’Orco il suo romanzo tra sogno e realtà, che mi è piaciuto molto e ho trovato particolarmente interessante, suscita al lettore molte domande ma davvero le risposte non contano quello forse che conta è l’avvincente emozione che suscita il libro.
Bene! Bravi! Bis!
Colgo l’occasione per spostare la discussione sul concetto di realismo. Dibattito interessante che si sta sviluppando sulla rivista il Crise, http://www.ilcrise.com, in seguito alla pubblicazione del mio racconto La storia in un blog. Tra parentesi invito chiunque lo volesse a partecipare.
Nel romanzo di Sandro Dell’Orco la realtà è punto di partenza per una riflessione più generale: realtà, non come aderenza novecentesca ai fatti, ma spunto per un’indagine a tutto campo sull’essere. Realtà ontologica o realtà concettuale? In Dell’Orco l’elemento fantastico introduce l’allucinazione come componente visiva del reale.
Siamo al di là della cronaca, per entrare invece dentro la sfida dei simboli. Ma quello che resta alla fine è l’atmosfera. Ciò non avviene peraltro in tanti romanzi sulla realtà di certa letteratura italiana contemporanea, Ammaniti, De Cataldo ecc… Lo sguardo del narratore, insomma, ha bisogno di superare la contingenza se vuole davvero incidere.
Facciamo un esempio, completamente diverso da Delfi, ma prezioso: Everyman di Philip Roth, dove il discorso sulla morte è mediato dalla realtà. Lo scrittore realista oggi non può limitarsi a descrivere i fatti. Occorre introdurre altri elementi: sogno, atmosfera, simbolo. Mediare la realtà, superare la figura per arrivare a un senso compiuto.
Un saluto
Alberto Toni
Non penso che la realtà oggi abbia più bisogno di mediazione rispetto a ieri. Elementi come sogno, atmosfera, simbolo, attraversano la storia della letteratura nel modo più legittimo e riuscito, ma volerli porre come condizione a priori della produzione letteraria contemporanea mi sembra una limitazione piuttosto arbitraria. Anche la “descrizione dei fatti”, nel momento in cui diventa arte, costituisce già una interpretazione. La riuscita dipende dal perché e dal modo in cui il fatto viene descritto o narrato.
Cara Ludovica, sono d’accordo. Io non ponevo infatti nessuna condizione a priori. Mi limitavo a rilevare un dato di fatto: in alcuni scrittori la realtà diventa cronaca spicciola. Spesso si tratta di esigenze di mercato. Del resto è stato lo stesso Guglielmi a rilevare come certa narrativa guardi troppo alla TV con conseguente svilimento del linguaggio. L’essenzialità presuppone uno scavo, quel di più insomma che consenta al lettore di andare al di là dei fatti. Non basta il mestiere. Ti invito a leggere il mio racconto sul Crise. Ma intendiamoci, non ho in tasca una ricetta, propongo soltanto il mio lavoro. E ovviamente come scrittore ho una mia idea di letteratura.
Un saluto,
Alberto Toni
Ricollegandomi a ciò che ho detto in precedenza, la lettura del suo romanzo mi porta alla mente immagini di quel Paese che ha dato i natali alla mia città ( Reggio Calabria) : i luoghi e le situazioni da lei descritte sono così vivide e coinvolgenti che per chi ha una mente fotografica come la mia li vedrebbe volentieri materializzarsi dietro una macchina da presa.Ogni azione seduce e ogni profumo o odore sembrano librarsi dalla pagina ed immergere il lettore nell’indagine in corso. Auguri a Sandro dell’Orco perchè possa pubblicare altre opere che aprano nuovi orizzonti all’intelletto
Il problema, adesso, se ho colto bene l’essenza di ciò di cui si sta discutendo, è se l’arte abbia il compito della rappresentazione. Ovvero, quindi, esperita ormai la sensazione che il vero sia un indicibile, migliore è quell’arte che meglio si avvicina al vero. Se è così, io credo che la questione sia stata in qualche modo messa in maniera inequivocabile da Nietzsche. L’arte, per Nietzsche che pensa per valori (vale ciò che vale, che tiene per il vero, che assicura il vero), è il valore supremo. Ma non perché sia la verità. Ma solo perché vale per l’accesso alla verità. Affinché la verità sia, questa necessita dell’arte. L’arte quindi da un lato apre alla verità, ma dall’altro, sotto un certo riguardo, rimane mezzo. Un mezzo per la verità. L’arte la si scambia sovente per rappresentazione solo in quanto non si è ancora fatta luce sul fatto che proprio perché è chiave d’accesso al vero, il vero che si mostra è la “fuga” del vero. L’arte infatti porta allo scoperto l’assenza del vero. Pensare quindi l’arte come una rappresentazione di qualcosa, risiede ancora nell’opinione che vi sia un qualcosa da una parte, che aspetta di essere rappresentato, e, dall’altra, appunto, la sua rappresentazione. Solo che questo qualcosa non appare: o meglio, appare la sua nullità. L’arte quindi non può permettersi il lusso della rappresentazione: ad essa compete solo l’esposizione (e proprio in quanto valore supremo). E a quel punto cade anche nell’oblio la funzione di “mezzo” dell’arte, ci si dimentica di questa funzione, di questa funzione che l’arte non può avere, mostrandosi come l’unico possibile vero. L’origine dell’opera d’arte è l’arte (lo diceva Heidegger). Il fine.
L’ultimo intervento mi sembra aver centrato il problema con compiutezza. L’arte, (l’origine dell’arte) non sta nella semplice rappresentazione ma in una corrosiva presa di distanza dalla realtà; come avviene molto bene in Delfi
L’ultimo intervento mi sembra aver centrato il problema con compiutezza. L’arte, (l’origine dell’arte) non sta nella semplice rappresentazione ma in una corrosiva presa di distanza dalla realtà; come avviene molto bene in Delfi.
Il tema toccato dagli ultimi interventi indaga lo snodo concettuale del valore dell’arte da mezzo a fine.
Tale passaggio non rischia di offuscare o meglio depauperare l’esposto dal rapporto con il reale?
L’esposizione presuppone una presentazione intenzionale di un vero (“un mezzo per l’accesso alla verità”, “l’unico possibile vero”).
Trovo più intrigante la “corrosiva presa di distanza dalla realtà”, un rapporto dialettico dell’arte con una realtà non riverberata.
Ho trovato veramente ‘poetico’: profondo e intrigante il libro di Sandro Dell’Orco, la cui lettura ti solleva in une dimensione del tutto inconsueta. Ma confesso – distratti come si è da tanto ‘quotidiano’ – che non l’avrei comprato se non avessi letto la sottile, finissima analisi che ne ha dato Elio Matassi nella sua recensione che ho potuto leggere sull’Avanti! Bel libro, e indispensabile recensione/introduzione alla sua lettura.
Pietro D’Oriano
la mia impressione è che questo romanzo sia una una biografia del reale, un rendiconto puntuale ma non solo della sua impossibilità di farsi oggetto per l’uomo, esemplarmente testimoniata dalla sua resistenza a farsi oggetto di indagine e di riconoscimento. lo scopo del romanzo mi sembra quello di realizzare un’anfizionia alla rovescia: nelle anfizionie antiche, intorno al tempio di Delfi (infatti, perchè proprio quest’ambientazione fuorviante, misterica, che sembra assegnare al reale un ruolo eminente nel destino umano con l’oracolo e l’anancasmo?) si mostrava la estrema povertà del reale, ed il suo bisogno di continuo arrriccchimento, con alleanze militari, guerrre religiose, finanziamenti templari… Con questo romanzo scopriamo la cosmologia del reale, la sua concentrazione estrema ed eccessiva, possibile solo nell’accelerazione che il tempo della scrittura sa guadagnare sul reale – sia pure prendendo esempio da uno sviluppo storico della musica, che all’antico oracolo non poteva non mancare, lo sviluppo letterario che istituisce il ritardo del reale rispetto a se stesso – e che istituisce un’anfizionia alla rovescia, dove il reale reclama uno spazio ulteriore per estendersi oltre il libro stesso – quindi, oltre il mondo.
“Delfi” non è un nome o un esempio, ma mostra ciò che da ogni nome è veicolato quando il romanzo si assume la sua responsabilità particolare, agire al di fuori di ciò che concepisce come spazio e contro la storia esplicita degli uomini, ma per il solo fatt che riesce a mostrare che cosa la estrema concentrazione del reale diviene, dopo la sua scoperta, in un libro che esiste perchè pretende di precedere ogni sua enunciazione.
Anch’io concordo con quanto sostenuto da Giulio. Infatti mi pare che egli abbia descritto, in fin dei conti, il punto d’arrivo della metafisica occidentale e abbia individuato l’essenza del nichilismo proprio nel descrivere che ciò che è rimasto impensato, in quanto impensabile, sia proprio il vero. Questo pensiero mette definitivamente alle corde il fatto che a tutto il pensiero occidentale sia sfuggito il pensiero dell’essere. Leopardi, Nietzsche, Gentile e Heidegger (e non dimentichiamoci di Michelstaedter) sono quelli che, traendo determinate conclusioni, a partire da Cartesio, Leibniz, Kant ed Hegel, hanno individuato ciò di cui tutta la metafisica occidentale (a partire da Eraclito e Parmenide. Non da Platone) in sostanza ha parlato per qualche millennio. Una forma di tristezza potrebbe trasparire dalla possibilità che il vero sia sottoposto ad una condizione, che cioè dipenda da qualcosa, ovvero che sia esposto ad un rischio. Che non sia lì, fermo, a disposizione, alla portata del discorso pubblico, della chiacchiera quotidiana, della curiosità. Infatti il rischio è un peso, è peso. Ma se in fin dei conti, come anche Rilke nella poesia “Forza di Gravità” evidenzia, è il rischio ad essere l’essenza di tutto, ben venga questo rischio. Che sia rischio. D’Altronde, visto che se vogliamo attenerci al vero, l’unica possibilità rimane il rischio, vuol dire che si “è” soltanto con il rischio. Perciò il nichilismo non è il nulla, ma forse la vera vita.
Mi è sorto un certo interesse nel veder citata una poesia di Rilke che non conoscevo e che purtoppo continuo a non conoscere perché sono riuscito a trovare su internet solo una versione in originale (ma non conosco il tedesco). Anzi, per la verità non sono neanche sicuro che sia questa, “Forza di gravità”, anche se la parola che in tedesco le corrisponde sembra essere “Schwerkraft”. Una poesia che comunque voglio riprodurre, con la speranza che qualcuno trovi una traduzione o la traduca.
“Schwerkraft”
Mitte, wie du aus allen
dich ziehst, auch noch aus Fliegenden dich
wiedergewinnst, Mitte, du Stärkste.
Stehender: wie ein Trank den Durst
durchstürzt ihn die Schwerkraft.
Doch aus dem Schlafenden fällt,
wie aus lagernder Wolke,
reichlicher Regen der Schwere
Mi sembra che gli interventi di Giulio, Elena e Cesare stiano correttamente riportando il dibattito sul terreno filosoofico, perché Delfi è un romanzo filosofico.
Una traduzione in italiano di “Forza di gravità” di Rilke è questa (di Vincenzo Cicero)
Centro, come da tutto
ti ritrai, pur ancora dai volanti ti
recuperi, Centro, tu, il più forte.
Fisso: come una bevanda l’arsura,
lo traversa di slancio la forza di gravità.
Ma dal dormiente cade
come da gravida nube
ricca pioggia di gravità.
Sono sicuro che il “rischiare”, come lo scrivere un libro, comporre una musica, andare a cavallo, prepararsi un panino, dirigere un’orchestra, infornare del pane, bere un sorso d’acqua da un bicchiere, girare la chiave in una toppa per aprire una porta, ecc. sia l’essenza di tutto. Anzi credo che il rischiare sia il necessario, che in fin dei conti non vi sia la possibilità di non rischiare. E rischiare non significa essere poco accorti: se chi rischia lo fosse, non per questo sarebbe più o meno accorto di chi agisce sentendosi protetto. Riflettiamoci bene: se uno si butta in una certa situazione senza sapere che al di là del rischio vi sia un impossibile (l’impossibilità che qualsiasi cosa possa essere qualcosa di diverso da un rischio), questo non gli garantirebbe un bel nulla: né una maggiore sicurezza, ma neanche una minore sicurezza di chi invece è convinto di aver ponderato ogni eventualità. Il gettarsi, ogni gettarsi, fa sì che lo sprovveduto si metta al pari di chi pensa di aver calcolato ogni apparire di eventi. La condizione del protetto (il protetto consapevole sa infatti benissimo, e fin troppo bene, che il calcolato al millesimo è anch’esso sottoposto all’incertezza, e che quindi la vera sicurezza consiste nel prendere in considerazione il dubbio, diciamo, del dubbio) è una condizione di massima esposizione, al pari dello sprovveduto, che, pur senza calcolando, si è aperto al tutto (seppur in maniera cieca). Il vantaggio che il consapevole porta con sé, nei confronti dello sprovveduto, è quello di non essere votato all’annientamento, ma di poter governare il rischio (l’impossibile da superare). Dico questo perché alla fine ogni pubblicazione è un rischio, come qualsiasi azione (l’azione è aoristica diceva inoltre Paul Klee) è un rischio. E stare nel rischio consapevolmente non può che essere incontrovertibilmente un’azione meritoria, perché il pubblicare è sempre un avere una consapevolezza (compresa, e soprattutto, quella del dubbio del dubbio).
Mi è piaciuto molto l’ultimo intervento sul rischiare e sul dubbio del dubbio. Mi sembrano due qualità-caratteristiche che il romanzo Delfi possieda in abbondanza
E proprio il tema del rischio nella dimensione estetica e’ un motivo centrale e ricorrente nel giovane Luka’cs, un autore molto caro a Matassi. E’ il rischio di rimettere in moto quella opacita’ che era rimasta celata alla mera descrizione (Cultura estetica), ma anche il rischio di radicalizzare la Sinnlosigkeit della nostra esistenza (L’anima e le forme). Il che significa accettare di vivere nelle crepe e negli abissi del reale, “come se” il senso fosse dato. L’arte, allora, ben lungi dal darsi come garanzia di salvezza, si profila invece nei termini problematici di una ostinata e arrischiata richiesta di senso. Cosi’ mi pare, ma su questi argomenti vorrei sollecitare l’intervento di Matassi.
Credo che la Latini abbia perfettamente ragione anche nel chiamare in causa un autore ingiustamente trascurato nella contemporaneità, come Luka’cs.
Il dubbio del dubbio è l’ultimo gradino sul quale il pensare occidentale è salito (o l’abisso senza fondo in cui è disceso). Pensare il dubbio del dubbio significa porre fine a quanto l’occidente, con la metafisica, aveva costruito senza mai condurre a compimento quanto man mano stava erigendo. Ovvero che l’essere è nulla. La Follia dell’occidente, come è stato chiamata la fine della metafisica, l’indifferenza verso gli opposti (verso l’essere e il nulla) trova una volta per tutte requie nel “calvario della coscienza”, direbbe Hegel. Che l’essere sia nulla, cioè, per la filosofia non è più un problema. Il possibile, per dirla in altro modo, per non negarlo, deve essere a sua volta un possibile: ovvero da un lato deve possedere il carattere evenemenziale, direbbero Derrida e Matassi, dell’evento che accade, e, dall’altro, proprio in quanto possibile, il carattere di un meramente possibile, ovvero che il possibile sia solo una possibilità che sia in un certo modo. Questo, naturalmente, apre alla possibilità, essendo un possibile, che possa essere anche in un certo altro modo. Ecco perché il dubbio, per essere dubbio, deve essere dubbio. Ecco perché, il divenire, per essere divenire, deve poter essere anche divenire e non sottostare al giogo del non divenire. Ma questo non vuol dire che Nietzsche, affermando che il divenire non diviene, avesse voluto dire che il divenire, per essere tale, non deve divenire. Se il divenire non diviene infatti significa che il non divenire del divenire è una possibilità del divenire. Questo discorso ci porta molto lontano, certo, almeno all’apparenza, dalla discussione di un libro. Ma a mio avviso, ogni tipo di lettura dovrebbe avere una chiave interpretativa con un pensare di questo tipo.
L’intervento di Claudio è molto stimolante e molto metafisico.
Credo che la letteratura e il romanzo debbano confrontarsi con la metafisica, altrimenti saremmo nel puro estetismo.
Mi piace che il dibattito stia toccando le vette più alte del filosofare.
Si può arrivare alla filosofia, anzi si deve arrivare alla filosofia anche partendo dalla letteratura e da un romanzo. Credo che questo punto di partenza sia ben rappresentato da Delfi.
Quanta filosofia! Ma è proprio vero che un romanzo debba confrontarsi e contaminarsi con la filosofia? Io ho qualche dubbio, preferisco leggere un testo letterario e perdermi nella mia immaginazione senza troppe concettualizzazioni!
Ho letto Delfi e mi sembra un romanzo molto riuscito perchè di un genere altamente ‘eclettico’ , un genere che attraversa contemporaneamente il noir, il filosofico, il redentivo, il totalitario, il politico. Non si deve necessariamente scegliere tra questi diversi approcci. La riuscita sta proprio in questo.
o bavardi, bavardi
Uno strettissimo nesso formale lega la struttura narrativa del romanzo alla partitura musicale, un elogio alla “frammentarietà” ed insieme alla potenza accogliente dell’arte che sembra perdere, proprio nella sua forza unificante, la divisione «distinzione» tra le singole arti, realizzando il sogno inseguito da Schoenberg e da lui più volte dichiarato nel suo epistolario all’amico Kandiskij, di voler realizzare un’«arte monumentale». Bravo Dell’Orco a intraprendere col suo romanazo questa strada di fusione tra le varie arti avendo come modello la musica.
«L’arte monumentale» prefigurata da Kandinskij e condivisa da Schoenberg è al fondo, a mio avviso, del romanzo di Dell’Orco, e ne fa il merito indiscussio: fusione tra le arti sotto l’egida drella musica.
e censurano me!
La fusione delle arti mantiene la loro distinta specificità, pur nell’unità del risultato artistico, incrementandone la potenza espressiva.
La questione delle arti (dell’arte) va posta in questo modo: ciascuna di esse (la poesia, la pittura, il cinema, la letteraura, la musica ecc. e, per motivi sui quali è impossibile dilungarsi in questa discussione, la filosofia) ha pensato, legittimamente o no, coscientemente o meno, di cogliere l’essere. Le classificazioni critiche sono tutte volte a se, per esempio, la poesia sia la migliore di tutte le arti (come per esempio la pensava Novalis), oppure se invece ad essere tale sia da essere la musica (Schopenhauer e molti altri), il romanzo (Mann e anche Leopardi, per certi versi), il cinema (per dirne uno, Greenaway) ecc. ecc. ecc. C’è poi chi dice, ma anche qui, solo per fare un esempio, che un particolare tipo di arte sia ormai divenuta un altro particolare tipo di arte (lo afferma ad esempio Lucas per quanto riguarda il cinema. Il regista di “Guerre Stellari”, a ragione, dice che, con il digitale, ormai il cinema sia pittura). E neanche qui, ed è questo il punto cui io vorrei arrivare, è possibile parlare di “fusione” tra le arti. Nel caso di Lucas, non è che da una parte continui ad esistere il cinema e dall’altra la pittura, che, insieme, in una fase successiva, si andranno a coappartnere. No. Secondo Lucas il cinema è divenuto qualcosa d’altro da sé. Il cinema (digitale) non c’è più ed diventato pittura. Ma questo non deve procurare sgomento: ammesso che sia come dice Lucas, ciò vuol dire che il cinema abbia, come sua storia destinale, come destino, l’essere pittura. Ovvero che l’essere del cinema sia pittura (forse aveva torto Kubrick quando diceva, in sostanza, che l’essere del cinema fosse il montaggio: un’intrepretazione, tra l’altro, che il più grande autore di cinema, Chaplin, deve non aver mai condiviso, ammesso che l’avesse potuto fare, vista la discrasia dei tempi. Infatti egli non girava per scene isolate per poi montarle eludendo i tempi, ma secondo le cronolgia di queste, una dietro l’altra, secondo la successione della sinossi). Il punto, quindi, per tornare alla faccenda iniziale, qual è? Che non vi è né da una parte la “fusione” delle arti, né, dall’altra, nella sua essenza, un’arte superiore ad un’altra, tralasciando la filosofia come testimone della verità, come segnale stradale che indichi la via, il sentiero. Il dire che la poesia o l’architettura o altro ancora godano di un rango superiore o inferiore per l’interpretazione dell’essere, significa fare appello al pensiero (alla filosofia, quindi). Ed è per questo, sotto questo rispetto, che scindere fra le diverse arti diventa inutile se non si considera quanto detto sopra. Che l’origine dell’opera d’arte è l’arte. Si intravede adesso la questione se la filosofia sia o no “arte”.
Se ho capito bene, la posizione di fondo di Claudio è che l’arte, in definitiva, non sarebbe neanche arte, se non vi fosse la filosofia ad interpretarla. Che quindi, se così stanno le cose, ciò che può dire l’essenza delle cose, le “cose grandemente abituali” direbbe qualcuno, sia solo la filosofia. Questo mi trova d’accordo, a patto che la stessa logica dispiegata per aprire al discorso della non fusione delle arti, la si applichi anche alla filosofia. Di quale filosofia infatti si parla? Della filosofia dell’essere, della volontà, della libertà? Il percorso metafisico dell’occidente infatti non mi pare che sia stato univoco.
Penso ci sia ancora un modo per intendere la fusione delle arti: l’influenza reciproca, i diversi apporti (visivo, acutico ecc…) delle singole arti, che si fondono in una singola opera specifica. La filosofia è un qualcosa sempre di extra-artistico e non può mai raggiungere, ma solo ricercare, la verità dell’arte, la compiutezza del suo senso. Inolre, ogni tentativo da parte della filosofia di trasferire l’opera all’interno di un sistema o di una linea di pensiero si è rivelato, quando non apertemente fallimentare, piuttosto insufficiente. Per fare solo alcuni esempi: Hegel, Schopenhauer, in parte anche Adorno quando indulge troppo alla prospettiva sociologica. Quanto a Hegel, che è forse l’esempio più lampante, la sua teoria dello Stato si avvicina molto più alla verità artistica di quanto non faccia la sua teoria dell’arte vera e propria.
200!
Abbiamo superato i 200 interventi perchè sia il romanzo che la recensione lo meritavano amoiamente. Il dibattito non è la logica conseguenza degli stimoli che si possono ricavare da Delfi.
Abbiamo superato i 200 interventi perchè sia il romanzo che la recensione lo meritavano ampliamente. Il dibattito non è che la logica conseguenza degli stimoli che si possono ricavare da Delfi.
hai detto bene prima nel refuso freudiano: il dibattito non è la logica…
Se fusioni delle arti significa far coappartenere l’essenza della musica, quella del cinema, della letteratura, della poesia, ecc., tutte diverse da loro, questo significa che bisognerebbe affiancare l’una alle altre queste essenze. Ma allora non sarebbe una fusione. E’ possibile individuare l’essenza comune a tutte le arti. Ed è solo la filosofia a poterlo fare, a mio avviso.
Nella logica del divenire delle Arti si sacralizza hegelianamente il divenire a scapito del divenuto, in misura analoga il concetto di fusione presuppone una chiara identificabilità degli ingredienti mescolati a vantaggio di un’essenza comune.
Per un sentire sinestetico mi piace riassaporare l’idea di “costellazione” che ridimensiona il valore dell’essenza comune e con esso quello di una filosofia inglobante rispetto alle Arti. Cito in originale, anche perchè non amo in quel punto le traduzioni ufficiali, da Dialettica Negativa: “Kostellationen allein repraesentieren, von aussen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat, das Mehr, das er sein will so sehr, wie er es nicht sein kann”.
Ad onta degli aritmetici conteggi, vivaddio, un blog che stimola il pensiero.
ho letto il romanzo e l’ho trovato avvincente!
Il dibattito si sta facendo sempre più interessante perchè il romanzo si può considerare la nuova opera d’arte totale
Ritengo il superamento dell’idea di un’essenza comune a tutte le arti una delle più importanti conquiste dell’estetica da due secoli a questa parte, una conquista che ha giovato spratutto alle tematizzazioni dell’arte musicale. Apprezzo la citazione adorniana che, se confrontata con più di un passo della Filosofia della musica moderna, rivela una chiara matrice compositivo-musicale. In gran parte delle elaborazioni filosofiche di Adorno, compresa quella di “dialettica negativa” si palesa piuttosto chiaramente il debito della filosofia nei confronti della musica.
A Massinissa, dalla imprecisata personalità : è vero che la quantità non è qualità ma comunque il fatto che Delfi abbia raggiunto i 209 interventi (un record) un qualche significato lo deve comunque avere, almeno per me che ho una forma mentis “sportiva”.
Ho finalmente letto il romanzo e mi sembra veramente affascinante e degno di suscitare un dibattito così appassionante.
Non se ne può veramente più di questo romanzo e degli elogi sperticati.
Sono curiosa di leggerlo ma sono altrettanto sicura che non piacerà.
Chiara ha torto, anche io sono curiosa ma altrettanto sicura che invece la lettura mi soddisferà.
Voglio distaccarmi da questo dibattito che sta prendendo una piega troppo femminile, io non sono curiso, sono interessato e acquisterò il romanzo per conoscerlo in profondità. Il dibattito mi ha veramente stimolato.
Delfi è un vero e proprio romanzo d’avventura da godere dalla prima all’ultima pagina. Non credo a letture troppo sofisticate o intellettualistiche ma al piacere della lettura e Delfi è in grado di procurare piacere.
che il tam tam funzioni non c’è dubbio, io stesso sono andato a leggermi il primo capitolo messo in rete da Hacca e trancio nuovamente il giudizio: paccottiglia
e comunque non è un record >cerca>cioran: 749 commenti
ne devi mangiare ancora così di michette, mente sportiva
refuso: cerca > celan
Caro/cara massinissa, data la sua natura imprecisata, di michette non ne mangio perchè sono a dieta, però le assicuro che in qualsiasi competizione mi cimenti, vinco o cerco di vincere, perchè ho uno spirito combattivo e soprattutto dico quello che penso in modo trasparente. Si può non essere d’accordo sul romanzo, si può dire tutto ed il contrario di tutto ma, a mio avviso, è più etico (mi perdoni massinissa, insegno Filosofia morale), dirlo in modo trasparente. Per lei si tratta di paccottiglia, ma perchè non firmarsi in modo autentico? Glie l’ho fatto già notare una volta e mi sono anche spinto fino ad essere disponibile a conoscerLa, ad un’unica condizione, che sotto massinissa si nasconda una bella sconosciuta. A questo punto sarei disposto a perdonarLe tutto quello che ha detto, perchè sono un esteta (ovviamente con dei limiti rigorosamente determinati).
Nel dibattito tra massimissa e Matassi mi schiero con Matassi, perchè tutti possono pensare quello che vogliono ma devono dirlo apertamente.
Ma se Matassi e Massinissa fossero la sessa persona? …Matassinissa!?!
Veramente geniale Ludovica ma non reale. Tra Matassi e Massinissa vi è un abisso incolmabile: la trasparenza.
La trasparenza… invita all’ostacolo. Qui ci sono problemi d’identità praticamente irrisolvibili.
Aspetto se possibile conferme: a dubbi assai forti.
I dubbi di D’oriano mi sembrano plausibili, in modo particolare quelli sull’identità.Per questa ragione il dibattito è così stringente.
Prof Matassi, lei insegna filosofia morale. Ma le pare morale assumere tutte queste identità? Doriano, Ludovico, Michela, Emiliano Console, Vincenzo Nappo, Arduina Fiorucci, Chiara Gabrielli, Chiara Mizzoni: non le sembra troppo?
La prego, Matassi, non dica di no, io lo so che è sempre lei.
La smetta. O quantomeno vada da un buon psichiatra per curare questa sua dissociazione.
Cara Fatina, io ho una sola identità, ed è quella di Elio Matassi ed ogni volta che mi pronunzio mi firmo come Elio Matassi. Tutti gli altri nomi sono di persone che hanno deciso di intervenire autonomamente, perché non ho nessun potere su di loro e nella maggior parte dei casi non li conosco neppure. Credo che uno psichiatra sia piùn adatto per Lei, Fatina, che si nasconde dietro fantasiosi pseudonimi. Io non ho bisogno di farlo e non ho bisogno neppure che i numeri siano duecento, trecento o altro. Il problema è sempre lo stesso, di una identità sicura. La dissociazione è solo sua, che attribuisce agli altri, quello che invece Lei stessa sta praticando, la non trasparenza. Basta!!! Da questo momento in poi non risponderò mai più né a fatine né a massinisse, perché non ne vale la pena e perché questi sono in malafede. Basta!!! Vorrei proprio guardarvi dritto negli occhi per esprimervi tutto il mio sano furore!!!
Ma alla fine la pentola a pressione chi l’ha vinta?
io tengo per la fatina, perchè lei sa ed è buona. Potrebbe fare swish con la
bacchettina
PS: care fatine e massinisse, vi è un’occasione pubblica in cui potete ascoltarmi: 14 settembre, ore 15.30 Carpi (Modena), lezione magistrale: musica come filosofia. Oltre il primato conoscitivo del theorein. Festival di filosofia di Modena, 14-15-16 settembre 2007. Sono queste le occasioni (e sono circa 100 all’anno) che mi ‘compensano’, non certo i numeri di nazione indiana. In questo preciso momento ho controllato le mie citazioni internet, sono 10200. Questi sono gli unici numeri che mi interessano. La mia identità è sempre la stessa, quella di Elio Matassi, che parla e scrive sempre rivelando pienamente la sua identità e non si nasconde mai. Non voglio più tornare sulla questione. Gli insulti non mi interessano, mi interessano le idee.
Purtoppo la persona cui stavo dettando ha sbagliato indirizzzo che ora correggo.
PS: care fatine e massinisse, vi è un’occasione pubblica in cui potete ascoltarmi: 14 settembre, ore 15.30 Carpi (Modena), lezione magistrale: musica come filosofia. Oltre il primato conoscitivo del theorein. Festival di filosofia di Modena, 14-15-16 settembre 2007. Sono queste le occasioni (e sono circa 100 all’anno) che mi ‘compensano’, non certo i numeri di nazione indiana. In questo preciso momento ho controllato le mie citazioni internet, sono 10200. Questi sono gli unici numeri che mi interessano. La mia identità è sempre la stessa, quella di Elio Matassi, che parla e scrive sempre rivelando pienamente la sua identità e non si nasconde mai. Non voglio più tornare sulla questione. Gli insulti non mi interessano, mi interessano le idee.
matassi o ludovica?
la persona cui stava dettando si è confusa con tanti fogliettini
Ho già detto che mi interessano le idee e non gli insulti. Sanno tutti che Elio Matassi non potrebbe mai essere una Ludovica e che tiene molto a questa distinzione. E’ stato solo un errore di battitura.
io sono sulla garzantina
ma lei pensa che Elio Matassi abbia bisogno di fogliettini?
per un errore del genere si può essere messi alla gogna per le vie di modena
lei non sa chi sono io lo dice lei non io
Matassi, ha visto? Le bugie hanno le gambe corte.
Mi fa quasi tenerezza… Diciamo che gesù bambino l’ha punita per le sue marachelle…
Ma mi chiedo, che cosa la spinge (lei che senza dubbio è persona colta) a svergognarsi così?
Chi non prova vergogna a sputare sulle persone nascondendosi è un malato o un incivile, comunque non merita alcuna attenzione, stesse pure sulla garzantina.
Piena solidarietà al Prof. Elio Matassi per gli attacchi pretensiosi e di lignaggio tutt’altro che nobile, un saluto ed un augurio di buone vacanze a tutti i membri del blog, dulcis in fundo agli autori del romanzo e della recensione,
Auf ein baldiges Wiedersehen!
Ultimo messaggio per il clan degli affetti da sindrome acuta di frustrazione da pseudonimo. Ignorate da sempre, sin dall’inizio, un dettaglio, ma un dettaglio decisivo che dimostra matematicamente, ossia al 100% la mia innocenza. Lo propongo alla fine come piccolo enigma e piccola sfida alla vostra intelligenza.
Schelling e Steiner avevano ragione: il pensiero è “triste” ma noi non possiamo vivere senza questa tristezza, fa parte di noi stessi. Egon ha perduto per sempre la possibilità di essere triste, perchè ha perduto quella di pensare, di essere autonomo, trasparente.Tutti dovremmo meditare su questo, in particolare quelli che appartengono al clan dei frustrati da pseudonimo.
la clipboard del submit comments, questa su cui sto scrivendo, ha la casella del Name (required) che memorizza l’ultimo nome utilizzato, per non dover riscriverlo ogni volta. Se lo devi cambiare 4 volte in 10 minuti,
come dalle 14 57 alle 15 07 ovvero 3 volte dalle 16 50 alle 17 00 del 25th july può capitare, se non sei sempre sveglio, che ti dimentichi di cambiare l’ultimo digitato.
Il Nostro, quello delle 10200 citazioni contate in internet, nella concitazione del non-sa-chi-sono-io, si è dimenticato di cambiare l’ultimo delle 16 52 prima di sottomettere quello delle 17 00.
xDell’Orco
io ho sensate e oneste ragioni personali per non firmarmi. Potrei non commentare e limitarmi a leggere le marronate che si postano qui. Me lo ripropongo spesso ma poi non resisto all’impulso di reagire
all’insopportabile.
Massinissa capisce di computer ma non capisce quello che dico. Ho già detto che sin dall’inizio vi è un dettaglio decisivo che lui ovviamente non conosce e per il quale sono matematicamente innocente. Affido alla sua intelligenza di scoprirlo. Ma vedo che non capisce e non posso farci nulla. In questo momento stesso parto per concentrarmi nella stesura finale di un libro che devo consegnare tra pochi mesi e non ho più tempo da dedicare a nessuno.
Saluti di buone vacanze a tutti
Che squallore! Ho letto il dibattito fin qui, prima con curiosità, poi con pazienza (l’ho letto tutto insieme e per la prima volta adesso) ed infine con grande delusione.
Ma chi sta scrivendo cosa? Il terribile errore di Ludovica/Matassi di ieri non mi sembra lasci spazio ad equivoci!
P.S. Ho letto il libro, teoricamente in oggetto, qualche mese fa, pur non potendo resprimermi nella maniera sublime ed entusiastica di molti (?) che sono intervenuti, debbo dire che la lettura è risultata piacevole ed interessante, come la “fiammiferaia”, sono lontana dai voli altissimi degli altri commenti, però onestamente inviterei gli scriventi a leggere ciò di cui scrivono, perchè mi sembra che pochi l’abbiano fatto
allora diciamo che non usi il pc perchè sei all’antica. La tua segretaria, cui invii per piccione pneumatico le tue perle, si affanna ma non ce la fa a stare al passo perchè sei un baleno.
A poche ore dalla chiusura dei commenti debbo ringraziare tutti coloro che si sono avvicinati al mio romanzo con serietà, attenzione e genuino spirito critico. E prima di tutti il Prof. Elio Matassi, che, conosciuto appena tre mesi fa alla Fiera del libro di Torino, si è subito innamorato del mio libro sostenendolo con la convinzione, la tenacia e l’entusiasmo che ognuno ha potuto notare. Egli in effetti ha colto, motivandola come io mai avrei potuto, la radice “musicale” di “Delfi”, che ha sede, come ho già detto nei precedenti interventi, nel mio particolare metodo di articolazione della forma romanzo, il quale trasferisce nel medium del linguaggio la composizione musicale. Un’altra sorprendente affinità mi lega ad Elio Matassi, ed è il comune amore per Adorno, un autore ingiustamente dimenticato dalla cultura ufficiale a vantaggio dei suoi sedicenti prosecutori (ma in realtà affossatori) Habermas e allievi. Queste coincidenze inattese, scoperte nel giro di qualche settimana, hanno sollecitato a tal punto la entusiastica generosità del professore, da fargli segnalare il libro presso gli ambienti filosofici e accademici di Roma e di Milano, con la conseguenza che molti prestigiosi filosofi e musicologi, ai quali va tutta la mia gratitudine, se ne sono appassionati e hanno partecipato al dibattito. Questo è quello che è realmente accaduto, ad onta delle ingiuriose e paranoiche tesi avanzate da alcuni.
Di “Delfi” non ho mai detto nulla, né dirò nulla in futuro. Posso parlare di come l’ho fatto, ma mai e poi mai di ciò che esso è. Spero solo che chi lo legge provi l’emozionante senso di libertà e di gioia che ho provato io nello scriverlo. Solo questo importa.
Massinissa secondo me, oltre ad essere incorso nel do con l’accento, non ha colto che Matassi abbia poca dimestichezza con i computer
piscialletto
Sono giunto per caso e solo adesso in questo blog e vorrei sapere se nei prossimi tempi sia prevista una presentazione di “Delfi” in qualche città d’Italia.
Caro Massimo, la prossima presentazione di “Delfi” si terrà a Fano, piazzetta di via del Teatro, il 13 agosto alle ore 11, nell’ambito della manifestazione “Beckettgrafie”. Ti aspetto.
non si entra per caso in archivio.
Ci si entra però via link di Hacca, dunque Massimo non può che essere entrato da lì se non è stato qui teleguidato. Ma perchè non si è rivolto direttamente ad Hacca? L’home page è piena di servizi informativi.
No, si vuole fare l’annuncio a più persone, va bene, ma perchè così obliquamente? Lo si annunci in bacheca, lo si annunci pure qui, ma diretto, domineddio! Perchè questa manfrina? Chi è ad onta?
Voglio tornare a spostare il dibattito sul suo terreno, su quello delle idee e del pensiero . Basta con gli insullti che sono strumentali. Riparto dalla trisstezza del pensiero, dopo aver di recente letto il bel libro di Steiner che ben si adatta al romanzo Delfi. Il fallimento di Egon, il protagonista, è anche un modo di abdigare alla tristezza del pensiero Egon non riesce più a pensare e non riesce più ad essere triste.
E’ da qui che dobbiamo ripartire.
ciao prof, non me ne voglia, si rilassi e non abdichi.
Finalmente il dibattito sta riprendendo quota perchè Delfi è un romanzo che lo merita, si fa leggere e fa anche pensare.
Matassi, ma lei è davvero fuori, se lo lasci dire. Sto ridendo a crepapelle, lo giuro. Adesso si firma Chiara Mizzoni. Tra l’altro il modo in cui so che Chiara Mizzoni è Elio Matassi è talmente semplice che il fatto che lei non se lo immagini neppure depone a favore della sua radicale ingenuità. Dunque, nessuna colpa. Solo, ancora, molta tenerezza.
Ripeto: con le sue 10mila citazioni sul web e con il suo invito a Modena filosofia, chi glielo fare di esporsi a questo?
Matassi, stavolta mi sono sbagliata. Stavolta era vero che la signora è persona a lei vicina, ma non è lei. Stavolta mi perdoni.
dolce perfetta fatina, al lunedì sera cosa fai?
Il lunedì sera punto la bacchetta verso lo specchio. Poi brillo e luminesco. Gli altri giorni idem. E’ solo in questo lucus a non lucendo che prendo forma e consistenza.
Delfi è un vero e proprio romanzo musicale. Credo di essere l’unico ad everlo detto.
Non era mai stato notato da nessun critico letterario. Vorrei che qualche critico letterario si pronunziasse su questo mio parere e sulla struttura musicale del romanzo. Che ne pensano a tal proposito Massinissa e la Fatina ?
non abbocco, nay, mi abbiocco
Egregio Prof. Matassi,
non sono un critico, ma soltanto un poeta e, in quanto tale, avevo fatto notare all’autore il senso della musicalità in Delfi.
Un direttore d’orchestra che riesce a utilizzare tutti gli strumenti a sua dispozione affinchè il concerto vibri di tutte le sfumature e le essenzialità emotive in esso contenute.
Se ne vuole sapere di più e se si accontenta: “Lettere Meridiane”, Città del Sole Edizioni, n° 10, Aprile / Maggio / Giugno 2007.
Forse il mio concetto di musica è diverso dal suo, ma cosa conta?
L’importante è che tra le pagine del romanzo il lettore riesca a SENTIRE un suono che c’è e che, di volta in volta, muta il suo tono in sintonia con le
vicende narrate. La saluto con viva cordialità.
si rende conto, Prof, che affermando di credere di essere l’unico ad averlo detto ha dato del ruffiano agli annuenti che sono intervenuti qui?
Ringrazio Jolanda Catalano ed anche Massinissa per avermi risposto. Non vedo questo automatismo così terribile tra l’essere daccordo con me e dimostrarsi succube delle mie opinioni. Importante è il dibattito e tutte le implicazioni, anche quelle polemiche.
Prof, avevo già detto che lei mi stava simpatico, adesso comincio anche ad avere stima. Se continua così vengo a Carpi. Anzi verrò di sicuro, io sarò quello che le offrirà una birra. Lei si schermisca e declinando mi sorrida.
Aggiungo solo, secondando la mia vis, che qui di terribile non è successo niente, solo una campagna di cattivo gusto e di pertinenza discutibile.
Ciao Bello, suo
Massey Ferguson
Dico solo questo: vado spesso al festival di Modena. Un appuntamento di grandissimo rilievo e spessore, dove vengono invitati i più grandi filosofi e intellettuali del mondo.
spessore, eh già, volevo dire, anche bi-partisan e assolutamente sì.
siamo su Amica qui? Forse ho sbagliato io, Prof.
Sono soddisfatto del miglioramento dei rapporti con i miei interlocutori; ovviamente l’appuntamento modenese è aperto a tutti; chiunque voglia parteciparvi può farlo liberamente e non posso che essere felice di venire ascoltato da tante persone intelligenti. Non chiedo mai a nessuno di essere totalmente d’accordo con le mie opinioni. Anche quelle molto diverse dalle mie mi stimolano e mi migliorano e quindi ben vengano!
La musica è filosofia: mi permetto di segnalare a questo blog che domenica prossima, intorno alle 20, su radio 24, ci sarà una puntata dedicata alla musica di Nietzsche e di Wagner.
Sono d’accordo con Riccardo sul fatto che la musica sia filosofia. Un punto di discussione però potrebbe essere il fatto se, nel loro rapporto, debba essere la musica a seguire la parola della filosofia o la parola della filosofia il suono della musica.
questo è il dilemma
Non sono d’accordo con i due precedenti commenti. Musica e filosofia, conformemente ai loro nomi e alla loro storia, sono cose toto coelo differenti. Nascono entrambe dall’uomo e dai suoi problemi, ma li declinano e li risolvono in modo radicalmente diverso. La comune origine non deve coprire la loro differenza e la loro differente funzione individuale e sociale. Quanto al fatto se la prima debba seguire la seconda o viceversa, ritengo che si debbano influenzare a vicenda, nel senso che la musica non possa prescindere da una visione vera e giusta del mondo, così come la filosofia sarebbe priva di senso se non percepisse l’espressione umana presente nell’arte e nella musica.
Preciso: ho risposto ai commenti di Riccardo e di Elena.
“Delfi” narra la storia dell’ investigatore Egon Hereafter – uno dei migliori nel suo campo – che, ricevuto l’ incarico di indagare su una misteriosa intrusione nel tempio di Apollo, prende l’ intera vicenda alla leggera, per finire poi, ad occuparsene con un’ ossessività quasi maniacale. A Delfi, Egon troverà un mondo ed una realtà al limite del surreale. Dominata interamente dal Controllo, un’ organizzazione invisibile, una sorta di soffocamento delle idee, di cui neanche gli abitanti stessi conoscono il vertice. Il Controllo sovrasta la città, le vite, il lavoro e, perfino la psicologia dei cittadini che, credendo di possedere una loro autonomia mentale, attuano, in realtà, la volontà del Controllo, senza neanche accorgersene. I membri stessi del Controllo manifestano ambiguità, sia morale che fisica. Il capo è addirittura un uomo, morto biologicamente, al quale è stata mantenuta in vita la capacità cerebrale, che gli consente di comandare. In tutto questo brulicare di personaggi grotteschi, spicca Castalia, della quale Egon finirà per innamorarsi. Con il passare del tempo, l’ indagine, anzichè progredire, si addentra in una spirale di passi falsi, quesiti, dubbi. Il romanzo piace, appassiona, cattura, trascina. Pagina dopo pagina, si entra in un tale vortice di mistero, surrealismo e suspense, che quasi non si riesce a distorgliesene. Dell’ Orco sà ben rappresentare questa “assurda” società di Delfi. Innanzitutto il potere del Controllo, questa associazione che tutto vede e può. Effimera dispensatrice di uguaglianza e democrazia. Ingannatrice! Invisibile! La realtà è ben diversa. Il popolo, tutti gli abitanti di Delfi si illudono di essere liberi! Ogni loro movimento, passo, lavoro e, perfino, pensiero, vengono decisi dal Controllo. Tutto questo ci ha, automaticamente ricordato il film “Le vite degli altri” di Florian Henckel von Donnersmarck, vincitore del premio Oscar 2007, come miglior film straniero. Ambientato negli anni 80, nella ex Repubblica Democratica Tedesca. Allora, la Stasi, spiava, controllava, la vita di ogni cittadino. Filo conduttore del film, il personaggio di un’ agente della Stasi, nascosto in uno scantinato a pochi isolati dall’ appartamento della coppia protagonista da sorvegliare. E’ lui la spia, il singolare deus ex machina, che non interviene dall’ alto, come nella tragedia greca, ma opera dal basso, chiuso tra le pareti dell’ ideologia abbattuta dalla bellezza dell’ uomo e dalla sua arte. La stretta sorveglianza, le perquisizioni, gli interrogatori, la limitazione di ogni forma di espressione, conducevano le persone all’ impossibilità di essere e pensarsi felici. Se non ci si atteneva alle regole, “misteriosamente”, si scompariva. Un pò come avviene in “Delfi”. Lo “straniero” che non vuole “adattarsi”, subisce una sorta di esilio. Ma rispetto alla Stasi, il Controllo è qualcosa di più! Più sottile, più subdolo, più illusorio. Sembra consentire una maggiore libertà, invece toglie la cosa più importante: la dignità. Ecco che Egon, lo straniero, può diventare un’ elemento discordante per il Controllo, mettendone in dubbio regole ed avvertimenti. Rappresenta un pericolo, reso reale, dal suo amore per Castalia, abitante a Delfi. Desiderando avere una relazione con lei, potrebbe sortire l’ effetto di un “risveglio”, un rendersi conto che si stava vivendo in un luogo dove l’ essere tutti uguali è mera utopia. Il romanzo contiene, inoltre, reminiscenze kafkiane. Difatti, l’ aggettivo kafkiano, è spesso usato per fare riferimento a situazioni assurde, paradossali e angoscianti. Alcune sue opere sono, a dir poco, surreali. Ne “La Metamorfosi”, il protagonista, Gregor Samsa, si sveglia, trasformato in un’ insetto! Dell’ Orco, ovviamente, non si avvale di simili metafore, però, a nostro avviso, è a buon punto! Sà mostrarci situazioni paradossali ed assurde, con grande maestria, avvalendosi di un’ ampio “bagaglio” culturale ed artistico. Un libro da leggere tutto d’ un fiato!
Io non credo che la musica e la filosofia, come tutto il resto, siano opera solo dell’uomo. Se così fosse, saremmo sempre nel dubbio del vero, se una cosa sia vera o no (chi potrebbe obiettare qualcosa di fronte all’affermazione che, essendo solo dell’uomo, solo un punto di vista, un fare dell’uomo, un qualcosa, proprio per questo potrebbe essere non vero). Credo piuttosto che la questione, da Cartesio fino a Heidegger, sia stata risolta, arrivando a pensare che il rapporto tra soggetto e oggetto non sia più un problema (che possa sorgere un dubbio che un qualcosa sia solo frutto del pensiero dell’uomo o che sia il mero oggetto o che sia l’uno e l’altro insieme non è più un problema: per fortuna tutto ricade sotto la volontà e il dominio dell’uomo). Ecco perché, il “peso più grande”, come diceva Nietzsche, rimane la responsabilità. Per certi aspetti, un giogo. Ma un giogo che libera. Perché, pur non potendo, necessariamente, sottrarci alla responsabilità, essa, nella sua struttura, rappresenta l’essenza della libertà.
Rispondo velocemente a Riccardo – riservandomi una risposta più articolata più tardi – dicendo che per la musica, per l’arte e – addirittura! – per la stessa filosofia non è essenziale il problema della Verità, dichiarata inattingibile fin da Kant, ma quello appunto del dolore umano che è possibile alleviare qui e ora.
Ciò detto, vorrei porre l’attenzione dei partecipanti al blog su un articolo apparso oggi sul Corriere della sera, dal titolo “Adorno cattivo maestro. Dei critici.”, in cui Alessandro Piperno, a conclusione della recensione di “Stile Novecento” libro di saggi di Giorgio Ficara, commenta il pessimismo di quest’ultimo sulla narrativa italiana contemporanea con queste (incredibili) parole.
“Ma so anche che dietro il discorso di Ficara si sommuove il nero fantasma di Adorno. E’ lui, quel vecchio inacidito snob, che leggevamo ai tempi dell’università compiaciuti dell’indignazione che solo lui sapeva infonderci, il grande corruttore. E’ lui, con il suo cattivo umore, ad averci impartito lezioni di aristocrazia apocalittica. Forse è venuto il tempo di contrastarlo. E chissà che le “invasioni” che lui considerava fatali alla letteratura… non siano il prezioso diamante del tempo a venire?”
Delle quali non si sa se piangere per la vergognosa e abissale ignoranza filosofica (e la volgarità) che evidenziano, o se ridere per l’aperta confessione di minorità e dipendenza culturale contro la quale, dopo appena trentanni, ci si ribella.
A presto.
il problema è il dolore di leggerti, così luogocomunista, così anonimo, così
scolare, così falsamente mesto e medio-reattivo, così subalterno
Di nuovo la storia di Adorno cattivo maestro, una volta dei giovani sessantottini, che avrebbe spinto all’azione violenta, ed ora dei critici. Storia inventata di sana pianta per i sessantottini – basta vedere i suoi testi di quel periodo e in particolare il saggio “Note marginali su teoria e prassi”, apparso in Italia in “Parole Chiave”, SugarCo Edizioni, in cui combatteva la prassi cieca e violenta che antivedeva e intravedeva nel movimento studentesco -, e storia inventata ora, o meglio pretestuosamente chiamata in campo, per tentare di togliere ogni residuo impaccio ad una letteratura “acqua e sapone”, in cui “si scrive come si mangia”, in cui la realtà empirica è rispecchiata pedissequamente, e in cui, finalmente, si celebrino le smemorate nozze fra romanzo e mercato, senza proteste e inutili sensi di colpa, e con l’unanime soddisfazione di lettori, editori ed autori.
La pretestuosità sta in ciò, che non è Adorno ad esser chiamato in causa – Adorno è abbondantemente al di sopra della comprensione di Piperno, almeno a giudicare dalle parole dell’articolo – ma qualsiasi istanza critica che osi mettere in discussione il potere – già assoluto – del mercato sul romanzo.
L’articolo di Piperno mi ha fatto venire in mente un’altra recente questione letteraria, accaduta qualche giorno fa, quando un aspirante scrittore ha inviato a diverse case editrici romanzi di Jane Austen attribuendoseli come propri. A parte la presunta non conoscenza da parte della case editrici di noti romanzi, ciò che si evince riporta la questione sopra agita del rapporto soggetto-oggetto. Perché se un dato libro è stato scritto da x ha un valore, mentre se lo stesso è stato scritto da y ne ha un altro, forse nessuno? Per altri aspetti, non è quello che fece Borges con tale Renard che riscrive il Chisciotte? Ecco perché la questione è che l’opera d’arte deve avere e ha come origine solo sé stessa, l’arte. Per essere tale dev’essere svincolata, assoluta, sciolta da tutto. La letteratura, quindi, e tutto il resto, per essere tale, deve sganciarsi sganciarsi dal tutto. Ma è per questo motivo che Piperno, nel suo articolo, vincolandosi alla priorità dei personaggi (ciò che vale secondo lui) rovesciando il problema (svincolandosi cioè dall’autore) commette lo stesso errore di chi invece è legato all’autore dei personaggi (il romanziere, il narratore: l’autore). Sono due facce della stessa medaglia, che agiscono con la stessissima logica. La filosofia questo problema l’ha risolto. Come si diceva prima, e per i motivi di cui sopra, si è inerpicata al di là del soggetto e dell’oggetto. La letteratura è letteratura, la musica è musica, la filosofia è filosofia, la pittura è pittura ecc. quando ciascuna è in grado di cogliere questo al di là (un al di là inteso hegelianamente, quello della coscienza). Ovvero, l’essenza della tecnica.
adesso si vuole coinvolgere piperno, mica per amore del dolore o di adorno, nooo!, per fare clamore, per promozione un’altra volta. Se piperno abbocca è un pirla, voi siete inqualificabili, diciamo prava gens
“Il vischioso e planetario cousinage mediaticodella comunicazione di massa dell’era televisiva” di cui parla Ficara e che Piperno sottovaluta al punto da considerarlo come possibile generatore del “prezioso diamante del romanzo a venire” è lo stesso della produzione culturale per l’audience, che ci ha portato alla cultura spazzatura su tutti i media – romanzo compreso – e alla nefasta adaequatio tra pretesi bisogni delle persone (in realtà continuamente indotti dagli uffici studi delle major) e quello che gli si propina. Questo è ormai sotto gli occhi di tutti e non come ai tempi di Adorno, in Italia, agli albori. Come si faccia a non vederlo è inspiegabile.
gaurda che l’ era televisiva è morta, l’uomo a una dimensione non esiste più, la legislazione ne ha preso atto (creative commons, ti dice niente?) e tu sei ancora qui a parlare di omologazione, bisogni indotti, adaequatio
sono con te, massey, fin dal principio
Se prima di liberarci di Adorno provassimo a liberarci da Kant per dire che l’arte senza Verità non sussiste e che la Verità si dà a conoscere nell’arte (non solo..) e difficilmente nella filosofia, in cui la metodologia non si autotrascende mai nell’esperienza ed in cui la Verità rimane, sì, “ricercabile” ma pur sempre “inattingibile”? Ed è proprio questo procedere dell’arte dalla Verità, il fare, nell’arte, “esperienza” della Verità qui ed ora, può, talvolta, alleviare quel dolore che è reale e vero qui ed ora.
oh, sì, ludovica, ancora, ancora, dai che sto per venire nel lobo frontale dx… peccato che tutto questo c’entri poco con la grande letteratura e con la sua saggia distanza dalle astratte e vanagloriose elucubrazioni degli intellettuali come voi.
Questo brano di “Stile novecento”, Marsilio 2007, di Giorgio Ficara, con cui concordo, giustifica ampiamente i miei ultimi tre interventi che avevo fatto sulla sola scorta della recensione di Piperno. Esso è contenuto nel capitolo “Italiani” (-scrittori -ndr).
“La letteratura sovranazionale dei romantici e la coscienza nazionale non erano poi così lontane. Erano entrambe universali e si ispiravano alla nozione di identità letteraria: siamo uomini in quanto costruttori di identità e questa costruzione si chiama letteratura. Le regole del mercato globale sono diverse: la letteratura è una merce che ci viene offerta, ma non è distinguibile dall’insieme stesso delle merci.
Quando ascoltiamo le dichiarazioni di questi scrittori globali (-da mercato globale – ndr) o aspiranti globali la parola ricorrente è narrazione, storia. L’umanità avrebbe bisogno di storie per addormentarsi, per passare il tempo, come di giacche di Valentino per coprirsi. L’ipotesi di un bazar della letteratura che risponde a un bisogno di narrazione fondato fisiologicamente come il bisogno di cibo, sembrerebbe realizzata in questi ultimi anni. Ma questo bazar non ha niente a che fare con l’identità letteraria, né con la sua difficoltà a preservarsi, crescere, essere ricordata. Ancor meno con l’universalità di cui è e sarà sempre una caricatura triste e proterva.”
Dove è appunto ribadito che il mercato è la grottesca caricatura dell’universale: infatti è l’universale che si realizza e continuamente si potenzia sugli uomini, e nonostante gli uomini, attraverso il loro cieco antagonismo, attraverso il bellum omnium contra omnes, e non attraverso la loro cosciente volontà e il loro comune accordo.
Continuazione. Come ben nota Ficara, l’identità, cioè l’Io autonomo, la coscienza piena del mondo e la piena libertà di agire, trova, nell’attuale mercato globale, una piena espressione di sé quasi solo nell’arte e nella letteratura, e anche lì con grandi difficoltà. E’ una dimensione irreale quella estetica, perché è finta – non per nulla gli anglofoni chiamano senza complessi “fiction” ciò che noi chiameremmo arte – ma per lo meno esiste, e garantisce ancora uno spazio e un mondo – sia pur finti – per l’espressione della libertà umana e di una possibile, e al momento utopica, universalità. Da questa nicchia protetta, ermeticamente chiusa ed isolata, una delle poche rimaste all’individuo, si vorrebbe scacciare lo scrittore, invitandolo alla socievolezza, alla comunicazione franca e diretta, alla narrazione, al messaggio, alla storia immediatamente consumabile, per esaudire i bisogni delle persone stanche del lavoro, per ritemprare le loro forze… affinché tutto continui com’è, in loro e fuori di loro. Questo vuole il mercato, che l’immane ruota continui a girare, senza posa e senza senso, ben oliata da una compiacente industria culturale che non si distingue più dall’industria tout court.
E giustamente Ficara dice che non dev’essere così, che l’identità deve essere preservata, che l’individuo nella letteratura deve dare compiti a se stesso (almeno lì), e non farseli dare da quel mondo da cui si è appunto ritirato per non riceverli. A costo di isolarsi, a costo di non essere pubblicato e venduto, a costo di non essere capito – esprimere pienamente la propria libertà e il proprio rifiuto a un un mondo che la nega, e cercare di comunicare il pathos e il brivido di questa scelta ai lettori.
Baby, lascia perdere, che si fottano. Ti porto sull’oceano, a Swampscott, conosco un ristorantino dove servono astici al vapore fantastici, poi andiamo nell’avamposto di Marblehead a prendere il sole
Dell’Orco non è a caccia di migliaia di copie, ma di prestigio.
Lo si capisce già dal titolo e dalla copertina del libro in sproloquio. Sbava per il prestigio. Trotta come un parcheggiatore dietro ogni possibile recensore “qualificato”.
Dà fondo a tutte le sue masticazioni pur di produrre un’accensione. Ma l’innesco latita.
Perchè la tua scrittura non è sexy , caro Sandro, indipendentemente dagli argomenti più o meno vieti che arieggi e dalle compagnie che frequenti.
Cara Ludovica,
non dobbiamo liberarci né di Kant, né di Adorno, ma da ogni metafisica, da ogni sistema, da ogni monismo, religioso o filosofico che sia. La letteratura, come ho già detto in questo blog, non ha nulla a che fare con la Verità, non fosse altro perchè essa è, innanzitutto, finzione. Essa esprime, da sempre, i desideri, le pulsioni, le emozioni della gente, e così, se vuoi, è un indice del dolore e della gioia che società e natura fanno all’uomo in un certo momento storico.
Quanto alla Verità, all’Assoluto, all’Essere, hanno cominciato a morire per lo meno da Cartesio, dalla scoperta dell’Io e della sua autonomia, vero punto cieco e irresolubile di ogni metafisica.
massey ha capito l’antifona e lo ha detto e ridetto, solo soletto fra questi abbacinati da se stessi, e per questo lo ammiro. questa si che è resistenza. che il tempo gli renda giustizia! eccomi, marlowe, ora possiamo andare.
“L’uomo a una dimensione” è sempre stato. Rappresenta l’essenza della metafisica. Non si tratta qui di un accadimento storico: si tratta esclusivamente di una presa di coscienza in qualche modo messa in evidenza.
fascino di marlowe, ti capisco, io ti avrei portato a mangiare le alborelle fritte a castelletto ticino :-(
Nella disputa tra Piperno e Dell’Orco io sono dalla parte di Del’Orco.
Mi sembra che il giudizio espresso su Adorno sia troppo sommario; i “Minima Moralia” sono un capolavoro del ‘900 e l’attualità di Adorno è dimostrata anche dal romanzo “Delfi” che è un romanzo profondamento adorniano .
Caro Dell’Orco, è evidente che abbiamo un’impostazione diversa. Per me la letteratura, come tutta l’arte, non è finzione, anche se la finzione può esserne una componente (mi riuscirebbe difficile pensare come finzione, ad esempio, la musica). Non vorrei cancellare dalla storia della filosofia né Adorno né Kant, ma assumerli criticamente. Penso, inoltre, che il pensiero metafisico non abbia mai cominciato a morire ma sia stato, talvolta, oscurato da un soggettivismo in ultima istanza tanto sistematico quanto una certa metafisica. Non penso infatti alla metafisica come “sistema” ed ho un’idea molto concreta della verità, di cui, infatti, sono convinta che ogni essere umano possa fare esperienza, proprio a partire dalla propria vita, dalle proprie emozioni, pulsioni ecc… L’arte non si limita ad esprimerli, ma è capace di caricarli di senso, di rivelarne in qualche modo il senso, riuscendo a trascendere anche la propria epoca (mi viene in mente la potenza utopica della musica in Ernst Bloch, la sua “non contemporaneità storica” che svela utopicamente il presente).
“”Delfi” è un romanzo profondamente adorniano”
è questo il vostro problema, miserelli! mica dite manniano, stendhaliano, flaubertiano, donchisciottesco, borgesiano o al limite, che ne so, ciropedico.
(o kafkiano, giusta la fascetta pubblicitaria.)
no: adorniano. un romanzo adorniano! tornate nelle batterie, e rimaneteci.
Mi permetto di aggiungere un ulteriore elemento di discussione che considero un elemento chiave nella lettura adorniana di questo romanzo kafkiano: alexandre pato sarà il nuovo kakà???
caro zio tom,
questione irrilevante, totti se li beve entrambi
stica!
bravo Sandro, il faut bien se rigoler un peu
sì, ma solo un po’, mio caro ‘mecon!’, il dovere mi chiama.
Cara Ludovica,
il problema della verità pertiene ai concetti, ai giudizi, ai sillogismi, cose mentali, eteree, intangibili, insensibili, cose della memoria e delle altre funzioni celebrali: un concetto, un giudizio, o più giudizi in un discorso, per quanto veri, cioè – diciamo così per non complicare le cose – aderenti alle cose, al logos che le governa, rimangono pur sempre cose impalpabili della mente. Con un discorso vero puoi arrivare a dire la causa, o la concatenazione di cause che, secondo una legge, producono un dato evento. Ma ciò che inevitabilmente rimarrà fuori sarà il desiderio, la repellenza, la paura, la sorpresa, il piacere, il dolore: in una parola l’emozione che quell’evento, o quella catena di eventi, hanno provocato in noi. Anzi, quanto più lasceremo fuori le emozioni dai concetti e dalla loro connessione, tanto più aderente al logos delle cose sarà il discorso. Cioè: il concetto porta nella nostra mente solo le caratteristiche della cosa che la fissano, la rendono uguale a se se stessa, e quindi perfettamente rispondente al principio di identità (e non contraddizione), A uguale ad A, che è alla base del ogni nostro ragionamento vero. Questo “trattamento” che il concetto riserva alla cosa, è il prezzo che paghiamo alla verità: se non facessimo così torneremmo all’animismo e alla magia della preistoria, o al medioevo, ma se facciamo così ci perdiamo un “pezzo” importante della cosa, anzi, il più importante, la gioia, il dolore o comunque l’emozione che essa ci induce, l’azione spontanea che essa è in grado di ispirarci. La filosofia, che mira alla verità, non può eliminare questo suo vizio d’origine, ma l’arte, che non mira alla verità, e non è vincolata – in generale – ai concetti e alla logica, lo può. L’arte diventa dunque la voce del represso, l’espressione di ciò che l’Identico, il principio di identità, tengono schiacciato sotto di sé e nascondono, la voce della natura dentro e fuori dell’uomo. Non che all’arte sia consentita l’irrazionalità, no, facendola l’uomo, ed essendo destinata ad altri uomini, essa deve essere, comunque, comunicabile, e dunque avere anch’essa un linguaggio, una sintassi, una logica, ma essa è (cito Adorno dal mio commento in questo blog del 30 giugno) “ paradossale se si giudica secondo le regole dell’altra logica. E’ un procedimento deduttivo senza concetto e senza giudizio. Sebbene le opere non siano concettuali né giudichino esse sono logiche. In esse niente sarebbe enigmatico se la loro immanente logicità non venisse incontro al pensiero discorsivo, mentre tuttavia finiscono per deluderne regolarmente i criteri. Più vicine che a ogni altra cosa esse lo sono alla forma del sillogismo, e al modello del sillogismo nel pensiero contenutistico.”
Finzione. Per finzione non intendevo solo la vera e propria finzione o imitazione – comunque presente in quasi tutte le arti – ma il più generale carattere di apparenza delle opere, a cui esse non possono rinunciare. Anche la musica, la più libera delle arti, crea una realtà sui generis che prima non c’era: una serie strutturata di suoni che, se non pone illusoriamente in esistenza una cosa del mondo empirico, pone certo in esistenza illusoria la successione articolata formalmente delle emozioni del compositore. Esse vengono cioè messe fuori, in esistenza, nella realtà empirica, rese indipendenti dal musicista, stanno lì come cose, esistenti di per sé, mentre prima erano insensibili a tutti tranne che a lui. L’imitazione – aveva ragione Aristotele! – è connaturata ad ogni arte, e le dà quel carattere di celia, di scherzo, di amusement, che anche la più seria si porta dietro senza darlo a vedere. Per questo Adorno disse una volta che dopo Auschwitz non si sarebbero più scritte poesie. Per l’incommensurabilità tra l’orrore che era accaduto e quel “divertimento” presente sempre nella fattura dell’opera che avrebbe dovuto rappresentarlo. Incommensurabilità che stride e repelle tanto, nonostante il talento comico di Benigni, anzi, forse proprio a causa di questo, nel film “La vita è bella”.
Sul problema della metafisica alla prossima puntata. Sempre che ci siano superstiti.
Caro Sandro,
innanzitutto si sbaglia, il buon vecchio totti ha fatto il suo tempo…. Comunque lei si dimostra simpatico e io le dico cosa non mi piace dei suoi interventi e quelli dei suoi bravi e dotti amici. Non tanto i vostri pomposi riferimenti pseudo colti e ahimè autoreferenziali (vede com’è fastidioso leggere una frase del genere!), di per sé legittimi anche se tremendamente pallosi, quanto il concetto che passate di arte. E’ quello che non mi va giù. Da che clicco su questo post mi sono ripromesso di non intervenire (lo hanno fatto in maniera brillante altre voci fuori dal coro) ma adesso la cosa è diventata insopportabile e allora dico la mia. L’Arte, sia chiaro, non è una nobildonna che scende dal suo letto a baldacchino, si siede sulla sua poltrona dagli intarsi finemente curati e si imbelletta il viso davanti a uno specchio di puro cristallo sospirando mollemente. Poteva andare bene un secolo fa. Oggi l’Arte è una tipa tutta sfavillante che ti ammicca in un locale affollato di gente e tu le offri da bere e poi magari te la da. Capisce cosa intendo? L’arte non è un palcoscenico per pochi che ostentano la loro erudizione. L’arte è una cosa che uno fa e la gente consuma. Per questo per essere viva deve avere corso nel suo tempo, essere accessibile coi mezzi del suo tempo, spendibile con la moneta del suo tempo, deve amplificare gli impulsi reali che spingono la testa e il corpo della gente. Caro Sandro, è un uomo intelligente, lei pensa sul serio che alla gente freghi qualcosa della “musicalità” del suo romanzo? La gente pensa a come fa a scucire 600 euro al mese per l’affitto se ne guadagna a malapena 1100…io credo che l’arte debba confrontarsi con queste cose, non con Adorno o Kant, marciti sotto un metro di terra. Poi ognuno è libero di fare qualsiasi volo pindarico su qualsiasi cosa ma a me piacerebbe che i libri per prima cosa continuassero a sapere di carta e di colla, la fottuta materia di cui sono fatti.
Il problema della metafisica mi pare che sia stato risolto. Riguarda il rapporto soggetto-oggetto ed è stato ben spiegato da altri interlocutori di cui ho letto sopra. Il problema adesso credo sia quello relativo a se dovremmo cominciare a parlare di metafisica da Platone (io dico di no) o da Parmenide ed Eraclito (e qui dico di sì).
Ribadisco: il romanzo Delfi è un romanzo profondamente adorniano.
adorniano, à poings fermés
finalmente lo zio tom – diciamo lo zio tom – comincia a capire che io parlo per affermare le cose in cui credo, e finalmente gli risponderò.
quanto a totti ha ancora abbastanza tempo per stracciarvi, anche con pato e ronaldinho
Potrei parzialmente concordare se la verità si riducesse alla pertinenza di concetti, giudizi, e funzione cerebrali che la imprigionano nel soggetto (trascendentale), ma la verità è qualcosa che, sebbene non li neghi, li eccede. Non è possibile darne una definizione, che significherebbe proclamarne il possesso, con facili ricadute in fondamentalismi di vario genere. Al contempo, la verità non esclude l’emozione soggettiva che producono gli eventi. Pulsioni ed emozioni soggettive ne sono una modalità di partecipazione, proprio perché sono profondamente vere. La realtà del dolore o dell’amore che si prova non è soggetta ad errore come un giudizio, ma è una reazione vera e reale ad un evento vero e reale. E’ la partecipazione al senso che quell’evento sprigiona. Ciò che rende l’esperienza partecipazione alla verità è il riconoscimento di un senso che trascende l’autoreferenzialità del soggetto, che in quel momento riconosce la realtà nella sua unità e comunicabilità. Non è né una Dialektik der Auflklärung né una metafisica identitaria che consente di svincolare l’arte dall’apparenza per restituirla alla verità come sua “rivelazione”, ma è la capacità di trascendere il soggetto nel mistero e nella forma: nel mistero, perché rimanda al senso che non è mai esauribile e circoscrivibile, nella forma perché questo senso è esperibile e comunicabile. Per ritornare sugli esempi musicali, non è un caso che Eduard Hansilck dia avvio alla critica musicale moderna svincolando la musica dalle emozioni del compositore e (tanto più del pubblico) asserendo che le emozioni non sono il contenuto né lo scopo della musica, ma è l’idea (la forma) in cui il compositore, sì, si esprime, ma lo fa in maniera intraducibile in altro linguaggio che non sia quello della forma musicale. Questo provoca emozioni e sensazioni soggettive che vengono, però, al contempo provocate e trascese nella forma musicale, che Hansilck, chiama, e non a torto, “bello”. Non sono quindi le emozioni del compositore ad essere poste in esistenza illusoria ma la forma, l’idea artistica ad essere posta realmente in esistenza.
Non credo che il valore in tal modo assunto dall’arte sia lesivo della più radicale esperienza umana, né che debba soccombere in nome di un presunto ‘negativo’ o ‘non identico’. Neppure dopo Auschwitz perde la sua legittimità: Primo Levi, dentro Auschwitz, poté percepire la poesia di Dante come “voce di Dio”.
Della bella replica di Giorgio Ficara a Piperno, uscita oggi sul “Corriere della Sera”, ne cito solo la conclusione:”Credo che si debba dare battaglia, e proprio in quanto adorniano, so che, nonostante tutto, molti giovani romanzieri sono già sul campo”. Mi conforta nella mia opinione: Delfi appartiene a questo “campo”, in quanto romanzo adorniano.
in merito all’arte dissento dallo zio tom, da sandro e da lodovica.
Zio Tom: essere del proprio tempo non significa necessariamente confrontarsi coi problemi di bilancio della gente. L’arte, e mi consento io stavolta un richiamo ( benjaminiano), opera sempre in condizioni di emergenza. É sempre critica della realtà, fosse anche quella di un’epoca d’oro. Perchè premonisce, avverte, scardina, scombina. Non sopporta il già detto, l’assegnato, il ridondante. Si misura con la storia (dell’arte) per ricavarne stimoli da rielaborare in modo inaudito.
Sandro: Le emozioni della gente, il dolore di vivere, per un artista sono irrilevanti, come Totti. L’artista ricava stimoli dalle proprie emozioni, certo, vedi il fauve o il primo espressionismo, ma non necessariamente, anzi raramente. Per esemplificare, la storia antica, fino a fine settecento, in occidente, è storia di arte funzionale, e converrai che in quel contesto il dolore e la gioia della gente non sono il movente. Poi si entra nel romanticismo, un cataclisma di portata pluri-epocale che agisce tuttora.
L’artista, alla buonora, scopre sè stesso, ma non già i dolori della gente. Certo ci sono artisti con sensibilità sociale, ma la misura della qualità artistica non sta nei sentimenti di cui l’autore è pervaso in creazione, ma sempre e solo e ancora, dai graffiti rupestri in poi, nel grado di sexyness di una linea, un tono, una forma plastica.
Altro esempio, lo scientismo del periodo che segue, mi concedo tagli grossi, trova sviluppo nel cosiddetto impressionismo. Che dolori e gioie della gente potevano mai importare a un Monet che dipingeva gli effetti della luce (cattedrale di Rouen) nelle diverse ore del giorno? O a un Signac, a un Seurat, che dipingevano per addizione di punti colore, come se fossero pixel di monitor?
Ludovica: con te la faccio breve se no mi coinvolgi in temi che esulano parecchio assai da quello che voglio dire qui: L’arte c’entra con la Verità per via di sensi, ma non in modo esplicito perchè l’arte aborrisce l’Esplicito.
Mind well: questa è una discriminante fondamentale e inconciliabile fra arte e filosofia.
Perchè Sandro è palloso? Perchè esplicita. Tu perchè non capisci la differenza fra qualità artistica e paccottiglia, perchè aneli all’esplicito.
massinissa,
fammi un riassunto
hai ragione da vendere
massa, se me la paghi…
l’arte e la scrittura infine sono due mondi diversi, se li si mescola, volendo dare prestigio alla scrittura e non viceversa, si toppano le analisi.
É comune fra gli scrittori e gli amanti della letteratura fare incursioni nel campo dell’arte. I risultati sono desolanti. Opinionistici. Da bar Benny.
la musica. Cosa c’è di musicale in Delfi, caro Elio, me lo deve spiegare meglio. Per musicale intendiamo un’assonanza? Il rispondersi in contrappunto di un capitolo con l’altro? La struttura di una sinfonia narrativa ? Io nel primo capitolo ci ho trovato solo dei “lui disse e lei rispose”, svolgimenti elementari.
e il piano pianissimo e forte fortissimo? Io vi ho trovato solo un tono monocorde e tedioso.
Forse s’ha da intendere il ritmo, i tempi, la chiave? Mi spieghi per favore. No, no, per carità, scherzavo.
Quando mi sono forzato a leggere il primo capitolo ero prevenuto, ma di buon umore, diciamo in diesis, alla fine della lettura ero in catalessi, diciamo in bemorto diminuito.
quanto a ficara, piperno, adorno, ma chi se ne frega, cosa c’entrano qui?
É evidente che qui si vuole tirare la sfoglia, la fouieda si dice a Carpi, dove a volte la tirano anche dietro qualcuno se riesce male
Cara Ludovica,
lo sai perché qualcuno non ci capisce? Perché non ci ascolta. Ci sente, ma non riflette su quel che diciamo. In preda alla smania di aggressione che lo divora, ci vede ancor prima di leggerci come nemici, e stravolge ad arte ogni argomento perché gli appaia negativo, perché sia l’occasione di scatenamento della sua rabbia. Non è colpa sua, è la sua testa che non va, lui non può che seguirla, e così le cose che dice sono solo i crittogrammi della sua paranoia. Una prova di ciò è la sindrome persecutoria del complotto, della congiura, della dietrologia a tutti i costi. Tu gli dici calmo calmo come stanno le cose, gli porti prove circostanziate e inconfutabili di come si sono svolte, ma lui ancor più furioso, continua ad accusarti e ad insultarti con la schiuma alla bocca. E’ più forte di lui, si deve sfogare: mi chiedo cosa gli hanno fatto da piccolo per aver accumulato tanto rancore. Comunque affari suoi. O purtroppo affari nostri. Un altro sintomo: è arrogante, tronfio, altezzoso, supponente e pieno di sé: ogni sua parola, che non sia l’insulto sprezzante, viene lasciata cadere come l’elemosina nel cappello del pezzente, salvo poi accorgersi che si trattava d’una moneta taroccata. Il nostro infatti non si muove nel mondo dei concetti e dei ragionamenti, che non ha mai dimostrato di possedere, ma nel mondo del lessico ricercato, italiano o preferibilmente straniero, della battutina arguta da quattro soldi, che non appartiene all’arte o alla letteratura, ma all’ambiente vano e vanitoso degli scrittori mancati o dei critici frustrati che gli orbita servilmente attorno, massime se si tratta di quello delle major. Che altro Ludovica? Ti debbo far notare il suo stile tranchant, che serve solo a mascherare la sua limitatezza di pensiero dietro frasi che vorrebbero mimare una concisione alta e sdegnosa, ma che in realtà, striminzite e scontate come sono, sembrano tratte da un bignami di letteratura o storia dell’arte? Oppure ti debbo rammentare che il suo scopo esplicito e dichiarato è il corrompimento – uso un sinonimo – di qualsiasi ricerca e discussione onesta che miri sinceramente a chiarire un argomento per amore dell’argomento? No! Guai! Per lui c’è il trucco! Non può esistere un genuino amore per la conoscenza! C’è qualcosa dietro! Bisogna assolutamente offendere, insultare, irridere i partecipanti alla discussione al solo scopo di mandare tutto a puttane, in modo da poterli vedere come in realtà è lui, in modo da veder confermato quanto la sua paranoia gli dice continuamente nella testa: che lui è il migliore e tutti gli altri sono feccia.
Dormi bene Ludovica.
Tuo affezionatissimo
Sandro
1. Cara Ludovica,
lo sai perché qualcuno non ci capisce? Perché non ci ascolta. Ci sente, ma non riflette su quel che diciamo. In preda alla smania di aggressione che lo divora, ci vede ancor prima di leggerci come nemici, e stravolge ad arte ogni argomento perché gli appaia negativo, perché sia l’occasione di scatenamento della sua rabbia. Non è colpa sua, è la sua testa che non va, lui non può che seguirla, e così le cose che dice sono solo i crittogrammi della sua paranoia. Una prova di ciò è la sindrome persecutoria del complotto, della congiura, della dietrologia a tutti i costi. Tu gli dici calmo calmo come stanno le cose, gli porti prove circostanziate e inconfutabili di come si sono svolte, ma lui ancor più furioso, continua ad accusarti e ad insultarti con la schiuma alla bocca. E’ più forte di lui, si deve sfogare: mi chiedo cosa gli hanno fatto da piccolo per aver accumulato tanto rancore. Comunque affari suoi. O purtroppo affari nostri. Un altro sintomo: è arrogante, tronfio, altezzoso, supponente e pieno di sé: ogni sua parola, che non sia l’insulto sprezzante, viene lasciata cadere come l’elemosina nel cappello del pezzente, salvo poi accorgersi che si trattava d’una moneta taroccata. Il nostro infatti non si muove nel mondo dei concetti e dei ragionamenti, che non ha mai dimostrato di possedere, ma nel mondo del lessico ricercato, italiano o preferibilmente straniero, della battutina arguta da quattro soldi, che non appartiene all’arte o alla letteratura, ma all’ambiente vano e vanitoso degli scrittori mancati o dei critici frustrati che gli orbita servilmente attorno, massime se si tratta di arte e letteratura delle major. Che altro Ludovica? Ti debbo far notare il suo stile tranchant, che serve solo a mascherare la sua limitatezza di pensiero dietro frasi che vorrebbero mimare una concisione alta e sdegnosa, ma che in realtà, striminzite e scontate come sono, sembrano tratte da un bignami di letteratura o storia dell’arte? Oppure ti debbo rammentare che il suo scopo esplicito e dichiarato è il corrompimento – uso un sinonimo – di qualsiasi ricerca e discussione onesta che miri sinceramente a chiarire un argomento per amore dell’argomento? No! Guai! Per lui c’è il trucco! Non può esistere un genuino amore per la conoscenza! C’è qualcosa dietro! Bisogna assolutamente offendere, insultare, irridere i partecipanti alla discussione al solo scopo di mandare tutto a puttane, in modo da poterli vedere come in realtà è lui, in modo da veder confermato quanto la sua paranoia gli dice continuamente nella testa: che lui è il migliore e tutti gli altri sono feccia.
Dormi bene Ludovica.
Tuo affezionatissimo
Sandro
Leave a Reply
Comments m
aspettavo la tua risposta e non mi hai deluso, minor
scusami Sandro, non è per perseguitarti, ma la tua letterina l’hai inviata a Ludovica o a Matassi? Chi mi ha detto calmo calmo come stavano le cose era Matassi, adesso quelle parole le attribuisci a Ludovica? É un riddle
Ciao massinissa, grande, sei in fase di spurgo…
Chiarisco la mia presa di posizione in merito all’arte che in questa sede ci ha fatto tanto discutere in modo incomprensibile. Ammetto che il mio commento, essendo stato scritto di getto, risulta poco articolato e preciso. Ma “i problemi di bilancio” che hai tirato in ballo volevano essere un elemento di paragone forse anche fuori luogo ma decisamente concreto rispetto a un tema tanto ozioso e affettato (a mio avviso) quanto la musicalità di un romanzo poliziesco. Ma non può essere considerato, chiamamolo il “tema sociale”, un fine o un metro di giudizio univoco per questa ben più complessa e composita cosa che chiamiamo Arte. Poi, da fanatico comunista che non sono altro, mi consenta, auspico che l’arte si faccia carico anche di un impegno civile esplicito e non rimanga “astratta critica della realtà”. Non esistono epoche d’oro, esistono “epoche” con classi dominanti. L’arte, quando nasce da quest’ultime, è accademia, quando nasce contro queste è avanguardia (novità, vento fresco che coglie i sapori del suo tempo) e quindi arte.
Sandro, sa, io ho il suo libro…in tutta onestà, leggendo sta roba, mi passa quasi la voglia di iniziarlo, ma perchè lo fa…la danneggia, mi creda, a meno che non si rivolga coscientemente ed esclusivamente a una casta chiusa fatta di prof di filosofia, musicologia e quant’altro. Insomma, vi passate la palla tra di voi. Ma io le chiedo, non si rompe i maroni? Legge mai Bukowski?
ps. scusi l’ardimento…
Una curiosità
Cara Ludovica,
che ti dicevo, la paranoia galoppa, adesso non riesce più a distinguere un tu per ipotesi da un tu indicativo.
Buona giornata.
Caro Sandro,
Ludovica si era già giocata l’identità molto prima del “calmo calmo”, quando Cristina, in un empito di deferenza fuori luogo verso una sconosciuta, le si rivolge il 28th June 15 04 chiamandola Puretù.
Cristina ritenne di dover intervenire per correggere la storpiatura del suo nome da parte di Matassi il 27th june alle 15 12 che l’aveva chiamata Tiziana. Errore di vanità professionale da parte di una dilettante dei giochi di copertura.
Dunque, in tre a tavolino, prima di iniziare la farsa, vi eravate dati dei nomignoli. Mi do del ciula per non aver potuto individuare con certezza gli altri due. Non che sia importante, vero, ma poichè si dava a me del paranoico ecc per l’uso del nick, ci tengo, anche se non so perchè, a smascherare tanta sfacciataggine.
Non commento questa tua ultima patetica precisazione per non infierire.
so perchè, sono malato, hai detto bene tu, sono in preda a sindrome persecutoria da complotto, a furore dietrologo.
Zio Tom,se lei riuscisse a leggere Delfinon solo con gli occhi ma con tutto
l’intelletto che,ne sono certa,si ritrova,credo che troverebbe esplicati in
modo eccellente quei temi sociali a cui (da comunista ,ma qui non si scherza neanche)tiene tanto. Tenti una trasposizione del controllo e della
spersonalizzazione dell’individuo nella nostra realtà e forse l’ottica del suo
giudizio si potrà spostare. Delfi non è un romanzo per intellettuali e simili
ma si rivolge a quanti,accostandosi ad esso,riescono a svuotare la mente
da preconcetti e giudizi di casta. La domanda è:oggi l’individuo può
ritenersi libero oppure,nonostante gli sforzi e le lotte,rimane suo malgrado
soggiogato a una corda che non si è certo cercato?
Pensi zio Tom,legga Delfi e dia uno sguardo alla nostra misera,misera
società:mi creda,troverà molto di più di quanto possa immaginare.
La saluto cordialmente.
Tra i romanzieri contemporanei che si muovono nell’ottica di Adorno vi è senz’alcun dubbio Sandro Dell’Orco, almeno per due motivi: per la presenza pregnante della musica nel suo romanzo e per la sottile critica alla società di massa di cui Adorno è stato un lucido anticipatore.
Prima di proclamarsi comunisti bisognerrebbe tener presente che una delle caratteristiche dei comunisti nella storia è, oltre una rigorosa disciplina di comportamento (e pertanto di linguaggio), l’approfondita conocenza del pensiero marxista. Quanto ai rapporti tra marxismo e letteratura, mi permetto dunque di rinviare a G.Lukacs, che individua ed apprezza, nel grande romanzo borghese di Thomas Mann, la potenza critica nei confonti della stessa borghesia.
Buongiorno. Si fa per dire. Vedo che il viscido da cui mi ero congedato qualche settimana fa s’è fatto metastasi; che tristezza. E lei, Dell’Orco, a dare spago…
Comunque.
Vorrei dire al signor massinissa che, alla luce dell’intera questa discussione, gli accordo tutta la mia considerazione e che, se vorrà farmi visita, mi farà cosa gradita.
dicevo degli altri due nomignoli. Dico due per dire plurimi. Potrei tentare un’attribuzione col metodo di Morelli, strutturalista ante litteram, ma non arriverei comunque a una certezza probante. Poi ci sono gli amici di facoltà e di territorio che si sono limitati a uno scambio; i dischi rotti tipo Giuseppe e i nullatenenti tipo Jolanda, che ce la mettono tutta ma insomma…ecco…frequentano solo piccoli luoghi comuni senza cogliere le potenzialità di liberazione che questa società misera misera, non quella italiana, ahimè davvero miseranda (e questo thread ne è la conferma), spalanca
Io sono malato, ma lei, Ludovica, deve essere affetto da deformazione porofessionale compulsiva. Vada in vacanza.
Ma nei prossimi giorni è prevista la presentazione di Delfi, in qualche città?
Certo che accadono cose strane. Io mi rivolgo a zio tom e invece risponde massinissa .Sono fratelli siamesi? e poi non crede massinissa che vivere continuamente una gravidanza isterica ,velenosa,autodistruttiva faccia più male a lei-lui piuttosto che alle persone che offende senza conoscerle? io vivo e conosco il bene: non temo il male perchè il MIO cuore è puro.
Pregiatissimo signor Bruno Cischetti,
sì, ci sarà, ma all’entrata è richiesto il certificato di salute mentale.
Cordialmente suo
S.D.
Ludovica, mi perdoni, ma non sto tutto il santo dì attaccato a sto sito…sa, ho anche un lavoro e una vita fuori da qui. Comunque le rispondo senz’altro, non tema.
Non capisco tre cose che vado semplicemente a enunciare ma per le quali la pregherei di non entrare nel merito trovandoci già abbondantemente fuori dai binari:
– Che ci azzecca la sbrodolata sul comunismo;
– Cosa c’entra se zio tom è o meno comunista;
– Ammesso che si proclami tale, da cosa evince che (zio tom) non conosca il marxismo.
Lasciando da parte le succitate quisquiglie, accetto il suo spassionato consiglio e leggerò senza meno il romanzo tanto dibattuto. Fermo restando, la mia convinzione, che questo modo di parlare sopra un libro non fa che sfregiarlo irrimediabilmente. Un po’ come succedeva con la poesia di Leopardi, ricordo al liceo, facevano di tutto per fartela odiare con tutti quei commenti su commenti e tu, se non eri attento, la mettevi nello stesso calderone delle poesie civili di Manzoni. Ma leggiamole, per dio, queste poesie, e bando alle ciance (un appello ai prof, so che non sparo nel vuoto).
Dopo questo nostalgico flashback lo zio tom si congeda, perché domani ha il suo ultimo giorno di lavoro e dopo parte.
Comunque, Sandro, se le fa piacere (ho trovato la sua mail in fondo alla presentazione dell’autore sul libro, che tra l’altro a dispetto di tutto fa una buona e misurata introduzione all’opera) le scrivo in privato come ho trovato il suo romanzo.
In questa sede saluto cordialmente e cordialmente auguro vacanze tranquille a tutti lontano da questo forum.
Ps. Ma sta sera gioca pato o è tornato in vacanza in brasile?
i puri non vanno con gli impuri, d’istinto
Gent. sig. Sandro dell’Orco,
il certificato non basta; si procuri anche un etilometro per l’occasione.
con osservanza
Sveliamo il “misteri” d’identità : sono Ludovica, non sono Matassi ; miei interventi qui sono del tutto autonomi: mi occupo di questi temi (filosofia, musicologia, letteratura…) nella mia attività di ricerca in ambito accademico, ed è per questo che conosco il prof. Matassi, che mi ha segnalato il romanzo e il sito di nazione indiana. Il giorno dello “scambio di identità” ero con lui, e, dopo aver scritto il mio intervento, lui mi ha dettato il suo, che io ho distrattamente spedito senza cambiare i dati. Tutto qui.
Chi sono gli impuri? come vede io continuo a comunicare con Lei ma ancora non mi sento infettata.Peccato che la purezza non le appartenga, si è proprio un peccato ,per lei però. Massinissa lei spreca occasioni uniche in questa vita irripetibile: essere in pace con se stesso!
poi vado in vacanza anch’io:
Prof. Elio Matassi, a fine forum, bella parola, Lei ci aveva promesso che avrebbe svelato un dettaglio che l’avrebbe scagionato al 100%.
Ci dia questo dettaglio, io le farò le mie scuse e insieme a Sandro annunceremo la pace e loderemo gli dèi.
Se ripete la dichiarazione di Ludovica non vale.
Ma sì vale, anzi supremum vale
\Cara Ludovica,
rispondo al tuo commento dell’8 ultimo scorso, ore 14,48, per dirti due cose: hai una prosa che mi piace: priva di ogni vana autoreferenzialità, attenta all’oggetto di ricerca, ma al tempo stesso non arida, in cui si sente l’amore e la gioia per l’indagine, come se da questa dipendesse la tua serenità e il senso della tua esistenza. I periodi sono controllatissimi, ma addolciti e vivificati da un’aura di profonda attenzione e di rispetto per te stessa e per la cosa, quasi che l’importante non fosse la cosa che indaghi, ma il rapporto vivo che ha con te. La seconda osservazione riguarda la nostra diversa visione della filosofia e dell’arte – che poi tanto diversa non è – , e in particolare il problema del monismo e della dialettica. In questo ambito volevo precisare che hai preso (e non solo tu) il mio concetto di “emozione” e di espressione della stessa in modo un po’ troppo ingenuo e volgare. Cioè: non intendevo dire che l’artista esprime le sue emozioni, come se, essendo gioioso esprime gioia, o essendo triste esprime tristezza, e questo con i rispettivi materiali della sua arte, ma tutto il contrario. E cioè: l’artista prima abbandona il mondo reale e tutte le emozioni ad esso relative, traccia intorno a sé il cerchio magico dell’arte, e poi, all’interno di questo, costruisce un nuovo mondo, lo forma, con i materiali che possiede (parole, note, colori, linee ecc.). Ma – ed è qui il punto – nell’articolazione della forma, nel processo per cui da una nota ne nasce un’altra, da una scena un’altra, da una linea un’altra, chi conduce il logos, chi dà necessità alla progressione, all’articolazione della forma, è sempre e solo l’emozione, non più l’emozione di fronte alla realtà empirica, ma quella interiore, oscura e allo stesso tempo ben nota all’artista che compone. Come questa emozione che guida e connette formalmente la composizione sia in fondo imparentata con quella del mondo empirico non è qui il luogo di indagare, basta dire che lo è, e al punto tale che l’opera riuscita è spesso il crittogramma più veritiero di quel mondo. In parole veramente povere: ciò che dice al compositore, o allo scrittore, o a un altro artista, qual è la nota, o la scena, o la linea, da far seguire alla precedente, è l’emozione e mai il concetto.
…e se invece scopaste un pò di più, tutti quanti?…
…magari con te, les deux côtés…
Ho riletto per la seconda volta Delfi e mi sembra che le implicazioni musicali ci siano tutte,così anche i motivi di critica sociale.
Se ti interessano le “implicazioni musicali” allora TROMBA piuttosto che ri(!!!)leggerti il romanzo… ti conviene…
…tu scanchigni, Matteo, fatti toccare…
…mi faccio toccare solo sotto la fascetta… e purché sia tocco adorniano… uah ah ah!…
ho capito, nascondi la mano
Caro Sandro,
grazie per le belle parole sulla mia prosa, tanto più gradite dal momento che provengono da uno scrittore. Accolgo con interesse la precisazione sul tuo concetto di “emozione”, che esclude ora ogni possibilità di essere equivocato come qualcosa di ingenuo e volgare. Quello che tu chiami “emozione” io lo chiamerei ‘senso della forma’, portando l’attenzione non solo sul soggetto, ma anche sul suo rapporto con l’oggetto (la forma e il materiale). A questo punto, però, potrebbe trattarsi solamente di una questione prospettica, che mantiene inalterata la sostanza.
Chiedo scusa per non aver visto che una data era stata pubblicata già in precedenza sulla presentazione di Delfi
Cara Ludovica,
sì, “senso della forma” esprime più esattamente, da un punto di vista funzionale, il rapporto dell’artista con l’oggetto, ma così il concetto si perde una sfumatura essenziale, che è fondamentale nell’esperienza creativa, e cioè il brivido – di gioia o d’angoscia – che accompagna e guida l’artista lungo il percorso della creazione. Per non perdermi tale aspetto ho usato il termine “emozione” che però presenta il difetto di essere troppo rozzo e consunto da un uso che gli ha tolto ogni profondità. Come vedi non è una mera questione terminologica, si tratta di restituire la cosa stessa, ciò che realmente accade nel processo creativo, con le parole, e non è facile. In conclusione, come dici tu, vediamo lo stesso fenomeno, ma io da scrittore, dal di dentro, e tu da filosofo, dal di fuori.
Sandro: “e in particolare il problema del monismo e della dialettica”
Mi son d’accordo che el problema del monismo emerga con urgensa dal thread, casso. Mentre quel de la dialetica, xè facile: xè venexiano, ‘sio can.
Mi sono perso purtroppo l’intervento di Franco Cordelli sul Corriere del 6 agosto, ma non quello dell’8 agosto, sempre sul Corriere, di Giorgio Ficara, in merito al dibattito su Adorno e la letteratura aperto da Piperno. Con Ficara continuo ad essere in generale d’accordo, specie quando dice “Il romanzo di oggi è in crisi non perché Adorno ne minacci il futuro con le sue ‘Note per la letteratura’, ma perché i romanzieri sono troppo poco in crisi, e hanno voltato le spalle al Novecento. Scrivono i loro romanzi come se il Novecento fosse una vecchia canzone che nuoce alla nuova e dovessero liberarsene, non pensarci più. Al contrario io credo che il nuovo sia dietro di noi, grande e tristemente abbandonato; e il vecchio, così semplice, così spontaneo, così modesto, così ovvio, sia davanti a noi, ‘intuibile’ come una pagina di rotocalco.”
Vorrei fare alcune osservazioni proprio su questo passo. Esso adombra la possibilità, anzi la necessità, ripresa peraltro in fine di articolo, “che si debba dare battaglia” contro questo andazzo, che basti volgersi di nuovo al Novecento, acquisirne con studio e cura idee e prospettive, per invertire la tendenza. Ora, a parte l’abissale divario tra potenza formativa dell’industria culturale e quella del sistema educativo tradizionale (scuola, università ecc.) – ammesso e non concesso che quest’ultimo si votasse ad una vera formazione dell’individuo – che rende l’impresa molto difficile, c’è un altro problema che la rende pressoché disperata. Mi riferisco al fatto che, come notava Pasolini, con l’industrializzazione c’è stato un mutamento profondo nella struttura interna delle persone, cioè nei loro “valori sostanziali”, nel modo di “funzionamento” della loro anima, dello loro affettività. La visione e la sensibilità arcaica, contadina, magico- religiosa (vedi “Cristo si è fermato ad Eboli”), che rendeva ancora la realtà e i rapporti tra le persone più caldi, solidali, emotivamente vivi e passionali, arretra e sparisce più o meno velocemente e viene sostituita da una visione più fredda, razionale, egoistica ed antagonistica con gli altri uomini, conformemente a quanto richiesto dalla nuova organizzazione sociale. La famiglia, che garantiva la formazione di una individualità affettivamente matura, solidale, comprensiva dell’altro, e soprattutto svincolata dallo scambio dominante fuori di essa, è sempre più esautorata dai media e soprattutto dalla inutilità delle sue stesse indicazioni, disfunzionali alla sopravvivenza nella società. Se tutto questo ha qualche possibilità di essere vero, allora il volgersi al Novecento appare in tutta la sua problematicità. Il Novecento, al di là e prima delle idee che ha prodotto, è tra l’altro l’espressione di una lotta tra una sensibilità umana solidale, arcaica, utopica, mitica, calda affettivamente, sostenuta dalla religione e dall’aristocrazia, e una sensibilità rigorosamente razionale, positiva e positivistica, antimitologica, demistificante di ogni valore spirituale che non sia quello del nudo scambio, del puro e semplice do ut des, sostenuta ovviamente dalla borghesia in ascesa. Ora, se uno dei due termini antagonistici sparisce, la lotta non ha più senso. Ed è precisamente questo che sta accadendo nel mondo avanzato e in Italia. Voglio dire che se anche ci si volgesse al Novecento con la più grande buona volontà, quella lotta non la si capirebbe più, come non capiamo l’arte egizia o babilonese, e non la capiremmo perché dentro di noi, dentro la nostra anima, dentro la nostra affettività ed emozione, non vivono più i valori (odio questo termine ma non ne trovo un altro) in difesa dei quali si muoveva la lotta alla fredda razionalità e allo scambio.
Non voglio essere apocalittico. Non dico che le cose siano irreversibili e irreparabili, voglio solo mettere ben in evidenza le vere difficoltà che si oppongono ad un auspicato e auspicabile ritorno al Novecento.
Caro Bepi,
è perché ho pensato alla gente come te che il monismo mi si è imposto con tanta urgenza.
In risposta a MatteoM : il blog è l’espressione più alta della democrazia,ovviamente della democrazia fanno parte anche i cretini…..
Ma il monismo precisamente che cos’è?
@Giuseppe:
PURTROPPO ne fanno parete anche i cretini, eh?
ah, come sarebbe bello un bel protettorato morale dell’orchiano in cui discutere di Adorno e Musica da mane a sera senza che alcun illetterato venga a disturbarci!
come soluzione al problema di noi cretini suggerisco l’istituzione di campi “di lavoro” in cui relegare tutti questi ignoranti rompiscatole. Questa immonda razza inferiore a cui il romanzo del Nostro non ha suscitato proprio nulla di nulla. Ciò decisamente prova che non sono umani. E sul cancello una bella scritta: “kretinerie macht frei”.
Ma fatemi il piacere. Anzi, fatemi un p*****o
Gentile Signor Bruno Cischetti,
lo chieda a Bepi che ne è un qualificato esemplare.
Caro Sandro sono qui per augurarti un grande successo per domani,Delfi lo merita e lo sanno anche quanti,nascondendosi dietro il vigliacco paraven to dello pseudonimo, tentano di affossarlo tra la carta straccia nella quale si rotolano da mattina a sera. Carissimi saluti.
Secondo me, tutti coloro che praticano la filosofia in modo retto rischiano che passi inosservato agli altri che la loro autentica occupazione non è altra se non quella di distaccarsi dalla vita.
Rispondo al signor Massimo: se per distaccarsi dalla vita, egli intendeva la morte, “che c’è di più essente – e cioè, pensando modernamente, di più certo – della morte?”. Sembra una frase comune, ma la pronunciava Heidegger in un commento alla poesia di Rilke.
Rispondo a Jolanda Catalano. Ieri alla giornata del Fanofestival dedicata a Beckett, si è discusso tra l’altro degli influssi beckettiani su “Delfi” e in particolare sulla “prospettiva del narratore” nel mio romanzo e in quelli di Beckett. A proposito di musica e letteratura c’è stato un concerto pianistico di Stefano Vagnini, con musiche ispirate a Godot e a Film. Particolarmente stimolante la partecipazione del grande Mario Dondero, fotografo di Beckett, di Ionesco, di Sartre, di Genet e degli intellettuali della Francia degli anni’50, che ha voluto onorarmi con la sua presenza e l’affettuosa amicizia.
Voglio fare una domanda a Massimo, l’ho pensata ieri pomeriggio al mare, dopo aver letto la sua opinione su questo blog che mi hanno segnalato. Il distacco dalla vita è da un lato, l’essere il corpo, separatosi dall’anima, da sé solo, e dall’altro, l’essere l’anima, separatasi dal corpo, da sé sola? O dobbiamo ritenere che la morte sia qualcos’altro e non questo?
ma quale annarita… si è mai sentita una donna esprimersi così? se lo lasci dire: oltre che un onanista di prima categoria, lei è davvero uno scrittore mediocre.
Ha ragione Annarita: il filosofo, diversamente dagli altri uomini,
cerca di liberare l’anima dal corpo, quanto più gli è possibile.
Sempre a margine della presentazione di Delfi alla giornata beckettiana del Fanofestival. Uno degli spunti più interessanti è stata la discussione intorno alla posizione del narratore nel romanzo contemporaneo e in particolare in Beckett e Kafka. Si è parlato tra l’altro di questa affermazione di Beckett (cito a memoria): “kafka E’ nella forma, io sono AL DI QUA – o AL DI LA’ della forma”. la frase esatta si trova in un libro di Steinberg pubblicato da minimum fax. Su questo “oscuro” frammento beckettiano si è avviata e (ovviamente non conclusa) un’appassionante dibattito tra i convenuti alla presentazione del mio libro.
Caro Sandro, ho apprezzato molto le informazioni che mi hai dato a pro posito del Fanofestiva. In quanto alla posizione del narratore nel romanzo contrmporaneo,desidererei,se ti è possibile,un breve sunto sull’argomento. Carissimi saluti.
Al mondo, e sono tutti italiani, tre sono stati i più grandi conoscitori (Canetti, a mio avviso, non li raggiunge, come pure Max Brod) dell’opera di Kafka. Il compianto Giuliano Baioni, il più grande di questi su Kafka, Claudio Magris e Massimo Cacciari. Quindi, se a proposito della forma, si parla di una forma nella quale ciò che ha forma è l’informe, allora siamo nella corretta interpretazione. “L’assalto al confine”, il tentativo di Kafka di captare il messaggio dell’imperatore, o la Legge, è un assalto che nella freddezza della sua letteratura mostra l’impossibilità di svelare l’ordine (la forma). In ciò si mostra l’impossibilità della forma, se non nella sua veste di qualcosa di già da sempre infranto e non componibile. Un po’, tanto per rimanere al tema di questo blog, come ciò che ha eseguito Mahler con la sua musica, stando anche a quanto giustamente dice Adorno in merito.
Baioni, Magris e Cacciari (ha ragione, Vet, sulla questione) sono davvero i migliori su Kafka (stratosferico il saggio di Baioni in cui parla di Kafka nel suo “La Questione ebraica”, come pure Cacciari in “Icone della legge”). Ma io aggiungerei anche Calasso e Anders tra gli esegeti di Kafka. Eccellenti sono anche gli ultimi due.
D’accordo anche su Anders, ma il punto è che a un kafkiano doc non si può chiedere di leggere “Kafka. Pro e contro”.
per forza siete sempre tutti d’accordo, è sempre lo stesso scrittore mediocre e onanista che, incapace di simulare un vero dialogo, se la mena con gli pseudonimi. povera nazione indiana, le è entrato il virus della peggior italietta intellettualconformista!
Tommaso Capestrano,
non c’è problema, con Gunter Anders, a proposito di Kafka, mi sono confrontato l’anno scorso, come puoi leggere su questa mia recensione pubblicata su “Libri e riviste d’Italia”.
Letteratura
Gunter Anders
Kafka. Pro e contro
Quodlibet, 2006, p. 200, € 14,50.
Com’è noto, l’ermetismo kafkiano, cioè la compatta, logica e inattaccabile chiusura al senso delle opere del grande scrittore praghese, ha prodotto, durante tutto il Novecento, una sterminata letteratura critico – interpretativa. Sono state avanzate spiegazioni di ogni genere: teologiche, filosofiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche; tutte plausibili e interessanti, che colgono ora questo ora quell’aspetto dell’opera dello scrittore praghese, ma nessuna veramente risolutiva. Che cosa voleva dire Kafka è rimasto e rimane oscuro. Questo libro di Gunter Anders, filosofo tedesco allievo di Heidegger e di Husserl, emigrato negli Stati uniti durante il nazismo e morto a Vienna nel 1992, al di là di molti e interessanti spunti chiarificatori sullo stile di Kafka, rimbalza anch’esso contro la rotonda, metallica superficie del corpus kafkiano e ricade malinconicamente tra gli inutili testi degli altri esegeti. La sua interpretazione – concepita nel 1934, e pubblicata nel 1951 – è, in pochissime parole, la seguente: che Kafka ha ben rappresentato l’uomo alienato e oppresso dalla nascente società industriale burocratizzata, ma ne ha al contempo proposto e promosso l’uniformazione e l’obbedienza cieca ai poteri sociali dominanti. Ciò lo rende un precursore dell’atteggiamento e della mentalità fascista e quindi un modello morale e letterario da combattere. A questa tesi cerca di ribattere, nell’Appendice del libro, Max Brod, opponendovi la sua ben nota tesi di Kafka quale homo religiosus.
Il senso di datato, superato e superfluo che emana – nonostante i pregi su esposti – dal testo, non ha, a ben vedere, una ragione cronologica, ma deriva tutto dalla stanchezza per un dibattito che dura da quasi un secolo senza alcun costrutto, per una spiegazione che, come tutte le altre, si lega al perno della ragione discorsiva girandovi intorno ciecamente e inutilmente. E’ quello che tra l’altro sta succedendo con Beckett. Viene quasi da chiedersi se l’ermetismo di Kafka non sia semplicemente da accettare, così come si accetta un quadro non figurativo, o una composizione musicale, senza cercare una spiegazione concettuale che non può essere assolutamente trovata. Da questo punto di vista, i lettori e gli esegeti di Kafka dovrebbero forse regolare l’approccio alla sua opera riflettendo sulle parole di Matisse, che rispondendo alle critiche di scarsa verosimiglianza di un suo viso di donna, disse: “Signore, io non creo una donna, io faccio un quadro.” (Sandro Dell’Orco)
Più o meno Magritte, se vogliamo rimanere al tema di quanto sopra, una volta disse, a proposito di una una sua opera, la raffigurazione di una pipa, “Questa non è una pipa”. Spessissimo, quando si vuol definire che cos’è un’opera d’arte, si fa volentieri riferimento a questa battuta, anche sui quotidiani (ultimamente, Sandro Veronesi in un elzeviro sul Corriere). Ma il punto è questo: in che senso debba essere intesa un’affermazione del genere? Non voglio tornare sull’argomento: altri, e molto meglio di me, con acume impareggiabile, hanno spiegato che cos’è l’opera d’arte (mi riferisco agli interventi in questo blog in cui si mette in evidenza la non strumentalità di essa, la perdita della strumentalità). Qui mi limito soltanto a ricordare l’interpretazione che Heidegger dà al “Le scarpe” di Van Gogh nel saggio tradotto con il titolo in italiano “L’origine dell’opera d’arte”, contenuto negli Holzwege. Su Kafka non v’è nulla da aggiungere a quanto scritto da Vet. L’unica aggiunta, proprio per farne una, è che una lettura vada fatta anche a Benjamin, al suo saggio su Kafka contenuto in “Angelus Novus”.
sempre tu, eh, pippalunga… qual è la diagnosi: borderline o depressione?
Cara nazione indiana,nella mia città,terra di miti,cultura e bergamotto,vive un signore di nome Otello Profazio,cantore popolare ma anche esperto di satira politica; c’è una sorta di filastrocca che parla dei politici prima delle elezioni,di come dopo averne ascoltato uno,li hai ascoltati tutti in quanto ciò che dicono è verosimilmente la solita solfa. La dedico a tutti gli (lo ) pseudonomi-contro. ………e come dicevamo…lu porcu avi tri pila e tri pila avi lu porcu,anzi… tri pila avi lu porcu e lu porcu avi tri pila,lu porcu avi tri pila e tri pila avi lu porcu………………………………………………………………… Cara,carissima nazione indiana,che facciamo tra uccidere il porco o strapparggi i tre peli?
Ma non è vero, come recita anche la quarta di copertina di “Kafka. Pro e contro”, che la maggiore preoccupazione dell’autore fosse di mettere in guardia davanti al fenomeno Kafka?
Scardanelli,
sì è vero, ma sta proprio lì l’errore, non ha senso mettere in guardia la gente contro dei romanzi.
Egregio Scardanelli, quando parlo di pseudonomi-contro,è ovvio che mi riferisco a quanti,per motivi che non oso immaginare, tentano con un lin guaggio scurrile e scorretto,la distruzione e del romanzo e dell’autore. Tutto ciò non mi pare che abbia molta attinenza col dibattito in questione perchè penso che si possa essere pro o contro rispettando comunque quel minimo di civiltà che dovrebbe albergare in ciascuno di noi.
Riprendo e concludo qui il mio l’intervento sull’articolo del Corriere della sera “Adorno cattivo maestro. Dei critici” di Alessandro Piperno. A giustificazione di questo commento in questa sede, dirò solo che Theodor W. Adorno è alla base della mia formazione, come uomo e come scrittore, e quindi alla base stessa di “Delfi” che è appunto il tema del presente blog.
Non avevo ancora letto il romanzo “Con le peggiori intenzioni” quando lessi l’intervento di Piperno sul Corriere. Ora l’ho finito e posso riprendere il dibattito lasciato in questo blog il 6 agosto scorso. Il suo libro chiarisce molto il suo intervento, sia per quanto riguarda l’accento posto sul personaggio quale elemento chiave della forma romanzo, sia per la polemica antiadorniana e più in generale antiavanguardista. In effetti il suo libro è totalmente centrato sulla descrizione di personaggi. I membri di una famiglia della buona borghesia ebraica e quelli di una famiglia altrettanto potente di gentili, i cui interessi economici ed affettivi si intrecciano, vengono raccontati dall’ultimo rampollo della famiglia ebraica – un intellettuale quaranta cinquantenne – a partire dal nonni, passando per gli zii, i genitori e altra varia parentela, per abbracciare infine la famiglia non ebrea, anch’essa rappresentata dettagliatamente in tutti i suoi componenti. La descrizione dei personaggi, sostenuta da un ottimo livello di scrittura, e da una impetuosa, inarrestabile affabulazione è buona, spesso affascinante (come nel caso del nonno Bepy, di Gaia, di Nanni Cittadini e di molti altri), ma non basta alla riuscita del romanzo. Non basta cioè che tutti i personaggi siano connessi da vincoli parentali o economici o affettivi per formare l’unità dell’opera, l’unità della forma: questa deve darla l’autore facendoli muovere non secondo realtà (non come in realtà si mossero) ma come la sua vis creativa, il suo impulso interiore gli suggerisce – e ciò non avviene. Questo è all’origine della più grossa pecca del libro: la mancanza di tensione narrativa. Il lettore all’inizio ascolta con interesse, e perfino con piacere, la virtuosa e sapiente voce narrante che penetra nei luoghi più riposti dell’anima, della mente e del portafogli dei vari e variopinti personaggi, ma poi si annoia, un po’ perché all’orizzonte non vede alcun tipo di azione (e di agente) che unifichi e dia senso a tutta quella pletorica esposizione parentale, e un po’ perché la varietà dei tipi, al di là delle insistite, compiaciute e differenziate analisi psicologiche, è più apparente che reale. Cioè: al di là della statura, capelli, peso, tendenze caratteriali, formazione, sessualità, ecc. – su cui tanto l’autore si impegna e si dilunga – sono i soldi alla fine (persi o guadagnati) a determinare la vita e i movimenti di tutti i suoi personaggi. Quando Kafka, da qualche parte, forse nei diari, disse: “Basta psicologia!” si riferiva proprio a questo, cioè all’inessenzialità dello psicologia nella spiegazione delle azioni umane. Il fatto che ogni differenziazione, ogni cromatismo individuale si perda oggi (pur continuando ad esistere) nel buio dell’egoismo individuale e universale, nella notte del danaro, deve necessariamente sfuggire a chi, come Piperno, ha fatto del personaggio ottocentesco dal forte spessore psicologico, una religione estetica, senza peraltro chiedersi se dopo duecento anni quel personaggio che creava il proprio destino con il suo Io e con la sua psicologia esista ancora. Per Piperno infatti la storia non incide sul romanzo e sui personaggi ottocentescamente intesi, esso è un’invariante eterna dell’uomo, “è come uno di quei fiori che attecchiscono ovunque, che si abituano a qualsiasi clima. Che non temono né il freddo né il caldo. Che fingono di appassire (chi sa poi perché –nota mia-) per poi rifiorire più forte che mai” (Corriere 4.8.2007).
Dicevo della mancanza di tensione narrativa. Essa dipende dalla mancanza di un’azione e di un agente nella storia. E’ come se qualcuno, per il solo gusto di intrattenere, e di mostrare il suo talento, si mettesse a raccontare con enfasi gli affari intimi della propria famiglia: la prostata del nonno paterno e le sue smanie snobistiche, la rozza volgarità di quello materno, il patriottismo estremistico dello zio, la stranezza e l’insoddisfazione sessuale della zia, l’omosessualità del cugino, la sudditanza del padre all’ex socio in affari dei nonni, la disinvoltura sessuale della nipote di quest’ultimo, il proprio feticismo per i piedi e la biancheria femminili, e così via: dopo un iniziale divertimento (venato magari di imbarazzo per la pretesa del narratore di far passare come eccezionali ed esemplari cose che ognuno esperisce quotidianamente, mutatis mutandis, in casa propria) non lo si reggerebbe più e lo si starebbe a sentire (o a leggere) tra gli sbadigli per mera compiacenza o spirito di coerenza. E’ questo che precisamente accade con Piperno. E accade proprio perché per lui il romanzo coincide con i personaggi, non va al di là di una buona descrizione dei personaggi. Dimenticando tra l’altro – non Adorno e nemmeno l’avanguardia – ma l’abc stesso del racconto, dimenticando Aristotele, che individuava appunto nell’azione, nell’azione necessaria e insopprimibile, il centro gravitazionale intorno a cui tutti gli altri dettagli – episodi, descrizioni, personaggi, ecc, – si aggregano, acquistando senso e concorrendo alla formazione dell’opera.
Ma è possibile un’azione romanzesca nel mondo descritto da Piperno? Questo bisogna chiedersi. Per un’azione tale è necessario un agente, un eroe, come si diceva una volta, qualcuno che si abbandoni alla propria passione sfidando la realtà. E nel suo mondo non c’è. Daniel Sonnino, il protagonista, condivide a tal punto il suo mondo, i suoi valori – che son quelli della borghesia romana medio alta – a tal punto ne è immerso e compenetrato fin dalla nascita, che non è assolutamente in grado di provare genuine passioni dirompenti e in contrasto con la sua famiglia e la sua classe sociale. Egli vede bene tutto il male, nella sua famiglia e fuori, ma facendone egli stesso parte, e non vedendo nulla al di là, lo accetta cinicamente come condizione universale e atemporale del mondo. In certo modo Daniel incarna, al di là e contro le intenzioni del suo autore, la fine dell’eroe e dell’azione romanzeschi. Non ne ha più le qualità. E’ così uguale al mondo in cui vive che non può trascenderlo con nessun pensiero e azione. E’ una corazza trascendentale la sua, come la pelle di rinoceronte di cui parlava Baudelaire.
Tutto ciò finisce per essere deleterio per il romanzo stesso che Sonnino – Piperno vuole scrivere e scrive. Non ha un’azione degna di questo nome da raccontare: l’unica sarebbe la sua passione adolescenziale per Gaia, la sua vecchia compagna di liceo, ma anche questa, nella realtà e/o nella rievocazione della memoria, finisce per essere tradita e depotenziata dai suoi (dell’autore) conformistici pregiudizi, dal cinico massacro di ogni sentimento e da un compiaciuto cupio dissolvi morale che salva solo il piacere hic et nunc. Così il romanzo che scrive, privo di eroe, privo di azione, privo di struttura e di forma, privo di ratio e di senso, si riduce alla mera descrizione intimamente disarticolata e rapsodica di personaggi, affidata unicamente allo stile, che, non potendolo da parte sua sostenere, lo lascia disperdere nell’aneddotica fine a se stessa, arguta e brillante, o nella rappresentazione superficiale di scene e dialoghi (specie nell’ultima parte) che lo rendono sorprendentemente simile a “Tre metri sopra il cielo”, di cui veramente, a tratti, sembra la versione colta e letteraria.
Ora, non è certo colpa di Piperno se le cose stanno così nel romanzo realistico, nel romanzo che pretende di rappresentare l’uomo empirico nella la realtà contemporanea. Egli non può certo cambiare se stesso, gli altri e la realtà. L’unico torto che ha è che si rifiuta di prenderne atto: di prendere atto che quel che è successo nel Novecento (nella società e nella cultura) ci ha cambiati in modo profondo, in un modo tale che il romanzo realistico non può semplicemente essere più praticato, per lo meno come lo era, in Italia, fino agli anni cinquanta. Piperno, più che a se stesso, alla sua necessità espressiva – che potrebbe suggerirgli nuove strade e nuovi modelli – dà retta, per bisogno di sicurezza, al modello tradizionale di romanzo realistico; ma, una volta adottatolo, non si ritrova dentro (come del resto quasi nessuno oggi) le qualità umane e morali per gestirlo e svilupparlo con un’azione strutturante. Così il romanzo non gli riesce e gli si sgretola nei suoi disparati personaggi senza che un briciolo della sua più profonda espressione passi nel testo. “Con le peggiori intenzioni” al di là della tecnica, del brio, della verve, dello humour, dell’ironia, degli ammiccamenti più o meno eruditi e snobistici, che continuamente mette in mostra per darsi una parvenza di vita, rimane un romanzo spento e monocorde, privo di quel soffio vitale che solo la passione dell’autore, se esistesse, potrebbe infondergli. La voce che vi si sente parla solo di sé, del suo vacuo stile à la page, e sorvola tranquilla, incosciente e irresponsabile insieme, il nucleo di emozioni rimosse che sarebbe suo dovere rappresentare.
jolanda catalano è forse la più grande poetessa europea vivente.
Non ho mai usato in vita mia un computer perché non so usarlo e mi sono rifiutato consapevolmente di farlo. Nutro un’autentica repulsione fisica nei confronti di uno strumento che abbassa il tasso di creatività individuale. Questo per il primo aspetto. Sul piano teorico e dialettico, la discussione aperta sul caso letterario Piperno-Fichera mi trova schierato con il primo. Credo che Adorno abbia ancora molto da dire anche in merito al romanzo della contemporaneità, sia per la forte influenza delle strutture musicali sia per i contenuti di teoria critica della società. Comunque una risposta più articolata e dettagliata sia sul primo che sul secondo aspetto la fornirò a partire dal 27 agosto.
Egregio G. Contini,la ringrazio per l’apprezzamento anche se lei non mi offre alcun elemento per comprendere la sua identità e quando e come ha avuto modo di leggermi. Sa,in questo blog popolato di insidie,anche una frase come la sua,per quanto positiva,potrebbe avere mille significati. Ma se desiderasse togliermi dal dubbio, sarò lieta di comunicare ancora con lei.
Indubbiamente il romanzo di Dell’Orco esprime la passione del presente, anche se di un presente ormai scarnificato e privo di identità. Proprio per questo Delfi è un romanzo che esprime lo spirito stesso della teoria critica.
Caro Sandro,in questo preciso istante in cui ti scrivo, un vento fortissimo sta disturbando i miei pensieri e qualche grossolana goccia di pioggia mi fa già intravedere un caldo autunno che avanza. Che dire quando sembra che tutto o quasi sia stato detto e ciò che rimane invece resta avvolto tra i magici veli di misteriose pagine bianche che chiedono linfa per meglio esprimersi? ma che cosa si deve esprimere? quale alchimia di parola terrà desti l’interesse e le emozioni del lettore? io parlo da lettore,non certo da critico e dico che quando leggo un romanzo,ho bisogno di partecipare anch’io come se fossi una piccolissima parte di quella struttura architettonica tanto più nobile quanto più riesce a farmi sorvolare la soglia del mero accadimento. Il pathos,Sandro, senza il quale la noia mi fa, se non subito,ma sicuramente dopo un po’,chiudere il libro per mai più ria prirlo.Ma il pathos smuove le pagine solo se l’autore ne è pervaso,solo se la sua passione per la scrittura è talmente forte (quasi una tempesta sul mare)tanto da spazzare via ogni orpello superfluo per lasciare al lettore la sensazione di aver vissuto parallelamente due,dieci o mille storie dentro un infinito spazio-temporale che alla fine lo lascerà incredulo,sgomento ma appagato.Un romanzo deve somigliare a un ventaglio: da qualunque parte lo apri,ti dà sempre sollievo.
Adesso il vento si è calmato e mi accingo a preparare la cena.
Buona notte Sandro, a domani.
Elio Matassi Says:
August 21st, 2007 at 12:01
Non ho mai usato in vita mia un computer perché non so usarlo e mi sono rifiutato consapevolmente di farlo. Nutro un’autentica repulsione fisica nei confronti di uno strumento che abbassa il tasso di creatività individuale.
>>>
Sei semplicemente un imbranato senza speranze…
Elio Matassi Says:
August 21st, 2007 at 12:01
Non ho mai usato in vita mia un computer perché non so usarlo e mi sono rifiutato consapevolmente di farlo. Nutro un’autentica repulsione fisica nei confronti di uno strumento che abbassa il tasso di creatività individuale.
>>>
E dopo tutto questo sputtanarsi in pubblico pretendi anche che ti si creda?
Preferisco non reagire agli insulti di persone che non hanno neppure la statura morale di farlo con il proprio nome autentico. Ho delle idee come tutti ed ovviamente, come tutti, provo piacere ad esternarle.
Dagli insulti alle idee. Ribadisco con convinzione che Adorno è un autore che ha ancora molto da dire nella contemporaneità, in modo particolare sulla società di massa e su quella mediatica. Proprio oggi mi è capitato di vedere al telegiornale la ripresa, enfatizzata da tutti i media e da internet, di una morte in diretta. Un bambino, pur sapendo nuotare, stava affogando e muore. Adorno è stato il primo a metterci in guardia contro questa sottile egemonia intellettuale esercitata dai media e ribadisco, con altrettanta convinzione, che, nel romanzo Delfi, oggetto di critica corrosiva sia proprio, sotto le vesti del potere del controllo, la stessa società di massa-mediatica.
Basti rileggere l’inizio di Delfi: “Non sono più nel mondo dei vivi. No, non sono ancora morto. Ma ormai non esisto più. Non ho più né un corpo né un mondo”. E’ proprio questa la condizione dell’uomo nella società di massa ed invece di insultare sarebbe molto più costruttivo meditare su queste affermazioni, a meno che non si sia schierati dalla parte della società mediatica.
Elio Matassi Says:
August 22nd, 2007 at 19:08
Basti rileggere l’inizio di Delfi: “Non sono più nel mondo dei vivi. No, non sono ancora morto. Ma ormai non esisto più. Non ho più né un corpo né un mondo”.
>>>
A Matass, hai provato con gli antidepressivi…
L’unica caratteristica che non ho è quella della depressione, sono infatti un iperattivo ed un ipercostruttivo. Comunque ho già detto che gli insulti non mi interessano e preferisco la discussione.
Dagli insulti alle idee: atto secondo. Non credo che sia una forzatura od una mia ossessione ritenere che il romanzo Delfi contempli più di una eco adorniana. Infatti, solo dopo aver fatto la mia recensione, ho conosciuto direttamente l’autore ed ho scoperto che si era laureato a Trento con Gianenrico Rusconi, che è stato il primo ad introdurre in Italia la teoria critica della società con un volume uscito presso Il Mulino. Quello che io argomentavo nella mia recensione veniva dunque ampiamente confermato dalla formazione del romanziere.
Sono d’accordo con Matassi suul’importanza e sull’attualità di Adorno per la critica alla società di massa e mediatica. Occorre però fare attenzione a non incorrere nel “pericolo” adorniano di un primato o egemonia della prospettiva sociologica nell’analisi dei fenomeni, soprattutto quelli artistici.
Caro Sandro, la società in cui viviamo è tremenda. Lo so che la mia è una affermazione banale ma mi riesce difficile rassegnarmi al fatto che il concetto di meritocrazia sembra essere ormai obsoleto. Ciò che sembra contare oggi per l’affermazione di un’opera,qualunque essa sia, è solo la forza economica che sta dietro le spalle di un autore. E su questo argomento ne ho viste e sentite proprio tante.Sono nauseata. Per ora ti saluto caramente.
Cara Ludovica,
non è che abbiamo molte scelte nell’analizzare i fenomeni: questi traggono origine dal mondo materiale diverso dal soggetto e, insieme, dalla nostra coscienza e dalla nostra prassi, dal potere sintetico dell’Io. Ciò è rimasto vero da Kant in poi, nonostante le contraddizioni della sua filosofia e nonostante i tentativi di superarli dell’idealismo e della recente metafisica. I fenomeni possono essere compresi solo nell’orizzonte di questa dialettica storica tra soggetto e oggetto, attraverso la quale propriamente si costituiscono. Essi sono l’unica cosa che (kantianamente) possiamo conoscere, e ci basterebbe, se solo questa dialettica raggiungesse il suo telos, cioè il benessere, la fine dell’antagonismo, la riconciliazione fra gli uomini.
Anche l’arte va inserita in quella dialettica se vuol essere compresa. Infatti essa è un particolarissimo fare del soggetto empirico (l’uomo in carne ed ossa e spirito) nei confronti della datità sensibile. Adorno, per sottolinearne la stranezza, disse una volta che se un extraterrestre osservasse l’operare di un artista lo giudicherebbe assolutamente insensato e incomprensibile. Questo fare acquista tuttavia il suo senso se inserito nel rapporto soggetto – oggetto (o uomo – natura) vigente in un dato momento storico, cioè – e siamo al punto – nella società.
Ciò che tu chiami “prospettiva sociologica”, dando ad essa una connotazione di puro metodo, quasi fosse sostituibile da altre prospettive altrettanto o più legittime, è in realtà la configurazione concreta dello stesso rapporto tra soggetto e oggetto, punto di partenza di ogni pensiero filosofico possibile. Se si riconosce che la filosofia è in generale la riflessione storica sul rapporto tra io e non io, universale e particolare, uno e molteplice, pensiero e pensato, uomo e natura, allora la società, che costituisce il presupposto e il teatro di quel rapporto, assurge a oggetto primo e imprescindibile della filosofia stessa.
Caro Sandro,
Kant ha compiuto – non è necessario che lo dica io – un’operazione intellettuale coerente, storicamente sensata, con cui ogni filosofo o pensatore successivo non può fare a meno di confrontarsi, e così è stato. Ciò non vuol dire, però, che il problema posto – nella sostanza già da Cartesio – corrisponda ad un effettivo stato di cose o ad una reale (dato che ‘vera’ non ti piace…) configurazione del rapporto soggetto-oggetto. Le contraddizioni, di cui bisogna pur tener conto, insite nel pensiero ‘trascendentale’, finiscono per comprometterlo, come avviene nel modo più palese, ad esempio, nella fenomenologia husserliana, col suo mal riuscito tentativo di passare dal palo della coscienza alla frasca dell’intersoggettività (mi si perdoni l’espressione poco elegante). Già la parola ‘fenomeno’, che anch’io ho usato, pone la questione in modo sbagliato.
La ‘prospettiva sociologica’, sì, è uno dei tanti metodi che valgono finché li si considera tali e circoscritti nel loro campo d’indagine e ciò vale anche per la filosofia stessa, che non può avere la pretesa di spiegare in modo esauriente il fatto (e non il fenomeno, mi correggo da sola) artistico o di qualunque altro genere. Porto ancora una volta l’attenzione sull’esperienza alla luce della dialettica soggetto-oggetto: quando il soggetto esperisce, esperisce la cosa che lo trascende. E’ ovvio che il soggetto lo fa secondo le proprie facoltà, prospettive, ecc…, ma (semplificando molto) alla cosa che percepisce o ci arriva (realismo) o non ci arriva (Fichte e compagnia), la terza opzione (Kant e amici) crea solo l’illusione dell’esperienza, del rapporto con la cosa, di un fantomatico io puro che sarebbe capace di pensarsi come tale mettendo, per così dire, ‘tra parentesi’ ciò che, in realtà, gli permette di concepirsi come io: il mondo, esperibile, anche se in modo non esauribile, pur – e proprio – nella sua trascendenza.
Il problema-storia. Ovvietà: i fatti avvengono nella storia, ma non è la storia che li “costituisce”, è, a limite,il contrario. Per quanto riguarda l’arte nello specifico, a titolo d’esempio, tornerei sulla già menzionata “non contemporaneità storica della musica (‘Ungleichzeitig’)”, citando (con qualche ‘taglio’) direttamente Ernst Bloch:
“E’ senz’altro possibile che le condizioni esterne abbiano favorito questa profonda non-contemporaneità storica[…] Ma queste ‘spiegazioni’ basate sull’esterno rimangono in definitiva esteriori e non rendono comprensibile il fenomeno nel suo complesso; la profonda solitudine storica, il piano dell’essere su cui Bach si colloca, non si può inquadrare sociologicamente. Inoltre lo stesso Nietzsche, quando coglie la non-contemporaneità storica della musica, la trasforma troppo violentemente in un semplice revenant e la collega troppo storicamente al passato invece di illuminarla a partire dal futuro: come spirito del grado utopico che secondo la sua essenza e malgrado innumerevoli affinità e libere recezioni, nel cuore della storia e della sociologia costruisce soltanto la propria casa, la struttura delle sue scoperte e degli intimi livelli dell’essere”(da Spirito dell’utopia).
Molto interessante il dibattito che si è sviluppato tra lo scrittore e Ludovica. Paradossalmente hanno ragione entrambi: Adorno ha sempre polemizzato violentemente contro la fenomenologia perché portatrice di valori e di conoscenze presuntivamente virginali. Di qui la necessità di andare incontro ad una sociologia che è, però, una sociologia filosofica fortemente caratterizzata in direzione dialettica, la cellula germinale della teoria critica della società. Ho già ripetuto svariate volte che Delfi è un esempio letterario di teoria critica, una trasposizione narrativa della sociologia dialettica. Dell’Orco presume fin dalle prime righe un individuo che ormai non è più tale, in quanto divorato dalla onnicomprensività della società di massa, a cui tenta vanamente di resistere fino al cedimento conclusivo. Per questa motivo ha ragione Ludovica nell’appellarsi alla non-contemporaneità blochiana, da cui almeno emerge, sia pure indirettamente, una possibile alternativa.
Mi sono già espresso in una circostanza con la formula ‘la passione del presente’ che caratterizza l’ispirazione di fondo di Delfi, dove tale dizione non è se non una versione aggiornata di un realismo critico-militante tipico dell’inizio del terzo millennio. Non vi è alcuna compiacenza né alcuno snobismo intellettualistico ma una compromissione diretta con il protagonista, Egon, per far risaltare tutta la potenzialità critica che ognuno di noi può ancora esercitate nei confronti dell’omologazione contemporanea. Senza questa potenzialità, che comunque, nel romanzo, viene sconfitta, non riusciremo più a vivere degnamente.
Rispondo solo ora agli interventi di Hektor R., Ludovica e di Claudio Vet (del 22, 23 e 24 luglio) nei quali si cercava di stabilire il rapporto tra arte e filosofia. Lo faccio commentando il passo sull’idea di “costellazione” citato da “Dialettica negativa”. Così come è posto da Hektor, sembra che tale idea sia raccomandabile ad una filosofia che non voglia essere inglobante rispetto alle arti. In realtà mi sembra che il procedere di una filosofia dell’arte non abbia nulla a che fare con l’idea di “costellazione”, che invece rivela tutta la sua potenza non in rapporto all’arte, ma in rapporto all’esistente, come capacità di restituirlo integro, anche negli aspetti non identici repressi dal concetto. La filosofia dell’arte deve immergersi nell’opera, ripercorrerne i nessi formali, lasciarsene travolgere mimeticamente – come chiunque -, e successivamente cercare di ripercorrere con i concetti i nessi tra il brivido provato – per così dire – e la totalità, tra il contraccolpo mimetico – spirituale ricevuto e la configurazione attuale dell’universale. Nell’arte l’oggetto è l’opera, qualcosa che già di per sé, costitutivamente, mette allo scoperto il non identico, e quindi la filosofia non ha che lo scopo, direi quasi “notarile”, di attestarlo, confermarlo, nel linguaggio dei concetti. Nella filosofia invece l’oggetto è l’essente, che nasconde altrettanto costitutivamente il non identico, che si tratta quindi di svelare. L’idea di “costellazione” è la strategia adorniana per far emergere il non identico attraverso l’uso della stessa ratio che lo occulta. Il sistema, la cogenza logica, che appartiene ad ogni discorso sensato, e che è irrinunciabile, fa violenza al particolare, al non identico del particolare: quest’ultimo si comporta bensì come previsto dalla legge trovata dalla ratio, si lascia cioè interamente dedurre dall’universale, e quindi sembra essere completamente adeguato al concetto che la ratio gli prescrive, ma in realtà, al suo interno, il momento mimetico della sofferenza e quello potenziale dello spirito autonomo, contraddicono silenziosamente quell’adeguazione di fatto. La “costellazione” serve a descrivere interamente questo stato di fatto: la deduzione logica del particolare dall’universale e insieme la sua potenziale non verità, la sua contraddizione: serve a far emergere, nell’ambito stesso della legalità logica vigente, una diversità dirompente, nella conciliazione apparente l’inconciliato. Non a caso l’esempio di costellazione portato da Adorno riguarda il capitalismo. Qui infatti un universale, come ens realissimum, domina su tutti i particolari a cui fornisce esistenza. Sembra quindi esserci cogenza logica. Ed in effetti essa è sempre più totale. In realtà se l’affermassimo come legge naturale, con catene ordinate di calcoli, sbaglieremmo, ci arresteremmo alla facciata: poiché i particolari soffrono nella adaequatio -e con ciò già la negano – , e poiché potenzialmente avrebbero la facoltà – giusta il libero arbitrio – di autodeterminarsi. La costellazione, secondo la parola stessa, invece di produrre more geometrico subordinazioni di concetti in una prospettiva gerarchica, quindi per così dire disegnare in modo definitivo e definitorio l’oggetto, lo accennano vagamente come fanno le costellazioni celesti, dandogli la libertà di essere così ma anche altrimenti. La cogenza viene affermata: la figura è lì, chiara come quella di Orione, ma come quella non così chiara da non poter essere completamente diversa.
Risponderò in un’altra occasione all’intervento odierno di Ludovica.
Cara Ludovica,
visto che non ci intendiamo con il lessico e il linguaggio filosofico, parliamo terra terra. Kant: perché è importante Kant, nonostante sia inaccettabile e superata la sua concezione complessiva. Perché mette definitivamente una pietra sopra ad ogni metafisica. Ciò che possiamo sapere ci viene dale impressioni dei sensi, e queste rimandano a qualcosa di diverso da noi stessi, dalla nostra coscienza. Questo qualcosa, detto rozzamente, è la natura, cioè il nostro corpo e il resto del mondo che lo circonda. Applicando il nostro pensiero alla natura ne determiniamo le leggi che, sfruttate, ci consentono di sopravvivere. Questo è il cerchio in cui si può parlare di verità. In cui si può applicare in modo veritiero il nostro pensiero. Al di fuori di ciò torniamo al medio evo, al dogmatismo religioso o filosofico, alla superstizione o alla magia. Adorno aderisce pienamente a questa visione, solo la integra con il concetto di non identico. Il non identico – ancora rozzamente – è tutto ciò che il pensiero è costretto ad espellere nel suo sforzo di catturare con i concetti, i giudizi e i silologismi le leggi naturali: il dolore, il piacere, il patire della nostra corporeità nell’esperienza con il mondo. Questo patire, che nella preistoria, e nel resto del mondo animale è modalità di sopravvivenza, per la ratio strumentale è fattore di disturbo: non è quantità, è qualità, ed inessenziale alla rigorosa e infinitamente ripetibile legge naturale. Reintrodurre in non identico nel processo di pensiero, reintrodurre il patire umano nella ratio, ha il significato di rendere la ratio ancora più completa e coerente, e di finalizzarla in modo consapevole al benessere dell’uomo. Tutto qui. L’introduzione del non identico non è l’attingimento della Verità: questa, con la v maiuscola, è esclusa in partenza. Chi ci ha fatto, chi ha fatto il mondo e l’universo e perché, tutto questo rimane fuori dalla nostra possibilità conoscitiva, rimane mistero, ed è merito di Kant avercelo mostrato una volta per tutte. Con il non identico si rende solo più cogente la ratio umana, permettendogli non solo di calcolare la natura, ma di abolire il dolore umano, che è la cosa che più importa.
Questo è il mio quadro di riferimento. Ora, tu pretendi che l’arte superi come per incanto la barriera del mondo empirico e raggiunga invece l’Assoluto, l’Essere, comunque il mistero che – sono d’accordo – ci trascende tutti. Lo affermi, ma non lo spieghi. Qual è il senso che ci permette di sentirlo? La fede? La grazia? Un’intuizione riservata a pochi prescelti – gli artisti appunto? Noi percepiamo con i sensi la realtà esistente, quella esterna e quella interna della fantasia e della memoria che da essa deriva, questo accade nel comportamento pratico e anche in quello artistico. L’artista lavora con i sensi che hanno tutti, non ne ha di speciali, quindi apprende dal suo mondo esterno e interno quel che apprendiamo noi. La Verità, l’Essere, Dio, gli sfuggono come sfuggono a tutti. Dici: “l’arte procede dalla Verità, con l’arte si fa esperienza della Verità qui e ora… la capacità di trascendere il soggetto nel mistero e nella forma restituisce l’arte alla verità come sua “rivelazione”…l’arte non si limita ad esprimere il dolore, la passione, ecc, ma è capace di caricarli di senso, riuscendo a trascendere la propria epoca…” Queste affermazioni, stando alle parole usate, non significano nulla, non hanno alcun contenuto d’esperienza, fanno solo nebbia, e oscurano dietro lo stile esoterico l’ukase irrazionale dell’arte come “porta dell’Essere”. Quale senso, dico io, si può trovare nel dolore umano se non quello di abolirlo? E che mi interessa di trascendere la mia epoca con il senso del mio dolore? Forse per arrivare alla banalità (falsa) che il dolore è un’ (altra) invariante metafisica o antropologica? Questo basti per il rapporto arte filosofia.
Veniamo alla prospettiva sociologica. Perché ha priorità su ogni altra? Continuiamo a parlare rozzamente. Senza società, niente Ludovica, senza Ludovica, niente pensiero di Ludovica sull’inessenzialità della prospettiva sociologica. E’ triviale ma è così. Aristotele, raccogliendo la tradizione socratica e platonica, dice che l’uomo è uno zoon politikon, un animale sociale, perché solo nella polis, attraverso la divisione del lavoro, l’uomo può sussistere: la polis, la società, è in ogni momento della storia la condizione di possibilità dell’uomo sia fisicamente sia spiritualmente: ancora più rozzamente, se lui non lavora per gli altri e gli altri per lui, lui muore di fame e di stenti, muore fisicamente e quindi spiritualmente.
Da qui la priorità della società e della prospettiva sociologica, da ogni punto di vista, gnoseologico, estetico, psicologico, ecc. Questo discorso, valido in generale, è tanto più vero oggi in cui la società sta diventando per gli individui che la compongono un blocco fuori e dentro di loro (dentro attraverso la preformazione spirituale indotta dalle agenzie formative e dall’industria culturale). Essa – o più precisamente la sua forma antagonistica – si sta configurando, con la globalizzazione incombente, come ciò che la filosofia chiamava ens realissimum, cioè l’essenza che domina la vita di sei miliardi di persone. L’essenza degli uomini, separata dagli uomini, che si contrappone loro come entità estranea.
In Delfi ad un certo punto ci si pone correttamente questo problema: “Per esempio, dovo sono i capi del Controllo? Già intorno a questa semplice e capitale domanda non c’è una risposta sicura.” Il romanzo riesce ad individuare la natura sfuggente del potere contemporaneo: non si sa dove siano localizzati i centri di potere ma questo non diminusce la loro rilevanza, anzi la rafforza perché si tratta alla fine di una forma di potere che, sia pur diluita, è ancor più invasiva e pervasiva di tutte le altre del passato. Delfi è un romanzo riuscito proprio perché riesce a fornirci una rappresentazione incisiva di questa nuova dimensione del potere.
L’alternativa a questa pervasività è rappresentata dalla nostra corporeità, l’unica che, a rigore, non può essere controllata compiutamente. Questa alternativa di una corporeità come unico argine al totalitarismo diffuso è un altro aspetto molto riuscito del romanzo. A domani le due attese dichiarazioni.
Avevo promesso di rivelare oggi il piccolo mistero che mi compete e che in parte era già stato svelato. Non so usare il computer, mi sono sempre rifiutato di farlo e, anche se la mia produzione annuale è molto ampia, procedo ancora con la mia vecchia macchina da scrivere. Chiunque voglia comunicare con me, deve farlo mediante il cartaceo o il telefono. La ricercatrice cui avevo dettato il mio sfogo su Modena ha commesso un banale errore ed è perfettamente in grado di intervenire autonomamente, dato che il suo oggetto di ricerca attuale concerne il rapporto tra letteratura e musica.
Ho conosciuto Dell’Orco solo quando ho presentato il libro alla fiera torinese; anche i miei rapporti con la casa editrice Acca erano inesistenti. Si erano rivolti a me con la speranza, dati i miei interessi trasversali, che riconoscessi alcuni spunti musicali che esistono nel romanzo. E’ puntualmente avvenuto senza nessuna forzatura. Questa è la realtà dei fatti. L’unica cosa che mi sono limitato a fare è stata quella di informare alcuni giovani ricercatori ed alcuni giovani amici intellettuali sull’esistenza del dibattito in “Nazione Indiana”. Alcuni si sono sentiti stimolati ed hanno partecipato, altri, invece, no, ma sempre liberamente, senza costrizione alcuna. Non vedo in questo nessuna forzatura.
“Con il non identico si rende solo più cogente la ratio umana, permettendogli non solo di calcolare la natura, ma di abolire il dolore umano, che è la cosa che più importa.” Caro Sandro, molto benevolmente, non ritengo che questo sia nelle intenzioni di Adorno, che, come tu ben sai, ha scritto i Minima moralia con il sottotitolo, Meditazioni della vita offesa.Il dolore viene dunque rappresentato in tutta la sua tragicità senza redenzione alcuna, anche se con aperture alla speranza, che Adorno mutua da W. Benjamin e, conseguetemente, dal patrimonio teologico ebraico.
Apprezzo il riferimento del prof. Matassi alla matrice teologica del pensiero adorniano, che ne investe l’intera produzione con importanti conseguenze anche sul piano musicologico ed estetico. Mi propongo di approfondire in seguito l’argomento e di rispondere più dettagliatamente alle considerazioni critiche di Dell’Orco.
Caro Sandro,
ho visto sul sito di Hacca che questa sera potremo ascoltare, dalle 24, una tua intervista nel programma “Notturno Italiano”.
In bocca al lupo!
Jolanda
Sono sicuro che nell’intervista radiofonica di stasera emergeranno tutti i temi dominanti nel dibattito che ormai da due mesi coinvolge Delfi. In questi giorni sto leggendo un altro “giallo musicale”: O dolce o strana morte di Lorenzo Arruga, un genere che si sta sempre più imponendo nella contemporaneità. Ovviamente tra i due romanzi vi sono differenze profonde, di stile, di scrittura, di struttura e di contenuti ma al di là di tutte queste profonde differenze è ineressante constatare come la musica entri direttamente nel tessuto narrativo di un romanzo, come nel caso di Delfi.
Io tornerei sulla questione relativa a Kant, nella quale si dici che con il pensatore tedesco si seppellisca la metafisica. E lo faccio in due battute: Kant cementifica la metafisica, in quanto per lui è davvero certo che (mentre per Cartesio, poco prima quindi di Kant, era indifferente) che vi è qualcosa al di là della ragione. Ma che questo qualcosa (che a Kant non è indifferente: è un problema) sia irraggiungibile. La metafisica con Kant probabilmente tocca il suo fulgore!
i commenti di questo post verranno chiusi fra tre giorni ma non si dice di quale era, qui ci cova una gatta o sciatteria impera
comunque, dopo due settimane di assenza, vedo che non ci si schioda, Sandro si macera nella poca autostima, Matassi loda il discente che sviluppa un prodotto notevole, Jolanda si mangia la erre greca, Adorno dice qualcosa di intelligente solo se risciacqua i frammenti di Benjamin
Caro Massinissa, intanto ben tornato! Data la tua assenza nel dibattito, mi stavo preoccupando sul tuo stato di salute. Non conosco i regolamenti di nazione indiana, né faccio dietrologie sullo scrittore che conosco personalmente in modo molto superficiale. Prendo spunto dalla tua ultima affermazione: hai perfettamente ragione, sono da più di trent’anni che sostengo, anche per quanto concerne la Filosofia della musica moderna, che Adorno si ispiri largamente a Benjamin, che, purtroppo, nella sua vita non ha avuto la stessa fortuna di Adorno. Prefersisco infatti, nei miei saggi, parlare di Adorno-Benjamin e credo di aver dimostrato che in quest’ultimo, nonostante le sue scarse competenze musicologiche, sia presente una sottilissima filosofia della musica di cui non si è accorto mai nessuno, a parte il sottoscritto. Lo documento in tanti saggi ed in un mio piccolo volume che sta per uscire per Il Ramo di Rapallo: “L’idea di musica assoluta. Nietzsche-Benjamin”.
Non mi sembra proprio che si possa imputare Adorno, come è accaduto per Heidegger, di disattenzione per le sorti del romanzo e/o netto sbilanciamento a favore della poesia. E questo per almeno due ragioni: quella additata da Matassi, ossia il suggerimento, almeno implicito nella riflessione adorniana, di una costruzione e struttura “musicali” dell’opera narrativa, suggerimento in qualche modo raccolto e divenuto operativo in un testo come “Delfi”; e poi perché al centro della sua speculazione, certamente almeno di quella che si dispiega in “Minima moralia”, c’è il soggetto/l’individuo così come il grande romanzo per sua costituzione (e – aggiungerei – con grande, disincantata verità e realismo) lo descrive e lo “inscena”, ossia, per un verso, assolutamente e disperatamente solo nella freddezza e indifferenza o nella più o meno aperta ostilità di tutti gli altri-da-lui e, per altro verso e allo stesso tempo, inesorabilmente implicato con tutti e da tutti condizionato in quella che Adorno chiama la società moderna totalmente socializzata.
caro Sandro come vedi tutto torna: ci sono io che mi mangio la “ere” greca e c’è invece chi si mangia il fegato comprensivo di bile. Tutto torna sempre e credo di aver individuato chi si cela dietro quello sciocco pseudonimo. Con la stima di sempre jolanda.
Marco Fortunato rivela le sue grandi qualità teoretiche, centrando il punto essenziale del dibattito. Ben vengano interventi come questo che arricchiscono di sempre nuove implicazioni una discussione che diventa ogni giorno più appassionante. Questo, ovviamente, rimanendo ferma la precisazione di Massinissa che Adorno ha contratto grandi debiti teorici nei confornti di Benjamin.
a meno che i tre giorni siano calcolati con una velocità angolare dell’asse terrestre pari a quella di Jolanda quando pirla su sè stessa negli esercizi mattutini
Commenti aperti per tre giorni dalla data del pezzo, oppure per tre giorni dalla data dell’ultimo commento. Ma forse ora è arrivato il momento di tirare le somme su questo thread di commenti, no?
Chi è venuto in soccorso del romanzo è stato il poeta per antonomasia. Cos’altro voleva affermare infatti Leopardi nel dire che è molto più difficile tradurre da una lingua straniera un romanzo invece che una poesia, se non dire che con la poesia (e la musica), il traslare le sensazioni da una lingua ad un’altra sia molto più libero che farlo invece con un qualcosa che fa le viste ad un sistema (il romanzo)?
Non è nelle mie intenzioni fare alcuna apologia della metafisica. I limiti della metafisica sono quelli della filosofia stessa, il ricorso al suo linguaggio si rende necessario quando si vuole tentare di spiegare od esprimere in termini razionali, anche solo per agevolare la comunicazione, fatti più complessi come quello dell’arte, oggetto del nostro dibattito.
Caro Sandro,
estendendo l’ambito della verità (necessariamente omnicomprensiva) al di fuori del cerchio, molto stretto, soggetto/natura, nei termini gnoseologici a cui ci riferiamo, è possibile che si ritorni pure al Medio Evo (in cui, peraltro, è tutto un proliferare di logica e sillogismi, mentre la magia trova la sua massima fioritura nel Rinascimento, con il recupero delle varie filosofie della natura), ma si ritorna anche a buona parte della storia dell’estetica prima e dopo Kant, con rare eccezioni. Il mistero non è tale perché inconoscibile e in generale non esperibile, ma perché non è esauribile e dimostrabile da un certo tipo di linguaggio: quello filosofico, delle scienze empiriche, delle scienze matematiche, della logica e nemmeno della metafisica. La verità, che ‘appare’ nell’opera d’arte e che rimane, nonostante la sua rivelazione nell’opera, mistero, è effettivo oggetto d’esperienza e, con un’ampia varietà terminologica, è affrontata come tale da molti artisti e filosofi che si propongono di spiegarla.
Dici: “L’artista lavora con i sensi che hanno tutti, non ne ha di speciali, quindi apprende dal suo mondo esterno e interno quel che apprendiamo noi. La Verità, l’Essere, Dio, gli sfuggono come sfuggono a tutti.”
Parole come ‘opera d’arte’,‘forma’, ‘bellezza’ vengono “spiegate”, nella storia del pensiero, anche la più recente, facendo riferimento il più delle volte a categorie che, quando non sono metafisiche, sono, in modo ben più cogente, mistiche (nel senso dell’immediatezza dell’esperienza). Questa fitta schiera di critici, filosofi, musicologi, ecc…appartengono spesso, per cultura e formazione, a contesti non sospetti. Per fare solo alcuni esempi più vicini al mio ambito di competenza e già citati nel dibattito precedente: il “kantiano” Hanslick, per spiegare la natura formalistica del bello musicale, usa più volte la parola “spirito”, Bloch, che, anche data la sua compromissione con il marxismo, non era certo un rigido tomista, utilizza, senza alcun pudore, il termine “essere”, “infinito”, “anima”…, il nostro caro Adorno è debitore della teologia ebraica e persino della cabalistica… Il mistero non sfugge completamente a nessuno e il riferimento a ciò che trascende la nostra esperienza meramente sensoriale – giacché anche quella del mistero non esiterei a definirla ‘empirica’ –, che rimane comunque imprescindibile, diventa inevitabile quando ci si voglia approssimare all’essenza più profonda del fatto artistico. Alla tua domanda su quale sia l’ “organo” che ci permette di cogliere la sua verità potrei rispondere solo con quel linguaggio, più artistico o mistico che “esoterico”, il cui contenuto d’esperienza è perfettamente rintracciabile nella storia dell’estetica, fatta non solo dagli estetologi, ma anche dagli artisti e dalle loro opere.
certe formazioni pendule i geologi le chiamano tautologicamente stalattiti, i poeti le chiamano zinzuli, chiara la differenza?
Dopo le vacanze estive, il dibattito che si sta sviluppando dimostra in maniera inequivoca che il romanzo Delfi è un vero e proprio romanzo filosofico, un genere che, dal mio punto di vista, ha ancora enormi possibilità di sviluppo. Sono infatti favorevole in linea di principio alle intersezioni, in primo luogo tra letteratura e filosofia, in secodo, tra letteratura e musica. Il dibattito è aperto e non vedo il motivo per cui dovrebbere essere spento dall’alto in maniera autoritaria. Lo ripeto per l’ennesima volta: il blog è l’espressione massima della democrazia.
voglio dire che l’emozione, il sentimento, la commozione, l’esaltazione non c’entrano nulla con il guizzo artistico-poetico.
Leopardi è stato modesto poeta, fatta eccezione per qualche lirica (definirlo antonomastico rivela scolasticità ed estraneità all’esperienza del bello-coltello); ricordo quanta ilarità suscitavano in quelli degli ultimi banchi, vampiri perfetti, i suoi “toccanti” pentirommi e volgerommi.
non si tratta di essere o no favorevoli alle intersezioni, Illustrissimo Signor Conte, anzi, interseco anch’io di già che interseca lei, ma di intersecare a proposito
Bella discussione. Mi piace. Dovrebbe piacere a tutti, estimatori e detrattori del mio romanzo, che in qualche modo l’ha promossa. E’ bella perché spinge fuori dalle aule universitarie la filosofia e la confronta con i problemi reali della composizione di un romanzo, problemi gestiti in proprio dalla categoria dei critici letterari, nei modi che sappiamo. Questo fa bene alla filosofia che si toglie dall’autoreferenzialità accademica e si cimenta con problemi empirici. E fa bene alla letteratura, al romanzo, alla poesia, che vengono strappate via dalle categorie sempre più mercantili e corrive della nostra critica, teleguidata dall’industria culturale.
Detto questo, rispondo ad Ettore Stancanelli. Kant ha seppellito la metafisica perché mantiene ferma la differenza tra soggetto e oggetto: l’Io trascendentale e la cosa in sé, affermati simultaneamente nella loro radicale diversità, rendono impossibile la loro riduzione reciproca: riduzione all’unità che è il principio stesso di ogni idealismo e di ogni ontologia. Adorno si rifà spesso a Kant, nonostante tutte le sue aporie, anzi proprio in virtù di esse, perché ritiene che le contraddizioni della realtà debbano essere (innanzitutto) riflesse dal pensiero, invece di essere appianate da esso per amore di coerenza e di assolutezza. Il pensiero, secondo lui, deve amare più la verità delle cose che la sua coerenza.
A Ludovica invece dico che nonostante i suoi sforzi, non riesco a capirla. Affermare che il mistero è tale non perché sia inconoscibile o inesperibile, ma perché non è esauribile e dimostrabile dal linguaggio filosofico, delle scienze empiriche, delle scienze matematiche, della logica e nemmeno della metafisica, significa (visto che queste sono tutte e sole le facoltà conoscitive che possediamo) affermare dogmaticamente l’esistenza di una percezione intuitivo – immediata che ci metterebbe in contatto empirico con un “retromondo” mistico accessibile solo a pochi eletti e agli artisti. In realtà, il non identico che si attinge nell’arte, non è misterioso: è la natura umana repressa da eoni che finalmente si libera, sia pure in effigie.
Naturalmente sono d’accordo con Matassi sulla democraticità del blog e sull fatto che non debba esser chiuso dall’alto, in maniera autoritaria.
Ricordo al caro Massinissa che sono già dal punto di vista istituzionale un intersezione: i docenti ordinari di filosofia morale in Italia sono circa ottanta, ma sono anche l’unico ad insegnare estetica musicale. Ma non si tratta di una questione banalmente didattica, sono i miei interessi che mi portano ad abbracciare le intersezioni fra filosofia e musica ed, in certi casi, anche fra letteratura e musica. Ho qui davanti a me, di freschissima uscita, il volume annuario Hermann-Hesse-Jahrbuch della Hermann-Hesse-Gesellschaft, dove è apparso un mio contributo Hesse und die “Neupythagoreische Musiklehre”. Lo ricordo non solo per attestare i miei interessi trasversali, ma anche perché nello stesso annuario sono presenti molti contributi di autori stranieri dedicati all’utopia di Castalia, che mi riportano direttamente a Delfi. Non può essere assolumente casuale se la protagoniasta di Delfi assume il nome di Castalia, di qui tante altre considerazioni che, in parte, sono state fatte, ma che portebbero essere ulteriormente svolte ed approfondite. I percorsi per intersezioni sono infiniti, sta a noi saperli individuare.
Non ho ben capito il regolamento di nazione indiana e il messaggio che la stessa redazione ha inviato in risposta a Massinissa. In democrazia le regole sono uguali per tutti e modificarle in fieri non mi appare molto corretto. Purtoppo questa è una consuetudine molto diffusa nella nostra società, a tutti i livelli, ahimé anche nell’ambito accademico a cui appartengo. Proprio per questo ho deciso, insieme ad alcuni amici, di fodare una rivista, per ora solo on line, “in Schibboleth” http://www.inschibboleth.org, con sottotitolo “nuovi orizzonti della laicità e laboratorio per una riforma della politica”.
il retromondo mistico, bello. Sono d’accordo con te, Sandro, qua e là.
L’artista non percepisce e non profetizza più dei brancolanti uomini comuni.
L’artista, ma ce ne sono di così tante specie!, è un uomo ingegnoso, semplicemente più ingegnoso , che riconoscendo in sè queste doti decide prima o poi di vivere l’avventura della creazione artistica. Poichè ci sono altri uomini che amano e apprezzano l’ingegno, egli, grazie a questi, può produrre reddito per sè. Punto.
Mica tanto punto. Perchè scoprirà prima o poi di muoversi in un campo minato. L’ingegno infatti nel momento in cui si esplica non può che operare controcorrente, altrimenti che ingegno sarebbe, sarebbe norma, mestiere, un’altra cosa. Controcorrente, già. Questo comporta l’ostracismo, lo sappiamo. Lui deve resistere, se crede in sè, nella sua missione.
Ora, è concepibile che l’ingegno si muova contro la Verità, cioè contro le leggi dell’universo? No, l’ingegno va contro le normalizzazioni e le convenzioni pigre della società degli uomini. Ma questo non è ciò che già fanno anche le ricerche varie, scientifiche, giuridiche, socio-economiche, le rivoluzioni politiche eccetera? Certo, ma quella dell’artista è una ricerca e una missione speciale, si avvale di mezzi tanto umili quanto singolari, un metro quadro di tela, un quaderno di appunti, un software di grafica, un palcoscenico ecc. e opera nell’affanno di tutti i giorni, ripeto di tutti i giorni, al servizio giornaliero dei suoi simili dai sensi ottusi, per acuirglieli, emanciparglieli, per educarli a vedere, ascoltare annusare gustare toccare quello che non vedono, sentono, annusano, gustano, toccano più, per rendere loro una vita meno cieca e vuota
la protagonista di Delfi si chiama Castalia, e allora?
Facciamo un gioco, io dico Antinoo, lei mi sviluppi alcune considerazioni che questo nome le ispira. Sono sicuro che mi attacca un bottone che non finisce più. Anche se non è il nome dell’eroino di un giallo filosofico.
Poichè io ho letto un capitolo del libro e mi basta per giudicare della sua qualità letteraria, sostengo che lei, nell’apprezzarlo a sfinimento, sia abbagliato da personalissimi criteri e pregiudizi extra-letterari.
Io credo anche che i giudizi, tutti i giudizi, anche quelli di calcio, quando sono seri e studiati, siano oggettivi, o meglio tendano all’oggettività. Non riconosco le opinioni. I giudizi si sbagliano per mancanza di esperienza e di informazioni. Poichè nel giudizio di Delfi lei si sbaglia clamorosamente, lo dico io, ma non nel cogliere male le vere o supposte implicazioni musicali o filosofiche, ma nel non considerare minimamente quello che va invece considerato quando si giudica un testo letterario, cioè la bellezza di scrittura, la sua bevibilità (io, non so lei, i libri non li leggo, li bevo), devo pensare che manchi di esperienza estetica specifica
X massinissa:anche se del mio giudizio porobabilmente non se ne farà alcunchè visto che (parafrasando il film i cento passi) lei mi considera nulla mecolato col niente,vorrei comumque dirle che per parlare dell’artista,come ho letto nel suo precedente intervento,bisogna che artista sia anche lei. E anche se non le interesserà saperlo,nel mio piccolo, ho avuto anch’io qualche batosta proprio per esssere andata controcorrente. Ma siccome sono abbastanza tosta e la mia passione è vera, continuo a scrivere in barba a quanti mi vorrebbero affossare nel regno della nebbia. per quanto riguarda il suo secondo intervento credo sia più corretto che le risponda la persona a cui è diretto.Saluti.
Partendo dalla misteriosa comparsa dei due amanti in un sito inaccessibile, Sandro Dell’Orco costruisce una storia avvincente che cattura il lettore e stimola la sua curiosità, immergendolo in una dimensione di sogno e portandolo a immedesimarsi con il protagonista, vivendo con lui, soffrendo con lui nella ricerca di una spiegazione logica da dare ad un mistero apparentemente irrisolvibile.
Il lettore più attento, nella lettura troverà lo spunto per riflettere su temi che emergono velatamente dal romanzo e che sono legati alla condizione umana, alla difficoltà di gestire la propria vita lontano dalla razionalità dominante, dai compromessi e dall’omologazione.
Più semplicemente direi che l’autore di Delfi abbia voluto dare corpo alle proprie fantasie, ai propri sogni, alle proprie paure attraverso un romanzo godibile e di grande impatto emotivo.
Gentile Ludovica,pur avendo apprezzato le sue elucubrazioni filosofiche,mi sono resa conto che lei non ha mai accennato a Delfi (cosa che invece ha sempre fatto il prof.Matassi). una curiosità,sempre che lei abbia voglia di esaudirla:il romanzo l’ha letto? e se lo ha fatto,cosa ne pensa? cordiali saluti.
Ieri ho letto un intervento di Piergiorgio Odifreddi su “la Repubblica” (“Quanto è debole la coscienza”), nel quale, recensendo una pubblicazione del neurofisiologo Libet, scrive che, “in termini musicali, la nostra sensorialità è come una fuga a due voci, in cui la stimolazione funge da dux e la coscienza da comes che la insegue a un intervallo di mezzo secondo”. Ma tutto questo non conduce a pensare che la cosceinza sopravanzi sempre, anche la percezione? Come fa la coscienza a portarsi dinanzi alla stimolazione se la stimolazione non avesse, già da sempre, saputo della coscienza? Io capovolgerei l’impostazione che dà Odifreddi e direi che è all’interno della coscienza che si può parlare della percezione. Quindi l'” a priori” è la coscienza”.
Cara Jolanda, io ho scritto delle cose di una ovvietà disarmante, ma ne ho sentito la necessità per far da contrappeso al delirio fuori tema che qui si consuma dall’inizio, cioè dalla recensione del Prof. fino all’ineffabile ultimo commento di Lucio. Continuo nel mio solco aggiungendo che insistere a voler fare gli artisti senza averne il talento può causare forti dolori agli arti
superiori. Vedo che anche tu hai rilevato qualcosa di anomalo negli interventi di Ludovica. Ti voglio bene, cosa credi?
X Massinissa:grazie per la risposta ma per quanto riguarda Ludovica,nonè che io abbia riscontrato qualcosa di anomalo,semplicemente di incompleto. mi sarebbe piaciuto leggere anche un suo giudizio a proposito di Delfi,un romanzo che,comunque se ne parli,a me continua a piacere. cari saluti.
Caro Massinissa,
ho molto apprezzato i tuoi ultimi tre interventi per lo stile della scrittura ed anche per la natura dell’argomentazione. Molte volte il modo è anche più importante dei contenuti e rispetto profondamente quello che dici. E’ altamente probabile che nel mio giudizio su Delfi io sia stato mosso sopratutto da motivazioni extraletterarie, ma questo, come tu ben sai, è anche nella mia natura e nel mio ruolo. Sulla qualità letteraria ed artistica si può certo discutere all’infinito ma anche su questo piano non ritengo che Delfi debba essere sottovalutato, almeno rispetto a certi scrittori contemporanei che vengono invece tanto enfatizzati dai circoli mediatici e lobbistici oggi dominanti. Comunque ancora grazie per i tuoi tre ultimi interventi, perché spostano il dibattito su un terreno molto serio che merita il massimo rispetto.
Il mio giudizio su Delfi non è semplicemente impostato nei termini del piacere oggi tanto rivalutato, si veda anche il recente volume di Armstrong, “Il potere segreto della bellezza”. Quello che mi interessa di più è la dimensione del racconto filosofico, dove per racconto filosofico intendo una presa di posizione militante nei riguardi della realtà contemporanea. E’ proprio di questi giorni la notizia allucinante di un delitto senza movente, pensato e gestito da alcuni giovani, che lo avevano propgrammato su internet e che, dalla virtualità, hanno deciso di passare all’effettività del delitto. Si tratta di un caso esemplare, di una tragedia tipica della contemporaneità, rispetto alla quale Delfi ha molto da dire. La mia simpatia intellettuale nei confronti di questo romanzo nasce proprio da qui, dalla capacità di denuncia di una società, apparentemente impalpabile, ma, in realtà, terribilmente curdele.
Aggiungo una piccola precisazione per Massinissa: la parte del romanzo che è riuscito a leggere non è il prologo o la parte 1, come viene definita, ma solo una piccola sezione introduttiva della parte II. Ovviamente non so se questo può modificare il suo giudizio, ma ritengo fosse utile precisarlo per l’informazione più corretta.
grazie della precisazione, Prof
La scrittura sexy, chissà che vuol dire. Finalmente lo sappiamo. Vuol dire la scrittura bevibile: i libri si bevono, non si leggono, devono andar giù come un bicchiere di Brunello, mica scherzi, mica come il Tavernello. Al vero intenditore, poi, basta assaporarne il bouquet: accostare la punta del naso al bordo del calice e il giudizio è tranciato, inappellabile: ciòfeca o nettare, paccottiglia o capolavoro. Con queste categorie da alcolista (anonimo) si vorrebbero analizzare e giudicare i romanzi. Povera Garzantina!
non solo i libri, mi bevo anche le mostre d’arte, mi basta un’occhiata per capire se c’è del buono, mi bevo anche i ristoranti, mi basta vedere l’arredo per capire come sarà la cucina, per non parlare della lista dei vini
ma hai ragione, non è con queste categorie ma è con queste categorie che io decido se entrare o no. Tu come fai, permalosetto?
Mi rendo conto che Massinissa ha una visione estetica del mondo che io condivido; anche per me il cibo viene prima accettato dagli occhi e poi dal palato, anche per me la lista dei vini è fondamentale in un ristorante e così per tutto il resto. Tra di noi rimane quest’unica differenza: quando ho preso in mano il libro di Dell’Orco, che ho ricevuto per posta (non avevo ancora conosciuto direttamente l’autore), ho provato un’istintiva simpatia e, perché no? anche piacere estetico, ancor prima di leggerlo, mi sembrava un bel libro. La lettura ha confermato ampiamente questa mia impressione sensitiva ed ha aperto prospettive extraletterarie, come argomenta Massinissa, ossia filosofiche e musicali rilevanti, e questo, per me, è molto importante.
scusa Prof., sono le 23 al mio meridiano, ti sei portato la ricercatrice a casa? Ci avevi detto che rifiuti il PC, sei ancora in ufficio?
caro Massinissa, proprio in questo momento una bella signora mi sta dicendo che il mio è uno snobismo filosofico tipico della vecchia scuola, il non saper usare il pc. In questo momento sto dettando al dott. Pini. Ieri sera alle undici una cara amica mi ha telefonato e le ho dettato quel piccolo testo. D’ora in avanti ti preciserò sempre la persona cui sto dettando le mie considerazioni.
Stai tranquillo che ci vorrà ancora molto tempo prima che decida di imparare.
Un caro saluto da Elio Matassi
Carissimo Matassi, ho una voglia di conoscerti da impazzire, ma non si può, le regole di copertura impongono, salutami il dott. Pini.
Con smisurato affetto
Massey
Un mesetto fa ho inviato un messaggio relativo a “Delfi”. Sono tornato da poco dall’estero, e rileggendo il tutto (non interamente, peraltro, perché il carteggio telematico si è fatto ponderoso assai) noto che la discussione è continuata, qua e là brutale, ma anche interessante.
Un aspetto molto curioso, e anche divertente, però, è stato la commedia degli equivoci che si è consumata rispetto alla presunta personalità multipla di Elio Matassi. Prima di entrare brevemente nel merito, lasciatemi fare “outing”. Sono collega e amico di Elio Matassi a Roma Tre e, sia pure cursoriamente, ho partecipato a questa discussione perché Elio me ne ha parlato con entusiasmo (francamente non ci vedo nulla di male). Anche altre persone che sono state accusate di essere Matassi en travesti, in realtà sono persone in carne e ossa — colleghi, amici o studenti di Elio, che hanno sentito da lui mirabilie su questa discussione (c’entra probabilmente il fatto che per Elio, immagino, sia la prima volta che partecipa a una discussione in rete: c’è nessun altro che ricorda l’ebbrezza delle prime discussioni telematiche?).
Capisco, sinceramente, che, dal punto di vista di chi non conosce l’ottimo Matassi, la cosa possa suonare un po’ strana: e, per questo, si può capire che qualcuno sia incredulo — e anche irritato — rispetto alle spiegazioni che lui ha dato sul suo essere inabile ad ogni attività telematica, se non per interposta persona. Conoscendolo, però, posso garantire che non sa nemmeno come si accende un computer (figuriamoci postare i messaggi con nomi multipli). Forse sarà snobbismo o forse una questione generazionale, fatto sta che è vero che Elio detta sempre i suoi messaggi a qualcuno.
Per mettere fine alla questione propongo che chi non ci crede, venga a Roma Tre una mattina, o mandi un suo anonimo amico, e vedrà la cerimonia della dettatura. Capisco che è una cosa desueta — e, per chi è pratico di computer, magari anche irritante, incomprensibile e un po’ buffa. Ma (di nuovo) che male c’è?
Non so se ciò basterà a porre fine alla divertente leggenda del Matassi multiplo (si sa che talora le leggende vivono di vita propria). Se però la notizia continuasse a propagarsi, sarebbe a sua volta degna di un trattamento letterario (“Uno, nessuno, centomila Matassi”) o filosofico (“Sulla molteplicità matassiana”), a cui si potrebbe utilmente dedicare un’altra discussione telematica.
Un caro saluto a tutti.
Caro Massinissa, Cara Fatina, Cara Redazione di Nazione indiana (in questo momento sto dettando alla dott.ssa Ludovica), l’intervento di Mario De Caro è stato veramente esilarante. Pensate un po’ a questo esercizio metafisico o a questa lezione minimale (qualcuno che oggi ha molta fortuna la definisce così) dedicata all’uno e il molteplice in relazione ad Elio Matassi. Il mio narcisismo ne risulterebbe veramente soddisfatto.
Desidero spostare la discussione sul romanzo ‘filosofico’ e sulla qualità letteraria. Sono necessariamente in contraddizione? Forse no e spero che d’ora in avanti gli interventi si concentrino su questo dilemma.
anch’io salverei di questo forum la commedia, sinceramente anch’io.
Un abbraccione a Elio
Ha certamente ragione Matassi : romanzo filosofico e qualità letteraria non necessariamente debbano entrare in contraddizione. Si pensi alla “Montagna Incantata” di Mann.
La domanda è retorica, mi piace più questa: può un programma politico avere qualità letteraria?
Indimenticabile l’incipit del Manifesto: “Uno spettro si aggira per l’Europa”
Elio, ma come scrivevano quei satanassi! Che ne dici?
Elio, mi piacerebbe che rispondessi anche a questa domanda: se Marx avesse scritto in stile addormentarmicosì, avrebbe avuto quel seguito?
X Ludovica:mi spiace che lei non mi abbia risposto. Ci tenevo veramente a leggere il suo giudizio su Delfi.
Gentile Ludovica,mi spiace che lei non mi abbia risposto. Ci tenevo veramente a leggere il suo giudizio su Delfi.
Prof. mi manchi molto. Perchè non chiami una tua amica al telefono e non gli detti un tuo breve?
il computer lo tieni sempre acceso, no? Solo per leggere dico, ce l’avrai un voltapagine in casa, ce l’hanno tutti
Le
Mass, ma secondo te l’oroscopo di Mani di Fata può avere qualità letterarie?
Sono le 22.31 e sto dettando alla mia amica Anna che mi telefona gentilmente per una chiacchierata, dato che sono nella più completa solitudine romana ed io, assecondando il mio carattere dispotico, sfrutto la sua gentilezza costringendola a controllare il dibattito che si svolge su nazione indiana. Credo che questo sia esauriente per giustificare il mio intervento serale. Rispondo subito al caro amico Massinissa: hai perfettamente ragione, la qualità letteraria è indispensabile alla riuscita di ogni progetto e, dunque, anche a quello di Marx. Ma sei proprio così sicuro che in Delfi non ve ne sia traccia? Rileggo in questo momento La Parola del Controllo, articolata in tre massime: “Il mondo e il tuo corpo sono del Controllo, esistono o si annullano secondo la sua volontà.
Il tuo pensiero è del Controllo, non sei tu che pensi, ma è il Controllo che pensa per te.
La tua volontà è del Controllo, non sei tu che vuoi, è il controllo che vuole per te”. (pp.237-238) Quello che io ho subito notato inDelfi è questa prosa, per così dire, controllata, quasi impersonale, come se avesse introiettato e metabolizzato a livello stilistico-letterario la Parola del Controllo e le sue tre massime. La ‘freddezza’ delle pagine di Delfi non è forse lo specchio del mondo ormai rarefatto che si sta vivendo e respirando? Voglio dire cioè che la qualità letteraria di Delfi sta in questa prosa, apparentemente anonima, ma che ha sedimentato in sé l’esercizio del Controllo e che, nonostante questo condizionamento scritturale, riesce comunque ad intravedere ancora un’alternativa sia pur minimale. La bellezza estetica di Delfi, per me, sta proprio nella capacità dello scrittore di essere ultrarealista (rispetto al Controllo che ormai lo domina) e, nel contempo, di additare una via d’uscita. Credo che anche questa capacità rientri nel canone estetico della qualità letteraria, almeno per me.
Caro Massinissa sono le 22.48, sto costringendo la mia amica Anna ancora telefonicamente (ti assicuro che è bellissima) a scrivere. Sempre sullo stesso tema. Avevo già detto in un precedente intervento che stavo leggendo il recentissimo romanzo di Lorenzo Arruga, O dolce o stana morte, concepito in tante brevissime istantanee-capitoli, che si susseguono incessantemente. Anche in questo caso la qualità letteraria viene raggiunta sia pure in una maniera completamente diversa, si tratta di un noir musicale che è anche, alla fine, una storia d’amore. L’erudizione del musicologo e l’autobiografia si fondono in maniera perfetta. Credo pertanto che la qualità letteraria o almeno l’aspirazione a raggiungerla siano sempre presenti in ogni romanziere e credo che questa aspirazione ed anche la sua riuscita siano ben visibili nella stessa Delfi. Ora, permettimi, non posso più abusare di Anna.
Elio, non parliamone più.
Piuttosto, ho dato un occhiata alla tua rivista on-line inschibboleth.org e ti devo fare i complimenti, il design è squisito, di taglio vegetariano e manuziano insieme, l’ho messa nei miei siti preferiti
Egregio prof Matassi,questa notte una luna arancio,chissà perchè,mi fa pensare all’Africa e alla magia della sua storia e dei suoi colori.Ha mai ascoltato la musica dei colori? un valzer di ginestre e glicini,un tango di papaveri,un minuetto di viole del pensiero,un bolero di rose selvatiche ? buona notte prof Matassi e felice risveglio.
joland disney band
Cara Jolanda, dal momento che credo fermamente nelle intersezioni credo anche alla musica dei colori. Vi sono alcuni miei saggi recenti, dedicati a quella che io defnisco la pregiudizioale musicocentrica, in cui critico fortemente chiunque voglia sostentere ad ogni costo il primato della musica su tutte le altre arti. Si possono capire le ragioni storiche di tale argomentaizone, dato che la musica ha sofferto a lungo della carenza di uno status autonomo, ma ormai siamo in un trend storico completamente diverso, dove devono prevalere le ragioni della vicinanza su quelle della lontantanza.
Caro Massinissa, grazie per i complimenti per inschibboleth, ovviamente è un progetto a cui tengo molto, perché ci troviamo in un momento storico in cui penso che sia doveroso per un ricercatore e per un intelletutale assumere una posizione più diretta ed esplicita sui problemi fondamentali della nostra contemporaneità.
Cara Jolanda e caro Masinissa, mi stavo dimenticando che entrambe le risposte sono state dettate alla dott.ssa Ludovica.
Egregio prof Matassi, la ringrazio di cuore per la risposta e sono lieta di sentire che crede anche alla musica dei colori. Io parlo da semplice poeta, non ho dunque molta competenza in materia ma le prometto che,se solo mi sarà possibile, troverò il modo per leggere qualcuno dei suoi saggi in merito. Per quanto riguarda il discorso della dettatura delle sue risposte,mi creda sincera se le dico che per me non assume alcuna rilevanza:io so per miracolo collegarmi con nazione indiana e se non ci fosse mia figlia a togliermi qualche volta d’impaccio non saprei proprio come andare avanti. Con viva cordialità,jolanda
Caro Massinissa,grazie per avermi collocata in quel mondo magico e colorato che ho sempre amato e continuo ad amare. Cari saluti,jolanda
Elio, per piacere, please, listen to me, adesso sto pensando che tu sia un gran furbacchione, tipo chiagni e fotti, ma fa gnente ti riformulo lo stesso la domanda di ieri notte, non per me, per il tuo avvocato De Caro:
Tu non sai accendere il PC, bene. Poichè di notte fai rispondere a quella bella fica della tua amica Anna, devo pensare che il PC lo sai almeno leggere, già che Anna risponde a tono su tua dettatura ai miei tickle tickle tickles, e che lo tieni acceso in permanenza. Ci hai anche detto che nella tua casa romana vivi solo e soletto, beato te, io vivo in un circo. Dunque, dall’ultima volta che il Tecnico ti ha acceso il PC tu non l’hai spento più, a volte va via la corrente per i temporali ma insomma se succede che si impicchino tutti, forza maggiore è forza maggiore. Allora, tu sei lì che ti godi la lettura di NI, su cui il Tecnico ti ha per così dire “sintonizzato” a tua preferenza , ed ecco…bisogna far scorrere il testo per leggere (lo schermo è quello che è, il mio è un 17″). Siccome sul mercato degli elettrodomestici c’è di tutto e anch’io ne posso avere bisogno, mi puoi dire che tipo di voltapagine digitale e automatico usi?
scusami, Elio, mi è sfuggito che costringi Anna a controllare il dibattito che si svolge su NI. Già, già, Anna è la tua rete-badante, che semo sibilante che sono.
Ma devi fare qualcosa, non puoi andare avanti così, metti che Anna ti legga senza la giusta intonazione, senza renderti il contesto, tu puoi capire male e poi se sei in viaggio…insomma è un disagio, come quello che provano gli adulti analfabeti quando cercano un numero civico
ma fai così tutte le sere? Povera tosa, questa Anna. E da quando? Da quando hai avviato questo thread? Ma è roba da Buster Keaton!
Senti, questa è roba forte, si può ricavarne uno script da sballo; se lo scrivo io mi dai l’ok? Come nome del protagonista mettiamo un nick di tuo gradimento
Gentile Jolanda,
mi scuso per non averle risposto prima. Penso che Delfi sia un romanzo ingegnoso e di piacevole ed interessante lettura. Debbo, ahimé, deluderla, nel caso lei sia aspetti da me “elucubrazioni filosofiche” – ammesso che siano tali – sull’opera in questione, per il semplice motivo che la mia scarsissima frequentazione della letteratura contemporanea di questi ultimi anni mi sottrae la possibilità di ogni riferimento comparativo. Pertanto, un tentativo di giudizio che esuli dalla semplice considerazione soggettiva rischierebbe di non rendere giustizia al romanzo. Spero di aver, almeno parzialmente, soddisfatto la sua curiosità.
Buona giornata
Ludovica
Caro Mssinissa.
in questo momento sto dettando alla dott.ssa Ludovica che mi ha letto gli interventi precendenti, come ieri sera la mia amica Anna mi ha letto gli interventi precedenti, perché io non ho un PC che non so accendere ma che rimane acceso tutto il giorno: se mi trovo all’università, utilizzo per la dettatura il PC del dott. Pini o della Dott.ssa Salomone, quando mi trovo a casa, solo come in questo momento, devo ricorrere alla lettura che una gentile dott.ssa o una gentile amica fanno delgli interventi e sulla base della quale io costruisco le mie risposte.
Da stasera questo non sarà più possibile perché vado a riprendere dalla case delle vacanze mia moglie e mia figlia. Ovviamente, mia figlia, che tornerà con me domenica sera, sa usare il PC. Quindi, da domenica sera potrei utilizzare, anche se mia figlia è molto impegnata nella preparazione di un concorso, per la dettatura, mia figlia. Quindi, come puoi constatare, in molti casi le mie risposte vengono argomentate sulla base di una lettura che mi viene fatta da una persona al telefono. Tutto vero e tutto facilmente riscontrabile, per chi mi conosce.
Cara Jolanda,
sarei molto lieto di poter leggere le tue poesie, perché ad intuito penso che possano esprimere quella musica dei colori di cui parli.
Caro Massinissa, dimenticavo, Mario De Caro non è il mio avvocato difensore, ma solo un giovane intellettuale che stimo e che mi conosce bene; è vero che sono un furbacchione, ma purtroppo non so usare né accendere un computer, e sono costretto, proprio come tu dici nelle ultime righe del tuo intevento, a comportarmi nella maniera da te indicata. Se vuoi costruirci un romanzo con un nome modificato mi farà molto piacere, perché anche se non so usare né accendere un PC riconosco di essere un narcisista moderato.
Heliokeaton, ti piace il nick? Richiama quello di un faraone illustre.
Ma torniamo indré, lo stile in scrittura, che cos’è? Come si forma?
Perchè Marx scriveva da dio? per esempio. Perchè aveva le idee chiare, il suo cervello gli faceva scorrere davanti agli occhi il film. Le immagini, gli incisi, i concetti fluivano come una birra buona alla sua penna.
Credo che tutti abbiamo provato l’esperienza di scrivere due tipi di testi: uno in cui sappiamo cosa dire, che ne so, la descrizione di un incidente automobilistico o una scrittura commerciale, per dire neh, e un altro di cui abbiamo scarsa idea del contorno, del contenuto e dell’efficacia , tipo un oroscopo, (rispondo con ciò anche a un commento qui sopra). Hai mai letto un oroscopo dei nostri giorni scritto bene, cioè che ti cattura l’attenzione? Non è possibile, es ist unmöglich!
Per scrivere un romanzo, incluse le sperimentazioni in progresso, devi avere il quadro generale in testa per poterlo poi sviluppare, aggiustare, limare, editare, rieditare. Se sei in questa condizione felice il tuo stile risulterà attraente, è molto probabile. Finnegan’s Wakes, per esempio neh, è un testo sperimentale ma si beve come una birra buona, anche se non capisci un’ ostia di quel che vuole dire.
Ora, prova a pensare a Delfi e dimmi se hai provato attrazione nel senso che ho detto
Sono stato chiamato in causa da Massinissa come avvocato difensore di Elio Matassi, che peraltro si difende benissimo da solo. (Incidentalmente ringrazio Elio per avermi definito un “giovane intellettuale”. Mi chiedo peraltro fino a quando si rimanga giovani, nell’italica accademica). Ripeto comunque che capisco i dubbi di chi è tecnologicamente sofisticato, ma ripeto anche che Elio i computer proprio non li tocca, come non tocca la maggior parte delle nuove tecnologie. Credo che, tecnicamente, si parli di misoneismo.
Seriamente, Massinissa, perché non mandi qualche tuo amico in incognito a Roma Tre, nell’ufficio di Matassi, in mattinata o a inizio pomeriggio? Se l’amico attende il momento giusto noterà Elio che infallibilmente chiede a qualcuno di leggergli l’email o di rispondergli ai messaggi elettronici (anche io l’ho fatto qualche volta, anche se non per Nazione Indiana, anche perché in questo periodo me ne sono stato in America).
Ciò detto constato, con un certo piacere intellettuale, che il mito della molteplicità ontologica matassiana continua a perpetuarsi. Alcuni titoli delle tesi di laurea che in futuro si potrebbero dedicare a questo mito sono: “Matassi: l’uomo a molte dimensioni”, “Elio Matassi nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” e “Identità e ripetizione: il caso Matassi”. Se ci sono studenti interessati, io faccio volentieri il relatore.
Ma non ho capito cosa c’entri Marx con il romanzo filosofico (solo perché “Il capitale” è pieno zeppo di riferimenti letterari?)
Riccardo Opi Says:
Ma non ho capito cosa c’entri Marx con il romanzo filosofico (solo perché “Il capitale” è pieno zeppo di riferimenti letterari?)
>>>
Se è solo questo che non capisci, sei avanti col lavoro.
Io è da 15 gg che seguo ‘sto blog e son dovuto andare in cantina a riprendermi il devoto oli.
Egr. Prof. Matassi, la ringrazio anticipatamente per l’attenzione e il tempo che vorrà dedicare alla lettura dei miei versi. Se in privato vorrà farmi avere il suo indirizzo, sarò lieta di farle pervenire alcune tra le mie pubblicazioni.
Questo è un blog dedicato a “Delfi”, quindi, per non annoiare gli altri, mi permetto di inviarle una lirica tratta da “Alternanze” (Calabria letteraria Editrice, 1996) dal titolo “Chiedimi”; a seguire una recensione del mio ultimo volume “Invincibili” (Città del sole Edizioni, dicembre 2005) a firma di Sandro Dell’Orco.
Chiedimi
Chiedimi di parlarti del mare
o del fiorito albero di pesco
e delle mille sfumature della rosa
ma non costringermi
a intristire il ramo,
a mortificare la luce
con cenere d’ulivo
nell’amplesso diurno
che serra terra e cielo
in sviscerate ipotesi
di quiete o d’agonia.
Se nel mare albeggia
la freschezza della luce
e se nel pesco e nella rosa
si placano gli affanni,
lasciami cantare
ancora litanie,
poesie perdute
che parlano d’amore.
Bevi, se vuoi, la goccia che vacilla
dalla consunta roccia dei miei anni.
Io parlerò del mare e della rosa,
dipingerò di pesco le pareti
ma non costringermi, no,
a martoriare
con petali appassiti
l’esigua treasparenza
della vita.
Nella poesia di Jolanda Catalano l’antica, immortale melodia greco – mediterranea viene violata e frantumata dall’esplosione inarrestabile della modernità. Resiste ancora, quasi come un relitto, in un mare di dissonanze del ritmo e del metro, l’andamento tenero e materno dell’endecasillabo, e sembra quasi un miracolo percepirne i dolci accenti nel turbine senza fine che spinge l’Io nella sua assurda spirale. E resiste il senso, deformato e mutilato come negli incubi, o assente, nel grido accorato che lo reclama. Il fascino sta in ciò, che la poetessa stringe con una mano la mano del Passato e con l’altra quella del Futuro, dilaniandosi nel tentativo di trattenerli presso di sé e raccontando il fallimento della sua impresa.
Invincibili è, nella struttura, un capolavoro di modernità. L’artista vi si sdoppia esponendo il processo di produzione poetica: la poesia e l’ansia di raggiungerla; il poeta e il poetato. I due poli sono limpidamente separati graficamente: il poeta è in grassetto, il poetato (il personaggio) in caratteri normali. La forza che travolge e perde entrambi è la vecchia hybris dei tragici greci, cresciuta a dismisura nei millenni e postasi ormai come unica e fondamentale legge del mondo globalizzato. L’Io arrogante, isolato, egoista, dimentico di sé come umile e limitata natura, e degli altri come fratelli, l’Io che si ritiene appunto “invincibile” fa qui, come nel teatro greco, esperienza del disastro, e alla fine viene “vinto”.
Questo è il senso di questo bellissimo poemetto, nel quale l’odio per l’orgoglioso Io umano si fa a tratti così veemente e totalitario che trascina nella condanna anche gli aspetti che potrebbero riscattarlo: la razionalità, la ricerca, l’utopia, e la stessa poesia. Da troppo tempo questi aspetti convivono con l’hybris e la sostengono – e allora che si butti via l’acqua col bambino dentro.
…Invincibili / ci credevamo capaci / di risolvere enigmi /con segni,/ geroglifici mobili al pensiero, / non decifrabili certo / in questa vita /………Ed ora, vinti / pensiamo di volare, / di salire l’Olimpo della parola / con coppe d’ambrosia nelle mani / e troni inesistenti / per un dire / che non si sposa più con il dolore / né ferma ancora punti esclamativi…
SANDRO DELL’ORCO
Libri e riviste d’Italia
Bimestrale di cultura editoriale e promozione della lettura
Istituto per il Libro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
N.3, Anno II, maggio – giugno 2006
La saluto caramente, Jolanda.
Ma che bello siete ancora tutti qua….pazzesco! Sono appena rientrato da una serata alcolica e non riesco a prendere sonno. Strano, mi sono detto, ne approfitto per leggermi la posta. Allora mi attacco al pc e mi dico, chissà che se ci hanno dato un taglio al forum su delfi. E invece, eccovi qua, sembra che il tempo si sia fermato.
Ho scorso velocemente gli ultimi post e condivido pienamente l’approccio di Massinissa. I libri si devono bere come la birra fresca che ho tracannato sta sera. Adorno o non-adorno la lettura deve essere godibile, andare giù liscia e lasciarti una sensazione di piacere viscerale.
Mentre scrivevo sta banalità mai troppo banale mi è venuta in mente una soluzione comune ai nostri problemi, prof. Ormai scrivere a computer sta diventando un mestiere per lei, con sto massinissa che interviene sempre. Facciamo così, le vengo incontro, stabiliamo una tariffa onesta. Lei mi dà un tot…chessò, 50 centesimi a riga, e io le batto quello che vuole. Così evita di stressare la vita alle sue povere collaboratrici. Che ne dice? Ci pensi, prof.
Brutalmente, lo stile, la qualità, è dominio. Dominio della materia, del progetto, del contorno. Il dominio si esprime come gli viene, scorretto, tranchant, precisamente
La materia, il contenuto, ispirano senza fatica il linguaggio, variamente, secondo personalità. Se la materia è morta, vedi l’oroscopo, non c’è possibilità alcuna di renderla con stile. A meno di rovesciarla, irriderla, storicizzarla.
Che cosa mi aspetto da un testo di qualità: che mi sia odioso come una cartella dell’agenzia delle entrate, di una lettera di sfratto. Voglio che mi costringa alla concentrazione come la conta del resto di una spesa.
Delfi filosofico? Io non me ne sono accorto; del Controllo? dopo zamiatin, huxley, orwell? Ma dai. E poi così esplicito: Controllo, khalas!
“invincibili / ci credevamo capaci / di risolvere enigmi /con segni,/ geroglifici mobili al pensiero, / non decifrabili certo / in questa vita /………Ed ora, vinti / pensiamo di volare” bellissima fin qua, poi ti perdi a definire, ma perchè?
massinissa Says:
September 1st, 2007 at 04:50
>>>>
Non voglio sapere delle agosce altrui, ho già le mie a cui badare, ma alle 4:50 sei andato a dormire o ti sei svegliato?
è adesso che mi sveglio, faccio i turni alla Breda di delfi
Caro Elio,
non pensavo che un giorno avrei fatto mente locale sul problema dello stile, nei termini in cui si sta presentando qui. Già parlare di stile non mi piace: ha che fare con il lato soggettivo della scrittura, indipendentemente dall’oggetto. Rimanda ad un andazzo molto in voga oggi, all’adozione di un modo di scrivere che deve essere a priori in contatto felice con l’ascoltatore o il lettore, di qualunque cosa parli. Pare così che la scrittura debba sempre compiacere il suo lettore, dargli qualcosa (visto che ha comprato il libro): ammiccarvi, blandirlo, metterlo comodo, intrigarlo, interessarlo, fornirgli piacere, insomma considerarlo come l’a priori e il fine di se stessa. Questa tesi ha dalla sua parte non solo le attuali major, che ne vedono la convenienza, ma tutta la tradizione letteraria dalle origini fino al Novecento. Diventa quindi complicato già solo provare a discutere questa tesi, figurarsi provare a contestarla. Comunque mi ci proverò, con l’avvertenza che ciò che scrivo adesso lo penso adesso per la prima volta, e che quindi avrà – lo stile appunto – del work in progress, con tutti i vantaggi e gli svantaggi della cosa.
Ciò che il senso comune e la tradizione danno per scontato, naturale, immediato, e quindi eterno: il rapporto narratore – lettore, in realtà è mediato anch’esso, e lo dimostra la sua improvvisa e radicale modificazione nel Novecento. Fino ad allora un narratore, rivolgendosi ai suoi ascoltatori o futuri lettori, raccontava loro un storia che poteva: essere realmente accaduta, potenzialmente accadere, o essere impossibile. In tutti e tre i casi l’intenzione del narratore includeva il lettore in modo essenziale. Voglio dire che il suo modo di raccontare, di affabulare, era determinato in maniera essenziale dalla presenza reale o futura dell’interlocutore, a cui si rivolgeva e che doveva intrattenere e affascinare. Nello scrivere si teneva sempre presente il lettore, con cui si condividevano la vita sociale e i valori morali, religiosi e filosofici che lo rendevano quasi intimo, familiare, e a cui bastava “ammiccare” e accennare per essere capiti all’impronta, senza inutili descrizioni o ragguagli che avrebbero solo appesantito l’opera. Il racconto del fatto, il contenuto, veniva sempre narrato con il pathos di questa fortissima intenzionalità di comunicazione con gli altri uomini della propria società. Ciò ha determinato, attraverso i secoli, la costituzione di una specie di stile degli stili: lo stile “comunicativo” che tutti li abbraccia, e per cui la narrazione è innanzitutto comunicazione con gli altri, calda, appassionata e sentita profondamente. Questo sentimento-di-non-essere-soli, questa bella e gioiosa socievolezza, questo schietto piacere di parlare con spirito, arguzia ed eleganza ai i propri simili, era essenziale nella scrittura, e vi precipitava, incidendo profondamente nel linguaggio e improntando di sé sintassi e prosodia, fino appunto a determinare, come ho detto, una specie di stile universale della narrazione. Il talento includeva – oltre le capacità compositive – questa capacità di intrattenimento facile e gioiosa, la lingua sciolta, la trovata brillante, il motto arguto e sorprendente, insomma tutti i virtuosismi dialettici che fanno felice lo scrittore e il lettore, e presuppongono un pubblico che li possa “degustare”. Così il lettore, aprendo la prima pagina di un romanzo, si sente subito in immediata, vera, genuina comunicazione e comunanza spirituale con un’altro uomo, e già questo fatto gli illuminerà miracolosamente la pagina, per il solo “tono” di scrittura, indipendentemente dal contenuto. Il lettore “sente” che lo scrittore sta raccontando una storia a lui, proprio a lui, e già questo lo mette a suo agio: accende la lampada, si sistema sul divano e si dice, Che bello, adesso questo mi parla e mi tiene compagnia con la sua voce suadente, ed io l’ascolterò perdendomi nella sua storia. Questo accade già prima di ogni contenuto raccontato, se lo scrittore si rivolge concretamente al lettore e se ha un minimo di capacità di scrittura. In conclusione, il fatto che una scrittura – al di là e prima di ogni contenuto – appaia al lettore come appetibile, bevibile, fascinosa, sexy, e via godendo, dipende innanzitutto da questa sensazione di immediata, calda, intima comunanza che lo scrittore instaura con il lettore . Adesso ti racconto una storia, mettiti comodo, vedrai come ti intrattengo, vedrai che ti faccio vedere!, gli dice lo scrittore. E continuando a raccontare lo fa “confidenzialmente”, tenendo sempre presente il fatto che il lettore si debba interessare e divertire.
Si dirà: che c’è di male in tutto questo? Lo scrittore si diverte, il lettore pure, e allora? Allora, dico io, il Novecento ha messo in crisi questo modo di intendere l’arte letteraria, come del resto ogni altra arte. Cioè, non il Novecento in senso astratto, ma quello che il Novecento ha significato in termini di mutamento radicale dei rapporti economici, sociali e morali tra le persone. Non la farò lunga, mi annoiano le analisi e questa non è la sede. Dirò allora, cortocircuitando tutto, che solo il pensiero di mettersi a scrivere qualcosa per un lettore, oggi, in un preteso caldo sentimento comune, è una cosa che farebbe vomitare pure i sassi, se potessero; è una cosa da sbellicarsi dalle risate se non fosse anche così tragica; è una cosa che potrebbe venire in mente solo a chi ha il cervello pieno di paccottiglia culturale e il portafoglio al posto del cuore. Ogni comunicazione, oggi, ogni esibita spensierata socievolezza, emana un repellente sentore di falso, di finto, di ottuso, come quello che si avverte nei giochi di società dei villaggi per le vacanze, e simili. Solo chi non ne ha mai avvertito il disgusto può credere ancora che sia possibile narrare una storia a dei placidi lettori suoi simili, come quando Berta filava. L’antagonismo attraverso cui il tutto si regge e si perpetua non ammette più isole felici, beate oasi precapitalistiche di fraterna comunità: tutti sono concorrenti di tutti, il bellum omnium contra omnes si è generalizzato, sta diventando la forma di rapporto e di comunicazione essenziale di ogni persona, dalla culla alla tomba. Da ciò la ripugnanza ad affettare intimità, spontaneità e socievolezza dove regnano freddezza, calcolo e egoismo. Insomma, questa esperienza – che nel Novecento diventa ineludibile ai più sensibili – porta lo scrittore ad elidere il tu del patto narrativo. Con quest’ultimo, prima, Io narravo Qualcosa a Te. Ora, invece, Io narro Qualcosa a Me stesso. Questa la rivoluzione copernicana del Novecento in letteratura, almeno nei rappresentanti più significativi.
Ciò, tra le altre importanti conseguenze, ha anche quella di trasformare radicalmente lo stile “comunicativo” che imperava fin da Omero, anzi, quella di abolirlo del tutto. Se la comunicazione con il lettore rimane è, per così dire, solo per inciso, indipendentemente dall’intenzione dello scrittore, e dovuta semplicemente alla natura universale del linguaggio, che resta comunque comprensibile a tutti.
Le qualità che prima era in auge: linguaggio pronto, fico, sottile, ammiccante, vivace, brillante, che costituivano il nerbo dell’eloquenza mirante a impressionare e coinvolgere il lettore, diventano ora ferri vecchi, che nulla hanno a che fare con l’espressione artistica, e che continuano a prosperare solo nel mondo della sottocultura, che in Italia coincide purtroppo con quello della cultura. Ferri vecchi: non servono più a nulla, perché lo scrittore non deve ammaliare se stesso, non deve comunicare con se stesso – visto che è un’unità e si conosce – e non può quindi esultare tra gli stracci di un virtuosismo vuoto e insensato. La scrittura artistica, isolata dalla comunicazione, comincia allora a farsi le pulci, a togliere tutto ciò che non serve allo scopo. Questo è ridotto all’autorappresentazione di un mondo, di un corpo e di un’azione, non per fare compagnia agli altri, ma a se stessi. Company è il titolo una prosa di Beckett, ma potrebbe star bene su ognuna delle sue opere perché ne esprime il telos autentico. Costruzione spoglia, nitida e precisa di un mondo c di un corpo, perché lo scrittore ci possa entrare e vivere la sua azione, lontano anni luce dal mondo reale e dalla sua comunicazione. La prosa diventa allora obbiettiva, povera, accurata, icastica, denotativa, fredda, impersonale: le parole enfatizzano il loro aspetto rappresentativo, creativo di realtà empirica, allucinatorio: sono i mattoni del mondo e devono essere messi con acribia, in modo esatto, affinché questo non crolli sulla testa del suo creatore. Le parole sembrano pronunciate da un morto vivente: razionali, asettiche, prive di orpelli e di espressione: da un morto che cerca di vivere appunto in un al di là che si crea egli stesso, e deve crearlo fisicamente, tattilmente, sensorialmente esistente, per potersi illudere di viverci. Questa è la miseria della letteratura con la l maiuscola oggi. E anche il suo grande merito. Considerazioni simili potrebbero farsi nei confronti dell’arte figurativa e della musica, dove l’abbandono del fruitore ha prodotto risultati analoghi, ma non le farò per non allungare oltre il mio intervento.
Tuttavia il rapporto con il lettore non si interrompe, non è più intenzionale, ma viene sostenuto dalla natura universale del linguaggio, come dicevo sopra. In altri termini, la storia vissuta in verbis dallo scrittore per sé soltanto, nella misura in cui si è cristallizzata nel linguaggio, può esser rivissuta in verbis da chiunque la legga. Il testo acquista letteralmente l’impersonalità e l’obbiettivita di uno spartito musicale.
Lo stile risultante. Certo, non è più quello culinario di una volta. E’ respingente, dissonante, spiacevole, distante. Soprattutto è miserevole, se valutato con i criteri del buon tempo antico: povero di lessico, di sintassi, esangue, monotono, pedante, insomma di scarsissima qualità letteraria. Ricordi il racconto Giuseppina la cantante, di Kafka? Vattelo a rileggere. Quello è il discorso più chiaro che uno scrittore abbia mai fatto sull’arte contemporanea, in cui appunto il talento rifugge l’eloquenza tradizionale e si rifugia esclusivamente nella forma, nella magia della composizione assolutamente cogente, che travolge il lettore esclusivamente con la necessità imperiosa dei contenuti.
Chi può capirla quest’arte? La risposta è sotto gli occhi di ognuno. Meno di tutti le persone di mezza cultura: quelli allevati, cresciuti e pasciuti dalla cultura mediatica, che rimesta continuamente tra i resti della cultura ottocentesca e li propone incessantemente come l’essenza immutabile dell’arte; e meno ancora gli scaltri e cinici imbonitori dell’industria culturale, gli operatori culturali di ogni risma, che essendosi venduti l’anima all’intrattenimento, ne propagandano malignamente la religione, ed odiano a morte chi gli ricorda, con opere opere nuove e genuine, il loro tradimento. Può capirla meglio, invece, e qualche esperienza mi conferma in questo senso, la persona culturalmente ingenua, senza stereotipi e pregiudizi da quasi colto, che penetra senza mediazioni nella macchina romanzesca, venendone così risucchiato e quindi espulso alla fine. Ne percepirà – intellettualmente – solo uno strato superficiale, è vero, ma è quello più importante, perché coinvolgente sotto il profilo pulsionale e delle emozioni. Può capirla pienamente, infine, chi è rimasto sempre aperto al nuovo, chi non ha mai venduto e ottuso la propria anima, e cerca nell’arte e nel romanzo la maniera di farla vivere.
ma hai scritto un poliziesco, brutto, ma un poliziesco. Per sgorgare le tue tubature?
Leggendo l’intervento in diagonale, mi è parso di capire che tu sia novecentesco.
Un articolo recente del Corsera su Leo Castelli mi ha fatto pensare al novecento in arte. Mi è balenata questa intuizione: la fine del novecento ha una data, il giorno del suicidio di Mark Rothko, che ha coinciso non a caso, secondo me, cioè si è ammazzato più per questo che per le sue turbe, con l’affermarsi della pop art, la quale ha spazzato via, salvo i residui e le intersezioni, il mito e l’epopea delle avanguardie storiche, artistiche e letterarie. Siccome sei un ragazzo intelligente e preparato, non sto qui a stenderti un fogliettone di considerazioni in proposito, ma se mi stimoli potrò farlo in seguito, puoi farcela da solo a capire che tutto quello che hai scritto qui sopra è muffa, sei stato doppiato dal contemporaneo che non è affatto senza lettori e fruitori. A milano ci sono ca 200 gallerie che non fanno solo attività “immobiliare” ma sono centri di iniziativa culturale come non mai da tempi immemorabili, frequentatissime in apertura, da fruitori avidi.
Ciao
il sandro si lamenta come il conduttore di cavalli da tiro xkè hann’inventato i camion
Ma di che si parla?
Tito Livio, c’hai presente il Sudoku?
Da: Il nuovo Zingarelli: STILE: Qualità dell’espressione risultante dalla scelta degli elementi linguistici che l’individuo compie in circostanze determinate deviando dall’uso corrente e dalla norma letteraria.
Ma cosa ne sanno i critici di ciò che muove un artista nel momento in cui crea? l’artista,quello vero,crea per sé e lo stile è dettato dalle idee o visioni dentro cui si muove, vive e respira, come un’atmosfera parallela ma diversa da quella in cui nello stesso istante si muovono gli altri. E lo stile,si sa, è ciò che differenzia un artista da un altro in tutti i campi dell’arte e in tutti i periodi storici. Mi chiedo: perchè a un Dell’Orco non deve essere riconosciuto uno stile personalissimo che lo diversifica dalla massa editoriale oggi imperante? e questa è cultura?: pubblicare prodotti scadenti ma di alto profitto? lo stesso discorso vale anche per la Poesia. Potrei fare infiniti esempi ma a che pro? buona domenica.
l’artista, quello vero, è un altro.
mi sembra di sparare sulla croce rossa
Mi permetto di segnalare l’articolo di Marcus Du Sautoy pubblicato oggi dal “Sole 24 Ore”, nel quale il matematico mette in relazione la musica con la sequenza di Fibonacci.
mi permetto di segnalare pro musica anche la tavola pitagorica (terza di copertina dei quaderni a quadretti)
Mi parli dunque del “suo” artista caro Mass, ma non mi venga a dire che dobbiamo parlare dei “maledetti”. Per scrivere oggi o produrre altra forma d’arte non è necessario rimpizzarsi d’alcol o di oppio e navigare per mari sconosciuti. La vita è già così maledetta che non serve farsi più male di quello che ci viene fatto. E non sminuisca tanto la nobiltà della croce rossa altrimenti io potrei benissimo sparare sulla legione straniera. Cari saluti.
Caro Sandro,
due parole su alcune parti del tuo intervento di ieri, a partire da una considerazione che mi trova d’accordo: “Se la comunicazione con il lettore rimane è, per così dire, solo per inciso, indipendentemente dall’intenzione dello scrittore, e dovuta semplicemente alla natura universale del linguaggio, che resta comunque comprensibile a tutti.” Io farei un passo in più. Come tu la presenti, sembra che l’opera abbia più a che vedere con la soggettività dell’autore che con l’oggettività (la natura universale del linguaggio) di se stessa. Insomma, che abbia più a che vedere con qualcosa di altro da sé (il suo autore) che, di nuovo, con se stessa. Io mi soffermerei su quel momento indipendente “dalle intenzioni dell’autore” che non riguarda solo l’opera compiuta, ma anche la sua genesi. Se è vero che il rapporto autore/ “fruitore” cambia nel corso del tempo, le opere d’arte mantengono, però, il loro valore oggettivo, che resiste al tempo indipendentemente non solo dall’avvicendarsi delle diverse dinamiche della comunicazione, ma anche dal contesto di “prostituzione culturale” nel quale, a volte, sono nate. Banalmente: leggiamo, ascoltiamo, guardiamo ancora opere che non escono minimamente scalfite dal fatto di essere state commissionate da questo o quel cortigiano, sovrano, ecc…. e sappiamo che ciò comporta anche, nella maggior parte dei casi, determinate scelte stilistiche. Questo per dire che ogni opera riuscita elide a priori “il tu del patto narrativo”, anche nel frangente più compromesso. Se andiamo al di là dell’”io narro Qualcosa a te”/ “Io narro Qualcosa a Me stesso” troviamo finalmente il Qualcosa (rallegramenti, Sandro, per l’uso della maiuscola) che narra se stesso attraverso di me, e, che, “solo per inciso” resta, perciò, comprensibile a (quasi) tutti. Riformulando secondo termini che ci vedevano un po’ più concordi: il mio senso della forma fa sì che la mia opera in un certo senso “obbedisca a questa forma”.
Ora, da dove viene questa forma? Da nessun “retromondo” – che non ho mai supposto – ma dalla realtà, dalla fatticità contingente,anche storica, in cui, tuttavia, proprio in quanto forma oggettiva, non si esaurisce e che non va confusa col famoso “contesto sociologico”, rispetto al quale mantiene la sua potenza critica o regressiva, utopica o redentiva che sia. Le pulsioni soggettive e le “emozioni” non sono l’essenziale, né per la composizione né per la ricezione: mi sembrava che su questo fossimo d’accordo ma le parole conclusive del tuo intervento mi hanno suscitato qualche perplessità, come anche l’implicita gerarchia tra fruitore colto e incolto – questa sì, forse un po’ troppo “primo Ottocento”.
Per Mario De Caro, Elio Matassi nell’epoca della sua riproducibilità tecnica è vermante geniale.
Caro Massinissa e caro Sandro, quando penso allo stile mi viene in mente, perdonatemi se sono troppo pendante, la celebre disputa ermeneutica tra Heidegger e il critico svizzero Staiger a proposito del celebre verso della lirica di Moerike “ciò che è bello è in se stesso beato”. Pur appartendendo alla corporazione filosofica, io sono dalla parte di Staiger, che ha perfettamente ragione di rimproverare Heidegger di fare un uso filosofico della poesia e della letteratura del tutto strumentale. Bisogna invece, per capire che cos’è lo stile, riferirsi al rapporto fra letteratura e musica, Staiger cita a tal proposito il celebre volume di Becking dedicato al ritmo. Non sono stato mai mosso, dunque, dalla consueta volontà egemonica che contraddistingue la corporazione filosofica e in questo credo di dare ragione ad entrambi. Siete molto più vicini di quanto lascino pensare le apparenze.
Cara Jolanda,
la lettura dei tuoi versi conferma quanto sto argomentando nell’articolo che sto per licenziare e che dovrebbe apparire ad ottobre, Il piacere dell’ascolto, dove ‘piacere dell’immediatezza’ e ‘piacere della ripetizione’ si fondono mirabilmente.
A tutti, mi stavo dimenticando (ormai questi miei interventi stanno assumendo un tono autobiografico)di prescisare che sono appena tornato a Roma e che sto dettando a mia figlia. Come tutti i giovani, mia figlia contrariamente a me, sa accendere e usare il PC.
Egr. Prof. Matassi,attenderò ottobre con la mia consueta pazienza. Sono certa che il suo articolo arricchirà di molto le mie convinzioni e il mio spirito.Desidero farle i complimenti per la sua rivista e mi permetta un saluto al Direttore Responsabile,un amico che avevo perso di vista e che ricordo caramente:ciao Aldo Maria,spero che tu stia bene.
A Massinissa: ma chi potrebbe negare che il 23 è il numero di Berg? Non è forse vero che nella Suite lirica vi sono 46 battute che aprono il terzo movimento e che queste, dopo 23 battute, vengono rispecchiate dalle 46 battute conclusive? I metodi simmetrici comunque vengono usati anche da Webern, Messiaen, Boulez, per non parlare di Schoenberg.
E’ mezzanotte, sto costringendo mia figlia ad usare il pc per dettarle quanto segue: ha perfettamente ragione Lucio Andronico, matematica e musica sono tra di loro avvinte da un’affinità elettiva.
ma lì, a roma tre, siete specializzati in corsi di recupero?
Matass, sei ancora capace di fare una radice quadrata a mano e sai distinguire un be-quadro da un diesis?
Caro massinissa, a Roma Tre non esistono corsi di recupero e io sono ormai convinto di essere totalmente irrecuperabile sul piano telematico. In questo momento sto dettando al Dott. Durpetti.
Caro Pepper, dicharo tutta la mia ignoranza in matematica. E’ sempre stato, sin da bambino, un mio limite. Non si può essere onniscenti.
Caro Lucio Andronico, con sempre maggiore difficoltà sto acquistando l’inserto culturale del Sole 24 ore, che sta subendo una deriva in parte analitico-scientista, in parte ultra-personalistica. Non aggiungo altro!
Sgt.Pepper, ma lei mi insegue dovunque! Capisco che voglia darmi man forte, la ringrazio, ma qui siamo sulla serie di Fibonacci, che ha trovato applicazioni anche nel campo delle arti visive.
E poi non capisco perchè usi quel tono di sfida col Prof. Matassi. Anche se non sapesse risolvere una radice quadrata cosa proverebbe. Tutte le operazioni inverse sono difficili, io per esempio non so fare nè le sottrazioni nè le divisioni, uso il calcolatorino…forse ho capito il nesso col Prof, mah…non la trovo comunque spiritoso
prof, non mi riferivo alla sua persona, che trovo sempre più simpatica e tenera, ma alla propedeuticità degli interventi che si irradiano dal suo entourage
Si vabbeh, abbiam capito.
Salute e Prosperità (Startrek)
Caro Massinissa, ormai sto capendo che tra di noi, dopo le incomprensioni iniziali, esiste un’autentica affinità elettiva. Ti assicuro che la cerchia dei miei collaboratori è animata dalle migliori intenzioni.
sono le migliori intenzioni che preoccupano, si fa per dire; qui è una gara a chi è più erudito ma si capisce che non c’è spessore proprio, militante.
Mi ricordano tanto certi interventi in assemblea fatti per farsi notare.
Non mi riferisco a Dell’Orco di cui non posso dire che non sia coinvolto. Di lui non capisco perchè tiri fuori sempre le major. Le major non fanno cultura, mirano al venduto, va bene, è così.
Dopo una full immersion per concludere un lavoro, sono tornato a leggere il dibattito delfico con la duplice aspettativa del pascimento intellettuale e del sollazzo viscerale. Ho riscontrato entrambe le cose, e questo è buono.
Per l’aspetto intellettuale, Massinissa ha scritto qualcosa che è stato ignorato, ma, secondo me, sarebbe meritevole di discussione. In un messaggio di qualche giorno fa scriveva infatti: “Finnegan’s Wakes, per esempio neh, è un testo sperimentale ma si beve come una birra buona, anche se non capisci un’ ostia di quel che vuole dire.”
Devo dire che anche a me è capitato lo strano fenomeno di cui parla Massinissa. Sono arrivato ai Finnengans Wake dopo Ulisse e i Dubliners (e se è per questo anche dopo la strepitosa resa cinematografica di “The Dead” da parte di Houston). Come Massinissa in quell’abbozzo di romanzo, dopo la prima geniale onomatopea, non c’ho capito un fico, ma mi ha affascinato. Un po’ di inglese lo mastico, ma la cosa non mi ha aiutato granché. Forse mi mancano i fondamenti di gaelico.
Insomma, con quel libro me ne stavo in adorazione come Champollion di fronte alla stele di Rosetta — prima della decrittazione della medesima. Solo che per me la decrittazione della stele joyciana certamente non arriverà mai.
La domanda che pongo alla comunità delfica (lo faccio in tutta serietà) allora è: quanto ha inciso, nella mia venerazione della Veglia dei Finnegans, il culto di Joyce? Detto altrimenti: se quella roba incomprensibile lì l’avete scritta pari pari qualcun altro, quanto l’avrei valutata? La risposta, ahimé, è che non l’avrei considerata per nulla. Come dire che il contesto, in quel caso, ha preso il sopravvento sul testo.
Fatemi fare un esempio musicale (per par condicio verso Elio). Sarò secchione, ma a me Schubert è sempre piaciuto molto. Lo trovo profondissimo. In giovane eta, mi pascevo dunque della sua opera omnia, come se fosse tutta un capolavoro. Ora mi rendo conto che la produzione di Schubert, in realtà, è di ineguale valore (come d’altra parte è naturale). In particolare, le prime sinfonie ora mi paiono assolutamente acerbe. Insomma, ora considero più il testo che il contesto. Forse dovrei farlo anche con i Finnegans, e ammettere che sono il capolinea, tra lo sterilmente enigmistico e il pretenziosamente vaticinante, di un sommo scrittore. O no?
Caro Mario, come di consueto mi trovo perfettamente d’accordo con te a proposito del rapporto testo-contesto. Mi dimenticavo di dire che il mio primo intervento è stato dettato alla dott.ssa Ludovica; questo secondo invece viene dettato al Dott. Dario.
degli pseudonimi: quale che sia la loro ragione, io so la mia, non intervengono certo per farsi notare, nè dicono più cazzate di quelli che si firmano. Sono, salvo casi labirintici, disinteressati alle ricadute. Si può dire lo stesso dei molti che sono intervenuti qui con nome e cognome?
A questo, caro Elio, pensavo tristemente quando dicevo che quello che salverei di questo forum è la commedia, la commedia umana, non quella degli equivoci matassiani che è plautina e amusante assai.
E con ciò e su questi aspetti mi professo un irreducibile balzaccottocentesco
Cara Ludovica,
non vorrei sbagliarmi, ma stavolta sono d’accordo con te. Forse la nostra terminologia non è la medesima, e questo dà luogo talvolta a incomprensioni: ma quanto al contenuto sì, stavolta sono d’accordo su tutto quello che dici. Non rallegrarti troppo per le maiuscole, stanno al posto del corsivo o della sottolineatura, e non denotano alcuna enfasi metafisica. E non dare più importanza di quanta ne abbia alla triade del patto narrativo, che io ho evidenziato molto perché il discorso sullo stile lo richiedeva. L’importante è la forma, la sua autonomia rispetto all’io empirico, alle intenzioni, emozioni e pulsioni dell’autore in carne ed ossa, come già avevamo concordato una volta su questo blog.
Di nuovo c’è solo il fatto che chiarisci che la forma non nasce da alcun “retromondo”, ma dall’essente, e, ovviamente, non in modo deterministico – e in quanto tale deducibile senza residui scientificamente o filosoficamente -, ma in modo dialettico, cioè esprimendo rispetto ad esso la sua autonomia, “la sua potenza critica o regressiva, utopica o redentiva”.
Quanto alla chiusa del mio pezzo, hai ragione, ho esagerato parecchio le qualità del fruitore ingenuo… ma l’ho fatto per ragioni retoriche: volevo solo dire che è più facile che l’opera d’arte venga esperita da lui che dall’intellettuale deformato dalla mezza cultura. A scanso di equivoci – così frequenti in questo dibattito – preciso quest’ultimo termine: chiamo così una conoscenza anche vastissima e ed esatta che non includa in sé il soggetto che la pensa, risultando pertanto vacua, esteriore ed insensata.
devo riconsiderare il De Caro, una delle poche voci singolari che ho letto in orrizzontale, a cui mando questa mia interpretazione affettuosa tardo-ottocentesca, ma ripresa successivamente ( ma come è possibile? Massinissa lei si incarta) e profeticamente da Benjamin, sempre lui, quando definisce il concetto di “aura” di un dipinto, del suo interrogativo ( di De Caro): noi umani, soprattutto se boriosi come me, prima di alzare il culo, oggi più che mai, la sappiamo infatti tutti lunga, almeno così crediamo, abbiamo bisogno di un éclat o meglio, e vengo all’ ‘800, di una Einfühlung, cioè di una forte empatia verso. Da dove ci proviene questa empatia? Beh, il contesto è un conduttore formidabile, più dell’oro. La gente oggi fa la coda per vedere gli impressionisti il cui rilievo agente, oggi, è null komma null, solo per fare un esempio neh. Cioè, questi visitatori c’hanno messo ca 100 anni per provare l’Einfühlung. Destino del genio, che ci vuoi fà, caro Mario. Se tu non avessi subito l’influsso dell’ambiente che frequenti, probabilmente sarebbe toccato a tuo figlio scoprire Joyce, il quale Joyce, anche lui a sua volta, oggi, conta ormai null komma null, salvo che per Sandro che è rimasto allo stream of consciousness, novecentesco, eurocentrico, appunto
Bacioni
questo non impedisce di potersi invaghire e di gustare la visione e la lettura della produzione datata, purchè ci si immedesimi a ritroso
nel contesto storico-culturale del concepimento.
Ma sono cose risapute, o no?
conoscenza vastissima e ed esatta che non include in sé il soggetto che la pensa, e pertanto vacua, esteriore ed insensata
fa, come la nota
Non so se le cose che dici sono risapute, Massinissa; comunque io le trovo molto giuste. Aggiungerei però qualcosa a quanto dici in questa frase: “questo non impedisce di potersi invaghire e di gustare la visione e la lettura della produzione datata, purchè ci si immedesimi a ritroso nel contesto storico-culturale del concepimento”.
Certo, anzi (e qui c’entrano i gusti personali) per me la più meravigliosa esperienza artistica è quella che apre mondi remoti dal mia, sia geograficamente sia (soprattutto) cronologicamente, e per farlo usa strumenti espressivi inventati di sana pianta. Penso, per esempio, alla pittura umanistica, che mi pare più gigantesca ancora di quella del Rinascimento maturo. Paolo Uccello, Antonello, Piero hanno dato voce a un mondo in grande fermento, e ancora ce ne trasmettono il senso oggi.
Lo stesso vale per la musica del Settecento. Ma anche per il Cinema degli esordi. Uno riguarda “La grande illusione” e medita, con partecipazione, sull’epocale cambiamento sociale che seguì la Grande Guerra. Roba che se devi leggere un saggio sul tema, ti addormenti a pagina 2. Idem, with potatoes, nei casi in cui l’arte di culture lontane nello spazio ci dice qualcosa (forse anche de nobis). Insomma, Miriam Makeba mi piace assai più di De Gregori o di Guccini.
Insomma, almeno per me, l’arte che più ammalia è quella che, misteriosamente, e con buona pace dell’Eugenio laureato, apre mondi, possibilmente remoti (e dei quali, se non fosse per l’arte, mi calerebbe assai poco). Ma io sì che ho detto cose risapute…
mi te matassi, adess
scusami Mario, qui l’ordine dei post è roulettiano, volevo matassare Sandro
In questo momento sto dettando a Ludovica.
Il dibattito ha assunto un tono veramente avviccente e l’amico De Caro e l’amico Massinissa lo stanno elevando a livelli vertiginosi. Sono veramente felice che questo avvenga.
Cara Ludovica,
altro sinonimo di mezza cultura: arrogante, boriosa e affannosa esposizione di vacua erudizione per colmare il proprio nulla.
condivido anche i tuoi gusti, che mi rapiscono, ma il contemporaneo e la strada mi inchiodano come un check point, di lì devi passare
chiedo alla redazione di bandire Nessuno
Cari amici purtroppo per almeno dieci giorni dovrò seguire Nazione Indiana in maniera sommaria ed affrettata: ho tre scadenze che mi prendono molto: il nuovo Festival di Vittorio Veneto che mi vede impegnato sabato 8 settembre nella tavola rotonda ” Ateo, credente o comodamente indifferente?”, il14 settembre con la lezione magistrale da tenere nell’ambito del Festival di filosofia di modena ed infine 15 settembre alle ore venti all’interno della festa Nazionale dell’Unità a Bologna, la presentazione della rivista Inschbboleth con Remo Bodei e Marco Filippeschi. Scusatemi pertanto se i miei interventi saranno troppo brevi. In questo momento sto dettando alla dott.ssa Ludovica.
Cara Ludovica,
c’è stato qualcosa di nuovo in letteratura dopo Beckett? Non me ne sono accorto, eppure leggo da sempre la letteratura mondiale. Per superare il Novecento bisognerebbe prima raggiungerlo, e qui, almeno a giudicare da alcuni vuoti e pretenziosi interventi anonimi, ne siamo molto al di sotto.
non mi lascerai qui da solo a parlare con l’orco? mi vien la parotite al pensiero
massa, la stai prendendo troppo sul serio.
Il matasssi è un frullato di giuliano ferrara e vanna marchi, e quelli che gli reggono la coda, reali o dummy che siano, sono i suoi parafulmini. Un fanfarone professionista, insomma, immune alle provocazioni, anzi ne trae nutrimento. Fai te.
se Beckett è stato il vertice del ‘900, ma per me è Céline seguito da Cendrars e Gadda, vuol dire appunto che non ce n’è più per Nessuno.
Siamo dentro a un’altra curva il cui raggio ci è sconosciuto e lo rimarrà fino a quando tu o qualcun altro non ci darà il capolavoro. Ma perchè possa essere tu devi prima prendere coscienza dello stato delle cose.
Per adesso dobbiamo accontentarci di qualche poliziesco divertente, non il tuo, mi dispiace
Cara Ludovica,
il fatto è che la letteratura novecentesca richiede non solo intelligenza, ma anche una fortissima capacità di guardarsi dentro, senza infingimenti e rimozioni, qualità ormai persa dalla generalità delle persone. Così può accadere che la superficialità dominante non veda che se stessa e si dichiari addirittura come il Nuovo. Chi vuol rimanere inchiodato a questa Contemporaneità è libero di farlo, ma finirebbe – speriamo – crocifisso alla sua stessa ottusità
Caro Sandro,
accolgo con hegeliano affetto il termine dialettica (lo so che ti riferivi a quello adorniano!) La forma nasce dall’essente… perciò è verità: mi sembrava già implicito nei miei interventi precedenti; quanto alle maiuscole…peccato!
(In questo momento sto dettando al prof. Matassi)
io rinuncio, un saluto a Elio e a Mario.
Ma pensa alla parabola dell’arte, cristo, che spiega gli sviluppi in corso anche ai sordociecomuti, meglio di tutte le tue baggianate cartapecoreccie!
massinissa,
what about a chess game?
Cara Ludovica,
vedi sviluppi tu? Io vedo solo smemoratezza.
A presto, mi fa piacere, davvero, che ci siamo intesi.
Un abbraccio affettuoso.
Ludovica, poi volo via davvero come i Patton’s soldiers, hai scritto:
In questo momento sto dettando al prof. Matassi
mi piace il coup che sia tu a dettare e matassi a scrivere
ma si può continuare a parlare con un fantasma?
Au revoir, Massinissa.
sulla deserta coltrice
accanto a lui posò.
Sgt. Pepper, questa mi è piaciuta (seriously!)
“Sulla deserta coltrice, accanto a lui posò”, dice il Lisandr, e vede Domineiddio che visita il Corso, nella di lui estrema solitudine. Detto da uno che, si sa, ha è a capo di una “Lonely Hearts Club Band”, diventa un funambolico joke transculturale sulla solitudine (con l’Onnipotente che nel frattempo è rimasto sulla coltrice…).
Bello!
Caro Sgt.Pepper,
una delle poche virtù che mi riconosco è quella dell’ironia e dell’autoironia; per questo ti rispondo che da Giuliano Ferrara mi distinguono in primo luogo i chili da perdere (i suoi sono molto più dei miei) ed in secodo le scelte di fondo, lui ha cambiato bandiera, io sono nato di sinistra e interista e morirò di sinistra e interista. Da Vanna Marchi, mi distingue un aspetto essenziale: io non vendo e non mi svendo, cerco solo di discutere e di rispettare anche chi la pensa in modo molto diverso dal mio.
Caro Massinissa,
ti prego di continuare ad intervenire, ti ho sempre considerato un interlocutore essenziale anche quando il dibattito si è fatto più duro. Non sono un volgare ruffiano ma uno che sa riconoscere ed ammirare anche l’intelligenza degli altri.
Caro Sandro,
io dico sempre quello che penso, continuo a stimare il tuo romanzo e mi batterò sempre per la sua affermazione e divulgazione, ma nutro stima anche per Massinissa, un avversario leale ed intelligente. Non credo che vi sia fra queste due credenze nessuna contraddizione. Non dobbiamo dimenticare neppure quel tanto di ludico che c’è in ognuno di noi e che ha svolto un ruolo non irrilevante nel nostro dibattito.
Caro Mario,
ti ringrazio per l’aria fresca che hai portato a NI. Sai che ho sempre apprezzato la tua duttilità intellettuale e riconosco che nella presente discussione dimostri anche di essere il buon figlio di uno scrittore di razza.
Cara Ludovica,
le ho sempre riconosciuto intelligenza, buon gusto, cultura e passione per la musica. Devo in questo caso apprezzare una qualità che non avevo ancora individuato: l’ironia, che, per me, ha sempre prevalso su tutte le altre.
A tutti,
sto costringendo la mia unica figlia a scrivere tutti questi interventi sotto dettatura. Lei è molto sobria e silenziosa, non so se sia animata dall’ironia ma sicuramente ascolta l’autorità paterna.
Com’è sua figlia???
Scusi, prof., è la curiosità che mi porta alla deriva…
Sa, è troppo simpatico, se potessi mi intrufolerei a una sua lezione…sono curisoso, appunto. Lei è di sinistra, come si spiega questa mandria di politici ex sinistroidi bolliti sgraziati ammucchiati tutti in fuga verso il centro? Cosa rende sempre verde la tanto grigia dc (pd)? Ci sono nato sotto la dc, sarei un po’ stufo. Triste pensiero notturno, lo so.
Massinissa,
Hai ragione, Celine è il punto più alto del Novecento, mai più raggiunto nemmeno da se stesso. In pochi lo direbbero. Sono fatto così, mi commuovo per certe piccole cose.
caro matassi,
raramente mi curo di sapere chi stia realmente dietro le parole che appaiono in un blog. Preferisco annusare ciò che scrive, + nella forma che nella sostanza, e i miei commenti cavarli dall’odore che emanano. Per me tu sei, come tutti gli altri bloggari, un’entità virtuale ben distinta dal sig. Matassi in carne ed ossa (che non conosco) e ogni commento, insulto o complimento al cyber-matassi son destinati. E’ un atteggiamento che suggerisco a tutti, specialmente ad alcuni novice.
Ironia e autoironia fan bene alla salute, sicuramente. Passa parola.
With love
per parlare bignamesco ancora un po’ avrei bisogno del vostro aiuto.
Se la pop art rappresenta l’inizio del nuovo secolo in arte, e penso di avere ragione, c’è qualcuno che mi può individuare con competenza l’opera e la figura di chi in letteratura (e musica) rappresenta simbolicamente la morte del novecento e chi rappresenta simbolicamente l’inizio della nuova era? Se c’è chi mi stimola su questo schema, caro Elio, potrei stare ancora qui con te e la tua band fino a raggiungere i 1000 commenti, così polverizziamo tutti i record: la hacca è contenta, Sandro pure e Tu, sportivo come sei, giubileresti come gibilisco quando ha saltato
l’asta
Massinissa, welcome back. Domanda ghiotta e importante, la tua. Ora ci penso su. E penso anche all’analogo nella storia del cinema, che secondo me è segnata da una simmetrica, epocale coupure: da Eisenstein e De Sica a Tarantino e Ang Lee, insomma, il salto paradigmatico sicuramente c’è (non necessariamente all’ingiù, of course, ma certo c’è).
Per l’intanto ho una metadomanda, rispetto alla tua collocazione della Pop-Art come discrimine tra il Novecento e il Post (che naturalmente ha in sé molto di plausibile).
Non ti pare, allora, che Warhol & Co. siano legati con un filo d’acciaio a Duchamp e agli altri mattarelloni del Dada? Se è così, le cose sono intricate. Il Post-Novecento, almeno in arte, ha un inizio carsico e giocoso, e dà i suoi frutti mezzo secolo dopo. E il Novecento continua, con avanguardie che sostanzialmente perpetuano (pur rinunciando all’ideale mimetico), il canone e la missione dell’arte moderna — quando in realtà questo canone e questa missione sono stati già belli che finiti nel pitale dell’ottimo Marcel.
Massinissa, la domanda che lei pone ha la sua risposta che tutta l’opera d’arte in occidente, in occidente, nell’Abedland, contiene già da sempre inizio e fine, alba e tramonto. Il vero precursore (che sia un musicista, un poeta, un filosofo, un letterato, un pittore) non viene mai superato. Nell’opera del precursore, in occidente, c’è già sempre inizio e fine. Non esiste il successore del precursore. Ma questo solo nell’opera dell’artista e non dell’artigiano (legga Aristotele: e arriverà il chiarimento auspicato). Altrimenti, Wozu Dichter?
De Caro: Duchamp non ha precorso la pop art, secondo me. É stato
un tipico rappresentante della cultura europea in crisi. Ai tempi suoi, prima che emigrasse in America, si opinionava di morte della letteratura e dell’arte, di morte dell’occidente (Spengler), Malevic dipingeva il suo bianco su bianco u.s.w., ma la produzione di fosforo europeo continuava imperterrita a tutto vapore e l’America ne comperava a bastimenti con provinciale subalternità. Duchamp, primo fra i migranti supponenti, messo i piedi laggiù, incantava i serpenti con le sue teorie sull’anti-arte. Fino a quando un certo Rauschemberg non si prese del dummkopf da J. Albers nei corsi di bauhausite che teneva in Carolina del nord.
Quel texano cocciuto avviò, con chiara coscienza, l’emancipazione dell’arte americana dall’europofilia (già Pollock con le sue maniere aveva mandato Duchamp a fare in culo). Siamo nel ’55 o giù di lì.
Fine prima puntata
il fatto che R. facesse uso di oggetti trovati non signifca che la sua poetica fosse mutuata da D. La storia dell’arte è tutta un anello, ma un conto sono gli stimoli e un altro l’approdo. Che ne so, il vecchio Tiziano Vecellio con i suoi sfondi sfatti è stato un proto-informale? O il vecchio Monet? O el Greco, un proto-cubista?
L’approccio di R. e poi di Wahrol all’oggetto trovato sottende un’altra Weltanschauung, non di crisi, non dada-provocatoria, ma di adesione sublimata e giocosa, hai detto benissimo, al reale.
Duchamp e i dada non sono giocosi, anche se ci fanno, ma dei serissimi e cupi demolitori o dei distanti e maligni osservatori del disastro incombente.
Fine seconda puntata
Le cose dette dall’amico di Numidia sui Dada, in particolare l’idea che, con tutti i loro pirotecnici tentativi di épater le bourgeois, in fondo fossero impregnati di disperata noluntas vivendi, sono come al solito interessanti assai e in buona parte condivisibili (da me, intendo). Basti pensare al tetro luciferismo del Bunuel dell’Age d’Or e dello Chien Andalou, in cui peraltro i Dada compaiono, tutti belli in schiera.
Ciò detto, non sono del tutto d’accordo che tra loro e la Pop-Art (sia pure considerando il grande Rauschemberg invece del sopravvalutato Wahrol) non vi sia un nesso assai più saldo di quello tra El Greco e Braque, ma questa è forse questione di gusti (critici) personali — e (nel mio caso) anche di carenze di cognizioni storiche nel merito. Per questo sono pronto a ricredermi.
Sulla musica, ho intanto la risposta (banale) a chi sia la figura della Grande Transizione. Direi senz’altro Stravinskij (più che i dodecafonici). La Sagra della Primavera a me sembra ben più rivoluzionaria del Wozzeck.
Detto ciò, attendo con fiducia di essere impallinato da Elio (non appena troverà qualcuno a cui dettare il suo prossimo messaggio…), che è un noto filogermanofilo, e lo resterà per sempre, oltre a rimanere di sinistra e dell’Inter. (Anch’io, peraltro, da piccolo ero dell’Inter, poi da grande ho capito e mi sono redento).
l’action painting e il color field painting sono gli ultimi prodotti dell’eurofilite
in America. Si potrebbe pensare che siano già una espressione autoctona, io dico di no. I suoi rappresentanti sono europei nel midollo. Pensa all’atteggiamento “maledetto” di Pollock, alla spiritualità consunta dell’ultimo Rothko (io prescindo dai valori in questo sproloquio, neh), alla gestualità espressionista di un de Kooning.
Adesso, prova a pensare se c’è un precedente europeo, salvo l’oggetto trovato, ma è trovato diversamente, nelle bandiere e nei bersagli della pop art. I formati sono dei billboard, le atmosfere sono cancellate, l’aura
svanita nei multipli. Ciò che impera è la celebrazione, la technicality, lo spessore quasi nullo del colore a rimarcare e riflettere la superficialità apparente delle intenzioni.
Fine della terza puntata
Mario, io mi riferisco alla transizione equivalente a quella della pop art in musica o in letteratura che abbia chiuso il discorso definitivamente con le avanguardie storiche del novecento. Stravinski è avanguardia storica.
Chiedo lumi sul post-novecento. In letteratura lo vedo in atto ma non so risalire ad quem. In musica men che meno. Nel jazz direi la fusion, non so, brancolo
Quando sono entrata in questo blog,credevo che il dibattito dovesse per ovvie ragioni,concentrarsi su Delfi. Mi sono invece resa conto che,man mano che passavano i giorni,il tutto cominciava ad assumere una connotazione diversa che non mi aggradava per niente. E’ pur vero che di Delfi si è parlato, ma ci sono alcune tematiche intrinseche al romanzo che, secondo me,avrebbero dovuto trovare più spazio su queste pagine:l’uomo e la sua solitudine,la società che tenta di omologarci ,barattoli nelle vetrine dei più potenti,e altro,altro ancora. Adesso mi sembra di stare in un mattaoio dove chi ha il coltello più lungo cerca di affondare meglio dentro la carne altrui.E questo è un gioco stupido e puerile che non conduce da nessuna parte. Chiamatemi pure ingenua,sognatrice da strapazzo,ditemi quello che vi pare,tanto come sono lo so soltanto io,ma finitela con questa soap-opera dove ultimamente c’è di tutto e di più tranne che Delfi. E poi desideravo dirvi che se il mondo degli intellettuali è tutto così,un cerchio senza via d’uscita dove tutti si parlano addosso,io sono fiera di non farvi parte.Io vivo nel quadrato della poesia pronta a fare entrare quanti,acculturati e non,desiderano un momento d’intimità con la loro anima,una breve pausa di spiritualità contro la violenza disumana della vita. Questo è un tema su cui dovremmo confrontarci tutti, poeti,narratori, critici,intellettuali di sinistra e vedere per le strade o dentro le case dei poveri cristi quanta importanza possa avere se e quando e perchè inizia o finisce o forse non finisce e non finirà mai un pezzetto di letteratura.Essere intellettuali oggi,per quanto mi riguarda,significa non perdere mai di vista la prerogativa più grande di questa vita:l’umanità.Carissimi saluti.
E Klee, con l’Angelus Novus, non trova posto?
Rispondo ancora a Massinissa — poi mi placo, anche perché se no qui stasera non si mangia. Sì, Action Painting e affini sono molto eurodipendenti; certo più della Pop-Art.
A proposito di chi, nell’arte yankee, sia euroemancipato e chi non lo sia , questa estate ho visto una esibizione bella assai di Edward Hopper (intendo: c’erano *tutte* le sue cose famose — non come quelle mostre che dicono “Caravaggio e la pittura della Marsica” e ci sono solo pittori di Scurcola). Be’, prima pensavo che il Nostro fosse un minore, ora penso che sia un Maestro e, dato che è di questo che parliamo, che abbia segnato un solco profondo con l’arte dell’altra parte dell’Atlantico.
Velocissimamente. Ho capito meglio cosa dicesse Massinissa: è vero Stravinsky non fa al caso.
Per Jolanda: ma che male c’è ad allargare il cerchio della discussione? Non è forse vero che uno dei guai della cultura di oggi è che è fatta a compartimenti stagni? Non si può parlare, assieme, di narrativa, di poesia, di letteratura e di musica — ognuno con la sua sensibilità e con le sue competenze?
Ciao a tutti.
Per Mario De Caro:certo che si può parlare di tutto in base a sensibilità e competenze.Lei porebbe insegnarmi però che quante più alte sono le competenze,tanto più semplice e accessibile diviene il linguaggio,o no? questo perchè io credo che non tutti i frequentatori di un blog abbiano ingoiato la treccani.E poi perchè non far partire da Delfi il dibattito,visto che gli spunti non mancano? Cari saluti
vedrai Jolanda che se mi segui arriviamo a Delfi. Se solo Sandro mi aiutasse…
massinissa,
se fossi jolanda ti risponderei: vai avanti che t’aspetto.
A Delfi ci sono stata e da sola:l’ho trovata bellissima!
Se soltanto Mass non moltiplicasse gli pseudonomi!
Jolanda,
scusa se mi permetto, ma guarda che sui blog, salvo rare eccezioni e estemporanei interventi, ci stan solo degli idlers, seppur eruditi, io incluso naturalmente, a parte l’erudito.
(ho scritto idlers x attenuare la suscettibilitò di qualcuno; la traduzione, risparmio la fatica, è perditempo)
Vai avanti che t’aspetto l’ho scritto io italianizzando dal dialetto milanese, ma credo non ti sia giunto il significato. E’ una sarcastica espressione x dire: No grazie, mandandolo… avanti lui.
A nome di tutti gli idler eruditi, mi domando e chiedo: ma non si era d’accordo che i più grandi sono Joyce, e Gadda, e Celine? E allora perché ci dispiaciamo per quattro aggettivi un po’ antichi e qualche costruzione sintattica un po’ ardita?
E comunque a Delfi non c’era quella che non si capiva bene cosa diceva?
Idler, a me sembra di non piziare.
A chi può interessare dico che non sono in fuga, sto sviluppando uno specchietto per De Caro sulla pop art che me l’ha chiesto. Ma l’obiettivo è quello di svilupparne uno equivalente per la letteratura al fine di inquadrare la contemporaneità e la posizione di Delfi. Alla buona, bignam bignam
A Jolanda non so cosa dire
.notte
A Mass saprei cosa dire
notte
tranquilla jolanda, ci pensa già sua moglie a tenerlo in riga. notte
Finalmente un po’ di normale umanità!
Sogni d’oro
ma che purezza questa jolanda! quando avverte che volge come volge, si dimentica che abbiamo assistito per 9/10 a commenti alieni e aberranti su musica e filosofia; forse che nel mondo omologato questi ingredienti sono diventati il bread and butter della colazione standard delle genti mediterranee?
E invece tu pizii, Massinissa, e con te lo fanno Dell’Orco, De Caro, Ludovica, Matassi e altri. Ovvero, spesso usate un linguaggio ricercato, fate sforzi di eleganza linguistica e riferimenti eruditi.
E fate bene! Ma non è questo un blog di letteratura? Possibile che la richiesta di un linguaggio “semplice e accessibile” — quello che ci perseguita sualla televisione, nei cattivi libri e nei giornali sciatti — ci debba inseguire fino a qui?
Ma chi l’ha detto che un linguaggio semplice (= banalizzante) può dire le stesse cose, e con la stessa forza, di uno un po’ più complesso? Perché non si dovrebbe, ogni tanto, fare uno sforzetto e consultare il dizionario o l’enciclopedia (? Ma cosa cacchio ci dobbiamo fare con i dizionari e con le enciclopedie, se non usarli ogni tanto per imparare qualcosa di nuovo (a parte il facco che con il De Mauro On Line e Wikipedia non si deve nemmeno alzare il sedere dalla seggiola).
Questo è buon blog (io l’ho seguito con attenzione dall’inizio), e dura molto, oltre che per la franchezza e lo humor, soprattutto perché c’è uno sforzo di comunicare in modo non sciatto e banale. L’idea che un presunto linguaggio e un pensiero semplici-semplici siano migliori dovremmo lasciarla a Rete Quattro.
Comunque si sa della famosa legge di Grisham, che la moneta cattiva scaccia sempre quella buona. Ormai l’accusa ferale è lanciata e farà il suo effetto.
Maurizio Costanzo sia con noi…
Tre brevi punti.
1. A me pare che tutta la discussione degli ultimi giorni abbia molto a che fare con “Delfi”, da lì sia iniziata e lì tornerà. E un blog del genere mi pare ideale per parlare anche del senso della letteratura e dell’arte.
2. Anche se vedo la sincerità e anche la passione di Jolanda, la richiesta di scrivere “semplice” mi pare fuori luogo. Anche se un po’ Idler esagera ad equiparare scrittura sempllice a banalizzazione, certo è vero che oggi un rischio c’è, è quello che si scriva e si parli in modo *troppo* semplice. Il mondo è complicato, il pensiero è complicato: non sempre il linguaggio semplice è il modo migliore per capire quel mondo e veicolare quel pensiero. E poi io non credo proprio che qui ci sia qualcuno che veramente non abbia gli strumenti per comprendere poche righe un po’ “difficili”.
3. E comunque immagino che qui tutti abbiano studiato e che tutti abbiano gli strumenti per seguire la discussione. Solo che, quando si toccano argomenti che uno non sa bene (e questo, chi più chi meno, immagino capiti proprio a tutti: almeno capita a me), se non vuole passare al post successivo o al blog della porta accanto (il che va benissimo), uno deve un po’ informarsi. Male non fa. Io, personalmente, da questo blog ho imparato. Anche da Jolanda.
E spero che la discussione continui per un altro po’, senza troppe indicazioni categoriche su dove si deve andare e come si deve scrivere.
Tornando al thread del momento (o uno dei tali), le cose di Massinissa sulla Pop-Art mi paiono molto interessanti. Io ho sempre pensato alla Pop-Art come un momento sostanzialmente marginale nella storia della cultura. Massinissa mi fa vedere, con buoni argomenti, un punto di vista diverso: magari non mi convincerà, ma trovo la cosa intellettualmente rinfrescante (come trovo rinfrescanti, peraltro, anche molte delle divagazioni sulla musica o sulla filosofia).
Per quanto riguarda l’aspetto umano, cui Jolanda (non senza ragione ci richiama), dirò che vivendo nella compassata (e talora ipocrita) accademia, trovo rigenerante il clima di un blog in cui ci si può attaccare con un po’ di sincera durezza e tre post dopo si è amici-come-prima. Questo non significa necessariamente che ci si sfida in duelli rusticani: significa solo che ci si appassiona al dibattito, ma gli si dà la giusta importanza — anche in senso ludico.
Gli addetti ai lavori di ogni disciplina, tecnica o umanitisca che sia, sviluppano sempre per comunicare tra loro, un gergo. Lo fa sia il muratore sia l’astrofisico. E qui io ci trovo molti passaggi gergali.
Si tratta solo di cogliere quando sono usati per impossibilità di ‘..veicolare quel pensiero…’ altrimenti o per dimostrare ‘..chi ha il coltello più lungo…’. C’è anche una terza possibilità; che taluni si siano scordati le parole di tuttidì e siano incapaci di esprimersi in altro modo. Per le citazioni dotte, sempre che siano tali, ‘..uno deve un po’ informarsi…’ per partecipare al gioco. Per un non addetto ai lavori come me, estraneo per cultura e interessi alla letteratura, è un ottimo esercizio mentale. Meno scomodo delle parole crociate.
..il bread and butter della colazione standard..
e il jam di strawberry non ce lo metti?
Mi sono assentato un giorno per un convegno salernitano sulla generazione dell’80 e noto con piacere che il dibattito sta diventando sempre più stringente e appassionante.
A questo punto posso pure dichiarare che Matassi sta diventando ininfluente ed inrilevante: il che mi fa anche piacere perchè sta a dimostrare che il punto di partenza, ossia il romanzo Delfi, è meritevole di grande attenzione e di discussione controversa ma autentica.
Sto dettando in questo momento alla Sig.ra Salomone.
Idler-ina, io ti amo
mass, non fare il galletto che ormai per farti lesso ci vuole un’autoclave a 200°C a 300 atmosfere
Ibis a Delphe, redibis ad Delphium. Non morieris in bloggo.
per un punto martin perse la cappa.
chissà con un punto e virgola la pitia che ti combinava
Ho detto semplice non semplicistico.
Poi fate come vi pare.
E poichè ho dichiarato che soltanto io so chi e come sono,le battutine su una vera o presunta ignoranza non scalfiscono minimamente le mie convinzioni. Carissimi saluti e felice giornata a tutti.
“oggi lasciatemi perdermi” (Adorni)
a me questo Pepper comincia a starmi sulle cicatrici
Non sottovalutare le capacità profetiche della Pizia e non pensare di essere il deus ex machina della situazione.
Cosa credi Mass,ti voglio bene anch’io.
Trovo proprio semplicistico pensare che su un blog letterario si *debba* scrivere solo in modo “semplice”. Si può creto, ma perché si deve?
Capirei pure se fossimo su un blog dedicato ai vantaggi della coltura del ravanello oppure a uno che commisura Scamarcio a Raul Bova, ma in un blog lettarario? Che male hanno mai fatto alla letteratura la complessità del fraseggio, il gusto della parola un po’ ricercata e il piacere della citazione chi-la-capisce-la-capisce?
Il novanta per cento della letteratura è sempre stato così e continuerà (speriamo) ad esserlo. Ad abundantiam…
Trovo proprio semplicistico pensare che su un blog letterario si *debba* scrivere solo in modo “semplice”. Si può certo, ma perché si deve?
Capirei pure se fossimo su un blog dedicato ai vantaggi della coltura del ravanello oppure a uno che commisura Scamarcio a Raul Bova, ma in un blog lettarario? Che male hanno mai fatto alla letteratura la complessità del fraseggio, il gusto della parola un po’ ricercata e il piacere della citazione chi-la-capisce-la-capisce?
Il novanta per cento della letteratura è sempre stato così e continuerà (speriamo) ad esserlo. Ad abundantiam…
Mi sembra che Mario nel suo ultimo intervento abbia ben colto se non lo spirito essenziale, almeno uno degli aspetti centrali del blog, quello ludico. Un aspetto che per me rimane fondamentale anche come concezione della vita e del mondo, rientra in quell’ironia ed autoironia che mi riconosco. Anche nei momenti, apparentemente più aspri, della discussione non ho mai messo da parte questo sentimento di fondo.
Mi sono dimenticato (detto alla Dott.ssa Ludovica) di rispondere alla stimolante richiesta di Massinissa su ciò che in musica lacera per sempre il Novecento. Rispondo così d’istinto che la Passione secondo Luca di Wolfgang Rihm risponde bene a questo identikit.
Cara Jolanda,
non credo che nessuno degli interventi che si sono succeduti negli ultimi giorni così intensamente siano esterni al significato dell’impianto narrativo e teorico di Delfi.
Non credo neppure che ci sia nulla di male se personalità così diverse che sono intervenute nel dibattito ricorrano a stili molto diversi. Qualcuno ha anche parlato di ‘gergo’, ma è ovvio che non esiste un solo stile di scrittura e che comunque ogni stile è chiaramente influenzato dai propri interessi. Comunque nessuno di noi si è mai espresso con la tortuosità di Immanuel Kant. Sto dettando alla dott.ssa Ludovica.
Egr.Prof. Matassi,mi trovo in sintonia con le sue affermazioni.
Anch’io mi riconosco una buona dose di autoironia (quelli che mi conoscono lo sanno ) ma ciò che mi è difficile tollerare è la volgarità.
Un caro saluto
pensa se invece che pepper fossi stato salt.. il nick pepper..ino lo cederei alla jolanda
with love, peace & music
(woodstock)
θα φύγετε εσείς θα επιστρέψετε για να μην πεθάνετε στον πόλεμο
qui si svacca in bello et in pace
mi manca tanto dell’orto, quello dei carburatori, sapete se c’è una filiale a cuma?
che cazzo vuoi dire, Sgt?
la jolanda mi ricorda la mia cara nonna, da parte di madre, Jolanda Gialdi, a cui un giorno, da ragazzino già supponente, trovandomi a casa sua e sfogliando la rivista Oggi cui lei era abbonata, rivolsi questa domandai: ma tu lo sai chi è il nuovo ganzo di Mina? Lei mi rispose acida: sì, lo so, e allora?
Elio, da queste note che ti copio-incollo, direi che hai capito la mia domanda, amo anche te
… Nel 1974, presentò una composizione per grande orchestra intitolata Morphonie-Sektor IV che fece molto discutere e segnalò Rihm all´attenzione generale. Cosa aveva questo pezzo per distinguersi dai tanti altri prodotti d´avanguardia? Il lavoro di Rihm suscitò i più accesi dibattiti, semplicemente perché dietro al titolo molto à la page presentava un carattere vicino a quello della tradizione sinfonica: vi si potevano cioè riconoscere qua e là le tracce di un passato e, addirittura, di quella musica tonale archiviata in fretta e furia nel dimenticatoio. Da questo momento per Rihm la strada, sebbene tutta da costruire, fu tracciata e, grazie a una vena estremamente prolifica, riuscì in pochi anni a sviluppare una poetica molto personale che si distanziava sia dai diktat delle avanguardie, sia dalle tentazioni nostalgiche dei reazionari…
Urca, mi sento inadeguato, non ho mai ascoltato Morphonie-Sektor IV. Ora me lo scarico da Internet…
Per Sybilla: sorella mia, quanto tempo!
Caro Massinissa,
la nostra comunanza di vedute diventa di giorno in giorno sempre più stretta e questo mi fa molto piacere. A magggior ragione mi fa piacere ripetto al gusto musicale. Sto dettando alla dott.ssa Ludovica.
Mi fa piacere, dimenticavo, questa comune passione per Rihm, il musicista contemporaneo che amo e stimo di più.
Elio, mi prendi per i bottoni? Io non so neanche chi è Rihm , ma grazie a te adesso lo so. Farò come Idler, me lo scarico. Cosa ti perdi Elio a non usare il piccì!
Caro Massinissa,
da alcuni giorni mia figlia mi sta dando lezioni serali per imparare ad usare il PC. ma temo, data la mia resistenza, che i tempi di apprendimento saranno lunghissimi. Non volevo prenderti in giro ma sono contento di averti fatto scoprire Rihm. Sto dettando alla dott.ssa Ludovica.
Ohibo, qui si impara pure qualche cosa di nuovo. Mi associo alla fila degli ignorantoni che di Rihm non sapevano nemmeno l’esistenza.
A propos, Elio, tra me e te (e tutti gli altri), siamo sicuri che ‘sto Rihm non sia uno strazio indicibile?
Caro Mario, ascolta “La Passione secondo Luca” e ti assicuro che non sarai preso né da tedio né da strazio.
Secundum Jolandam, Matassus delendum est, quia magnam culturam monstravit.
Crucifige!
massinissa Says:
September 5th, 2007 at 13:25
che cazzo vuoi dire, Sgt?
>>>
Ehilà giovane con un radioso futuro alle spalle, guarda che io il nick non l’ho mai cambiato, veh. E il Rihm, se non te lo ricordi +, era un ottimo purgante, a moh di caramella jelly. Però a te consiglio le fave di fuca.
In tertia bolgia Sgt.Pepperum incontravit qui accusatus fuit simoniae et conficcatus erat in rupe.
eh la madonnaaa! direbbe renato, mio conterraneo bolso, anche il sergente
parla latino. Miracolo della Misericordia! Qui fra un po’ i muti parleranno e i ciechi vedranno!
Io il nick l’ho cambiato una volta per due turni ma dopo che hai piziato fuori una improba rivelazione, sanguanun, vediamo se ci prendi adesso
Egr. Prof. Matassi,mi riferisco all’intervento di Pizia-Mass delle I5:37. Questa non è più ironia ma maldicenza in quanto io mi firmo con nome e cognome reali.Tale multipla persona non può permettersi di fare affermazioni a mio nome neanche per gioco,in questo caso per burla nei miei confronti. Quando il gioco supera certi confini non è più accettabile neanche da chi,come me in questo caso,si ritiene più che autoironica. La saluto caramente.
simoniaco sarebbe chi?
Barlafüs d’un bardassun, ballandran d’una baldrocca, bacioccon d’un battista, becch fottrist, bescott del gerlo, incürabil de Biagrass, bolgiron d’un boffacrusca, bordocch de föravia, borian, borich, bosin, bozzaronazz, brugnon, busechin schisciaa, busseree
Visto che sui blog capire roma x toma è un attimo, sospendiamo lo show e facciamo playback:
>il pepper e il salt? hai provato a mettere sulle cicatrici il salt? e non ho infierito su dove t’han provocato le cicatrici.
>bollirti ad alta temp e press? il cappone vecchio è duro da masticare.
Eccheccè di rivelatorio in ciò? Se lo sai solo tu, non dircelo.
Sorry old man, ma altro non acchiappo xkè altro non ho scritto.
te sé de cattà, a te non mi rivolgo perchè sei una cagazibetta, una camerleccaja, un avvilimento, una cangelera, una caponera, una carcassöla, una cadrega armada, una carna de coll, una cialada, una cilappa, un cinq quattrin, una ciccolattera, una ciocchera, una colmegna, una comaa, un condemen, una coreghetta, una cospettona, un crani de legn, una crosera di ferii, una cunina, una févera cutta
purtela via, non aiuta la causa, ha l’intelligenza della gallina del renato, lo si capisce da come guarda la gente
Il blog è come un medicinale: l’uso prolungato può provocare effetti collaterali indesiderati. In tali casi sospendere la terapia e rivolegersi al vs medico di fiducia.
scusa Sgt, Pepperum era in accusativo
massa,
cos’è che volevi trattare, la pop art? Forse c’era un errore di stumpa nella richiesta. Volevano che tu parlassi di Pop Corn.
sgt, t’han tajà giò de gross
In uno dei miei ultimi interventi ho parlato dell’aspetto ludico del blog, un aspetto essenziale; è venuto comunque il momento di tornare a quello dialettico-discorsivo, altrettanto importante. Mi chiedo: come mai i critici letterari non sono mai intervenuti per esprimere il loro parere sulla struttura narrativa di Delfi e sui suoi esiti critici? Questa struttura narrativa contempla o no una struttura musicale e l’impianto costruttivo di Delfi presume o no una teoria critica della socitetà? Sarebbe interessante sentire l’opinione anche di qualche critico letterario; ovviamente trovo molto interessanti anche le successioni di Massinissa, ma in modo altrettanto ovvio non so se siano da attribuirsi ad un critico letterario, ad uno scrittore o comunque semplicemente ad un intellettuale o ad una persona intelligente. Quando uso l’espressione intellettuale non ho alcun intento dispregiativo, anzi, per me l’intellettuale è almeno un grandino sopra lo specialista, perché ha una capacità di giudizio che va oltre il proprio ambito di competenza. Sto dettando a mia figlia.
Forse, dopo lazzi e cachinni, è il caso di tornare a parlare di cose. Massinissa stava esponendo una sua teoria sul passaggio cruciale dall’arte novecentesca (in senso lato)a quella post-novecentesca. Elio ha tirato fuori dal cilindro un importantissimo musicista di cui nessun altro dei partecipanti al blog aveva (credo) mai sentito parlare. Dunque Elio vince al KO tecnico la disfida sul trapasso paradigmatico in campo musicale.
Ma sulle altre arti? E sulla letteratura? Massinissa, cosa hai in mente? Qual è l’analogo letterario della Pop-Art e dell’inaudito (in senso etimologico) Wolfgang Rihm?
Lo dico anche perché, chiudendo il cerchio, è forse anche tempo di tornare a Delfi.
Conosco da sempre, e negli ultimi tempi ne ho conosciuti veramente molti, critici musicali molto raffinati ed acuti. Sarebbe interessante ascoltare la loro opinione su Delfi e su tutto il dibattito. Ovviamente senza nulla togliere alla vivacità e alle schermaglie degli ultimi giorni.
Elio, ma sei tu che sei telepatico o io? Oppure è concidenza destinale?
(Sto dettando a me stesso).
caro Mario lasciami prima finire l’ultima puntata sui pop corn.
La pop art non eleva oggetti trovati a idoli concettuali, come fanno ancora oggi certi epigoni di D. Non dice “questa non è una pipa” ma dice “questa è una pippa”, davvero è una pippa, non la sua rappresentazione.
Jasper Johns dipinge una bandiera a stelle e strisce ma non la carica di simboli, valori patriottico-tonali, plastico-musicali. Egli vuole realizzare una bandiera; come dici? sì, una bandiera, una bandiera del cazzo, questo quadro è una bandiera, non si alza, non garrisce, è una bandiera, il suo contenuto è una bandiera, la sua forma è di bandiera.
Tu mi capisci, vero?
Fine
Se capisco, Massinissa, il punto è che la Pop-Art svuota sul serio l’idea di rappresentazione, ma non nel senso del dadaismo (che ancora giocava con la rappresentazione) né in quello dell’astrattismo (che semplicemente si svincolava da ogni forma) ma nel senso che gli oggetti d’arte sono (non rappresentano, come per Magritte) se stessi.
E immagino che tu alluda anche alla vexata questione della sociologia artistica: è l’artista, e solo l’artista, che può stabilire quale oggetto, in quanto *quello* specifico oggetto, è oggetto d’arte. Did I understand?
you did
Interessante, sì, interessante, Massinissa.
Resta ora la questione della dissoluzione del canone avanguardistico in letteratura. Da giovane mi dicevano mirabilie in questo senso di Robbe Grillet. La sua teoria mi pareva interessante. Solo che quando ho provato a leggerlo direttamente mi è sembrato una pizza cosmica.
Non saprei…
Elio, sei da trovare anche tu, però.
“Sarebbe interessante sentire l’opinione anche di qualche critico letterario; ovviamente trovo molto interessanti anche le successioni di Massinissa, ecc.”
Torni a fare marketing? Ascoltami, dolcissimo ingenuo amico:
se nessuno dei forti che evochi è ancora intervenuto, non credi che sia già questo l’indice di una stroncatura b. & b.?
C’hai Massey, non lamentarti, è uomo di occhio
sto ascoltando in cuffia intanto che scrivo: Anne-Sophie mutter di Rihm.
Me gusta y me deja hacer otro, shukran, Elio bey, massalama
massinissa Says:
September 5th, 2007 at 18:18
sgt, t’han tajà giò de gross
>>>
a ti sin desmentegàa de bagnatt i pèe cun l’oli d’uliva
notte
Mutter, Entschuldigung
ottimo, Sgt. Si usava così in campagna? A te li hanno bagnati? Io mi ricordo quando mi hanno cresimato, il vescovo, the bishop, che mi passava soavemente il pollice unto sulla fronte…ero rapito e compreso.
Domanda: l’olio da cresima è d’oliva extravergine liturgico?
massinissa Says:
September 5th, 2007 at 22:13
ottimo, Sgt. Si usava così in campagna?
>>>>
L’arcaica saggezza contadina. Dal sta sü de doss che te me peset al sügüta pü a fa l’asin ch’el fen el custa. Non avevano tempo da perdere in chiacchiere, povera gente.
Dai, massa. Basta perder tempo. Porta avanti il lavoro che t’han commissionato. Ti manca solo la zampata finale.
Ho ripetuto alcuni tuoi interventi al Benny’s Bar, e m‘han già pagato il caffè. Io voglio arrivare al cognacchino, se non a una cena alla Trattoria Benzun, roba bona a prezzi bun.
PS: Mi scuso coi lettori non proprio miei concittadini, ma sono a disposizione per tradurre in italiano.
fine della ricreazione, tornate ai vostri post
Extravergine d’oliva.
robe-grillet ha un peso atomico che si avvicina di brutto a quello dell’elemento che cercava mendeljeff, ma non è lui, non se l’è filato nessuno.
Penso a uno scarto (lacerazione, after Elio) non sovrapponibile a quello artistico. La derapata giallo-noir-police-horror-business-sfxistica cui assistiamo che matrice ha? Siamo distanti da Beckett anni luce. Credo che si debba scavare in direzione ovest, ancora una volta.
uè, Ludovica, non riesco a identikarti, come ti va? Hai dettato a Matassi?
intanto che aspettiamo parliamo di Sandro-Beckett.
Volendo, si può definire musicaliforme tutto ciò che si sviluppa nel tempo: il cinema sì, la fotografia no, il teatro sì, la pittura no, u.s.w.
Ma se l’arte parla ai sensi, io tirerei in ballo la musica solo se c’è di mezzo l’orecchio. La struttura, il contrappunto, il ritmo sono riscontrabili in mille altri processi, naturali o artificiali. Le ricerche futuriste di Russolo hanno
aperto la strada a notevoli sviluppi ed esiti in tal senso (Elio, was sagen Sie?)
Anche facendo reading a 1000W, è orecchiabile Delfi?
Elio è partito per un giro accademico-convegnistico-culinario, durante il quale non so se troverà facilmente modo di dettare i suoi ponsamenti delfici. Sono certo, però, che proverà, e comunque domenica sarà di nuovo nell’Urbe, più grande e più bello che pria (come diceva l’Ettore).
Intanto cerchiamo a Ovest.
Delfi, roman filosofique, ecco qui si puole discettare.
Non basta che mi passi allusioni da quattro soldi sulla vita infelice degli uomini controllati e deterministicamente mossi.
Il Controllo – già a scrivere la parola mi devoglio- contrariamente al passato ( marcusiano e pasoliniano) quando era subdolo e sottile, oggi è dichiarato, osceno, spataffiato, la nostra vita scorre su binari inderagliabili.
Dunque Delfi non rivela nulla e già questo è un bel limite per una memoria filosofica, o no? Ma Delfi è un romanzo.
Senti, vado avanti dopo, devo salutare la mia nipotina che è un fiore, ha due anni e 1/2 e parla come una radio
Mario, vai avanti tiki, esco a prendere un caffè, fammi trovare un kon al mio ritorno
A porta Ludovica, ier sera el piuveva. Bei tempi, eh?
n.d.r. Porta Ludovica è un quartiere di milano dove ho trascorso parte della mia youthness
massa, son costretto a darti ragione. La musica si sente solo con le orecchie. C’è un’altra via, un po’ scomoda forse. Prendete un cacciavite col manico isolato, non troppo morbido. Avvolgete sullo stelo metallico una decina di spire di filo della luce. Attaccate i due capi del filo al posto dell’altoparlante del vs I-Pod. Stringete il manico del cacciavite fra i denti e date gas. Non è Hi-Fi, ma non disturberete il vs vicino sul treno o sul bus.
Important Notice: Se avete la dentiera, è possibile che suoni lei.
Eppoi non usate a sproposito la musica nelle vs dissertazioni, che è l’unica Arte che raggiunge tutti, indipendentemente dalla loro formazione culturale, e soprattutto è indipendente dalle stampelle/promozioni dei critici. neh.
Mandare a puttane. Sì, vogliono mandare a puttane. E’ il compito che gli hanno o si sono dati, e insieme è il loro happening, il loro concetto di arte situazionista. Trasformare tutto in quel che sono loro: nullità. Per questo amano la pop art, misera riedizione di Dada, inventata dai mercanti. Per chi non se ne fosse accorto, il loro comportamento in questo blog è ciò che loro intendono per arte: la sua radicale eliminazione. Non conta ciò che si discute, la cosa stessa, perché questa è giudicata a priori merda – tutto è merda perché ne hanno gli occhi e il cervello pieni –, conta solo danzare allegramente sul cadavere di ogni significato, di ogni pensiero, di ogni umanità che faticosamente cerca di emergere dalla melma. No! Devi stare sotto, come noi, come tutti! dicono i loro sardonici interventi a sfondo sadomasochistico. E quando la festa è finita, quando tutto sarà distruzione e silenzio, avvertendo di nuovo l’amaro del nulla sotto il palato, ricominceranno a guatarsi in giro se c’è qualche accenno di vita da abbattere, per sfogare il rancore di non averne più una. Per questo amano tanto lo stile per lo stile, perché non avendo più contenuti – la loro anima è ottusa a ogni stimolo umano ed estetico – è l’unica cosa che gli rimane, e ci si aggrappano con la patetica passione di professori di liceo in pensione, sfoggiando un’erudizione che suona ogni volta vuota, kitsch e penosamente ridicola. E’ il trionfo della semicultura, dello spirito svincolato dai reali impulsi del soggetto, che si estende ignaro di sé sul mondo, compiaciuto e satollo del suo nozionismo e dei suoi schemi concettuali con cui pensa di possederlo. Le sue preoccupazioni sono classificatorie: qual è il termine a quo o ad quem di questo e di quello? Quando finisce il Novecento, e quando inizia il Post? E’ la pop art il superamento dell’avanguardia? Con simili approcci da bignamino o da settimana enigmistica, si pone di fronte al fatto artistico. Del resto sono quelli dominanti: basta prendere qualsiasi manuale di storia dell’arte per rendersene conto. E d’altra parte anche se volesse non potrebbe averne di diversi: avendo annichilito la propria anima non può più usarla per esperire l’arte, che si accontenta di trattare con spirito da ragioniere. Ecco, l’anima, o l’io, la sua forza, la sua debolezza: queste le categorie da cui partire se si vuol capire quel che sta succedendo, anche nell’arte. E si possono capire solo se uno l’anima ce l’ha ancora, se le sue reazioni pulsionali sono ancora le sue e non quelle inculcategli dalla società e dall’industria culturale. L’opera d’arte – qualsiasi – necessita come a priori assoluto della capacità del soggetto di auscultare la propria anima per condurla dove essa stessa vuole liberamente andare. Per liberare il non identico, c’è bisogno del suo contrario, l’identico, lo spirito, che una volta tanto si mette al suo servizio invece di schiacciarlo sotto di sé. Per questo la semicultura non basta, non basta aver intelligenza per fare e comprendere l’arte, occorre aver conservato un rapporto aperto, tenero e confidenziale con la propria anima, un rapporto non interrotto o deformato da rimozioni, stereotipi e formazioni reattive, in modo da poterne udire la voce che chiede di liberarla con l’articolazione della forma. L’espressione ha bisogno del soggetto per andare oltre il grido impotente, e il soggetto ha bisogno di quella se si vuole liberarsi dalla prigionia in cui consiste.
Il cinismo, il nichilismo, Dada e revival non servono all’arte – e del resto Dada era dichiaratamente antiarte – come non servono a nient’altro. Sono la versione bene informata del conformismo. Come la tanto decantata ironia che se la ride in mezzo ai suoi stracci. Stanno ben nutriti e pasciuti dietro i battaglioni dello statu quo, che provvedono a distruggere a parole per accomodarcisi tanto più comodamente. E’ la storia del riflusso, che continua con lunghissima onda dagli anni settanta, che predica la morte di tutti i valori – diffondendola anche dai megafoni dei media in cui si è installato – per giustificare a se stesso e agli altri la sua cooptazione nel potere una volta aborrito.
Pur se difficilissimo, pur se quasi non esiste più soggettività, occorre invece aver fiducia nel soggetto, nella sua capacità di articolare una forma dai suoi stessi impulsi, ridando così agli uomini un esempio di vera vita nella falsa. Solo lui può farlo, non c’è che l’uomo per salvare l’uomo, per questo bisogna crederci.
ué, va chi c’è. Mandare a puttane cosa, Sandro. Se volessi mandare a puttane il tuo avvenire di scrittore ti ignorerei semplicemente, invece sono qui a darti generosamente corda. Perchè mi diverto, as simple as that. Col tuo solito sproloquiare, con cui non mi confronto per assennatezza, hai interrotto un discorso – cioè l’hai mandato a puttane- che prometteva bene come contributo paracritico al successo del tuo paramusicale, parafilosofico, parapoliziesco romanzo. Adesso non so più dove sono rimasto, mi hai annichilito con la tua insipienza. E ancora contro le major, i mercanti, i pupari, ma va, va
la pop art non supera le avanguardie, le salta! Segna il passaggio a un’altra curva, a un’altra pista, come succede nella storia quando si esaurisce un filone o cambiano i mezzi di produzione o cambia la tecnologia o cambia il mix antropoide.
In casa mia ho solo quadri di pittori informali milanesi, coi quali ho anche discusso, a suo tempo, della maledizione della popart.
E poi fai casino, no, non ti seguo…
capire su che curva ti trovi è fondamentale se vuoi produrre qualcosa di significativo. Questo non è bignami. Se non hai le coordinate del presente non è possibile fare arte, salvo casi rarissimi di forza bestiale come in Ligabue o quell’altro alienato svizzero come si chiama. Senza questa consapevolezza si fa esercizio da dilettanti, quello che descrivi bene tu che te ne intendi: il soggetto che vuole liberarsi, la massaia, il concorso per pensionati, la parola toccante, una lacrima sul viso ecc.
avanti, dimmi perchè hai scelto la forma poliziesco, su, come ti è venuta questa idea del genio articolato?
i pupari riempiono il vuoto o l’insufficiente consapevolezza degli autori
il fatto che tu negliga l’a quo l’ad quem mi mette agito.
Da professore di liceo in pensione ti seco in epistemologia intersezionale
Ehi Artisti, che parlate di ’.. trapasso paradigmatico in campo musicale…’.
E’ morto Pavarotti e manco una parola?!
Ma ce l’avete almeno il giradischi in casa?
dunque l’arte secondo Sandro è espressione dell’anima, basta avere l’anima e zac! il pezzo è d’arte.
Io ho sempre creduto che fosse il prodotto di una mente speciale.
L’ho capito da quando osservavo il mio compagno di banco che disegnava degli animali con meravigliosa simiglianza. Perchè lui sì e io no. La sua mano era uguale alla mia. Il fatto è che il suo cervello vedeva il coniglio come se ce l’avesse davanti in fotografia, con le ombre e tutto il resto.
Avete mai fatto delle passeggiate con i pittori di Barbizon? Vedono delle cose, degli scorci, dei colori che io non vedo. Non sono invidioso, mi inchino e li ringrazio di insegnarmi a vedere.
Lo stesso accade in musica, c’hai un bel da studiare se le note non fumano in testa, se l’orecchio non è sopraffino. Non so se è leggenda, chiedo a Elio, mia nonna Jolanda mi raccontava che Toscanini alle prove riprese un professore a corde, fra cento orchestrali, intimandogli di tirare su un pochino una corda.
É morto Pavarotti? Oh, poveretto, io mi aggiorno alla mattina, mi dispiace
io credo che tu Sandro sia velleitario, non portato alla letteratura scritta,
come me del resto. Temo che tu abbia la bocca senza palato.
L’impresa artistica, oltre a necessitare di quel quid che chiamiamo vocazione, ha bisogno di un altro ingrediente, la consapevolezza critico-storica, quegli a quo e ad quem che tu sottovaluti. Il compito della critica è appunto quello di soccorrere i talenti ignari
ma Delfi è un romanzo. L’idea di optare per un poliziesco, in sè, non è peregrina; visto che il tema è trito come l’oroscopo sviluppiamolo in un contesto improbabile, mitico, utopico. Io non so come si svolgono i fatti, già che ho letto solo un capitolo, ma immagino che il plot si regga su qualche pregiudizio mitologico; se così non fosse la location sarebbe gratuita e impropria assai. Ma L’autore ci ha detto che lui non si rivolge al lettore e quindi ogni arbitrio è lecito. Chi lo sa. Certo che io come lettore mi riservo però di stimarlo un volgare piazzista, un seminatore di specchietti. E questo credo sia il caso di Delfi, una molla per allodole.
Del resto che la materia non sia viva, non sia conficcata nella carne dell’autore, contrariamente a quello che egli parrebbe rivendicare quando ci informa nel codesto blog di avere sonde nel profondo, lo dimostra la povertà dello stile, la miseria dei dialoghi, la fumettistica sbozzatura dei protagonisti.
Povera,povera Sofonisba!!!
siamo benestanti
Mario, che ne diresti di Stephen King?
Ehilà, sei già sveglio. Ciao, neh.
Sono appena tornato dal Benny’s Bar, ma il caffè me lo son dovuto pagare io oggi. Avevo preparato the following, ma prima ho dato il cicchetto.
>>>
Bla, bla, bla.. Vogliamo stringere? Anche xkè se esaurisci i tuoi appunti, poi non c’hai + niente da dire.
Einstein, quello dell’mcquadro, cercava una formula, che stesse su una riga, che descrivesse l’universo e l’arte il caro Alberto l’ha definita l’espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice.
Tutto il resto è noia (Califano)
Cara Jolanda,
mi rivolgo a te perché mi ripugna rivolgermi a chi ha la consistenza morale di un calunniatore anonimo, o di un maniaco sessuale telefonico. Questo miserabile, amusico totale, non nelle orecchie, ma nell’anima – che non sa neppure cosa sia -, pretende di penetrare in un’opera vedendone una particola, un assaggino, un sorsetto – secondo la sua estetica gastronomica che non si vergogna nemmeno di nascondere. Dopo cent’anni e passa che l’arte figurativa, come tutta l’altra arte, è essenzialmente composizione, articolazione necessaria di una forma, con qualsiasi materiale – colori, stracci, tagli, merda, sperma, sangue, colpi sul legno di un pianoforte, corpi viventi e chi più ne ha più ne metta – il nostro rincoglionito professore in pensione si permette ancora di cagare i suoi giudizi in base “al ricco impasto”, alle “agili pennellate”, “alla bella materia”, visibili in un angolino del quadro (quando ancora c’è), ignaro dei risolini imbarazzati del povero uditorio costretto a sentirlo. Pretende, il nostro semicolto, di capire il tutto dalla parte, come una buona forma di pecorino, o una bottiglia di Barolo; gli basta vedere una particola dell’opera per capire tutto – cioè nulla, perché quella parte è qualcosa solo in rapporto alle altre. Ma I cast pearls before swine: uno come lui, che alla sua veneranda età non ha capito queste cose, non le capirà mai più.
Con affetto, sempre tuo,
Sandro
rassicurato sul fatto che non appartengo nè alle major, nè a nessun altra corporazione culturale, il nostro tira fuori le unghie della subalternità riscattata
Do massa 1.75:1 su sandro. Si accetta Visa e Mastercard (e anche i francobolli).
Carissimo Sandro,
non ti crucciare tanto non ne vale la pena. Ho visto autorucoli da niente ( narrativa e poesia )pubblicati dalle cosiddette “grandi case editrici” che sono soltanto fotocopie sbiadite, eppure vengono considerati autori di tutto rispetto. E’ solo un gioco di potere che nulla ha a che fare con la bontà dei testi. Ciò che conta oggi,purtroppo,è il vil denaro,nella vita e quindi anche per ciò che concerne la letteratura.Rimane solo la triste consapevolezza di vedere asini che galoppano e cavalli di razza ancora fermi alla partenza.Ovviamente,nella corsa,i vincitori lo sanno già in anticipo.
Ti saluto caramente,
jolanda
E la nebbia,Sandro,la triste nebbia del nord ,non credi sia un elemento importante per l’ottundimento della coscienza?
Ti risaluto
jolanda
per il termine a quo: stephen king
per il termine ad quem: sandro dell’orco
per il trash pop: jolanda catalano
l’arte contemporanea privilegia l’interessante e l’eclatante piuttosto che il “bello”, non so se volevi dire questo, e l’interessante si vede a colpo d’occhio, come una pennellata. Delfi è privo di tutto, salvo della brama
grossa di successo del suo mediocre autore e della sua minus habentes
she-fan
habente
Ragazzi,
se vi deprimete x quel che ha scritto un massinissa su un blog, alias tecnologico del Benny’s Bar, che manco ha letto il de busillis, come argomenterete con un critico vero e, soprattutto, col pubblico?
Prestate però orecchio anche ad un aforisma di Longanesi, l’editore (senza alcun riferimento a presenti e assenti):
‘L’arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere stati chiamati’
Riconoscete infine che il massa è l’unico che s’è speso, xchè nessun’altro s’è affacciato ed interessato a voi, dopotutto.
Amen
>>>
el massa canna pure il latino, eppure insiste senza vergogna
…habens,habens…
almeno così spiegavano i miei cari insegnanti.
lL’osso è più duro di quello che pensavi:attento alla dentiera!
il latino è sempre stato la mia bestia nera, mi veniva bene dal-a, da a-a ero un dell’orco.
però te chi sei, guastafeste? non sarai una major-ette, per caso?
io insegnavo applicazioni tecniche, poi mi sono dato allla caccia degli impostori sul web
sto dando la pappa al mio secondo di 10 mesi, capisce già di poppart
Uela! Il Mulo ha finito di scaricarmi Alchemy – Live dei Dire Straits. Moh me lo metto su DVD e me lo ascolto a palla sull’home theatre.
Va’ che a 10 mesi c’han già i denti e mordono
E poi non si fa riferimento a persone fisicamente o psichicamente meno fortunate,mai,o almeno non nel senso in cui l’hai fatto tu,caro il mio Mass,perchè offendi una,purtroppo,categoria di persone che in questo momento non possono risponderti.Lo faccio io per loro: vergognati!
Sono stata e a volte sono una guastafeste e mi diverto pure.
In quanto alla major-ette devo deluderti:sono stata soltanto una bellissima major-ata.
troppa presunzione, mi riferivo a Pepper che a occhio ha un
Q.I.=10x il tuo
I.Q.
se lo sei stata adesso come le tieni su? O vai cordless come le comari?
Your disc is ready! La supa l’è cotta. Vado a infilarlo nel giradiscolo.
Maj-orate, cordless. quì sta nascendo un’amore.
Mi vu.
a plus tard
Gli asini conoscono solo i cardi,le orchidee con tali quadrupedi sono proprio sprecate.
infatti: asina asinum fricat
adesso gli cambio i pannolini in Arno
il Sgt. è un Bonvesin de la Riva destra
Epperò massa, sai che mica mi spiace l’accostamento? E mi ci ritrovo pure qua e là. Come cavolo l’hai scovato, mago merlino?
Frage:
è più intrigante essere sottovalutati dagli ignari o essere sopravvalutati dagli accademici?
ogni riferimento a persone o animali viventi è casuale
massa, prendi questa>>>
Il bambino aveva un buco nei pantaloni, che lasciava vedere una famiglia povera. (La fiera delle castronerie)
Devo ritrovare quel libro. ce l’ho in cantina da qualche parte. Vi suggerisco un giro a: http://www.geagea.com/43indi/43_06.htm
vi è umorismo lieve e acuto, e se proprio ci tenete pure ‘letterato’. Un es.:
>Una volta fu chiesto a Pontidio: ” Come giudichi uno che si fa cogliere in flagrante adulterio?” “Lento di gambe” rispose quello. (Cicerone)
Stasera se non altro potreste risparmiare una pastiglia antiacido.
Dipingeva vivi come fossero morti da due giorni.
Una volta che voleva dipingere un morto, la bara era già chiusa.
(Karl Kraus)
Questa è + in tema:
Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma.
(Karl Kraus)
Questa e poi basta, sennò mi fan pagare il ticket:
Che differenza resta tra un convinto e un ingannato? Nessuna, se è stato ben ingannato.
(Friedrich Nietzsche)
sottoscrivo l’ultima
karl kraus è uno dei padri
E’ buffo l’uso di ‘..uno dei padri..’ quando la creatura ne può avere logicamente uno solo. e la madre non ci fa una bella figura, per non parlar del baby. Stanotte ci penso.
C’è qualcuno che ha letto l’intervista a Dawkins ieri su Repubblica?
A TUTTI I LETTORI DI QUESTO BLOG
Cari lettori,
il nostro anonimo cazzaro, e quell’altro poveraccio che gli tiene bordone, hanno insinuato ieri e l’altro ieri, tra una puttanata e l’altra del loro insulso repertorio da filodrammatica liceale, che dovrei ringraziarli, perché se non ci fossero loro a darmi un po’ di notorietà, il mio libro sarebbe del tutto ignorato, visto che i critici “veri” continuano a latitare, sia fuori che dentro questo blog. La verità – come sempre nel loro caso – è tutto il contrario. Hanno apprezzato pubblicamente il mio libro, con accurate analisi letterarie, e talvolta con accenti entusiastici, i seguenti critici e intellettuali: Arnaldo Colasanti, Andrea Cortellessa, Giulio Ferroni, Mario Lunetta, Franco Matteucci, Renato Minore, Franceso Muzzioli, Elio Pecora, Walter Pedullà, Tino Sangiglio, Claudio Strinati, oltre ovviamente a Elio Matassi, i suoi amici filosofi e musicologi, e altri meno noti, ma altrettanto validi, a cui rimando nel sito di Hacca. Se poi altri importanti critici e scrittori, estimatori del mio libro – di cui non posso ovviamente fare il nome –, da me invitati, hanno purtroppo ricusato di partecipare a questo blog, ciò è stato dovuto, per loro esplicita ammissione, proprio alla squalificante presenza in esso dei soprannominati mentecatti, con i cui dementi e calunniosi interventi non vogliono avere nulla a che fare – e li capisco.
Dunque in questo, bisogna ammettere, il nostro cazzaro e i suoi amici sono riusciti: a mandare parzialmente a puttane questa discussione, tenendone lontane persone di grande cultura e sensibilità artistica, e abbassandone il livello. Solo parzialmente però, perché il blog è continuato grazie al tenace e generoso impegno di Elio Matassi e dei suoi colleghi che hanno fatto fronte.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Sandro Dell’Orco
ma perchè allora ti sei voluto esporre in un blog?
Non lo sapevi che è viscido e pieno di infelici bisognosi di tueggiare con uomini rari e di genio come te con cui non avrebbero altrimenti chance di contatto, data la diversa collocazione culturale e antropologica?
..sono riusciti: a mandare parzialmente a puttane questa discussione…
mi sopravvaluti, mio caro simpatico vanitoso permalosetto
A tutte le persone pensanti della blogosfera
In questo blog sono intervenuti a titolo di amicizia e amore per la letteratura i seguenti commentatori appassionati di Delfi, in ordine di apparizione:
Federico Platania, Antonio Veneziani, Cristiano, Francesco Idotta, Marco Palladino, Andrea Caterini, Gabriele, Giovanni, Francesco Tarquini, Marisa, angelo, David Frati, Giuseppe, Alberto Toni, Fabrizio, Silverio Novelli, Dav, Mil, Eva Gerace, Carmela Tringali, Mauro, Ludovica, Cristin Tiziana, Dario, Jolanda Catalano, Marco Fortunato, Mario De Caro, Chiarameta, Giulia, Micaela Latini, Marco Filoni, Paloma Brook, Maurizio Fava, Vito, Hektor R., Luca Aversano, Elena, Domenico Vadalà, Giulio, Fiorella De Simone, Pietro D’Oriano, Cesare Guarino, Fabio, Claudio Vet, Chiara gabrielli, Draga Rocchi,, Valerio, Arduina Fiorucci, Vincenzo Nappo, Emiliano Console, Michela, Ugo Cive, Massimo Stranti, Francesco Rupi, Riccardo Opi, Loredana Filoni, Mario Ancona, Annarita Palmoli, Paola Celano, Tommaso Capestrano, Ettore Scardanelli, Luigi Deco, Lucio Andronico
Il vecchio Massey di fronte a una così preposterosa falange di interventi pedanti, fuori tema, aberranti, orchestrati, partitici, non ce l’ha fatta a stare zitto, tenuto anche conto della sua attività di cacciatore di web-impostori. Essendo un amante di Shakespeare ha probabilmente ecceduto in scurrilità, ma egli non abiura quello che ha scritto, anzi, gli piacerebbe
davvero confrontarsi con gli importanti critici ed estimatori di Delfi non intervenuti costì.
Sandro, lui, l’orchetto cagatore, cosa dirgli che non ho già detto. Ah, ecco, l’ho visto in una trasmissione di Telereggio (C) quest’estate che diceva dellle belle cose su Delfi. Non ho potuto seguire l’intervista perchè sono rimasto come ionizzato dalle belle mani del giornalista partecipe.
uè, rinnegato!, ma non avevi detto che tu non ti rivolgi ai lettori?
osservate come le facce da culo, i sepolcri imbiancati, i pudibondi, i subalterni, reagiscano come plebei, schiumino come rospi se solo gli fai notare che la testa ce l’hanno solo per separare le orecchie a sventola, come è di fatto
mi sarebbe piaciuta una bella sfilza di insulti romaneschi e invece no, cazzaro! non la dice già lunga sulla sua statura d’escrivano? Cè bisogno di leggere tutto un micidiale capitolo?
mi piacerebbe sentire Walter Pedullà, che stimo e che conosco bene, cosa ne pensa veramente, off-record, del tuo testicolo
tu sei un servo, se ti dicessi chi sono, verresti a leccarmi i piedi stanchi e viola dopo un giorno di calci in culo che ti ho dato per farti trottare
professore di liceo! e dà del rincoglionito a me! valore morale! Se ne avessi un pico-grammo avresti, se non li avessi commissionati tu, bloccato gli interventi di falsa adulazione già alla seconda apparizione, con un bel achtung ai lettori, come hai fatto adesso, pelabrocco!
scrivi come un travet, senza visione, faticosamente, giocando a domino coi nessi, una parola tira l’altra, senza il passo regolare; ma chi se ne frega del passo regolare se tu avessi brio, inventiva, carattere.
Quanto a coinvolgimento personale, guarda, facendo 100 una partecipazione commossa a un necrologio, tu sei 10
filosofia, critica sociale. Roba talmente vecchia che si può trovare già composta come modello di default di un software sindacale
poveraccio! dice, questo sfigato mangiatore di parole senza poterle gustare perchè è senza palato.
Questo piteco che ha bisogno di un girello di rottinculo per stare in posizione eretta
questo divoratore di letteratura mondiale che non ha capito un cazzo: perchè c’è stato qualcosa dopo Beckett?
Guarda io farei un 2-1: stephen king centrale, truman capote a sinistra e un don de lillo a destra
Quanto tu e i tuoi amici siate degli strateghi minimi! Siete stati in silenzio concertato per 24h, tu hai fatto le telefonatine per il permesso di nomazione, avete fatto uscire questo comunicato frollo…e poi? avete pensato agli altri passi?
Alzando lo scontro a questi livelli non c’è più niente dopo.
Come fate a continuare il blog? Senza il vecchio Massey e soprattutto senza più motivazione, voi medesimi. Che cosa fate? Elio riscrive il suo teorema, tu il solito cagatema, Jolanda prepara una parmigiana per tutti?
C’è un solo modo per continuare, se ci tieni, e se Elio vuole il mille.
Che entrino in gioco quei tuoi critici che stimano tanto Delfi.
Ti prometto da uomo che se entrano non interverrò nel dibattito.
Mi piacerebbe Pedullà ma anche Cortellessa e Minore o gli altri che hai tenuto in serbo, ma che non nomini, ecco quelli. Senza barare.
Bollettino medico-letterario:
dopo interminabili inerventi,si sta spegnendo,tra liquami di bile e una rabbiosa agonia,l’illustre mass “lei non sa chi sono io”.
Addolorati e affranti gli fanno compagnia i suoi multipli pseudonomi a imperituro ricordo di colui che non ha avuto gli attributi per dichiarare la sua identità.
Il prossimo bollettino(defininivo) sarà diramato al più presto.
Avevo già pensato a una cena per tutti a base di parmigiana
Soltanto che dopo:provinciale,artigianella,nullatenente,cervello di gallina, diversamente abile,e sono gli epiteti che ricordo senza scorrere le pagine del blog,non potrò più invitarti . Peggio per te!
Ed ora,coraggio,spara! Tanto è l’unica cosa che sai fare.
.
i miei multipli sono stati i seguenti:
massey
ferguson
sybilla
tutti trasparentissimi a tutti meno che alla bradicefala jolanda
piuttosto, chi si nasconde dietro i seguenti nomi senza cognome:
cristiano, gabriele, giovanni, marisa, angelo, giuseppe, fabrizio dav, mil, mauro,ludovica, dario, chiarameta, giulia, vito, hector r., elena, giulio, fabio, valerio, michele
a parte la fatina, massey ha giocato da solo contro 65 invasati, per 3 mesi e non è per niente affaticato
Per raccontare bugie (cazzate) ci vuole ottima memoria e tu,caro il mio mass-strutocamelus,non ne hai.
Se tua figlia,posto che tu ne abbia una,fosse bradicefala,useresti ancora questo termine,brutto bacucco incivile che non sei altro?
Cacchio massa, li hai stesi.
Oggi però vado a funghi cantando Lucy in the Sky with Diamonds.
massinissa, io ti ammiro.
non credevo che la nobiltà di spirito potesse resistere a tanta idiozia. a me l’ottusità dei presenti (non ci sentono, cazzo! sono assordati dalla loro stessa stupidità piccolo-intellettuale!) ha fatto venire la gastrite da un pezzo. sul serio.
chiunque tu sia, grazie.
Bene, bene, bene. Il nostro innominato e innominabile pallone gonfiato è scoppiato. Era così pieno di boria e di stronzate che è bastato pungerlo con uno spillo per farlo esplodere e fargli spruzzare tutti i suoi spocchiosi escrementi su questo blog. Sì, il nostro cazzaro lei-non-so-chi-io ha sbroccato, ed ora, come il pazzo lombrosiano, gira furente e senza posa intorno al suo computer per cagarvi ogni cinque minuti i suoi deliri. Bene, bene, bene. Tra un po’ arriverà al valium e alla camicia di forza e ci saremo liberati di lui. Intanto ci propone un’altra delle sue esilaranti farneticazioni. Dopo aver impestato e sputtanato questo blog per tre mesi con la sua repellente e vigliacca presenza, pretende adesso di ripassarlo al bucato togliendosi lui di mezzo, senza rendersi conto che la puzza e le macchie di merda che vi ha lasciato sono indelebili – a sua eterna onta – come la sua stupida e proterva arroganza. Non ha capito, il nostro paranoico peracottaro, che passa il suo inutile tempo a dar la caccia alle sue allucinazioni di web – impostori, che nessuno ha bisogno della sua maligna presenza e del suo demente scilinguagnolo, in cui, con ignoranza pari all’impudenza, fa consistere l’arte letteraria.
Caro Sandro,ho appena sfornato una parmigiana di lusso.
Se vuoi chiamare gli altri ( Matassi ,De Caro )e quanti altri fanno parte di questo blog concertato,di parte e così via,il pranzo è servito.
un abbraccio
jolanda
quello di voler dire sempre l’ultima è tipico dei mediocri
bene bene bene
vuoi dire che mia moglie…. moh ce lo dico e mi vendico
come stride quel bene bene bene!
devo comunque complimentarmi con te, stai cercando di migliorarti
bene bene bene
pepper, paguro bernardo, vuoi scollarti o no?
vorrei fare un metablog, una specie di blob dei blog, che ne dici NM ?
non solo quelli letterari ma anche quelli d’arte, politica, costume.
Pensa al blog di grillo, ai commenti neoqualunquisti che scatena; non credi che ci sarebbe da piziarci addosso dal ridere?
stack!
l’improvvisazione la chiama scilinguagnolo!
Naturalmente se parla d’improvvisazione al circolo del tempo libero parla di impronta, di jazz, di dripping, perchè, insomma, gli va riconosciuto, l’ha messo insieme un certo repertorio
adesso ti spiego:
io giro sempre intorno al computer perchè ci lavoro, faccio dei frattali.
Intanto che lavoro tengo aperto delle sessioni divertenti.
Ti assicuro che musica a delfi è un ottimo break.
Adesso ce li ho in una cartella ma posso metterli in rete e fare un link con dedica: uno floreale per Jolanda, uno fognario per te, uno musicale per Elio
Li ibrido, li coltivo, gli cambio i connotati, a partire da una formula del cazzo auto-iterante all’infinito a meno che non gli poni delle condizioni di stop.
Ecco, tu sei un frattale, ogni tua parte si ripete nel tutto, da qui la inutilità
di procedere nella lettura di delfi dopo il primo capitolo, il pattern è quello, potrà cambiare dimensioni ma è sempre lui, una forma di cavolo fiore
massinissa, davvero resisteresti a tanto neoqualunquismo? a me dopo l’esperienza di questo thread pare di averne abbastanza per i prossimi cent’anni! ma forse hai ragione, il lavoro di squadra sarebbe anche divertente, e la condivisione dello spettacolo della miseria mi darebbe forse un po’ di forza in più…
(a proposito di forza, dell’orco dovrebbe scrivere sempre come nei suoi ultimi due o tre commenti, avrebbe almeno un po’ più di piglio – sempre che poi abbia le palle di lavorare duro – dico duro – a tutto il resto.)
ad maiora, massey, ti ricorderò come l’ultimo baluardo d’intelligenza critica contro il più logorante assalto di stupidità intellettuale cui mi sia mai capitato di assistere.
Caro Massinissa,
dopo alcuni giorni vorticosi in cui sono stato impegnato in deiversi convegni e tavole rotonde in giro per l’Italia sono tornato a Roma e, aiutato da mia figlia, ho fatto accendere il PC per vedere come si stava sviluppando il dibattito. Mi sono molto sorpreso che negli ultimi giorni si sia accesa quasi una disputa all’ultimo sangue, molto personalizzata, rispetto a cui mi sento estraneo. Non sono suscettibile ma ritengo che la definizione di ‘accademico’ mi vada un poco stretta. Se accademico significa insegnare all’Università, non posso negare di essere un accedemico, ma se ‘accademico’ significa essere completamente autoreferenziale e totalmente svincolato da ogni forma di dibattito, allora non mi riconosco in questa definizione. Sono un trasgressivo per natura e questa doppia appartenenza filosofia morale ed estetica musicale, che preoccupa molto gli accademici (questi sì veramente accademici) non viene digerita da ambedue le parti e questo dimostra il mio sostanziale antiaccademismo. Credo che la funzione di un intellettuale e di un ricercatore sia quella di non parlare solo ad una ristretta cerchia di specialisti, come fanno i veri accademici, ma di rivolgersi, coinvolgendolo, a un grande pubblico, perché un intellettuale deve saper intervenire nella formazione dell’opinione pubblica. Credo che la mia partecipazione a festival e a manifestazioni simili ne costituisca una verifica estrema.
Caro Sandro,
non vorrei che la piega che ha assunto il dibattito negli ultimi giorni fosse il preludio di un duello all’ultimo sangue, e in questo caso non mi sentirei di essere il padrino di nessuno dei due contendenti. Io spero che nei prossimi giorni il dibattito possa tornare sui temi sollevati sin dall’inizio, ovviamente con opinioni anche molto diverse se non addirittura opposte. Ogni dibattito assume pieghe molto controverse senza che questo debba comportare alcuna violazione personale.
nevermore Says:
September 9th, 2007 at 21:41
massinissa, davvero resisteresti.. ecc.
>>>
tutto d’accordo, ma col tuo congedo io mi toccherei gli attributi. eppoi never say never
mmmh matassi, la frittata è fatta, non resta che mangiarla. io l’ho trovata appetitosa. alla prox
love
Non credo che la frittata sia fatta; fino a pochi giorni fa il dibattito si era tenuto su livelli molto alti. Spero che da oggi torni ad essere una discussione, anche accesa, anche durissima nei giudizi, ma senza nessun personalismo pregiudizioale da ambedue le parti.
And the raven said “Nevermore”.
matassi, lo spero anch’io, ma non s’esageri con l’altitudine chè nn tutti ci sono abituati.
ludovica, senza ironia, ma il tuo intervento, che io traduco e il corvo disse mai +, non lo acchiappo.
E.A.Poe, The raven.
merci, adesso me la vado a leggere
acc.. è meglio che la trovi tradotta in ita
Caro Massinissa,
mi mancano i tuoi interventi sferzanti, sfavillanti ed anche brillanti. La tua assenza comincia a preoccuparmi. Hai sempre saputo che per me non sono importanti solo le mie opinioni ma il dibattito; e tu sei stato indubbiamente uno dei protagonisti di questo dibattito. Hegelianamente posso sostenere che anche tra le persone che sono più distanti sul piano dei contenuti, può esserci un legame sottile che, nonostante tutto, continua ad unirli.
Torno da un week-end termale, senza computer. Anch’io ho letto con un po’ di sorpresa la singolar tenzone degli ultimi giorni.
So, peraltro, che non c’è nulla di più cattivo del buonismo, ma a me pare che la ferocia degli ultimi scambi in questo blog sia un po’ out of place. Qui c’è un autore che (del tutto legittimamente) pensa che il suo libro sia degno di attenzione; un critico che (altrettanto legittimamente) pensa che non sia molto buono. Di mezzo, peraltro, ci sono due sensibilità estetiche molto diverse: per l’uno, i riferimenti fondamentali sono Kafka e Beckett, per l’altro Capote e King. E già questi due Pantheon, tanto difformi, lasciano intendere che è difficile raggiungere giudizi comuni.
Poi c’è il fatto che mentre qualcuno in questo blog scrive in chiaro, altri scrivono con nomi d’arte; e, mentre qualcuno mantiene una scrittura seria, altri preferiscono gli sberleffi. Sarà meglio accostumarci a queste modalità miste di dibattito, credo. Ci accompagneranno per qualche decina d’anni (poi magari si passerà ai dibattiti telepatici, e sarà un altro cambiamento radicale).
Per quanto riguarda le accuse più feroci, certo la rete che registra tutto in diretta, non aiuta a moderare gli scortri. Ma, sapendo ciò, magari poi è più facile fare macchina indietro.
Mi dispiace essere stato troppo buono — cosa che non sta bene, mi rendo conto. Prometto però di essere più cattivo in futuro. Anzi, comincio subito: Elio, mi sa proprio che quest’anno, com’è giusto, l’Inter vince la Mitropa Cup.
preciso a de caro, che sembra non capire (già con stravinski):
guarda che io non ho messo kafka vs capote, ho detto solo che kafka&co appartengono al novecento e che adesso siamo su altre sponde, chiamale post-novecento, post-moderno, post-euroguardie, di cui king&co forse sono le prime espressioni come la pop-art lo è stata in altro campo, senza
manifestare personali predilezioni , a parte shakespeare, céline e carlo porta
Ben arrivato a Tuttobuono, e un saluto eteronimo anche al Massey. Stavolta però forse l’equivoco non c’è, come invece c’era stato per Igor.
Tu pensi, se non sbaglio, che King & Co. segnino un cambio paradidgmatico — il che non vuol dire che ti attribuisca l’idea che tutti gli altri paradigmi siano tutta robaccia, of course. Anzi sulla tua triade “classic” sono perfettamente d’accordo (anche se aggiungerei anche Belli e Gadda, e non sono d’accordo con te su Leopardi).
Però — e immagino che anche su questo siamo d’accordo — non è che, come se nulla fosse, oggi uno si mette a scrivere un altro Otello oppure un altro Giovannin Bongee oppure un altro sonetto belliano (come faceva, male peraltro, il Trombadori) . Se c’è un nuovo clima culturale non si può ignorare (per questo il neo-gotico ci fa un po’ schifo, anche se il gotico ci piace). Per questo i finti modigliani della clamorosa beffa di qualche anno fa, una volta scoperto che non erano di inizio Novecento non se li è filati più nessuno (giustamente).
Questo dal punto di vista metodologico. Nel merito, poi, si può naturalmente discutere se il paradigma King-DeLillo-Capote sia quello dominante e anche se sia il più importante (io ho dei dubbi, e forse anche te?). E si può anche discutere se il paradigma kafkiano sia obsoleto o no.
Anch’io, come Mario, non aspiro ad essere troppo buonista; mi sono semplicemtne limitato a registrare le due tendenze che hanno caratterizzato il dibattito fino a questo punto. Non raccolgo la provocazione calcistica di Mario, perché sono scaramantico. Certo che ho assistito in diretta a Italia-Francia ed ho visto solo un grande giocatore, Vieira, e, guarda caso, gioca nell’Inter. Ti basta, Mario? Mi sono permesso questa digressione calcistica perché in un’occasione ho parlato di mentalità sportiva. Ebbene questa per me si traduce non nel superare i mille interventi a NI, ma nell’auspicare che l’Inter possa fare più di cento punti.
A proposito, Massey, che mi dici di Paul Auster? (Per capire come delimiti il nuovo paradigma).
Sono d’accordo con Mario: calzante l’esempio su gotico e neogotico. Non si può limitare cronologicamente il “godimento” dei prodotti artistici, di qualcunque natura.
delizioso
un’altra che capisce romax
Per Ludovica, sì, però la questione è complessa. Mettiamo che ci troviamo di fronte un formidabile inedito, che so, di Cervantes. O di Gogol. E ce ne pasciamo. Poi scopriamo che è un aprocrifo contemporaneo (a noi). Non ce ne pasciamo più. Perché? L’oggetto fisico sempre quello è.
Il punto è che non ci parla più di un’epoca di cui pensavamo ci parlasse; non ci dà più il senso di una forma di vita altra dalla nostra.
Per questo tutto il dibattito di questi giorni (a parte il corpo-corpo finale) mi pare centrato — anche rispetto a Delfi. Si tratta di stabilire le coordinate della letteratura odierna,per usarle da metro di paragone. Secondo alcuni un filone, chiamiamolo “kafiano” non pare obsoleto, ad altri sì. (Forse non interpreto correttamente Massi-tuttobuono qui, ma il punto teorico resta comunque). Su ciò c’è da discutere.
Poi naturalmente c’è il caso di chi prova a seguire il paradigma in voga, e non ci riesce. Ma questo è un caso più banale di insuccesso artistico. Mi pare molto più interessante il caso dell’anacronismo, dell’attardamento. Ma per discutere di quale sia la Stimmung che permetta di valutare questo punto è giusto tentare, come pure (naturalmente tutti in modo personale) hanno tentato molti di noi in questa sede.
Detto ciò, tra poco parto per gli States e ci resto fino a inizio settimana prossima. Vado, appunto, in Indiana e dà lì seguirò, spero, NI. Spero che la discussione continui fruttuosa.
Tutto ciò che è stato detto qui mi pare legittimo, e tutto opinabile. Meno una cosa. Elio, c’è un solo modo perché l’Inter faccia cento punti. Assumete Moggi, su quel piano siete ancora deboli (anche se già vi date da fare, giusto?).
Ma, tra poco, il rigore per battere il record di Cioran chi lo tira?
Sgt., ci pensi tu?
Grazie Mario per avermelo detto, non immaginavo proprio che la questione fosse complessa. Pensavo fosse una cavolata così tanto per fare conversazione on line.
Ironica, la Ludovica. Solo che se dici che “non si può limitare cronologicamente il “godimento” dei prodotti artistici, di qualcunque natura”, questo in parte è vero, in parte è falso.
Pensa a Ossian. Chi se lo fila oggi? A un certo punto se ne godé, poi non si smise di goderne. E, anzi, le cose sono più complesse. Il canone estetico è cambiato moltissimo in tempi recenti. Ma ancora di più in passato: se si legge la Critica del Giudizio di Kant si vede che gli esempi che fa di grande arte ci fanno ridere (comprese le poesie che riporta). Hume diceva che l’unico vero critico è il tempo. I critici umani possono solo cercare di indovinare cosa il tempo farà. E ciò prova che ciò di cui godiamo oggi, forse domani non se lo filerà più nessuno.
P.S. Sgt., mi preoccupi. Lascia stare la bistecca e vieni in postazione, che c’è da tirare il rigore…
la fascetta “il nuovo kafka” è stonata (mi comporto) non perchè ci sia sproporzione fra-e-fra o perchè sia un volgare commercial, ma perchè rivela una totale backwardness di prospettiva e una totale assenza di consapevolezza del nunc.
E’ come se a me che faccio computer art mi dicessero, per farmi un complimento, che sono il nuovo rembrandt
Mass, in effetti lasciamo stare le fascette. Però ci hai messo curiosità sulla tua computer art. Non se ne può vedere un esempio, naturalmente anonimo o pseudonimo da qualche parte? (Così, per par condicio, le nostre robette si possono vedere in rete o nelle librerie più polverose).
leopardi:
ho detto mediocre poeta e lo confermo, ma grandissimo filosofo dell’esistenza, all’interno di un filone che con lui si apre e che procede così: Leopardi, Shopenauer, Kirkegaard, Nietzsche, Benjamin ed esclude come infiltrati Heidegger e Sartre
X ora, tenendo ruolo al mio nick:
There’s nothing you can do that can’t be done.
Nothing you can sing that can’t be sung.
Nothing you can say but you can learn how to play the game.
It’s easy.
(All you need is love, the fab 4)
Di solito grosso modo sono d’accordo con te. Ma su Leopardi proprio non vedo perché dire che non è un gran poeta. Prendiamo la Ginestra? Come potrebbe essere importante più per una filosofia dell’esistenza che dal punto di vista poetico? Anzi, la mia domanda è mal posta. Che senso ha sconnettere le due cose?
Che gli manca a questi versi:
Ma più saggia, ma tanto /Meno inferma dell’uom, quanto le frali/Tue stirpi non credesti/O dal fato o da te fatte immortali.
In realtà immagino che il tuo sia soprattutto un problema di obsolescenza linguistica. Il che riporta il discorso a quanto si diceva pochi messaggi or sono. Se è così, vedo il tuo punto (anche se obietterei che Leopardi il linguaggio arcaico lo reinventa).
Leopardi come pensatore del nulla, dell’opacità e dell’inconsistenza della reltà imprigionata nell’eterna gabbia del nascere e del morire, va ben oltre, per esempio, della filosofia di Schopenhauer e a anticipa anche il nichilismo di Nietzsche e apre la strada all’intera filosofia del nostro tempo. Ma Leopardi è grandissimo, il più grande, anche nella poesia. in quanto rappresenta l’ultima illusione di salvezza offerta agli uomini, oltre il fallace ottimismo alimentato dal paradiso della scienza moderna e della tecnica. La sua grandezza filosofica, inoltre, è stata ignorata, ma è inevitabile che egli abbia a diventare il pensatore che alla fine dell’età della tecnica smaschera il culmine della felicità e vede in esso il culmine dell’angoscia.
Lucio, benissimo. Solo che tu hai parlato del senso della poesia, del significato della sua filosofia: e siamo tutti d’accordo che sia enormemente importante. C’è un dissidio cursorio, invece, sulla sua grandezza di versificatore. A me “che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude” sembra poeticamente geniale; a Mass, immagino, sembra invece ostentatmente obsoleto.
Altri pareri?
By the way, foneticamente Lucio Deco somiglia oltremodo a Ludovica.
Che siano cugini?
Mi dispiace ma non c’è proprio alcuna parentela. Capisco che se una non afferra la mostruosa importanza delle questioni è probabile che non capisca nemmeno quale sia la questione….
Dopo molto gioco a centrocampo, nel quale si sono distinti i due gemelli del gol, Matassi e Massinissa, con frequenti incursioni dei terzini d’attacco Ludovica e De Caro e interdizioni molto dure di Dall’Orco e Jolanda, allo scadere del tempo regolamentare Sgt. Pepper insaccava con una gran zuccata la rete dell’incolpevole Cioran! La squadra di Delfi vince così la Coppa del Bloggo tra il delirio della folla.
bellissima, d’accordo, sarà il pregiudizio antico verso quel “pentirommi e volgerommi”
si sono aperte di nuovo le cateratte
Sì, oggi “pentirommi” suona proprio buffo. Ma ai tempi di Giacomo era consueto: quando uno legge i suoi contemporanei — che usavano lo stesso lessico — nota sia che quello era l’idioma del tempo sia, soprattutto, che messo in mani letterariamente meno sapienti, il risultato, quello sì, oggi fa oggettivamente sbellicare (penso che so, a Bechet o a Aleardi, ma persino al Carducci trombone, che la mia maestra mi faceva memorizzare a colpi di randello). For example:
“E la Vergine ecco appar,
Luminoso il volto e mesta,
Quale in mezzo alla tempesta
Una stella sovra il mar.
E commossa di pietà,
Di que’ popoli a ristoro
Apre lor le porte d’oro
Dell’ardente carità.”
Insomma, chiedo alla corte clemenza per il povero Jacques , in nome della carità ermeneutica.
lucio deco, per esempio, è un apprendista del copia-incolla, che senso avrebbe dire di lui che è il nuovo Mimmo Rotella
massey, non ricominciare a cantare il demi-demi
IN MANICOMIO
IL PAZZO: “Leopardi: ho detto mediocre poeta e lo confermo!”
IL MEDICO:”Ehm, certo, certo. Di solito grosso modo sono d’accordo con te. Ma su Leopardi proprio non vedo perché dire che non è un gran poeta.”
demi-demi
mario, questa è per te, da parte dell’ape
l’ape non ha capito che qui è tutto un dissidio cursorio ( da to curse, of course)
IL MEDICO:”Ehm, certo, certo. Di solito grosso modo sono d’accordo con te. Ma su Leopardi proprio non vedo perché dire che non è un gran poeta.”
E Dell’Orco un grande scrittore.
(E molto autoironico, soprattutto).
questa è del bumble-bee (J.C.)
under the bam
under the boo
unde the bamboo-tree
mivantumivant’eubellusceccuchisugnueu!
ccuveniarrericuntaiperati!
è il problerma dell’empatia, se tu mi dici che è un falso cervantes crolla il mio abbandono alla fascinazione che mi possedeva fino a quel momento.
Questo è un processo che vivono spesso le donne quando si innamorano
di un uomo per la sua fama (anche piccola, di ufficio, di gang rionale).
D’un tratto quell’uomo che prima era un dio diventa una nullità.
centumigghiaarrassu!
mi vanto, mi vanto di essere quella bella asina che sono!
chi viene dietro conta i passi tuoi (?)
chi viene dopo di te è un vigliacco o una spia (mah)
centomila cancri a te (?): deve essere un incantesimo, una fattura
Egr.Prof.Matassi,nell’intervento di ieri notte lei dice”un intellettuale deve saper intervenire nella formazione dell’opinione pubblica.”
Sono perfettamente in linea con la sua affermazione. Mi sarei dunque aspettata una sua fortissima tirata do’orecchie a chi ,in questo blog,che suppongo sia seguito da moltissime persone,si è permesso,senza alcun nesso,di offendere una categoria meno fortunata con epiteti degni della più bieca inciviltà. Desidero comunque darle una scusante: forse al suo ritorno dai covegni cui ha partecipato, vista la disputa in atto,avrà fatto una lettura un po’ affrettata,saltando il punto da me sottolineato.
Proprio perchè questo è un blog di letteratura,credo che una lezione di civiltà avrebbe avuto il suo significato prima di continuare il dibattito letterario. Perdoni la mia franchezza ma per me i diritti umani vengono al di sopra di tutto.Sempre con viva cordialità
jolanda
mario, forse hai ragione tu su leopardi, è un problema di linguaggio,
però insomma se l’è cercato lui, il linguaggio letterario del suo tempo poteva essere diverso, non penso a porta o al belli ma a questi versi,
che ti cito a memoria e che sono per me la più bella definizione di poesia
che io conosca:
…e quando /il tempo con le sue fredde ali vi spazza/ fin le rovine, le Pimplee fan lieti di lor canto i deserti…
a proposito, chi cazzo sono le Pimplee?
Elio, questa signora dei diritti umani, non sa più cosa dicere, mi ha fatto una fattura!
…e l’armonia vince di mille secoli il silenzio
IN TRATTORIA
NANDO – A Ma’, bbono ‘sto Frascati docche, quasi quasi me ne faccio n’antro litro.
MARIO – Ma nun è Frascati docche, è er vino della casa.
NANDO – Sti cazzi? E’ bbono e a me me piace.
MARIO- Ma nun cià più l’empatia: nun senti che te crolla er tuo abbandono alla fascinazione che te possedeva fino a un momento fa?
NANDO – Ma vaffanculo te e l’empatia: er vino è bbono perché lo sento bbono; e allora nun fa er cazzaro, arzete e portamene n’antro litro.
Scusate, avete visto passare un canguro?
cominci a diventarmi simpatico
Leopardi, Keats, Heine, Hölderlin, Shelley, Byron, bene bene bene:
sentiamo la Bertuccia: con che cosa l’accompagneresti un sentimento di disgusto, questa sera, prima di addormentarti, dovendo scegliere in questo
scaffale? O uno di pena cosmica? O uno di esaltazione? O uno di scoramento? O uno di felicità? O uno di frenesia?
dimmi quando ordineresti un Leopardi millesimato?
Caro Sandro,
magari l’avrai fatto per pura celia, però il tuo ultimo intervento coglie un punto filosofico molto discusso (tra i filosofi, anglosassoni di solito, non tra i letterati). Al di là dell’ironia, che comunque non era male, tu punti verso un’intuizione: che un oggetto (che sia vino, sia un libro o sia un quadro) è quell’oggetto con tutte le sue proprietà. E dunque, dice questa intuizione, la sua storia causale non può fare nulla per cambiarne il valore. E’ vero: abbiamo questa intuizione. Ma abbiamo anche l’altra, alla quale accennavo prima (e che credo esemplifichi il punto di vista di Massinissa), secondo la quale un oggetto d’arte conta ANCHE per la sua storia. Per questo di Ossian, o delle statue dello pseudo-Modigliani non si è parlato più quando si è scoperti che erano falsamente antichi.
Abbiamo tutte e due le intuizioni, e dobbiamo trovare un equilibrio riflessivo tra di loro.
Per questo, UNO dei modi di giudicare della bontà di un’opera d’arte è vedere se sta nel suo tempo (questo è in base alla seconda intuizione metaestetica; in base all’altra, l’opera d’arte ha valore astorico).
Ho comprato il tuo libro e lo leggerò al ritorno da un breve viaggio americano. Professionalmente il tema determinismo/libertà mi interessa molto, e come ho avuto modo di dire, anche se il punto di vista di Massinissa mi pare corretto (c’è un paradigma post-novecentesco, che deriva dalla Pop-art), penso anche che oggi esistano anche altri paradigmi estetici: uno per esempio, che viene da Borges ed è filosofeggiante. Forse non sbaglio se dico che il tuo libro a quel paradigma fa riferimento. Dunque lo leggerò in quella chiave. So che a molti è piaciuto, ad altri meno, ma questo vale sempre, naturalmente.
In queste settimane ho discusso di questi temi perché mi interessano sinceramente. Ciò detto, mi dispiace che il dibattito abbia preso una piega troppo aspra — e secondo me non necessaria. Io faccio stop.
Grazie a tutti, comunque.
noi vediamo, leggiamo, ascoltiamo, gustiamo, tocchiamo con gli organi giusti ma è la mente che elabora i dati. La mente di ciascuno ha la sua ricchezza o povertà di esperienze/cultura e quindi ciascuno vede ecc solo quello che può vedere essendo lui. Non esiste, mi permetto, l’intuizione assoluta, se non come pregiudizio di cui si pagherà il lusso irrazionale prima o poi.
Dell’Orco, quando facevi sul serio non ci beccavi; ora che facevi per scherzo, hai detto una cosa giusta.
Scherza un po’ di più, Sandro, dà retta a chi vede lontano…
ma ti sei mai soffermato sulla vendita di quadri in telemarket?
riescono a vendere fondi di magazzino altrimenti invendibili giocando sull’empatia che un certo nome fa scattare. Quel quadro sarebbe altrimenti invendibile sul mercato dei collezionisti informati.
Perchè il periodo è démodé, perchè è l’ultima maniera insignificante ecc.
E invece queste televendite vendono che è un piacere, qualche volta anche dei falsi, a loro insaputa, ma in generale vendono il pezzo originale.
Peccato che vendono l’aura, non l’opera in sè che è fuori mercato, respinta dal collezionismo preparato. E gli argomenti degli imbonitori sono quelli che fanno presa sui nullatenenti in materia: il nome famoso, la pubblicazione, le notizie che bastano a buon intenditor ecc
E come fa a rispondere la Bertuccia se non ha voce umana?se poi la bertuccia potesse parlare,non parlerebbe certo con lo strutocamelus.
Se poi lo strutocamelus,alzando finalmente il suo capo spelacchiato dalla sabbia,chiedesse sinceramente scusa alle categorie di cui sopra,forse la Bertuccia potrebbe farti l’onore di qualche domanda.Intanto la Bertuccia può dire solo questo: ……’na ‘ota ‘ncera cu ‘ncera,’ncera nu surici ‘nta lumera,u jattu ju mu pigghia e si rrinchiu u mussu i canigghia.
Massa, ti sto facendo una domanda seria. La prima in ‘sto blog. Sai che sono ignorante in materia e quindi non essere sarcastico perché ho già pronta una pagina di contromisure.
Che differenza ci trovi tra il nullatenente in materia, che compra il quadro da tele55, e il collezionista preparato che acquista da Sotheby quando entrambi nella loro anima provano lo stesso trasporto?
tu non sei la bertuccia, tu sei una maga maggiorata e bonazza, almeno così hai detto
il mondo dell’editoria è uguale, c’ha i suoi remainders e mercatini dell’usato, che anche a vendere un libro/1 Euro vanno in utile perchè o i costi sono stati già coperti dal venduto o i costi dell’invenduto sono stati già assorbiti dal bilancio.
Io non sono la bertuccia e nemmeno le altre cose in elenco.
Ma tu non hai ancora chiesto scusa,come faccio a parlarti?
Non ti parlerò.Poca o niente perdita per te,ovviamente.
Facimmola ‘sta pace, Massinisso! Chiediamogli scusa a Jolanda, e finimmola a tarallucci e vino, che ‘sto blog alla frutta è arrivato…
e veniamo alle major/ minor:
L’unica differenza è che le major hanno un break-even point più alto, cioè devono vendere più copie per libro pubblicato delle minor per raggiungere il pareggio. E il break si applica per singolo libro, non sul bilancio globale e magari consolidato. Il comportamento di una major è uguale uguale a quello delle minor, che anch’esse valutano il break-even per libro.
Ora se il break di una minor come la Hacca, metti, è di 1000 copie, ma credo meno, il break di una major può essere di 5000 copie, ma credo meno. Tu capisci che per una major pubblicare un dell’orco rappresenta un alto rischio, anzi una certezza di non raggiungere il pareggio.
Mentre per una Hacca può essere ok, ecco perchè sei con la Hacca che ti ha comunque dato la chance nella speranza, più o meno razionale, che almeno 1000 copie si dovrebbero vendere. (Io ti auguro 1million).
Se ne vendessi di più e il tuo nome come autore di delfi diventasse stellare tu saresti corteggiato da tutte le major internazionali.
Gattuso, Totti, Del Piero pubblicano con le major perchè i loro pseudolibri si calcola che venderanno >5000copie.
As simple as that
Il problema sono i lettori, io cmq sono conquistato e comprerò il tuo libro.
Mi sai dire a MIlano dove posso trovarlo, non ce l’hanno tutti i migliori librai, sorry
Mo’ mi ci scappa la lacrimuccia.
Sandro, ora tocca a te: riconosci che Massi’ è nu’ bravo quaglione, magari un po’ discolo (c’ha messo novecento messaggi a dire che si comprava ‘sto libro). Tu, Massi, confessa a Jolanda che manco ti ricordi perché si è offesa e comunque ti dispiace.
E tu Elio celebra la fine della funzione.
Così il blog si può rititolare: Musica a Delfi con redenzione.
Niente, manco m’ha sentito. Nebbia sulla manica; il continente è isolato.
E l’ultimo chiuda la porta. (Patsy, da Nick Carter)
A certo, Massy, da’ pure ‘na rispostina al povero Sgt. Patsy. Su, che è quasi Natale e tutti siamo più buoni…
No, Pepper, il collezionista non prova lo stesso “trasporto” di un “borghese”, è tutto un’altro feeling.
Il collezionista è un amatore, innamorato di un periodo, di certi autori e di questi di un certa stagione. Puoi immaginarlo da te come si muove se hai fatto il collezionista di francobolli, o di monete o di prime edizioni ecc.
a me questa jolanda fa cadere le braccia, dimostra quello che per 900 commenti ho voluto dimostrare
mmh, it makes sense. thanks.
Da “Alternanze “:
…….dove le mani
come le tue ora
si perdono nel vuoto
ciondoloni.
Dong! Siamo a 800 commenti.
Da “Lettera a due madri” città del sole edizioni
…..due madri Gilda, due nella mia vita,
una di sangue che mi diede amore,
l’altra di poesia e di parole.
Dong! Attenzione che si finisce come il blog di diamonds……….
buona notte a tutti
fem
8O4
Caro Sandro,non so quando leggerai queste righe ma le scrivo ugualmente. Questa notte sto pensando a mio padre e al fatto che se avesse avuto la fortuna di continuare gli studi,forse sarebbe diventato un grande poeta.Ma erano anni difficili per la povera gente; era necessario lavorare,la famiglia numerosa non consentiva sprechi e al massimo si completava la terza o la quarta classe elementare.
Ma che poeta sarebbe stato,lui che amava leggere ,lui che credeva in quei valori che man mano si andavano assottigliando mentre la febbre del denaro e quindi del potere continuava a salire. Forse come “Pablo”, non so, ma certo un grande poeta. Sandro mi chiedo:ma cos’è cambiato da allora? noi siamo andati a scuola e pure i nostri figli,ma cosa è cambiato? forse la possibilità di scriverti questi miei pensieri attraverso le pagine di un blog,ma per il resto? mi sembra di vivere in una restaurata (e male) torre di Babele dove nessuno fa uno sforzo per meglio comprendere la lingua altrui. E’ questa la civiltà tanto decantata? mio padre aveva 84 anni quando ,silenziosamente , è andato via con il suo sogno di una società più giusta. E ora dimmi,Sandro,cos’è cambiato se il sogno di mio padre non si è mai avverato,se la gente continua nel suo folle declino?
Buon giorno Sandro,
serena giornata
jolanda
Da ” Inesauribile desiderio ”
di Enzo Aprea Tullio Pironti Editore
Per uccidere il tiranno
Lasciatemi un varco
per uccidere il tiranno
sarò pelle
per le vostre bandiere.
Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing
Pensi di essere spiritoso? tornatene nel nulla da cui provieni.
Vade retro!
hai visto il mio canguro?
dessine-moi un mouton…
Caro Mario,
ti prego di tornare sulle tue decisioni, perché la tua intelligenza, la tua ironia ed autoironia sono indispensabili alla prosecuzione del blog. Senza la tua verve, sicuramente, la discussione, pur continuando, non potrebbe essere la stessa.
Allo stesso modo, sarei dispiaciuto dell’assenza di Massinissa, che vedo con piacere essere tornato da protagonista nel dibattito. Apprezzo anche che abbia deciso di comprare il libro di Sandro.
Ho notato anche che al nostro dibattito sono intervenuti oracoli, canguri ed altre entità; ma io sono molto favorevole al pluralismo ontologico.
Qualche chiarimento su Leopardi. Diciamo così. In ogni discussione, che si parli di un paio di scarpe, del sorgere del sole, dell’accendere una lampadina, del camminare, del chiudere una finestra, ecc. sarebbe auspicabile che si definisse dapprima di cosa si stia parlando. Anche il discutere della poesia, dell’arte e via dicendo, se non le si reputa di rango inferiore alle azioni precedentemente elencate, a mio avviso si dovrebbe portare quanto meno verso di esse una pari possibilità di rispetto. Ammesso quindi che l’arte e la poesia godano di pari dignità del camminare, del chiudere una finestra, io credo che dovremmo definire di cosa parliamo quando parliamo delle poesia di Leopardi. E così cerco di rispondere in una volta a tutti quelli che sono intervenuti dopo le mie osservazioni precedenti. Quindi, se parliamo di poesia come un qualcosa che dice qualcosa, essa, da questo punto di vista, rientra nel catalogabile ed interpretabile attraverso ciò che apparentemente lo nega. Il pensiero. E aggiungo che se entrassimo nel campo del dire e stabilissimo ciò di cui stiamo parlando, ci lasceremmo alle spalle di conseguenza anche il mero opinare. Perché dico questo? Perché se la poesia di Leopardi è un dire qualcosa, Leoaprdi è il poeta che non solo non è mai ancora esistito, ma è un poeta che proprio per questo deve ancora avvenire. Non si tratta di opinare o di fare mere dossografie. E se l’impostazione è condivisa (è di questo che si sta parlando), Leopardi non solo dice, ma è capace anche di dire l’indicibile. Il nulla. Da sempre e per sempre quindi si è svincolato dal rischio di non dire nulla. Ora, se questo signica che sia stato un grande poeta, non è un compito che mi compete. Credo che un’eventuale risposta sia talmente esplicita da far emergere in tutti gli ascoltatori di Leopardi la risposta che dice qualcosa solo a chi la “logica del cuore” di Pascal, Leibiniz, Rilke riesce a dire qualcosa (e scusatemi l’ultima citazione).
Come per macia prometto di liberarmi in 5 minuti.
Alla mi a destra assistente ladrone, come potere vedere lecato e immobile per non potere intervenire in mio aiuto. Alla mia sinistra ladrone numero due , stesso legato come altro, per non interferire in numero macico.
Mio amico Barabba, per chi avere perso numero precedente, è stato liberato dalla macia di soldato mascherato ponzio pilato, che con la sola lavaggio di mano ha sciolto catene. tutto popolo felice ha detto: ” ora tu maco, come cazzo fai?”
Io risposto: io figlio di personaggio molto influente e di madre vergine o saggitario non ricorda.
Pronti per numero di grande magio medioorientale:
Io con l’aiuto di soldatini di piombo prendo legno grande e tre chiodi grandi poi mi siede su legno grande e mio amico dei parioli prende grande martello e ficca in mano destra chioto, in mano sinistra altro chioto su due piedi chioto.
Io non dice nemmeno parole brutte contro uomo influente né contro madre saggittario o ariete non ricordo.
Io dire ad alta voce, per tutto mio pubblico che 5 minuti io libero.
Grande macia!!
Formuka macica inizia, non ricordo, come per ELOY ELOY o cosa simile, mia linguia molto difficile si dice di bambino che scrive male nonstante grandi studi su grandi libri tipo TOrah o cosa simile non ricordo.
Grande macia:
Uno, due, tre, cazz…..sbagliato formula, cielo tutto nero, tempio amici riccioletti tutto distrutto, allora io pensa: sbagliato davvero formula, io chiete soltato che ha successo ,lui incazzato nero, prende grande bastoncino per spiedino e buca me pancia io dice anche così più difficile io libero.
Grande macia!!!!!
Io MORTO!
MA…..siori e sioere dopo tre giorni io come nuovo , spostato grande pietra, lasciato mutante e andato a CUBAAAAAA!!!!!!
E siori e siore
Grande Macia!!!!!
Tu avere tempo , io racconto anche macie piccole macie…..domani!
# la redazione di HACCA Says:
September 12th, 2007 at 16:47
E’ stato interrotto qui in Nazione Indiana il dibattito attorno a ”Delfi”, il nuovo romanzo di Sandro Dell’Orco, e alla recensione firmata da Elio Matassi “Musica a Delfi senza redenzione”.
Vorremmo tuttavia invitare tutti coloro che desiderano continuare la discussione nel sito
http://www.hacca.it
dove è possibile per chiunque inserire dei commenti.
Grazie per l’ospitalità e l’interesse. Vi aspettiamo!
# Véronique
https://www.nazioneindiana.com/2007/09/01/bacheca-di-settembre-2007/#comment-77781
e ancora:
da Sandro Dell’Orco i 13 set (1 giorno fa)
a nazioneindiana@gmail.com
data 13-set-2007 8.47
oggetto Ringraziamenti
Alla Redazione di NI
Gentilissimi,
desidero ringraziarvi moltissimo per l’ospitalità concessa al thread “Musica a Delfi senza redenzione”. Il fatto che sia potuto durare due mesi e mezzo – cosa mai vista in un blog letterario – esprime meglio di ogni possibile elogio il vostro rispetto e la vostra sensibilità per l’autentico e stimolante dibattito culturale, nonché la vostra vocazione alla formazione letteraria attraverso il confronto libero ed aperto delle opinioni più diverse.
Non avrei mai immaginato che il mio romanzo “Delfi” suscitasse tante discussioni. Giudico la cosa positivamente: per lo meno non è un libro morto. La discussione prosegue come sapete su http://www.hacca.it .
Grazie ancora di cuore a voi tutti.
Sandro Dell’Orco
Se credete, potete dare visibilità a questi ringraziamenti pubblicandoli in Bacheca o dove ritenete più opportuno.