➨ AzioneAtzeni – Discanto Undicesimo: Gianni Usai (lettura di Giovanni Carroni)
lettura di Giovanni Carroni
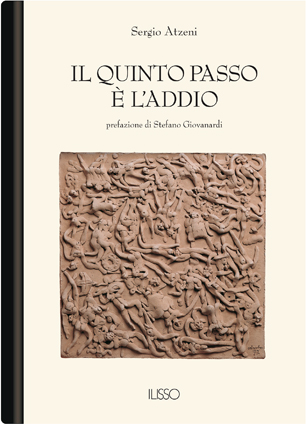
Discanto Undicesimo*
Catturato dal nero attorno, dal profumo dell’acqua e dal silenzio, Ruggero Gunale si perde, la memoria lo acceca come sogno a occhi aperti. A bocca chiusa intaglia il tessuto unto e grosso del ricordo.
da Il quinto passo è l’addio di Sergio Atzeni
Come nasce un romanzo
di
Gianni Usai
Che ci vuole a raccontare il mondo? Un’anima un pensiero, un pensiero una faccia, una faccia una foto.
La fa semplice Corrado, che è solo un’idea incompiuta, una possibilità in divenire, e ancora una faccia non ce l’ha ma parla già tanto. Per lui è questione di luce e del momento giusto, deve solo portarsi appresso la sua Leica e il cinquanta millimetri. Invece l’uomo, l’uomo il cui nome qui non ha alcuna rilevanza, sa che il travaglio è tutto da questa parte dell’obiettivo – o della pagina, nel suo caso. Perché la differenza la fanno gli accidenti che ti hanno portato a quella luce e a quel momento. La vita balla la rumba sotto i tuoi piedi, mentre tu, un passo giusto e due passi in fallo, provi a capirci qualcosa e tutto ciò che non sei riuscito a capire lo affidi a una storia. Ché se non ne sei venuto a capo tu, magari qualcun altro… Dev’essere per forza qualcun altro. Quelli che la storia la sanno raccontare sono sempre inadeguati, persino quando sono immaginari come Corrado. Il più inadeguato di tutti, un relitto, anche se porterà in giro la sua faccia di cazzo come un trofeo, quando ne avrà una o tutte quelle che vorranno dargli, e pare che nessuno lo possa fregare. Ma Corrado e il nostro uomo ci sono nati, fregati, sconfitti, e hanno dovuto imparare presto a fingere di saperci convivere con la fregatura e con la sconfitta. Pure questa è un’arte, che tu sia uno scrittore o uno dei suoi personaggi che scalpita per essere raccontato e letto, per esistere nel tempo effimero ed eterno in cui due occhi si posano sulla parola e le danno voce e consistenza. Il banconiere del Caffè delle fate ogni tanto gli rivolge uno sguardo che l’uomo non riesce a decifrare. Lo si direbbe uno sguardo neutro, privo di qualunque sentimento, eppure mosso da una peculiare forma di curiosità, la stessa che un chirurgo rivolgerebbe all’area in cui sta per praticare l’incisione, come se ciò che davvero gli interessa fosse al di là di quell’ostacolo che tuttavia non può essere ignorato. Poi gli occhi del ragazzo, avrà vent’anni, si perdono nella penombra del bastione terrazzato, oltre i tavolini quasi deserti e più in là, nella notte ambrata della città, reale fin dove osa l’immaginazione. La città indolente e restia a prendere sonno. Sarà l’aria tiepida di settembre, sarà che Villa Nova asseconda i pruriti con le tende tirate per non dare nell’occhio.
«Lo vede quel tizio?»
L’uomo si volta a seguire il cenno del ragazzo, un movimento della testa che proietta una parabola invisibile dal suo mento imberbe agli occhi del cliente seduto nel primo tavolo a destra, a cavallo del confine in cui le luci del caffè scemano nell’oscurità imperfetta. E quel confine, o forse la notte stessa, pare un’emanazione della sua inquietudine.
«Dicono che si chiami Ruggero, ma non ho mai sentito nessuno pronunciare il suo nome. Sono trent’anni che ogni sera viene qui, mi chiede se ho visto una certa Monica e si siede a quel tavolo ad aspettarla. Non parla con nessuno, beve vino rosso fino alla chiusura, paga e mi lascia una mancia troppo generosa per uno che ha l’aria di essere arrivato al fondo. Monica non è venuta, dice, domani partirò e non farò più ritorno.»
«E perché lo stai raccontando a me?»
«Non le sembra strano?»
«Cosa?»
«Non lo so, però c’è qualcosa di strano. Magari lei che beve Calvados in un bar all’aperto di Villa Nova. Il fatto che la sua faccia mi sia familiare, in un modo incomprensibile, come se questa familiarità fosse l’effetto di un evento accaduto in un tempo che deve ancora arrivare. Era già stato qui?»
«Una notte di tanti anni fa, credo, la notte in cui ho incontrato un caro amico. Forse non proprio un amico, ma non saprei in quale altro modo chiamarlo. Come lo chiami qualcuno che conosci quanto te stesso e del quale non sai ancora niente? Lavorava al tuo posto e aveva la tua età.»
«Mi somigliava?»
«Ancora non l’ho deciso. Ma potresti essere tu, se domani uno scherzo del destino cambiasse il corso della tua vita e facesse di te un famoso fotografo.»
«Non so niente di fotografia.»
«Allora potresti davvero essere tu.»
L’uomo guarda il cliente in disparte, jeans e camicia appesi al corpo magro, macilento, il volto sfatto, i capelli incolti e abbandonati a un canto d’amore e disperazione, gli occhi fissi nel buio iniziato molte solitudini fa, ben prima che la notte arrivasse. Una sagoma sinuosa ne incrocia la traiettoria ancheggiando al ritmo di tacchi maliziosi, e lo sguardo del tizio si accende di un bagliore ultraterreno e allo stesso tempo carnale. Monica! Dura poco, niente. La suggestione si fa donna per il tempo di attraversare uno spicchio di luce, poi torna attesa delusa, sollievo o tormento destinati ad altri. Il tizio vuota la bottiglia nel bicchiere e manda giù il primo degli ultimi sorsi che lo porteranno all’addio. La sua storia è stata già raccontata, pensa l’uomo.
Il barista passa in rassegna i tavoli vuoti, tutti meno uno, e versa un altro Calvados.
«L’ultimo giro lo offre la casa, e Monica non si è vista nemmeno stasera.»
Non avrà vent’anni. All’uomo riporta alla mente fantasie contorte e pervicaci mal di pancia che si fanno parole; sogni e incubi dimenticati o mai ricordati che riaffiorano tra le righe e si propagano in vite aliene, da vivere per interposta persona fintanto che gli si dà forma. Ancora quel tempo sospeso in cui trent’anni sono una notte e una notte dura trent’anni, per sempre.
«Come ti chiami, ragazzo?»
«Mi chiamo Corrado.»
Che ci vuole a scrivere un romanzo? Una faccia un pensiero, un pensiero un’anima, un’anima mille storie.

* Azione Atzeni- mode d’emploi
di
Gigliola Sulis e Francesco Forlani
‘E scoprirai quello che resta di un uomo, dopo la sua morte, nella memoria e nelle parole altrui’. Sergio Atzeni, Il figlio di Bakunìn Il 6 settembre del 1995, inghiottito dal mare come l’amato Fleba il Fenicio, Sergio Atzeni perdeva la vita nelle acque dell’isola di Carloforte. Sardo, appena quarantenne, era stato militante comunista, anarchico leader studentesco, impiegato insoddisfatto, sindacalista, pubblicista. Dopo la fuga dall’isola, tra l’Emilia e Torino, divenne correttore di bozze, lettore di manoscritti per case editrici, sontuoso traduttore – un testo su tutti: Texaco di Patrick Chamoiseau. Per tutta la vita fu intellettuale rigoroso, poeta e scrittore immaginifico, autore di romanzi-mondo come Apologo del giudice bandito, Il figlio di Bakunìn, Il quinto passo è l’addio, Passavamo sulla terra leggeri, e di una cascata di racconti tra cui Il demonio è cane bianco, I sogni della città bianca, e Bellas mariposas. Come nel Figlio di Bakunìn, pensando oggi a Sergio, ci chiediamo: che cosa resta di uno scrittore, dopo la sua morte, nella memoria e nelle parole altrui? Per rispondere a questa domanda, abbiamo invitato degli autori legati all’opera di Atzeni a dare nuova vita ai personaggi o ai luoghi o alle atmosfere della sua opera. Interpretando, riscrivendo, stravolgendo creativamente, in totale libertà. Un coro di voci diverse per una raccolta di racconti brevi, una rifrazione e moltiplicazione di frammenti post-atzeniani. Assolutamente vietata l’agiografia, e ‘massima penalità per chi si prende troppo sul serio’, come scriveva Sergio in uno dei suoi ultimi articoli per “L’ Unione Sarda”. Nasce così il gioco del discanto*, da intendere sia come far decantare delle buone pagine in nuove storie sia come costruzione di voci in forma di polifonia medievale. * Francesco Forlani ‘Nella Sardegna magica in cerca di Sergio Atzeni, “Reportage”, n.10, 2012, ripreso nel 2017 da Minima Moralia Gigliola Sulis, ‘Chi era Sergio Atzeni?’, “Le parole e le cose”, 22 novembre 2012
Si può seguire il PODCAST su:
⇨ Youtube
⇨ SPOTIFY

