La notte non esiste di Angelo Petrella
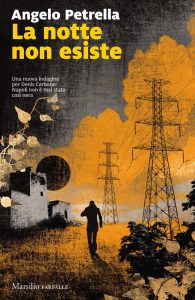
di Guido Caserza
Il ritmo giambico, ossessivo del periodare breve, impiegato per rafforzare l’icasticità delle scene, amplifica anche le iperboli del fittissimo intreccio di La notte non esiste (ed. Marsilio), seconda puntata della quadrilogia di Angelo Petrella che ha come protagonista l’ispettore Denis Carbone. Lo ritroviamo quattro mesi dopo la vicenda raccontata nel romanzo precedente (Fragile è la notte), alle prese con un crimine che incarna le peggiori turpitudini umane, fra bambini seviziati, brutalizzati e orrendamente uccisi e, dietro di loro, a incombere come una maschera del fato, gli oscuri intrighi di una setta segreta che ha ramificazioni nelle istituzioni e negli stessi apparati giudiziari, perché il crimine e la colpa, almeno da Ellroy in poi, non sono discriminabili per compartimenti e la giustizia coabita con il reato; ne è, anzi, il complemento in un mondo, quello della pubblica sicurezza, dove «nessuno era pulito». Lo stesso Carbone ha nel suo passato una macchia, sebbene giustificata da un ardimentoso sentimento di giustizia personale: per svolgere le sue ricerche private sulla sparizione della sorellina Alice aveva messo su un giro di scommesse truccate che gli erano costate una sorta di esilio nel commissariato periferico di Posillipo, dove tuttora esercita la sua mansione.
Poco sopra ho usato il termine iperboli per caratterizzare l’intreccio del romanzo: Petrella, che è maestro nella costruzione di trame, questa volta sembra aver ceduto a un eccesso di autocompiacimento, disseminando l’intrigo di colpi di scena, agnizioni vere e fallaci, con il risultato che esso appare in alcuni passi un poco arzigogolato e inverosimile. Ma ci sono qualità tali, in questo romanzo, che fanno passare in secondo piano questo eccesso di autocompiacimento, di climax e anticlimax, a partire dall’evocazione istrionica della struttura dei romanzi d’appendice. È infatti proprio l’istrionismo di Petrella, retoricamente un’ironia amplificata, a far sì che si possa sorvolare su certo ingolfamento di colpi di scena (penserei, per dare l’idea, alle macchine narrative di Eugène Sue) e, un po’ benignamente, gustarli da una parte come esche per il lettore beatamente ingenuo, dall’altra come occhiolini al lettore disincantato che riconosce in essi un gioco metanarrativo con la tradizione narrativa popolare.
L’altra qualità, che è contigua a questa, è l’impiego dovizioso di tutti gli stereotipi del genere poliziesco: il fissismo psicologico e comportamentale dei personaggi, con la loro descrizione sommaria risolta in brevi schizzi; l’impiego di tratti abitudinari ormai logori, con l’impiego a profusione di sigarette, litri di caffè, whisky dozzinale e antiacidi per uno stomaco corroso; il ricorso a una donna fatale che spezia e compensa quell’«odore di solitudine e morte» che pervade il romanzo e che nemmeno le sigarette fumate a nastro possono coprire.
L’impiego dei tipi e degli stilemi fissi del reportorio di genere è naturalmente una qualità solo a patto che non decadano a ruoli prefissati all’interno di un universo romanzesco chiuso: il poliziesco corre sempre di questi rischi; li corre naturalmente anche Petrella, ma con un grado di accortezza maggiore rispetto ad altri colleghi. Sebbene le personae dramatis di La notte non esiste preesistano in quanto tipi tradizionali, sebbene tutto sia subordinato all’esigenza dell’azione e a un intreccio scoppiettante, sebbene lo scrittore trascuri lo scavo psicologico (onorando anche in questo la retorica del genere), riesce però a creare un personaggio memorabile (quello dell’ispettore Denis Carbone), contraddistinto da un’evoluzione psicologica talmente definita da farne un carattere letterario a tutti gli effetti. Sul carattere di Carbone tornerò più sotto.
Un’altra qualità del romanzo, forse la sua maggiore virtù, consiste nel modo in cui all’azione viene conferita una portata simbolica: ciò non avviene tanto per il simbolo (un sole a cinque raggi, impiegato dalla setta di criminali) disseminato nell’intreccio, poiché esso ha meramente una funzione narrativa, quanto per quella grotta labirintica in cui il protagonista rischia di smarrirsi nell’epilogo. «Quel maledetto labirinto» è infatti il simbolo dello stato mentale di Carbone, la cui psiche è tutta introflessa in un passato da cui non riesce a liberarsi e che continua ad affiorare, un passato su cui grava il senso di colpa per non avere saputo proteggere la sorellina Alice, misteriosamente scomparsa venticinque anni prima e la cui vicenda tragica è forse collegata ai nuovi orrendi crimini rituali, ma anche un passato fatto di amori illusori, divenuti fantasmatici.
C’è, dunque, una profonda tessitura simbolica che costituisce l’aspetto subnarrativo del romanzo e ne fa scaturire i motivi profondi: è raro che in un poliziesco il significato dell’opera dipenda, più che dall’azione, dai suoi simboli e dalla psicologia del protagonista. Qualcuno potrebbe impiegare, per definire questo romanzo, l’etichetta di poliziesco esistenziale, ma ritengo che non sarebbe del tutto calzante, come non lo sarebbe il suo accostamento al noir mediterraneo. C’è qualcosa di più, nel romanzo di Petrella, che forse va contro le sue stesse intenzioni, ed esso va cercato nella tara malinconica del protagonista e su quel senso di fato che incombe sulle sue azioni.
Dovrebbe essere un personaggio accidioso Carbone, autonegantesi alla realtà, quasi un belacquista, sopraffatto com’è dai rimorsi e dal rimpianto, ma sappiamo che la malinconia può generare azione, e l’ossessione trasformarsi in motivazione. L’idea fissa, su cui si impunta il malinconico, può prendere la figura di un’azione coatta e l’accidia belacquista trasformarsi nel ripudio disperato di sé stessi, ovvero nell’idiosincratica costruzione di un altro sé, determinato, seppure vanamente, all’azione risolutiva.
La grammatica narrativa del romanzo è disseminata delle particelle congetturali “se” e “ma”: il topico se non avessi fatto (o il suo rovescio, se avessi fatto) è il loop psichico che tormenta la mente di Carbone: venticinque anni prima la sorellina Alice si è immersa nel mare di Napoli e non è più tornata a riva. Qualcuno l’ha portata via. Carbone era rimasto a riva. Questo è il tormento dell’ispettore, la sua idea fissa. Il se è lo stigma psichico di ogni uomo dominato da simili tormenti e pensieri ossessivi, su cui altri ne germinano fatalmente, perché il destino, nell’uomo malinonico, non è altro che tempo ripiegato su sé stesso. Tanto che anche l’indagine poliziesca diventa a un certo punto una reduplicazione del medesimo assillo psicologico, ne è, direi, l’equivalente intellettuale, come vedremo fra poco.
Parassitato da un’idea esclusiva e fissa, Carbone trasforma l’indagine in quello che gli psichiatri definiscono «delirio esclusivo», non solo perché i delitti di oggi sembrano legati alla sparizione della piccola Alice, ma perché nell’azione l’ispettore trova l’illusoria terapia del proprio male, una sorta di revulsione morale che sposta l’attenzione da una idea fissa all’altra.
Persino la morte, sempre all’orizzonte, sembra implorata come una catarsi che possa conferire un valore estetico ai fantasmi del passato, ed è una morte sempre aleggiante: «morte e solitudine» sono il corrispettivo simbolico di una psiche introflessa, dunque non sorprenderà che, per la profonda innervatura simbologica del romanzo, anche gli oggetti sfumino in una dimensione instabile e aleatoria, sottratti alla loro denotazione.
«I panini comprati al chiosco che si affacciava sull’isolotto di Nisida sapevano di cartone e fretta» dice il narrattore a commento di un fugace pranzo consumato da Carbone e da Teresa, la segretaria del commissariato. La constatazione, di primo acchito, sembrerebbe prosaica e rimandare al classico pasto da poliziotti, ma la contiguità metaforica materiale/immateriale («cartone e fretta») è indicativa dell’instabilità dei realia, ossia di quella aleatorietà esistenziale che è tipica del malinconico.
Anche il tempo dell’azione è spesso sottratto, seppure per brevi incisi narrativi, al suo divenire per lasciare spazio al tempo mentale di Carbone; un tempo che non progredisce, perché «lui riviveva lo strazio ogni notte» (lo strazio della perdita della sorellina), un tempo che si dilata nella sua immobilità persino all’interno dell’inchiesta: in un momento clou dell’indagine, dopo il ritrovamento di un primo bambino morto, mentre l’ispettore, il commissario e un tecnico visionano il filmato di una videocamera di sorveglianza, «il tempo sembrava dilatarsi, incepparsi nella sua progressione». Ciò che fa Petrella, evidentemente, è trasferire metaforicamente nell’indagine il tempo mentale, personalissimo, dell’ispettore, perché lo stigma della malinconia pervade fatalmente ogni cosa.
La memoria è la dannazione del nostro eroe, al pari della dannazione memoriale delle tragedie attiche, qui rivisitate attraverso lo strumento degli stilemi del genere poliziesco che fanno scaturire, a tratti, un effetto di straniante ironia: «La sua mente galoppava a ritroso, ansimava nello sforzo di tenere a bada quello che era rimasto troppo a lungo sepolto nei recessi della memoria, e che ora stava per schizzare fuori con la portata di un mostro marino. Le ginocchia quasi gli cedettero mentre tornavano a galla brandelli dell’incubo che lo accompagnava ormai ogni notte da venticinque anni a quella parte.» L’enfasi della figura retorica («con la portata di un mostro marino»), la corrività dello stereotipo («Le ginocchia quasi gli cedettero») sono gli strumenti di cui Petrella si serve istrionicamente per esasperare ironicamente la tragicità del momento. Se gli strumenti sono logori, scelti proprio per il loro carattere di facile riconoscibilità, il trattamento che ne fa l’autore è però ironico, tutto teso a evidenziarne l’artificio: un procedimento enfatizzato nei due inserti in cui Petrella attualizza e introietta la funzione del coro e dell’oracolo delle tragedie. Lo fa, coerentemente con il tratto malinconico del protagonista, lasciandone parlare l’inconscio nella figura del sogno, seppure (artificio nell’artificio) non in prima persona, ma mediato dal tu con cui il narratore/inconscio si rivolge all’eroe. Avviene una prima volta, quando Carbone rivive oniricamente la scena della scomparsa della sorellina, in una sorta di flusso di coscienza per interposta persona (il coro del sogno che si rivolge a lui), una seconda volta quando invece l’inconscio prende la forma dell’oracolo, avvertendolo che incontrerà ancora il suo nemico, «e sarà un giorno ostile, in cui sulle pareti di roccia sorgerà un sole oscuro e invernale». In questo inverno dello scontento si fondono oracoli antichi e suggestioni scespiriane, contaminandosi con i topoi del poliziesco: in momenti come questi Petrella riesce a rinnovare il genere rispettandone la retorica dominante e i repertori tradizionali.
L’ossessione della sorellina scomparsa è narrativamente il motore del romanzo e ciò che viene a costituire la motivazione dell’eroe ad agire: «Era entrato in polizia con l’assura idea di trovare il rapitore di sua sorella (…). Era questo il motivo per cui ogni ingiustizia diventava una questone personale.»
L’introflessione dell’inchiesta passa attraverso questa introflessione del tempo, sotto il segno di un carattere malinconico e maniacale, condannato da una parte all’azione, dell’altra a vivere in un tempo saturnino e immobile («Il volto sorridente di Alice gli balenò davanti agli occhi come se il temo si fosse fermato»), in cui il passato, sempre ritornante, assume il tratto psicologico del perturbante.
«Il passato tornava sempre. Ma non avrebbe mai creduto che potesse incastrarsi così assurdamente con il presente»: l’incipit del terzo capitolo sintetizza efficacemente il plasmarsi dell’inchiesta sulle ossessioni personali dell’ispettore. Il loop psichico del malinconico diventa in qualche modo il sostrato metafisico dell’inchiesta, pervadendola strutturalmente: anche in essa vale l’ossessione congetturale dei se e dei ma (avendo compreso di trovarsi a fronteggiare forze potentissime e oscure, Carbone rimpiange di avere ucciso il questore corrotto – fatto occorso alla fine del romanzo precedente -, perché di lì tutto e partito: se non l’avessi ucciso! arriva infatti a dirsi), un’ossessione che traligna persino nelle angosce della vita sentimentale, nel momento in cui Carbone rimpiange di non aver fatto di più per trattenere Laura, la donna fatale che continua a dominarne i pensieri: «se fosse stato zitto – scrive il narratore in sua vece – avrebbe coronato il sogno degli ultimi dieci anni.» Ai lati dell’inchiesta giudiziaria, sui lembi che la avvolgono, viene così a generarsi una giuntura simbolica delle due figure femminili, Alice e Laura, una giuntura che forma il controcanto sentimentale dell’inchiesta: «Sentiva di esserci arrivato, finalmente, e provò una specie di nostalgia: avrebbe voluto che Laura fosse lì per capirlo, per vedere con i suoi occhi che non si era sbagliato. Per accettare la sua crociata contro chi gli aveva strappato via Alice e il loro passato insieme». E non è ovviamente un caso che la giuntura si saldi scopertamente nel cuore del romanzo.
Non è poi neanche un caso che l’azione si svolga fra la vigilia di Natale e Capodanno: non è solo il periodo del tempo astronomicamente sospeso, ma anche il tempo della nera lassitudine malinconica, ancora l’inverno dello scontento, fin troppo schematicamente contrapposto alla festa collettiva.
La coazione del malinconico si dilata in questo tempo sospeso, il rimpianto e il desiderio ne sono lo stigma e, all’interno di questa cornice, l’indagine non può che trasformarsi nell’ipostasi del destino. Un tempo sospeso, a rileggerla a ritroso, è anche l’intera vita dell’ispettore Carbone che ha trascorso notti insonni «correndo dietro ai propri fantasmi e scegliendo di rimandare la vita anziché viverla»: il belacquismo, nonostante la revulsione morale della diuturna, defatigante inchiesta, è tarlo operante nell’intimo di un’esistenza bloccata, in quella regione della psiche in cui il malinconico attivo riconosce di non aver vissuto la propria vita, che è tragica, e insieme ironica, agnizione. È per questa vita non vissuta che all’ispettore «il tempo sfuggiva di mano»: la frase arriva nelle fasi conclusive dell’inchiesta, a caratterizzarne la concitazione e il precipitare degli eventi, ma in essa riverberano i fantasmi del passato e quelli irrealizzati della psiche di Carbone, in una strutturante connessione simbologica.
L’unica indagine che il malinconico conosce è infatti quella su sé stesso: è per questo che l’inchiesta poliziesca diventa la figura di una infinita indagine sul proprio mondo interiore, e su di essa si plasma strutturalmente, ripetendone in modo ossessivo quel modello circolare e labirintico che campeggia in tutta la sua evidenza nel potente simbolo della grotta, in epilogo.
Infine, è per questa profonda e decisiva coesione simbolica del romanzo che l’inchiesta va letta come domanda – chi cerchi sipettore? -, all’insegna dell’antichissimo tropo del quem quaerit.
Angelo Petrella, La notte non esiste, Marsilio, pagg. 190, euro 15.

