L’aquila e il pastore (da “Estampas rurales”) – Gabriel Miró
(questo testo è tratto da “Il Molino a vento e altre prose”, bella antologia di racconti di Gabriel Miró (1879-1930), Benito Pérez Galdós e Vicente Blasco Ibáñez, tradotti da Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi, e curata da quest’ultimo, per Galaad Edizioni, 2015; nel mix di “desuetudine” e estrema potenza, a me ricorda da vicino il nostro Vincenzo Pardini; GS)
di Gabriel Miró
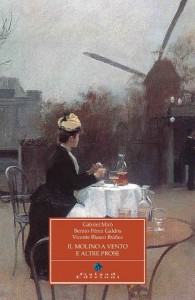 Un’aquila seguiva sempre il gregge. Il suo verso risuonava in tutta l’azzurra vastità del giorno, le pecore si fermavano e la guardavano. A volte volava così bassa che si sentiva il fischio delle piume e del becco e la sua ombra enorme passava sui dorsi lanosi delle bestie.
Un’aquila seguiva sempre il gregge. Il suo verso risuonava in tutta l’azzurra vastità del giorno, le pecore si fermavano e la guardavano. A volte volava così bassa che si sentiva il fischio delle piume e del becco e la sua ombra enorme passava sui dorsi lanosi delle bestie.
Nelle ore più calde il pastore si coricava sul prato di gramigna e le pecore si stringevano contro le rocce. Tutto il fondovalle era inondato dal sole: rossi campi coltivati, alberi in fiore, orti recintati, ruderi di casolari, sentieri che sprofondavano in un caliginoso orizzonte…
Il pastore pensò: “Il mondo che vedo è così grande che non potrò percorrerlo tutto nella mia vita. E il mondo non mi vede. Se in questo momento arrivasse il figlio del padrone e io lo gettassi giù da una rupe, nessuno lo saprebbe: la terra è troppo vasta”.
Ben contento, si voltò su un fianco affondando la nuca nell’erba del prato; ma gli rodeva la fronte un’inquietudine, come quando una palpebra vuole aprirsi, e alzò gli occhi. Appollaiata sul ciglio di un burrone, con tutto il corpo piegato, l’aquila lo guardava. Il pastore le gettò maledizioni e agitò i pugni in aria come un ossesso. Frusciava la sua fionda e il bordone andava su e giù. L’aquila prendeva il volo e si alzava nel cielo.
Quando l’ombra della montagna si sdraiava sui campi arati, il pastore raccoglieva il suo piccolo gregge; il cane indirizzava gli agnelli sul sentiero e teneva d’occhio le pecore che restavano indietro. In alto, l’aquila in volo calmo e diritto sorvegliava la loro strada.
Gli occhi dell’uccello magro e biondo riempivano di furore la solitudine dell’uomo: si sentiva spiato fin nei pensieri. Del resto, non ci sono state colombe innamorate di uomini e agnelli presi da passione per una donna? Be’, il pastore e l’aquila si detestavano. Di notte il pastore si domandava: “Da dove mi starà spiando in questo momento?”. E nascose trappole vicino al pascolo, e come esca mise delle carogne, carne affumicata e perfino pane che si tolse di bocca.
Lo svegliava uno sbattere d’ali, di ossa, di becchi. Volpi giovani e vecchie, cornacchie, gufi si contorcevano fra le tenaglie… Il pastore li finiva a bastonate o a mani nude. Non erano loro gli oggetti del suo odio, e siccome non lo erano li aborriva e li calpestava. Ma una mattina le sue risate e le sue grida risuonarono trionfali nella valle. Magnifica nella sua disgrazia, l’aquila si dibatteva con gli artigli insanguinati nelle ganasce della tagliola. Il pastore si fece di lato e rimase in attesa che il sole fosse alto per vederla bene e gustarsela. Voleva specchiarsi in quegli occhi immobili come braci rotonde: in quelle luci trasaliva la freddezza di una ferocia e di una regalità indomabile.
Avrebbe voluto distruggerli mordendoli come un frutto, proprio come avrebbe fatto lei se il pastore fosse morto allo scoperto sulla montagna. Ma se l’avesse accecata lei non avrebbe potuto sapere che lui la guardava. La guardava implacabilmente. L’aquila schiudeva il becco convulso; le ali si ripiegarono e parvero le spalle di uno sventurato coperto da un manto di bellezza come una croce. Arrivò il cane: le girò intorno latrando, soffiando vapore dalle fauci. La testa dell’aquila era eretta, intagliata contro il blu come la prua di una nave contro l’orizzonte; nei suoi occhi accesi c’era il riflesso del cane, del pastore e di un gioioso panorama del mattino campestre.
“Come l’ammazzo?” pensava il pastore. Come poteva ucciderla in modo che il supplizio durasse a lungo? Il mastino e il padrone si scambiarono un’occhiata colpevole, e il cane attaccò. Non riuscì ad azzannare la prigioniera, e gli cadde la lingua a terra come un falco ferito, e gli scricchiolò la mascella.
«Non hai il coraggio di lottare con lei!» gli disse senza parole la risata grassa del padrone. Era vero: non si azzardava. Intorno all’aquila l’aria bramiva con l’impeto del suo respiro, delle sue penne ritte, del suo tragico rancore. E al pastore si gonfiavano di rabbia le vene sulla fronte, perché neanche lui osava afferrarla o aggredirla. Si alzò all’improvviso e tornò al suo accampamento. Lasciò il mastino a guardia dell’aquila. Non che potesse scappare, ma non voleva che, vedendosi sola, trovasse riposo nemmeno per un istante. E non ci mise più di un istante ad andare e tornare con una vecchia museruola.
Venne gente: un contadino, una vecchia del casolare, un mulattiere di passaggio, un bambino che andava alla scuola rurale. Chiesero: «È l’aquila che ti seguiva sempre, come se fosse l’anima tua?».
Il bambino voleva portarla con sé per distrarsi durante la lezione. La vecchia gli chiese una penna timoniera e un artiglio e il mesenterio per farne rimedi contro il malocchio e le malattie. Tutti circondarono l’aquila e le misero la museruola canina allacciando le stringhe di fil di ferro. Poi la tolsero dalla tagliola, proprio come se fosse un’oca. Un dito era quasi staccato; il pastore glielo strappò del tutto e lo gettò al mastino che lo acchiappò al volo e subito lo sputò e fuggì via, come se quel dito gli desse la sensazione che l’aquila fosse lì, presente. Il pastore la guardava e si immedesimava. Dietro l’intreccio dei ferri della museruola, la testa dell’aquila esprimeva un senso di paurosa disgrazia e il suo sguardo fiammeggiava così umanamente che il pastore fece un passo indietro: stando troppo vicino, la museruola lo infastidiva come se fosse lui a portarla, fissata nella carne e nel sangue.
Tutti la volevano toccare e se la passavano di mano in mano: le palpavano il petto, soffiavano sul piumaggio per vedere i pidocchi sulla pelle nuda, le stringevano il becco togliendole il respiro, sentivano il palpitare delle sue palpebre, raschiavano calli e concrezioni dai suoi artigli. All’improvviso l’animale ebbe uno scuotimento convulso, un duro colpo d’ala risuonò come tuono e l’aquila saltò nel sole.
E la gente diceva: «Morirà come un cane, un cane del cielo e delle vette».
«Morirà di struggimento come una persona, come quando era felice.»
E la guardavano sorridendo. L’aquila saliva nell’azzurro, libera e gloriosa, con la museruola canina.

