La città dei futuristi
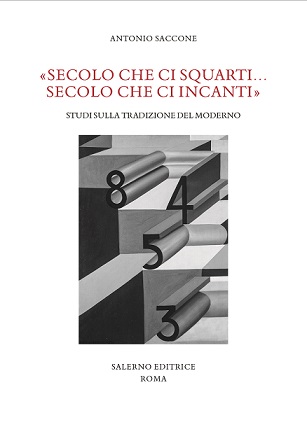 (È da poco pubblicato Secolo che ci squarti… secolo che ci incanti di Antonio Saccone, raccolta di saggi che attraversano il novecento letterario italiano, da Ungaretti a Luzi. L’autore ci regala un breve estratto che volentieri pubblico. G.B.)
(È da poco pubblicato Secolo che ci squarti… secolo che ci incanti di Antonio Saccone, raccolta di saggi che attraversano il novecento letterario italiano, da Ungaretti a Luzi. L’autore ci regala un breve estratto che volentieri pubblico. G.B.)
di Antonio Saccone
«I caratteri fondamentali dell’architettura futurista saranno la caducità e la transitorietà. Le case dureranno meno di noi. Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città»: cosí è proclamato nel manifesto intitolato all’architettura futurista, anno 1914, autore Antonio Sant’Elia. Sono passati cinque anni dall’apparizione del futurismo sulla scena italiana ed europea. Il movimento fondato da Marinetti, inseguendo la tensione totalizzante iscritta, per cosí dire, nel suo codice genetico e, perciò, promulgando il diritto a invadere tutti i settori dell’attività umana, ogni versante culturale o aspetto del costume, ha già dettato le sue prescrizioni alla letteratura, alla pittura, alla scultura, al teatro, alla musica. Ha già avviato il collegamento della sua capillare e proteifore espansione con la ricerca di una comunicazione poliespressiva, nella quale e attraverso la quale far saltare le usuali frontiere tra le singole arti e, piú in generale, tra l’arte e la vita. Il ritardo con cui l’architettura è inserita tra i linguaggi da rivoluzionare sub specie futurista è, tuttavia, solo apparente. L’attenzione per la città come fondale su cui proiettare il dinamismo della vita futurista e intessere le nuove modalità di percezione dello spazio e del tempo è, in realtà, immediata e, sin da subito, tutt’altro che irrilevante. Ancor prima di sancire la nascita del futurismo, Marinetti mostra, nella sua produzione in lingua francese, di nutrire un forte interesse per il tema della città. Nel 1904 una delle tredici sezioni, dedicata al Démon de la vitesse, in cui è suddivisa Destruction, silloge di poèmes lyriques, si traduce in un’esaltazione criptofuturista dell’orizzonte urbano, non priva di favolistica inquietudine. Il culto della città tecnicizzata («la ville gorgée d’ombre et crépitante de lumieres») raccoglie ed esaspera, nei modi di un lirismo debordante, il filone celebrativo della vita contemporanea inaugurato dalle Villes tentaculaires (1895) del poeta belga Émile Verhaeren, precursore di molte idee futuriste, stando alle ammissioni dello stesso Marinetti. Nel 1908 La Ville Charnelle, terza raccolta poetica di Marinetti, dà vita, come già indicato dalla soglia dell’intitolazione, a una città carnale, emblema antropomorfizzato di un’esplosiva sensualità. L’uso abnorme delle immagini, la proliferazione di analogie, la fusione di metafore erotiche e metafore tecnologiche inscenano un paesaggio metropolitano, dischiuso al nomadismo dell’automobile, paradigma di aggressività e di rapidità intuitiva, capace di mettere in atto una liberatoria volontà desiderante, una dionisiaca esorcizzazione di tutto ciò che costituisce impossibilità e morte.
Siamo di fronte a veri e propri cartoni preparatori del manifesto fondativo, prossimo a inscenare la sua novità tematica ed espressiva. Il proclama del 1909 si apre, com’è noto, su un notturno, carezzevole interieur: il suo caldo arredo orientaleggiante («lampade di moschea dalle cupole di ottone traforato», «opulenti tappeti») si accampa come figurazione del retaggio di una neghittosa condizione decadente («la nostra atavica accidia»), dal cui morbido torpore l’insonne compagnonnage futurista è smanioso di emanciparsi. È il salotto della casa milanese di via Senato, definito da Marinetti «attizzatoio di idee» nella sua autobiografia «parolibera aeropoetica», La grande Milano tradizionale e futurista. Il gruppo d’avanguardia è fiero di essere una minoranza impegnata in una titanica gara contro le norme imposte dall’ordine naturale. Unico punto di riferimento alla propria separatezza è la sintonia con l’alacre umanità che lavora e vive febbrilmente nei grandi insediamenti urbani:
Un immenso orgoglio gonfiava i nostri petti, poiché ci sentivamo soli, in quell’ora, ad esser desti e ritti, come fari superbi o come sentinelle avanzate, di fronte all’esercito delle stelle nemiche, occhieggianti dai loro celesti accampamenti. Soli coi fuochisti che s’agitano davanti ai forni infernali delle grandi navi, soli coi neri fantasmi che frugano nelle pance arroventate delle locomotive lanciate a pazza corsa, soli cogli ubriachi annaspanti, con un incerto batter d’ali, lungo i muri della città.
Quella futurista appare sin dal manifesto d’esordio come una prospettiva imprescindibile dalla cultura della megalopoli industriale, del cui inesausto movimento elettrificazione e meccanizzazione scandiscono ritmi e scenari.
*
Antonio Saccone è professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Napoli «Federico II». Ha al suo attivo, oltre a numerosi studi in rivista, alcuni dei quali tradotti in lingua inglese e francese, volumi su Bontempelli, Palazzeschi, Dossi, Marinetti, Ungaretti e altri fondamentali autori e questioni della modernità ottonovecentesca. Ha tenuto lezioni e conferenze in molte università europee e nordamericane. Collabora alla pagina culturale del «Mattino» di Napoli.

