LUMACHE NEL NOTTURNO
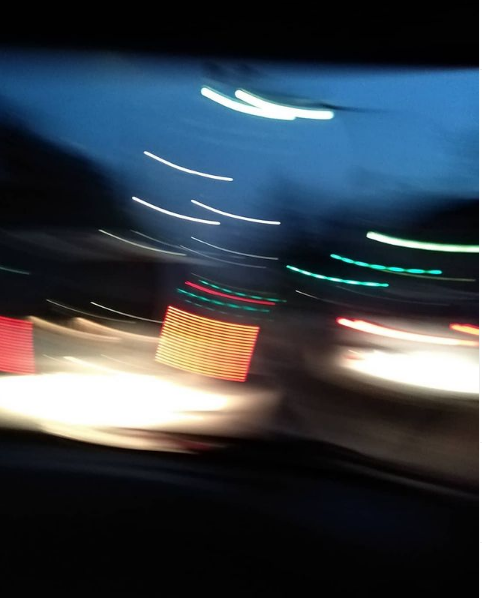
di Antonio Potenza
Aspetto da un lasso di tempo interminabile che arrivi il notturno e mi riporti a casa.
Mi crogiolo all’idea del bus che percorrerà la Prenestina, bagnata dall’arancio dei lampioni, per restituirmi al nero della mia camera, che è fumoso e nerastro, appena disturbato dalle finestre del condominio troppo vicino al ballatoio. Che bello sarà quando la mia stanza mi abbraccerà con il suo odore dolciastro, insozzato dai rivoli di fumo che lascio entrare quando spengo le sigarette sul cornicione. Vorrei che il bus arrivasse ora per sostenermi nel cammino in direzione del sonno, con il quale – finalmente – l’alcool che ho ingerito per tutta la sera, al pari di un assetato con le labbra increspate, si dissolverà confondendosi con il mio mondo onirico. Infine, sballottato dalla forza dei succhi gastrici sognerò di cadere dalla terrazza di casa mia e in un colpo di voce sarò riportato finalmente alla normalità.
Ma per ora resto qui, a Porta Maggiore, sbilenco su un guardrail malconcio.
Posso immaginare quasi tutte le macchine che si sono schiantate in questo ferro convesso nel quale, letteralmente, giaccio in attesa del bus. Ilaria, poche ore prima, d’altronde aveva ragione: i mezzi qui potrebbero non passare mai, ma l’attesa a volte non pesa poiché regala quell’ambigua sensazione di perdita estatica, forse causata dai capricci dei ruderi romani. E in ogni caso, aggiungeva Ila, si riesce sempre a tornare a casa, anche se a volte non è la tua. Con Andrea prendemmo le sue parole in modo letterario e sfidammo noi stessi. Proviamo, faceva, a tornare a casa prima dell’alba anche da ubriachi lerci.
Chi perde non paga pegno, ma chiama il primo dei due che gli viene in mente.
Ecco: la situazione attuale è la conferma della mia tracotanza.
Ma se Ilaria avesse ragione, allora, oltre questi grossi archi di pietra cremisi dovrebbe tra poco comparire il notturno con i finestrini appannati, trasbordante di vite umane. Allo stesso tempo, e per il medesimo motivo, potrei tranquillamente non vederlo apparire mai.
Guardando l’orologio mi attanaglia una sorta di ansia: tra poche ore il sole sarà ritornato su, e allora non avrà senso dormire, si aggancerà un nuovo tremito nervoso, la preoccupazione del fare che si attiva solo con i raggi ultra violetti. Bramerò il sonno senza riuscire ad averlo, nemmeno nel pomeriggio con le imposte abbassate, a causa del cuore tachicardico. Esorcizzo le previsioni funeste e il gelo tirando fuori dal pacchetto un’altra sigaretta che possa scaldarmi almeno le punte delle dita, perché questo inverno a Roma è più ostico di quelli vissuti nei due anni precedenti. Quindi mi avvolgo meglio la sciarpa e mi stringo nel cappotto di renna.
A questi problemi di natura ansiolitica e termica, domattina, penso, si aggiungerà lo sconforto di aver perso la scommessa. Quel banale commento di Ilaria sulla composizione madreperlacea di Roma, riguardo le stratificazioni temporali che trasudano porpora all’interno di questo polmone esangue, comincia a tormentarmi. Tra i palazzi umbertini e le rotaie arrugginite dei tram, attraverso il puzzo di ascella nei bus e al di sopra delle vestige cremisi della prima età romana, vi è un filo di bava che collega ogni cosa, come testimonianza dell’essenza zoomorfica della città. Lo vedo, sfavillante nella sua bioluminescenza, il lento passaggio della chiocciola, con il suo carapace diamantato nel quale si solidifica lo scorrere millenario del tempo, collegando con le sue spire di carbonio e le sue lamelle di conchiolina le membra dilaniate di Roma. Questo minuto essere si trascina lungo il metallo raggrinzito del guardrail, sale l’immensa coperta di renna che mi avvolge e in un lasso di tempo tutto sommato breve rispetto alla mia attesa, sta risalendo l’epidermide della mano.
Sui crinali delle nocche luccica debolmente non appena il notturno supera gli archi stanchi dell’acquedotto e con il cammino grassoccio ci raggiunge, puntandoci addosso i fari sporchi. Una lamina di luce ci raggiunge e abbacina il suo carapace, così come la mia vista per un lungo secondo. Ritornato a vedere, accosto le dita all’asfalto per aiutarla a scendere. In qualche modo la sua atarassia mi influenza e sono sorpreso che non mi importi più se il conducente e i passeggeri stiano sbraitando, ci vuole accortezza nel far scorrere il tempo, ma loro non lo sanno.
Ad ogni modo entro e le portiere si chiudono con un cigolio sfinito dietro la mia schiena. Qui dentro siamo tanti, non riesco a contarci perché le teste più vicine sono così grandi e strette tra loro che ciò che c’è dietro mi arriva come il miraggio di un’intuizione. Rumori e sudore si diffondono in tutto il mezzo. Italiano e indu si mischiano in uno sferragliante autobus dell’Atac e la cosa, forse a causa dell’alcool, mi appare romantica. specialmente se la inserisco nel nostro movimento verso la periferia, se la pigmento con i triangoli di luce arancione che sputano i lampioni dinoccolati che scorgo oltre il vetro.
Una buona prima parte dei passeggeri, pericolosamente ammassati in quel parallelepipedo dalla vernice sbeccata, scende all’altezza del Pigneto, tra le colonne della sopraelevata, per poi disperdersi nelle viuzze scure; la seconda parte so che lo farà all’altezza di Largo Preneste, tra un paio di fermate.
Ora l’aria si sveste dall’anidride carbonica emessa dall’eccesso di viventi in uno spazio troppo ristretto. L’agilità respiratoria mi permette di percorrere qualche passo, benché sballottato dai movimenti violenti del mezzo, in direzione dello spazio destinato ai disabili. Qui scivolo sul vetro annebbiato. Il chiacchiericcio non si ferma, fin quando la corsa bruscamente si interrompe con una frenata a Largo Preneste e quasi la totalità della gente ritorna a casa in quello spiazzo sferzato dai venti freddi.
Trovo pericoloso addormentarmi proprio adesso, benché la patina grigiastra del sonno assecondi lo scioglimento degli zuccheri alcolici nel sangue. Non sono bravo a resistere, e la pressione della sonnolenza è tale che a dispetto del vetro gelido sul quale giace la mia fronte che alla fine cedo e mi sottometto alla sua forza tentacolare.
Quando mi sveglio siamo ancora in cammino su questo bus malandato. Le scosse della corsa hanno disturbato il mio sonno, percuotendo i nervi del collo che ora pulsano sotto la giacca. Mi sembra di aver dormito per un tempo lunghissimo, ma guardando fuori asciugando con la manica la patina di condensa, scorgo che siamo a pochi metri oltre Largo Preneste. La mia percezione non sembra essere tarata sulla realtà.
Ogni qualvolta mi capiti di addormentarmi in pubblico – evento non così raro – mi risveglio puntualmente con la barba madida di bava e stretto dalla sensazione che lasciano gli sguardi di scherno sul mio stato di incoscienza. Meglio controllare attorno: nella coda del bus c’è una ragazza dai capelli corvini e la fronte tondeggiante appiccicata al vetro con uno sguardo che tradisce un’assenza; un po’ più avanti, nella postazione con i quattro sedili, un uomo con un cappotto marrone sdrucito, mi sembra sui quaranta, approfitta dello spazio per distendere le gambe; ad un posto da me, un altro uomo dalla barba grigiastra, intrisa di alcol – il puzzo si avverte da qui – mi guarda, ma sembra osservare oltre me, azzarderei attraverso me e la cosa mi inquieta allo stesso modo con cui mi affascina; infine, alle spalle del guidatore un ragazzo sbarbato è intento a pizzicare del tabacco che inserisce all’interno di una cartina, quindi con disinvoltura lecca la colla e accende.
Il conducente grida qualcosa, senza voltarsi, ma il ragazzo imperturbabile riempie il bus di fumi bianchicci.
Noialtri passeggeri sembriamo non provare nessun fastidio; o quanto meno, non abbiamo eventualmente la forza di ribattere.
Solo in questo momento ho la voglia di osservarli meglio, provando una certa tenerezza ingiustificata, e più come un gioco d’attesa decido di dare un nome ad ognuno di loro: Gilda è la ragazza dalla fronte fusa con il finestrino; Arturo l’uomo disteso; c’è poi Gianluca il fumatore – che nel momento del suo battesimo, consuma gli ultimi tiri di sigaretta e in mano ne termina già un’altra – e infine Elio l’uomo che mi guarda attraverso le membrane.
Fuori dal finestrino le luci si susseguono rapsodicamente, mentre all’improvviso compaiono i primi cancelli ricoperti dai cespugli ribelli di Villa Gordiani. La loro apparizione presagisce la fine della corsa, ci siamo, dico – forse ad alta voce tant’è che tutti mi guardano, ma l’imbarazzo passa in fretta.
Gianluca, con in mano la seconda sigaretta, percorre il pezzo di autobus che ci divide. La sua figura è schizofrenica a causa delle lance di luce elettrica filtrate dai vetri opachi.
Ne vuoi? chiede.
Dico di no.
Lo lascio dietro di me con la sua paglia, per avvicinarmi alle porte. Colgo lo sguardo di Gilda che dal fondo del veicolo tira su col naso, mi osserva e poi ritorna a guardare fuori, sorniona. Prima che io possa scendere, riguardo la scena perturbante.
A parte il tentativo di approccio di Gianluca e gli occhi di Gilda, movimento che potrebbe essere anche di circostanza, il resto fa da sfondo: Arturo continua a dormire in quella sua posizione funambolica tra i quattro sedili, Elio non smette di tallonarmi con lo sguardo, nessun movimento delle mie membra gli è sfuggito.
Lui è il personaggio più inquietante di questo palcoscenico. La sua carnagione olivastra gli contorna gli occhi che sono neri, li vedo anche dal limitare dell’autobus, ma la percezione che si crea nella mia dimensione visiva restituisce un luccichio giallognolo che non so se dovuto ad un ingiallimento del cristallino o a un brillio ipogeo, quasi impercettibile. Il suo sguardo non mi ha mai lasciato, mi viene da credere che mi avesse già trafitto nel momento stesso in cui sono entrato all’interno del bus, nonostante la mole di corpi che ci separavano; anzi no, penso, era riuscito a farlo ancor prima del mio ingresso: quando aspettavo alla fermata ha allungato lo sguardo oltre le teste, superando il guidatore, seguendo le linee dei fanali, incurvandosi con i ghirigori del carapace cristallino della lumaca, salendo attraverso le linee della mia mano e i peli del mio braccio, zigzagando tra i brividi di freddo del mio petto, fin sopra, nelle valli concave delle mie orbite.
Cambio il suo nome, ora è lo Sciamano. Mi viene da credere che questo incontro sia la risultante di una sua divinazione e ciò mi procura la claustrofobica preoccupazione di una malandata prigionia. Ora lo capisco, ci è riuscito con l’ausilio delle chiocciole che adesso sono anche qui, in questo autobus che viaggia senza una destinazione avulso dalla limitazione del tempo, abitano tutte qui in verità – come avevo fatto a non vederle! – e strisciano pigramente: una è anche sulla bocca dello Sciamano, ma lui sembra non percepirla, o lascia che quell’essere molliccio gli inumidisca le labbra arricciate – che orrore! – la loro bava ha creato una rete di filamenti lattiginosi e brillanti, vie lattee smorte, bianche bisettrici che rigano lo spazio e i corpi per adagiarsi, dilatandolo, sul tempo. Penso con una dolce rassegnazione a questa allucinante cattività. Di questo si tratta alla fine, mi dico, mentre rimbalzo tra la strada e gli occhi paglierini dello sciamano: di una carcerazione. La fine di Villa Gordiani tarda ad arrivare e non arriverà.
Mi si stringe l’epiglottide, mentre con l’ultimo grammo di coscienza grido qualcosa al suo indirizzo, mi sento svenire. Forse è una bestemmia, o un epiteto, forse ancora il suo nome, quello dei suoi genitori. Ciò che so è che nell’ultima immagine che registrano i miei occhi lo vedo sorridere, soddisfatto. Nel mio buio vellutato mi scruta ancora, con attenzione.
*
Quando riapro gli occhi, fiamme elettriche si stagliano contro un cielo dalla colorazione incerta.
Percepisco un dolore diffuso sulla parte posteriore del cranio e nonostante questa sofferenza riesco ad alzarmi dall’asfalto ancorandomi al guardrail. Il mondo barcolla adesso sul suo asse e mi restituisce immagini disturbate, sporcate dalle luci alabastrine dell’aurora. Mi inserisco in questo quadro impressionista completamente imbevuto di vomito. Credo anche di avere del sangue nella parte bassa della testa, ma mi manca il coraggio di constatarlo.
Dall’altra parte della strada intanto un vecchio barbone dagli occhi paglierini e la carnagione olivastra mi fissa in modo insistente. Io alzo la mano in segno di rassicurazione, ma continua a guardarmi, mi pare abbia sorriso appena. I suoi occhi stranamente mi infondono un senso di quietanza.
Alzo il polso dolente e l’orologio segna le cinque del mattino, proprio come quella volta che finii nudo sul lungo Tevere a smaltire la sbronza. Ammetto a me stesso di provare un certo affetto per i mondi onirici che mi fa scoprire l’alcool.
Sull’asfalto intanto giace il pacchetto di sigarette chiaramente trafugato. Lungo l’involucro trasparente una lumaca sta lasciando la sua traccia bavosa, trainando questo guscio voluminoso dalle spire concentriche e bluastre. Sapere che qualcuno ci metterà più di me a tornare a casa cheta un debole principio di ansia, allora accendo l’ultima sigaretta lasciata misericordiosamente dal ladro, per coadiuvare l’effetto calmante, invece mi provoca una vibrazione convulsa di tutte le camere cerebrali. Allora vomito sulle rotaie del trenino che porta a Cento Celle pensando a Ila e Andre. Conscio di aver perso la scommessa, sto muovendo serenamente i primi passi indolenziti sulla Prenestina, svestita dalla sua notte.
Non li chiamerò.
*fotografia Mariasole Ariot


That makes me wonder ..