La pelle di Dario Bersade
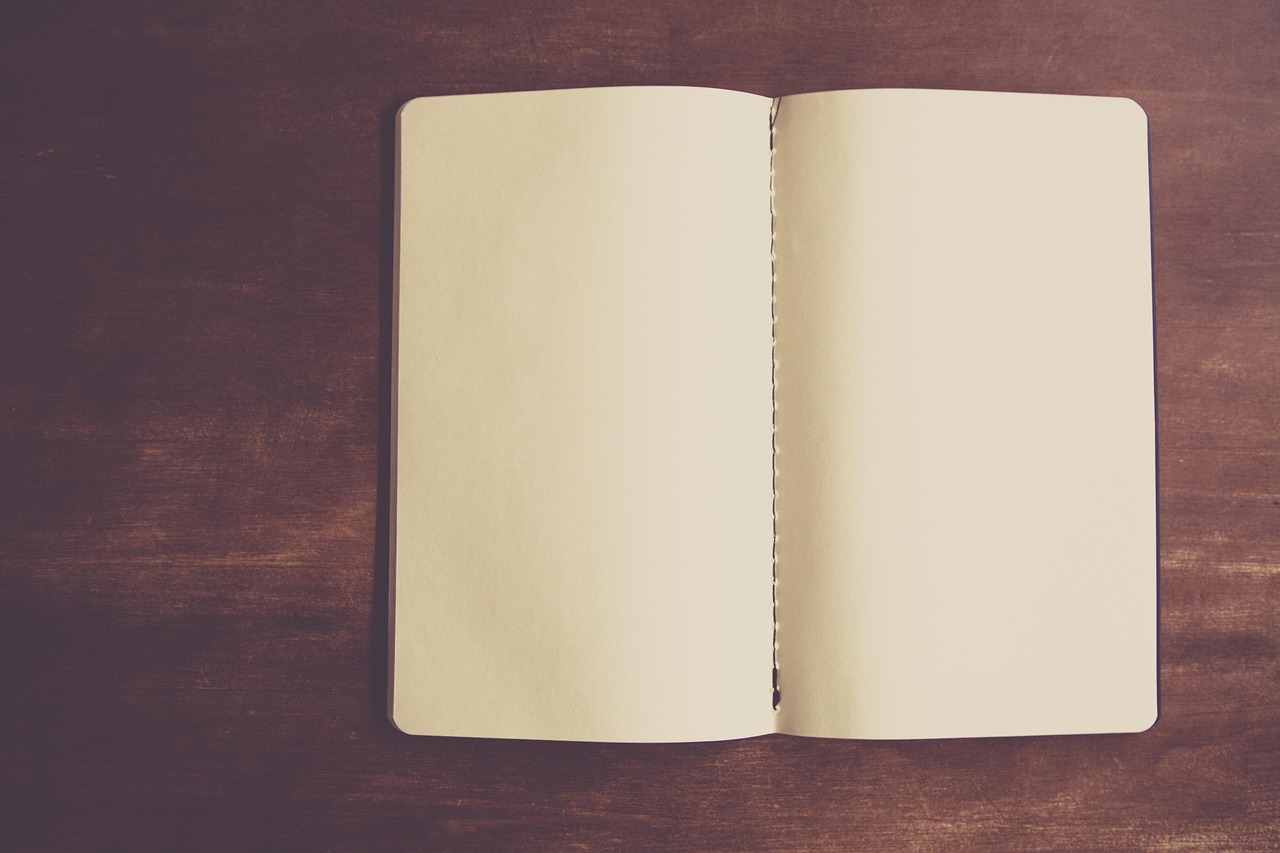
di Aurelio Vatteroni
La prima volta che Dario si tolse la pelle il fatto creò non poco scalpore. Ne parlavano tutti, all’università, fra gli amici del liceo. Si discuteva di come ci fosse riuscito, di quanto ci avrebbe messo a ricrearsi, di quanto avesse sofferto nel mentre.
Non conosco, così come credo non li conosca nessuno, i dettagli dell’accaduto. Ognuno raccontava ciò che sapeva, sperando fosse di più di quanto ricordasse il suo interlocutore. L’argomento attraversava le aule universitarie e per una settimana divenne il centro di ogni incontro. Ricordo i curiosi che si avvicinavano agli amici più stretti, il chiasso, i bisbigli, a volte le risa. Ma ricordo anche lunghi silenzi, che iniziarono a comparire le sere successive, superata l’adrenalina dei primi giorni. Le coppie si stringevano sedute nei lunghi corridoi. Nessuno riusciva ad andarsene prima delle nove, orario in cui i guardiani si decidevano a cacciarci – persino di loro ricordo i visi allungati, insonni; ci parlavano lentamente, come se entrassero anch’essi nella bolla dentro alla quale eravamo immersi dal giorno in cui la notizia aveva iniziato a circolare.
Non ho mai conosciuto Dario Bersade. Quanto so di lui proviene solo dai racconti di quei giorni all’università e dal diario di Sofia Bonfini, che ho potuto leggere due anni dopo l’accaduto. Avevo visto più volte Sofia nella facoltà di Lettere e ci eravamo scambiati qualche parola di circostanza. Sofia è poi andata a vivere a Lisbona e il suo diario mi è arrivato tramite Francesco Grassi, mio amico stretto, che si è traferito nella stanza presa in affitto da lei durante gli studi a Roma. Era un piccolo quaderno nero, di quelli che andavano in voga tra noi ventenni – li compravamo tutti nello stesso negozio – e che poteva essere un semplice regalo di Natale fatto in famiglia, magari da qualche cugino che conoscesse vagamente i gusti dell’interessato.
Nel diario compariva due volte il nome di Dario, uno alla data del 12 novembre 2018, prima dell’accaduto, ed un altro al 13 febbraio 2019. È l’unica persona che conosco ad aver mai rincontrato Dario e ricordo, per questo, di aver letto avidamente quelle pagine. Sono ormai passati quarant’anni e adesso non ho idea di dove sia finito quel quaderno. Per quanto mi stia sforzando, non riesco davvero a distinguere quali eventi appartenessero al primo incontro con Dario – del 12 novembre – e quali al secondo – del 13 febbraio. Ho deciso così di rimettere insieme quanto mi torna alla memoria, in un’unica giornata a cavallo fra le due. Data la stranezza di tutta la vicenda, ritengo infatti che il modo in cui mi sia rimasta impressa possa essere più reale di quanto potrei ricostruire in maniera più esatta.
Era una mattina fredda, con il sole nascosto da un velo bianco di nuvole – non ricordo il meteo di quell’anno, ma questa descrizione potrebbe adattarsi bene ad entrambe le giornate. Sofia era arrivata all’università in anticipo, vestita con un cappotto rosso e dei jeans chiari. Si era seduta al bar e aveva preso il primo caffè della giornata. Non faceva mai colazione a casa. Si svegliava prima che si alzassero tutti e, come di nascosto, come se non abitasse davvero in quella casa, si lavava e usciva. Non voleva farsi vedere – ma da chi? in fondo abitava con delle coetanee – fino al momento in cui arrivava al bar; si sedeva, ed accettava che lentamente la vita le si risvegliasse davanti. Al tavolo accanto a lei erano seduti dei ragazzi più piccoli – dovevano avere la mia età –, che scherzavano, ridevano sul professore e si lamentavano per lo studio. Era stata anche lei così, nei primi anni. Adesso stava arrivando qualcosa di strano, di diverso. La maturità. Non sapeva che significato attribuire a quella parola, ma si sentiva stanca di vedersi bambina, di sentirsi dipendente da un qualcosa che non fosse lei. Qualcosa di vivo, di pressante, di ostruente. Qualcosa con il sapore di varechina e capelli lisciati dal balsamo. Di questo parlò con Dario, quando la raggiunse al bar. Si spostarono poi in una piazza squadrata, che poco aveva a che fare con San Lorenzo, il quartiere universitario. Dario ascoltava e si muoveva piano. Ricordo che Sofia aveva annotato una frase pronunciata da lui, “non lo so neanche io”. Non sapeva neanche lui che volesse dire il tempo perso sui libri, le pause, le sveglie presto, le ubriacature forzate. Non sapeva neanche lui che significato avessero i libri, le pagine stampate, le ore a girare intorno a se stessi. Nessuno dei due sapeva che significato avessero i baci – se lo dissero mentre erano sdraiati a letto – e perché davvero ci baciassimo sulla bocca – anche io tuttora non ho la risposta, ma credo possa essere utile aprire un libro di psicanalisi.
Non credo che Dario avrebbe apprezzato che si parlasse così tanto di lui, in futuro. Non so nemmeno se questo racconto – abbastanza deludente, mi rendo conto di avervi montato le aspettative – risalga ai giorni precedenti o successivi a che si togliesse la pelle. Rileggendo quanto ho scritto, mi sorprende di aver iniziato con La prima volta che Dario si tolse la pelle. Di fatto non so se questa cosa sia mai più successa, ma se ho scritto così è perché questa è la percezione che mi è rimasta dell’accaduto. Che sarebbe risuccesso, che sarebbe risuccesso ogni volta che Dario avesse rimesso piede nella camera dove aveva dormito con Sofia.
Oltre a queste poche righe, c’è qualcos’altro che mi è rimasto del diario di Sofia. C’era un foglio all’interno, che avevo immaginato potesse essere opera di Dario. Non ho conservato neanche quello, in realtà, ma ai tempi lo ricopiai e ancora adesso porto con me il duplicato. Ve lo restituisco qui, sperando possa interessarvi.
Mi muovo a passi lenti. Vedo le tue labbra piene, i tuoi occhi brillanti. Se cado la paura e il vuoto.
Sento le strilla, la violenza, la corda tesa. Così i miei muscoli.
Sento il rimbombo asfissiante.
Sono dentro di te e vedo i tuoi occhi socchiusi. Vorrei darti l’amore che non so dire, l’amore che non so conoscere. Ho paura di parlare, di pronunciare il tuo nome. Ho paura di spogliarti e vederti nuda. Ho paura di vedermi nudo.
La mia carne è consumata dai miei stessi sguardi. Sa di vecchio, sgualcito, logoro. La odio perché conosco la sua storia, perché non mi appartiene. Appartiene a qualcosa che ero ed ora non riconosco. Morta prima di nascere, la mia carne mi soffoca e brucia sottopelle.
Le tue labbra piene sanno di dolce pastiglia del sonno, del caldo delle lenzuola afose. Non ti conosco. Non so conoscerti. C’è una porta stretta e una lingua impronunciabile. Mi fermo. Sto stringendo forte le tue braccia.
Per non cadere.
Ho deciso, dopo quarant’anni dall’accaduto, di scrivere la storia – o, almeno, quanto ne so io – di Dario Bersade perché stanotte ho fatto un sogno che me l’ha ricordata. Ero in camera mia, nel mio letto, e mia madre, in piedi davanti a me, mi diceva di smetterla di pensare ai miei capelli. Nel tastarli, notavo di avere un cappello. Una volta tolto e preso tra le mani, mi sono reso conto che era la testa di mio padre – mio padre è morto mentre ero all’università. Lui non aveva capelli, quindi avevo in mano una testa rasata, che lentamente ha iniziato a spaventarmi. Vi stavano crescendo sopra dei capelli neri, corti, con in mezzo delle ciocche bianche. A quel punto mi sono svegliato. Il primo pensiero che ho avuto è che quel sogno appartenesse ad Dario Bersade.


Racconto breve ed altalenante che descrive pensieri, curiosità, sensazioni ed emozioni di giovani. La loro scoperta del mondo, dell’amore, della capacità di “levarsi la pelle” con la poesia come risposta all’inquietudine dell’età. E infine il ricordo, il foglio sgualcito, la copia di un diario…. un sogno o un incubo: l’età matura?
Mi sono ritrovata giovane e smarrita. Disgustata e spaventata. Curiosa e attratta.
“Morta prima di nascere , la mia carne mi soffoca e brucia sottopelle.”
Il corpo parla e dice il vero. Il corpo non mente ed occorre ascoltarlo. Fino al gesto estremo che libera. Chi scrive trasmette empaticamente la confusione e la paura dell’essere vivi e in cambiamento. In un mondo tra l’onirico e la realtà.