Abitare una lingua
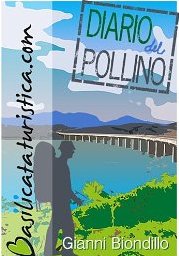 Lo scorso agosto ho vissuto una bellissima esperienza nel Parco nazionale del Pollino. Ne ho scritto un diario di viaggio che ora è disponibile gratuitamente in formato ebook (ad esempio qui, qui, o qui). Riporto di seguito un piccolo estratto del secondo capitolo.
Lo scorso agosto ho vissuto una bellissima esperienza nel Parco nazionale del Pollino. Ne ho scritto un diario di viaggio che ora è disponibile gratuitamente in formato ebook (ad esempio qui, qui, o qui). Riporto di seguito un piccolo estratto del secondo capitolo.
di Gianni Biondillo
Franca è una di quelle che è tornata. Per amore. O meglio: è tornata perché il marito amava troppo la sua terra ed ha preferito lasciar perdere la sua specializzazione d’ingegneria meccanica e tornare, da Roma, qui in Basilicata; e lei, per amor suo lo ha seguito. L’amore per un amore. Una specie di amore al quadrato insomma. Me lo racconta mentre apre per me solo la sede del Museo della Cultura Arbëreshe di San Paolo Albanese. Il museo è piccolo, ha la classica sequela di oggetti tipici di tutti i musei della cultura contadina che si possono incontrare un po’ dappertutto nel Sud Italia. Un museo a ben vedere noioso, didascalico, senza quella capacità di stupire, di interagire col pubblico che hanno molti dei musei che ho visitato in giro per l’Europa. Ma Franca è albanese, arbëreshe, di nascita e per come la vedo non è il museo, è lei quella che mi interessa.
Lei porta con sé, sulla sua pelle, quella cultura che vorrebbe mostrarmi nelle teche, negli oggetti quotidiani che, se non usati, divengono lettera morta. Quindi la sottopongo ad un fuoco di fila di domande alle quali, educatamente, non si sottrae. Ha voglia di parlare, di interagire, di mostrare il suo orgoglio d’appartenenza senza arroganza, spesso, anzi, con una modestia che commuove. “Ho imparato l’italiano andando a scuola” mi dice. La sua seconda lingua. Perché qui, da quasi cinquecento anni si parla un albanese del sud, in parte cristallizzato a quell’epoca, in parte mutato col mutare dei tempi e dei contatti con gli abitanti e i dialetti del vicinato. “L’albanese moderno è molto diverso dalla nostra lingua” mi spiega, “ma se mi ci impegno lo capisco, un po’ come un italiano che intuisce uno spagnolo se gli parla lentamente”. Mi racconta della lavorazione della ginestra, di come i suoi nonni riuscissero a trasformarne la fibra in un filato per farne abiti, sacchi, coperte. Mi mostra i costumi tradizionali esposti ma ci tiene a dire che alcuni di questi abiti sono ancora usati quotidianamente dalle ultime vecchiette che girano per il paese. Nulla di folkloristico, insomma, ma vita quotidiana. Dopo di loro, probabilmente più nessuno vestirà così: mi sento nel cuore di un cambiamento epocale, ineluttabile. Come se stessi assistendo alla morte di una stella nel firmamento. In fondo è inevitabile, è inutile vivere di nostalgie per gli usi altrui. La storia di quegli abiti, di quegli attrezzi di lavoro, è anche la storia – per quanto gloriosa, per quanto leggendaria – di miserie, di fame, di fatica.
Immaginiamo, dagli studi di Ernesto De Martino in poi, la Basilicata come una terra immobile, relegata da noi in un eterno medioevo. Ma ciò che aveva affascinato l’antropologo oggi, prendiamone atto, non esiste più. Ed è giusto che sia così. Trovo snob il modo di vedere questa regione, questo insistere sull’idea che sia un popolo di vecchi, con usi e costumi sepolti nella notte dei tempi, questa idea mortuaria, funebre, fatta di riti contadini e tradizioni fossilizzate, che piacciono tanto ai cittadini frenetici del nord, lettori estatici di scrittori “meridionalisti”, così “autentici”, così “esotici”. C’è chi ci marcia su tutto ciò. C’è chi ha fatto la sua fortuna artistica, in un eterno, infinito neorealismo fatto di piccoli Rocco Scotellaro, di verghismi degli stenterelli, di Franceschi Jovine in pectore, di “buon selvaggi”, di briganti televisivi, di salsicce lucaniche e sagre popolari del fagiolo o della porchetta.
Ma questo non lo dico a Franca perché lei non fa parte di questa risma di persone. Lei, semplicemente, parla, canta, ama, sogna in arbëreshe.
Neppure una settimana fa ero in un’enclave ligure della Sardegna. Da Pegli negli stessi anni della fuga dall’Albania di questa gente, una comunità di pescatori di corallo s’era trasferita in Tunisia, a Tabarka. Due secoli dopo furono cacciati (“fuori di qui, stranieri che ci rubate il lavoro!”) e perciò il re sabaudo donò loro due isole in Sardegna: Sant’Antioco e San Pietro. Girare per quelle strade dal piano regolare, piemontese, e sentire parlare in un ligure stretto, o mangiare la focaccia proprio come potrei farlo a Genova, mi aveva straniato. Qui è ancora più affascinante. La resilienza di una cultura supera le più incredibili avversità. In fondo noi, prima ancora di un luogo, di un paese, tutti noi abitiamo una lingua. È quella, su ogni cosa, che ci forma, che ci identifica. Ogni volta che muore una lingua muore un mondo. Ogni volta che una lingua resiste, resiste la diversità, la molteplicità, la ricchezza dell’umano.
Ovviamente nulla resta immobile e uguale a se stesso, sarebbe contrario alla vita stessa. La comunità arbëreshe subì persecuzioni, su tutto religiose. Furono “cattolicizzati” a forza. Ma residui di resistenza culturale restarono intrisi nei gesti e nelle abitudini di questa gente. Si mischiarono col nuovo per diventare altro (che è in fondo il modo migliore per conservare le cose). Nella chiesa principale mi viene fatto osservare un affresco scoperto da poco: mostra un’ostia quadrata e una scritta in greco. Nulla di che dal punto di vista artistico, ma dimostra come ancora nell’Ottocento il legame col rito bizantino fosse forte. E lo dimostra il fatto che agli inizi del Novecento la chiesa cattolica, dopo tanto inutile sottomettere, trovò una sorta di compromesso, inventando da zero la Chiesa Cattolica italo-greca di rito bizantino. Come a dire: se non riusciamo a piegarvi del tutto, vi inglobiamo. Mantenete le vostre abitudini orientali, basta che vi dichiarate cattolici. Don Francesco, l’attuale presbitero, ha preso con fin troppo zelo il compito conferitogli. Sta, negli anni, riempiendo la chiesa, che ha tutto l’aspetto di una tipica chiesa cattolica, di icone bizantine. Lui stesso è un pittore e studioso raffinato e molte delle immagini sacre poste sull’iconostasi (che non c’era mai stata prima) le ha dipinte lui stesso. “Dietro, nella parte riservata al clero, s’è fatto aiutare dalla figlia”, mi viene detto. Figlia? Ah, già… me l’ero dimenticato: i preti di rito bizantino possono avere una moglie, possono avere figli. Ed essere cattolici. Giusto per far capire che la chiesa di Roma è molto più pratica e malleabile di quanto immaginiamo!
Don Francesco vive con un po’ di fastidio la presenza di statue sacre all’interno della chiesa, vorrebbe ci fossero solo icone. Vorrebbe, insomma, ripristinare un passato perfetto, inamovibile. Illogico: ormai, dopo secoli di culto, la comunità arbëreshe ama le sue statue così cattoliche, così italiane, che senso ha imporre così tanto integralismo di ritorno? Mi avvicino alla statua di San Rocco, santo veneratissimo in questa parte del sud Italia. Mi mostra la ferita sulla coscia, e piuttosto che ad un bubbone della peste lo associo ai turgori delle punture di zanzare e di tafani che mi stanno mangiando vivo in questi giorni. Ad ognuno la sua pena, insomma.


sulla basilicata che abito, dei margini delle marginalità e delle Bellezze, delle solitudini, dei grandi problemi e delle potenzialità.
ho scritto un inedito:
“La Lucania: terra dei boschi bruciati. Narrazioni coi luoghi e il resto”
Ma la Regione, ovviamente, ha più mezzi di distribuzione di massa.
buon lavoro
Grazie per le visite.
b!
Nunzio Festa
Nunzio, vedrai che prima o poi ci si incrocia su quelle lande.