Atlantide, Il Grande Dittatore e un dubbio capitale sulla scrittura collettiva – Una lettera a Vanni Santoni
di Giuseppe Zucco
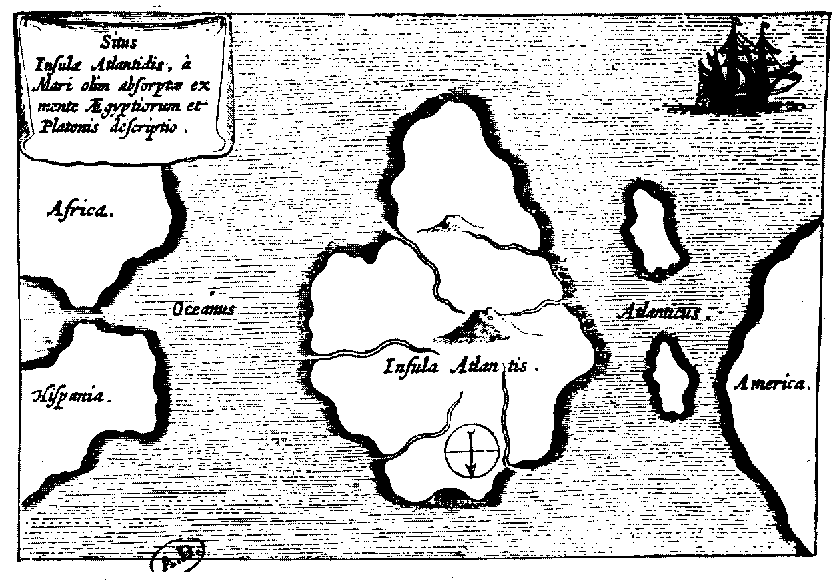
Caro Vanni,
domenica scorsa incontro un tuo lungo articolo su La Lettura del Corriere della sera, e affrontando quest’ultimo lo strano caso della scrittura collettiva, un argomento e una modalità di composizione letteraria che affiora ciclicamente nei punti più disparati dell’oceano della letteratura, un’isola tipo Atlantide, con i suoi fasti e le sue cupole dorate che balenano negli occhi di qualche avventuriero per pochi istanti prima di inabissarsi ancora tra i flutti, mi ci sono calato dentro, cercando di avvistare la stessa isola dalla prua del mio divano.
Del resto, è un luogo comune, ormai, anche se il più difficile da conseguire: fare letteratura, perdere giorni sonno forze dietro le continue evoluzioni dei personaggi e della lingua – dei personaggi dentro la lingua, della lingua dentro i personaggi – riesce davvero solo se chi scrive, forzando la propria natura, bucando il guscio di granito in cui prospera incontrastato Il Grande Dittatore del proprio Io, riesca a connettersi a tutto e ogni cosa, dalla materia inerte alla più insignificante creatura alla più lontana esplosione stellare. E scrivere a più mani, da subito, nel furioso e diacronico battere sui tasti di un numero elevato di dita, rende evidente una tra le possibili soluzioni al problema, non fosse altro che Il Grande Dittatore da solista si trova a cantare in coro, guardandosi per forza di cose intorno e tentando di accordare la propria voce a quella degli altri partecipanti alla scrittura. Non è un caso, infatti, che nell’articolo si parli di concertazione nella produzione di un testo: più voci, fondendosi, corrompendosi, modulando ognuna in funzione delle altre, avverano una nuova trama, una nuova tessitura, una nuova composizione in cui un mondo – reale o presunto, minuto o espanso, nella sua ineguagliabile stilizzazione e complessità – trova un senso o lo disperde, lasciando ai propri lettori la sensazione che la vita sia questa festa mobile, per dirla con Hemingway, o la migliore catastrofe in cui avventurarsi o battere i denti.
Da parte mia, andando indietro nella storia della letteratura, sebbene con qualche forzatura, ho sempre inteso la scrittura collettiva come un’officina di letteratura potenziale, la formula con cui i componenti dell’OuLiPo, nel 1960, definivano la letteratura che veniva fuori da una scrittura vincolata, dove i vincoli, le restrizioni, i contraintes, le regole categoriche adottate convenzionalmente prima di mettersi a scrivere – George Perec, per esempio, venne a capo di un intero romanzo senza mai usare la lettera e – costringevano gli scrittori a battere nuove piste, altri modi per affrontare la realtà, il verosimile o il suo contrario. E scrivere in 115, come è capitato a te, mettendo a punto un metodo, convogliando in un unico e coerente risultato le spinte centrifughe a cui porta il furioso e diacronico battere sui tasti di molteplici dita, non è altro che consegnarsi a questa enorme costrizione, tentando di tramutarla da vincolo in risorsa, rendendola più che altro produttiva di idee e soluzioni. Per essere parecchio vintage, questa costrizione non sarebbe altro che una musa, in fondo.
Ma continuando la lettura dell’articolo, oltre a incrociare un illuminante excursus di come la scrittura collettiva abbia trovato in Italia un terreno particolarmente fertile, abbondano tutta una serie di riferimenti ai software open source e all’intelligenza collettiva della rete, certo, alle similitudini con le botteghe rinascimentali come officine di creazione e luoghi di confronto e pianificazione, va bene, alla palestra in cui possono consapevolmente accedere perfetti sconosciuti per diventare poi gli artisti di un prossimo futuro, giustissimo, alla messa in ombra degli aspetti più deleteri e velenosi dell’autore al tempo della società dello spettacolo, senz’altro, alla constatazione che ogni testo è una produzione collettiva a cui concorrono le più diverse e troppe volte anonime professionalità, ok.
E la letteratura? E la fuoriuscita dal proprio Io e la connessione a tutto e ogni cosa? E il mondo e l’assegnazione o la dispersione di senso?
In un attimo scorgo Atlantide, poi volutamente la perdo di vista, non inseguendo più le cupole dorate, ma un dubbio capitale. Che la scrittura collettiva, molto più della scrittura sostenuta in completa solitudine, sia una sfida artistica così impegnativa da un punto di vista psicologico, così sfiancante in campo relazionale, così snervante per la ricerca continua di equilibrio e compromesso tra le parti in causa, che alla fine chi la pratica sostituisce il fine, la letteratura, al mezzo per arrivarci, il metodo di scrittura collettiva – diventato a questo punto un valore, un valore assoluto.
Tra l’altro, lo dici molto chiaramente nell’articolo. Due erano i nostri obiettivi: codificare un metodo di scrittura collettiva che potesse essere usato da chiunque, per qualunque tipo di testo narrativo, e utilizzarlo per realizzare un romanzo a molte mani che fosse sufficientemente valido da arrivare alla pubblicazione con un editore di primo piano.
Ed è proprio a questo punto che il dubbio iniziale ne produce molti altri: possibile che a una simile profusione di forze e immaginazione collettiva debba seguire un risultato piccolo piccolo, cioè un romanzo sufficientemente valido da arrivare alla pubblicazione? E la scommessa, l’ambizione dei risultati? Dove differirebbe questo romanzo rispetto a quello scritto da un unico scrittore, nel numero dei suoi autori? E non è questo un modo per prestare il fianco al mercato piuttosto che alla letteratura? Non è che messa così, i 115 autori, evidenziati in grassetto, manipolati pubblicitariamente come un fenomeno da guinness dei primati, diventano un’arma del marketing e della promozione editoriale invece che un setaccio raffinatissimo delle ossessioni umane?
Io non so se riuscirei mai a partecipare a un progetto di scrittura collettiva. Mi sembra già così complicato, alle volte, allineare le parole in completa solitudine cercando il giusto modo di dire le cose. Mi sembra, alle volte, che il Grande Dittatore mi reclami a sé e che io non riesca fino a fondo a uscire dal suo guscio o, a mali estremi, rendere l’interno di quel guscio un mondo angusto però abitabile – di Ferdinand Céline, in fondo, ce n’è stato uno, e pochi come lui. Ma la scrittura collettiva, secondo me, se spinta al vertice delle sue possibilità, anche se tra mille complicazioni, ha modo di ovviare con molta più forza e decisione questo problema. C’è in gioco la possibilità di connettersi ancora più profondamente a tutto e ogni cosa. Anche se Atlantide, nell’orizzonte di questo articolo, è balenata davvero troppo poco in bella vista.
I commenti a questo post sono chiusi


Ciao Giuseppe, grazie per l’intervento. Stiamo preparando una risposta strutturata.
V.S.&G.M.
non avevo dubbi, aspetto la vostra risposta.
[…] letto con interesse la tua “lettera aperta” sulla scrittura collettiva. Per quanto ti rivolgessi a Vanni, il tuo discorso chiama in causa la SIC, ed è per questo che il […]
Ho letto una sola volta, e affannosamente, lo ammetto, la lettera aperta di Giuseppe Zucco, perciò sicuramente il mio è un commento assolutamente “a caldo” e non filtrato dall’elaborazione della ragione, della mia formazione culturale o delle mie esperienze di “scrittrice”.
Di solito preferisco lasciarmi trasportare dalle prime impressioni e da alcune parole chiave che hanno colpito la mia attenzione, anche a rischio di aver capito male (e me ne scuso in anticipo, così mi paro le spalle), ma senza alcun condizionamento del mio pensiero. E’ assolutamente ovvio che lo stesso vale per la risposta di Vanni e Gregorio, non fosse altro che per assoluta “par condicio” (Scusate, ragazzi, prometto di rileggere il vostro intervento più tardi, con calma)
Dunque io sono una di quei 115 autori e devo dire che, quando lessi dell’iniziativa, ero assolutamente dominata proprio da quell’ego Dittatore (sono anche figlia unica e questo credo abbia avuto un peso notevole nella formazione della mia personalità) che mi impediva di condividere con altri anche solo una virgola di qualsivoglia azione, produzione, elucubrazione mentale o comportamento che mi riguardasse.
Però la proposta, scrivere una storia ambientata nel periodo della Resistenza, era troppo importante per essere immediatamente cestinato, perciò, timidamente, inserii il primo commento nel gruppo e la mia “candidatura” fu accettata.
Da quel momento iniziò il mio lavoro di stesura delle schede (e qui non mi dilungo nella spiegazione del metodo, perché non è questo lo scopo del mio intervento), che i coordinatori del progetto, avevano organizzato con una tale sistematicità e precisione, soprattutto nell’elaborazione della mappa di luoghi e personaggi (principali e secondari), nella scansione dei tempi di stesura e di restituzione degli elaborati definitivi, nonché nell’organizzazione dei gruppi, da fare invidia perfino agli Svizzeri (non me ne volete, ma abito a soli 5 km dal confine di Stato e conosco molto bene questa loro metodicità, che non sempre deve essere considerata un difetto).
Sicuramente sono stati mesi impegnativi, ma non snervanti, perché credo che nessuno di noi abbia vissuto la frustrazione di dover “cedere”, rinunciando al proprio stile di scrittura, per adeguarsi alle scelte fatte dai coordinatori. Personalmente, quest’esperienza è stata altamente formativa, almeno per questa serie di motivi:
1) Ho ritrovato il mio passato e recuperato la “Storia”, attraverso la “storia” della mia famiglia
2) Ho approfondito alcune vicende che mi erano state raccontate dai miei nonni e dai miei genitori, ma che non avevo mai verificato nella loro oggettività
3) Ho scoperto altri episodi accaduti in quel periodo in tutta Italia e che non sempre si possono leggere sui libri di Storia
4) Ho riscoperto l’uso del dialetto, soprattutto il mio e come veniva parlato a quell’epoca
5) Ho capito che altre persone condividevano i miei stessi sentimenti ed emozioni rispetto a quell’epoca
Ora il libro sta per essere distribuito, ma personalmente non mi sento manipolata, né credo di essere un fenomeno da guinness dei primati, perché credo che recuperare un periodo storico così delicato e controverso, soprattutto se realizzato da un gruppo di persone “normali” e non da cattedratici, o da professionisti della parola, sia stato molto più importante di qualsiasi operazione di marketing.
Non mi sono mai sentita vincolata ad alcun argomento, poiché ognuno di noi è stato assolutamente libero di scegliere di lavorare sulle schede che gli erano più congeniali, con l’unica raccomandazione di “non andare fuori tema” (del resto, non si procede così anche quando si assegna il tema d’Italiano a scuola?)
Il vincolo era rappresentato dal fatto che si trattava di “una storia ambientata nel periodo della Resistenza”, ma, nonostante l’attenta pianificazione, l’impianto narrativo del romanzo non è mai stato concepito come un masso granitico inattaccabile, ma si è operato anche con una certa flessibilità e la mappa dell’intera costruzione è stata costruita a poco a poco, proprio grazie al progressivo approfondimento nella stesura delle schede.
Questo ha permesso di modificare la visibilità di un luogo o di un personaggio, di approfondire un episodio precedentemente ritenuto più marginale, aggiungere o rivedere qualche dettaglio.
A noi autori questa operazione non è costata nulla, in termini economici, e l’eventuale profitto sarà devoluto o all’Anpi o comunque non servirà ad arricchirci o a darci una celebrità che francamente non credo c’interessi più di tanto. Del resto, oggi la Rete propone un’infinita serie di siti, blog, case editrici che, a costi più o meno contenuti, danno la possibilità di pubblicare di tutto e di più, così da poter appagare anche l’Io più smisurato.
Quanto alla tecnologia, che di questo progetto è stato uno dei protagonisti principali, perché ci ha permesso di mantenere costanti i rapporti e le comunicazioni fra noi e con la Redazione, finalmente ecco un ottimo motivo per smettere di demonizzarla e utile esempio da trasferire nelle scuole (ma questa è un’altra storia: non ne parlo, altrimenti vado fuori tema).
Al di là di ogni altra considerazione, non m’interessa entrare nella mente di Vanni e di Gregorio, per sapere le ragioni di questa loro “sfida artistica”: voglio invece dichiarare pubblicamente che mi sento orgogliosa e fiera di TUTTI NOI, perché il vero traguardo raggiunto non è stato quello di vedere il nostro nome nei titoli di coda di questo romanzo (Ohps… lapsus freudiano! Già sto pensando ad una trasposizione cinematografica de “In territorio nemico”…!), ma quello di aver recuperato una dimensione CORALE delle vicende di un popolo, il nostro, che ha ancora qualcosa da dire alle future generazioni.
Con infinito affetto e riconoscenza a Vanni e Gregorio per avermi aiutata a crescere un po’ di più…
[…] abbiamo parlato recentemente su Nazione Indiana qui e […]