Idiosincrasia dell’inadeguatezza: Zerocalcare, c’est moi
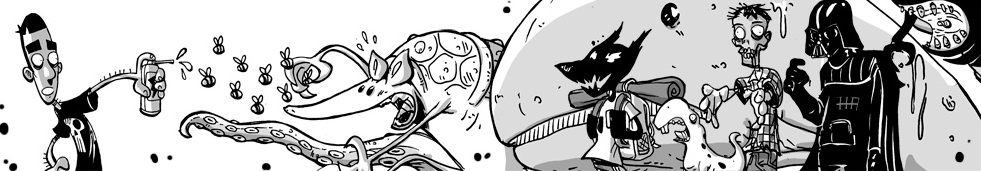
di Giulia Scuro
Zerocalcare dichiara di aver scelto la propria firma per caso. Il fumettista Michele Rech, noto a un pubblico in costante aumento, utilizza lo pseudonimo suggeritogli da uno slogan pubblicitario. Per questo motivo, e poiché l’autore di Dimentica il mio nome dedica proprio ai nomi il suo ultimo graphic novel, in libreria dal mese di ottobre, ho deciso di ripensare al suo lavoro attribuendo un peso specifico allo zero e al calcare, efficaci chiavi di lettura che compongono lo pseudonimo e sulle quali si fonda, a mio parere, anche la sua poetica.
Dimentica il mio nome è un’opera in parte autobiografica. L’autore stesso ha ribadito più volte quanto gli sia costato lavorare sulla propria famiglia, e cosa abbia significato per lui, ma questo non ha meravigliato i lettori abituali perché Zerocalcare è solito prendere spunto dalla propria vita, sia nelle tavole che hanno iniziato a comporre il suo blog nel 2011, sia nelle opere pubblicate in precedenza. In quest’ultimo lavoro si può dire che Zero raggiunge l’acme della sua verve autobiografica, toccando le corde del romanzo di formazione: la retrospettiva dei ricordi di infanzia, attraverso la morte della nonna, rende il lutto l’evento “zero” da cui ripartire per considerare le tappe e i significati della staffetta generazionale matrilineare che hanno caratterizzato la Weltanschauung del protagonista.
La maternità occupa in questo fumetto di formazione un ruolo fondamentale e quasi sostituisce la cinica ineffabilità dell’abituale, onnipresente armadillo, prodotto subcosciente che stimola nell’autore l’auto-indulgenza alla sottrazione sociale. In questo fumetto assistiamo alla nascita dell’animale-spalla di ZC e risulta evidente quanto l’armadillo e la madre siano personaggi antitetici: rispetto al primo, la madre è il simulacro della costruzione e della protezione disinteressata; baluardo della crescita per il giovane Zero, nonché spauracchio del suo complesso generazionale, è lei a insegnargli, nelle tavole conclusive dell’opera, che il nome anagrafico può essere dimenticato e che a volte la ricerca dell’identità personale trae giovamento proprio dal superamento delle etichette imposte, il che valorizza la scelta di un nome d’arte.
Lo pseudonimo fortuito che sovrappone l’autore al personaggio – utilizzato sia in forma assoluta, sia come nome e cognome, a seconda che lo si chiami Zero, Calcare, Calcà, Zé, Sig. Calcare o per intero – racchiude le principali strategie dialettiche dell’artista. Innanzitutto, vale la pena soffermarsi sul “calcare”: i grandi temi di ZC sono caratterizzati dall’essenzialità del residuo e argomentano ciò che si incrosta nei lunghi minuti della giornata; non a caso le ore serali o notturne, quelle dell’inadempienza, occupano molte tavole, mentre altre, numerose, sono dedicate agli interstizi temporali, come i viaggi in treno, le attese in aeroporto o le telefonate. In Un polpo alla gola il momento più importante nella vita scolastica del piccolo Zero è l’intervallo: è quello lo spazio in cui hanno luogo gli eventi decisivi.
Zerocalcare fonda in questo modo una filosofia dell’interstizio, del calcare che si deposita nel fondo del quotidiano. S’impone un’attitudine alla serialità, alla rappresentazione autobiografica di ciò che è incondizionato, che assomiglia a un grado Zero di barthesiana memoria del genere fumettistico. La scrittura calcarea è a latere, la stessa formazione di Calcare avviene a uno stadio “zero”; sia chiaro che non si parla di una mancanza di positività o negatività legate a una qualsiasi chiave di merito o demerito, ma piuttosto di una predisposizione idiosincratica alle curve, agli alti e ai bassi, per cui i rilievi possono essere solo quelli minimi e polverosi del deposito inerte.
La cultura di gruppo è quella che permette al protagonista di non soccombere all’interno del suo quartiere, Rebibbia, dove la singolarità è duramente punita. Rebibbia, territorio predisposto al controllo perché ospita uno dei carceri più grandi d’Europa, ha un valore simbolico per l’autore, che non perde occasione di parlarne: essendo un capolinea della metro B di Roma, è un luogo in cui, se si arriva, si resta – a volte anche contro la propria volontà, come in carcere; non è un luogo di passaggio interstiziale, ma di partenza o di arrivo. Questo posizionamento nella cinta romana è spesso sottolineato da Zero e probabilmente è il principale tra i requisiti che rendono Rebibbia capace di creare in lui quel sentimento di appartenenza per il quale gli è difficoltoso qualsiasi spostamento.
Ma come si risolve il paradosso per cui i due principali coefficienti nello pseudonimo si annullano? La soluzione è proprio nella convivenza di due tensioni volitive: la gioventù raccontata dall’autore/personaggio è quella intrappolata tra il raggiungimento di standard impossibili e la dipendenza da droghe facili e accessibili come videogiochi e serie tv. Zero ritrae un profilo in genere sommerso, quello della idiosincrasia dell’inadeguatezza: sintesi per cui si teme l’inadeguatezza più di ogni altra cosa ma, al contempo, è la stessa inadeguatezza a fungere da schermo e a mantenere giovani. L’élan giovanile è mediato da una serie continua di POSTICIPA simili a quelli proposti dalla sveglia del cellulare e a cui Zero fa riferimento in Dimentica il mio nome; lo stesso carcere diventa per l’autore una “fabbrica d’attesa”.
Il blog condiziona la percezione della vita reale del fumettista, consentendo al lettore l’immedesimazione. ZC assume il grado zero del trentenne: ambizioso ma modesto, pigro ma impegnato, socievole ma solitario. E così facendo capovolge la dimensione fumettistica: se le storiche strisce dei quotidiani rappresentavano l’evasione dalla realtà, ora, all’interno dell’iperspazio informativo di Internet, in cui non ci sono certezze né mezzobusto 2.0, la quotidianità zerocalcarea è più che mai realistica e mette in luce quelle piccole, segrete, talvolta inconfessabili debolezze e malignità che ognuno cova dentro di sé.
Zerocalcare, c’est moi! L’ipersoggettivismo che nei fumetti è solitamente posto in secondo piano rispetto alla mimesi supereroica diventa con ZC il presupposto per raccontare un nuovo modello formativo. Sarà per questo che in Dimentica il mio nome i riferimenti puramente fumettistici (vedi le volpi e i fantasmi del passato) sono solo l’escamotage dell’autore per non rendere troppo espliciti i misteri familiari. Al lettore è lasciato lo spazio di riempire i buchi nella memoria del personaggio: anche se inizialmente questi hanno impedito a Zero di crescere, è nella necessità di colmarli che va ricercata la fonte della sua immaginazione e di un – adesso sì – personale e privato percorso identitario.
[disegno d’apertura per gentile concessione dell’autore]

