Sguardi dal Novecento
di Giacomo Verri
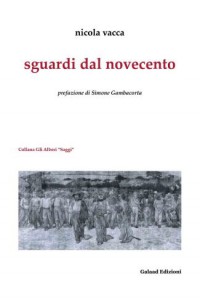 (Nicola Vacca, Sguardi dal Novecento, Galaad, pp. 133, euro 13)
(Nicola Vacca, Sguardi dal Novecento, Galaad, pp. 133, euro 13)
Gli sguardi di Nicola Vacca fanno nascere nella mia mente l’immagine di due occhi, isolati da tutto il resto, che accusano o che subiscono un’accusa, che inchiodano o che vengono inchiodati a una colpa. Sono Sguardi dal Novecento, come recita il titolo dell’ultimo volume del poeta e critico letterario di Gioia del Colle. Sono occhi di uomini in rivolta, come quelli di Albert Camus, sono finestre su pensieri complessi in cerca di continuità e di coerenza con se stessi. Sono sguardi di donne e di uomini illustri, da Alda Merini a Ennio Flaiano, da Sciascia a Calvino, da Borges a Barthes, e di altri che illustri lo sono stati di meno, a tutto nostro svantaggio (com’è il caso dell’autore di In margine a un testo implicito, Nicolás Gómez Dávila, o di Edgardo Marani). Di là dalle loro peculiarità, con finezza indagate da Vacca, ciò che li rende fratelli nella sorte è il loro ruolo di testimoni scomodi del secolo breve, di decrittatori dei totalitarismi, di scrittori, per dirla con Silone, non proprietà dello Stato ma della società.
Quelli di Vacca sono perciò sguardi di chi non ha nascosto i guasti della democrazia, né di chi dietro alle gabbie ideologiche si è trincerato, provocando quel “ritardo sullo sviluppo e sui bisogni dell’uomo contemporaneo” che oggi ancora ci fiacca. Sono piuttosto occhi fieri, quelli che ci vengono incontro, di creature che, pur braccate dalle accuse del pensiero dominante, hanno scelto “la solitudine riservata ai disturbatori e ai pensatori scomodi”. Donne dei margini, come Alda Merini, “grande visionaria”, educatrice del cuore che entrava “con l’amore per la scrittura dalla porta chiusa a chiave della follia, per spalancare finestre di celesti mutamenti sul divenire di un pensare totale”; e uomini appartati, traditori delle altrui aspettative per non diventarlo di se medesimi, ricercatori di questioni morali che fanno della poesia un mestiere quotidiano.
Kraus, Cioran, Luzi sono pensatori inattuali, bestie dell’intelletto che scagliano lontane le maschere dei dogmi, all’inseguimento, come Pessoa, di quel “vasto libro dell’inquietudine, che cerca nelle elucubrazioni dell’abisso interiore i principi dell’immortalità dell’anima” per salvarsi dal quel “disastro troppo recente” che è la modernità. Questi sguardi dal Novecento tracciano una mappa del disastro, seguendo i passi di chi ha aperto la via a salvifiche considerazioni inattuali, a quell’“altrove che bisogna frequentare per riscoprire il fascino della differenza”, fascino che è sentimento profilattico rispetto a ciò che la dittatura del benessere desidera che diventiamo: una folla innumerevole di uomini eguali (per ripetere quanto Alexis de Toqueville scriveva a proposito della democrazia in America quasi due secoli or sono), intenti a procurarci piaceri piccoli e sguaiati con i quali soddisfare il desiderio. Gli autori di Vacca, ed egli con loro, ci avvertono del pericolo di una esistenza vuota di stupore in cui vegetiamo senza vivere, in cui tocchiamo gli altri senza amarli, respirando in noi stessi e per noi stessi, ignorando che sulle nostre teste grava un potere immenso e assoluto e particolareggiato e viscido che cerca di fissarci senza revoca nelle irresponsabilità delle maschere che indossiamo.
L’invito è quindi a svelare e a svelarci, a mostrare lo sguardo di ciò che è umano, consapevoli, come scrisse Wislawa Szymborska, che “solo ciò che è umano può essere davvero straniero. Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento”.

