Giancarlo Pontiggia e Stefano Raimondi: risorse contro tempo
di Matteo Bianchi
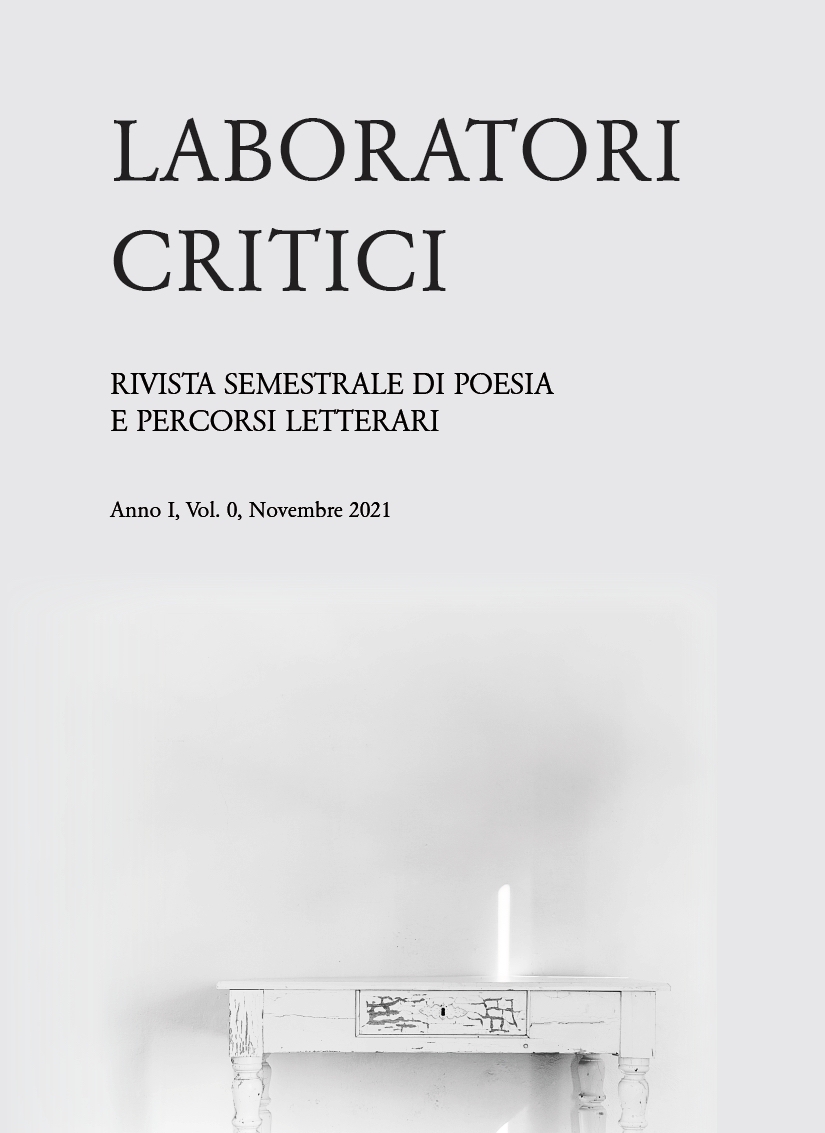
«Tutto sembra quasi poter rivivere, in questi giorni di primo autunno, come se niente fosse cambiato, anche se sappiamo che non è così, e che non potremo mai più essere come prima. Il senso di mortificazione che tanta parte di umanità ci ha inflitto nell’ultimo anno e mezzo, non potrà mai essere dimenticato». È stata una mail cristallina di Giancarlo Pontiggia, amara quanto intellettualmente onesta, a spingermi a cercare le risorse del silenzio nei versi inediti suoi e di Stefano Raimondi che ho proposto nel numero zero di “Laboratori critici. Rivista semestrale di poesia e percorsi letterari”, edita da Samuele Editore.
«Ci sono amici che ci hanno ripugnato con le loro sciocchezze; e altri che ci hanno fatto pena, come se ci fossimo trovati di fronte a degli sprovveduti – incalza il poeta – eppure non lo erano, e qualcuno di loro pareva persino possedere una testa. Evidentemente era tutto apparenza, buone maniere, una vernicetta di conoscenze a buon mercato che copriva una millenaria, cronica stupidità sociale, fatta di populismi e irrazionalismi assortiti. Forse la rivoluzione illuministica, nella quale abbiamo confidato, era solo un’illusione. O forse gli uomini non sono altro, nel loro complesso, che una razza fragile, accasciata, autolesionistica, volta più al male che al bene, duramente provata dal suo stesso vivere. Da un vivere troppo al di sopra delle loro reali possibilità. La nube della morte, che sempre ci tallona, oscura ogni nostra volontà, ogni nostro minimo pensiero». L’oblio sarebbe provvidenziale, anche perché «dopo tanto Novecento e tanta Action Française, dopo Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, dopo innumerevoli pessime recite, la prossima stagione del mondo rischia di ripresentarsi con gli stessi lustrini di prima: molte parole d’ordine, molto politically correct, pensieroni di niente».
La becera utopia che ci avrebbe voluto tutti proni a clichés abusati e a un progresso disumano pare sia appassita. Per non tornare sudditi di scelte politiche spesso illogiche, benché abili a camuffare errori di ogni genere, si dovrebbe rileggere il Leopardi de La Ginestra; sarebbe sufficiente per spazzare via qualsivoglia pseudo-certezza di cui ci si fosse paludati in precedenza, scordando la fragilità e la precarietà della condizione umana. Prendendo le mosse da un preciso assunto polemico – la contestazione nei confronti sia del «secolo superbo e sciocco» sia del suo orgoglio prometeico, vuoi del vacuo ottimismo provvidenziale – il canto si rivela capace di conferire alla cognizione dell’infelicità comune un senso agonistico nell’appello a una solidarietà rinnovata tra tutti gli esseri. Sotto la specie dell’umile ginestra si disegna così un atteggiamento nient’affatto pacificato e distaccato, ma anzi critico rispetto all’insignificanza dell’esistenza universale, sia alla necessità di una resilienza morale tramata finalmente di consapevolezza. Infatti come la ginestra con l’ostinato ricrescere del suo manto fiorito riconferma un amore alla vita traente e il suo significato dà consenso a un meccanicistico destino universale, così l’essere umano può trovare una via di autentica grandezza soltanto nella scoperta della “forza della debolezza”, ovvero nel convogliamento della coscienza di precarietà e miseria verso il superamento di ogni orgoglioso o rassegnato isolamento intellettuale in una «social catena»; in una sfida solidaristica – e non solitaria – proclamata in nome e a dispetto di qualunque mistificazione e banalizzazione religiosa o politico-sociale: «Libertà vai sognando, e servo a un tempo / vuoi di novo il pensiero, / sol per cui risorgemmo / dalla barbarie in parte, e per cui solo / si cresce in civiltà» (vv. 72-76).
È stata la rilettura dell’Enchiridion di Epitteto, tradotto da Leopardi e riedito da Aragno con la sostanziosa introduzione di Giuseppe Raciti, a ispirare la poesia che segue di Pontiggia e che somiglia molto a una prosa lirica. Dai versi incalzanti, ma senza vincoli metrici, traspare quanto la cosiddetta “filosofia pratica”, ossia l’insieme di esigenze morali che gli antichi applicavano alla vita quotidiana, avesse convinto e coinvolto il poeta recanatese; quanto fosse di fondamento per lui un senso di giustizia che orientasse le azioni di ogni individuo tanto in società quanto in solitudine. Difatti «è stato un uomo giusto, e non lo sapeva». Non a caso, nel prontuario Sette brevi lezioni sullo stoicismo (Einaudi, 2021), John Sellars rammenta che secondo il suddetto Manuale gran parte della nostra infelicità «si deve semplicemente a un errore di classificazione», ossia al pensiero incessante di poter controllare fenomeni che esulano dal nostro controllo, incluso il nostro corpo.
Appartandosi nella dimensione di un tempo interiorizzato e non più corrente, quasi parlasse da dietro le quinte di una scena teatrale, Il custode si rivolge al lettore descrivendo un uomo che fu grande e non solo in ciò che scrisse. L’autore lo ritrova nell’intimità di un pensiero felice, frutto di una sua fantasticheria, ma che in fondo avrebbe potuto essere in Leopardi, o almeno nel maestro Epitteto. Di fronte all’attualità sempre più ferina e vacua del dopo pandemia, a una realtà che ricama sui ruderi delle ideologie, ma ignora qualsiasi occorrenza amministrativa del marasma collettivo, e che sembra ricalcare lo sconforto di A se stesso – quel senso di impotenza, «(…) quel potere / maligno che di nascosto governa per il male di tutti» – Pontiggia immagina un altro mondo, parallelo al nostro, eppure affondato dentro il nostro.
Il custode
DI GIANCARLO PONTIGGIA
Non so più da quanto tempo mi è stato detto di custodire quest’anima.
È l’anima di un uomo che già da un bel po’ non vede il bene della luce.
Ma per quanto tempo ancora dovrò vegliarlo? E che cosa significa?
Chissà perché gli sono così care queste creature, se davvero gli sono poi così care.
C’è qualcosa di insano nel tener tanto a gente, che sa così poco della vita. Noi
non sappiamo niente di loro, né loro di noi, e per questo mi giunge strano che proprio io, tra i tanti, debba prendermi cura di uno di loro.
Di quest’uomo, so soltanto che è vissuto, molto tempo fa. Un tempo così lontano, da non aver più cognizione di quanto ne sia davvero passato.
Mi dicono che dovrò vegliare un’intera notte, una, ma così lunga, che mi sembra non debba passare mai.
Ma dov’è, lui, ora?
Schegge di esistenza mi perseguitano.
Lo vedo mentre è un bimbo, e piange, perché ha perduto la madre. Era tanto tempo fa.
Un’altra volta è felice, mentre tocca la zampa di un gatto.
Ma che ne so del tempo, a volte mi pare di impazzire
nel pensare il labirinto della sua mente, dove niente ha ordine, e tutto pare guerreggiare in un tumulto continuo,
mi prende un senso di capogiro a pensare a ciò che è, piango anch’io, a volte, mi pare
di essere lui, solo che lui ha smesso di avere pensieri, è sprofondato non so bene in cosa,
mentre io me ne sto qua, mi arrovello intorno alla sua sorte,
e mi dimentico della mia,
che forse fu grande, un tempo, e ora è niente. Forse non è successo per caso, forse
c’è un disegno in tutto questo, che mi sfugge. Forse non c’è nessun disegno, e non ho avuto alcuna consegna.
Mi chiedo: cosa ne sarà di lui?
È stato un uomo giusto, e non lo sapeva.
Forse è per questo che sono qui.
Ogni tanto mi chiedo che c’entri la mia sorte con la tua.
Ma senti o non senti? E se no, che ci faccio, qui, che ci sto a fare? Cos’è che sto vegliando? A volte ho la sensazione che sia tu a vegliare su di me, e che il mio tempo sia scaduto.
La felicità è una zampa di gatto. Volevi intitolarlo così, il tuo libro, ma i tuoi fedeli scrissero A se stesso: pensavano che fosse troppo poco. Non sapevano
che era il tuo pensiero più profondo.
Se almeno sapessi com’è
una zampa di gatto, e cosa vuol dire carezzarla. Ma tu sì che lo sapevi: tu sì che eri felice, in quel momento. E io?
* * *
I «sovrumani silenzi» e la «profondissima quiete» di Leopardi accomunano le piccole creature cittadine che Stefano Raimondi passa in rassegna nel suo bestiario all’uscita di scena del custode di Pontiggia. L’infinito leopardiano preme sotto le parole dell’autore come un’ombra necessaria e già dal primo frammento lirico: le formiche insegnano a chi le osserva a raccogliere i ritagli delle voci care per poi stiparli nelle crepe del buio che ci avvolge in vista di cambiamenti radicali. La crudeltà della primavera di eliotiana memoria torna anche nel contesto urbano, nel minimo quotidiano del poeta milanese; poiché per creare spazio a nuove vite, aprile ne sacrifica altre inconsciamente, ciclicamente.
Raimondi riesce così a riprodurre nel lettore la sensazione spaesante di ignara colpevolezza, di spietatezza connaturata e inconsapevole dei bambini che uccidono le lucertole per gioco, per fare esperienza al mondo, quasi il giudizio morale fosse solo umano – e perfino troppo. Quasi aleggiasse sopra di loro l’aura di un San Giorgio ancora acerbo, ma già pronto a trafiggere le perversioni dei rettili, un San Giorgio alienato quanto la società contemporanea che ha snaturato i riti gettando nel dimenticatoio le proprie radici mitiche. D’altronde, i bestiari medievali erano sì fonte di stupore attraverso una concezione simbolica dell’esistenza – chi si fermerebbe ancora per la strada a stupirsi dei balzi di un merlo fuori stagione? – ma specialmente opere di carattere didattico allegorico che trasmettevano le virtù alla moltitudine analfabeta.
Il bestiario delle stagioni
DI STEFANO RAIMONDI
I
Era quella la voce che aspettava ogni volta, che il tutto gli si rivoltava contro, ogni volta che sentiva di urlarlo fuori il buio, quello che si assiepava come un confine, come un infinito. Sentiva la collaborazione del respiro impigliarsi nelle crepe, le stesse che le formiche usavano per stipare, nascondere, vivere gli inverni.
II
La lumaca era lenta più della sua bava e lentamente si scrutava, si guardava fin dentro i luccichii e si curava piano, piano come fa l’immobilità quando, c’è qualcuno che ti può scorgere, vedere: come quando dalla tana si smuovono le ghiaie, si aprono le spine e il mondo entra per chiamarti, scoprendoti.
III
Me lo dicevi al telefono: “Il mio corpo racconta ormai storie diverse da prima, dice cose che sembrano lontane e invece già si corrodono i contorni, si sfilacciano gli orli”. Me lo dicevi preparandoti come fa la cavalletta quando, se la vedi, s’immobilizza tutta e poi scatta sulle gambe accartocciate e sparisce. Me lo dicevi così il dolore come per non farti vedere.
IV
Anche il merlo sembrava aver confuso la sua primavera. Saltellava sospettoso sotto gli alberi stesi ancora come morti. Cercava i balconi scossi dalle tovaglie; cercava voci di pane cadute dagli avanzi del mondo e si proteggeva, dai fiori gonfi, tra le gemme ancora chiuse, ancora pronte per esplodere che gelavano, a poco a poco, senza accorgersi che era lì la primavera, lì sdraiata sulla terra nera intorno. La nostalgia lo confondeva…
V
Non c’era che questo nel sogno, che questo nel silenzio: il tradire dei pensieri, uno ad uno, come se potessero sparire sempre o restare appesi, leggeri, come spellature. Erano come tagliati e poi ricrescevano sfrontati, come se dovessero finire male. Era notte! La lucertola del pomeriggio si mangiava la coda che le ricresceva sempre, voracemente. Intanto i bambini la uccidevano in continuazione, spietatamente. Le fecero una tomba con le foglie e ogni volta si commuovevano ridendo. Era questo il giro, il girone, il patto: tutti lo sapevano. Ma lei moriva lo stesso, continuamente e non era ancora finita la primavera.
Milano, 26 marzo 2018 – 18 ottobre 2021

