Radio days: Mirco Salvadori, Arlo Bigazzi & Vittorio Nistri
 Non c’è gusto in Italia ad essere felici
Non c’è gusto in Italia ad essere felici
di musica, perduta indipendenza, tenebra e rivoluzione Pt. 2
di
Mirco Salvadori in conversazione con Arlo Bigazzi e Vittorio Nistri
Assortimento Dolci Fini, Fondantes, Confetture, Frullati Conserva, Cioccolata, Galanterie di zucchero. Si assumono ordinazioni in Torte Croccanti Pasticcini. La mia sovrabbondanza glicemica inizia a sussurrarmi che il viaggio in una delle capitali della Mitteleuropa, antica realtà che segretamente continuiamo a celebrare come fase di incanto culturale prima della caduta, forse finirà al pronto soccorso causa coma diabetico. È un rischio che bisogna correre, quando il richiamo delle Galanterie di zucchero supera di gran lunga il canto delle Sirene di mitologica memoria. A ben pensarci il vecchio Ulisse da queste parti ancora tiene banco e non nelle fattezze dell’eroe di Itaca ma in quelle di un romanzo la cui stesura era iniziata in questa città e proprio in questa via, in un violentemente ventoso luogo affacciato sul mare con tutto il suo carico di pietra carsica sulle spalle.
Uso il navigatore azzerando in un attimo la scenografia mentale che avevo allestito per l’evento, la sola città nella quale riesco a muovermi senza perdermi è la mia Venezia e raggiungere questa via da un lontano parcheggio vista mare, risulta per me operazione concretamente angosciosa. Perché poi due toscani abbiano deciso che Trieste e quel caffé in particolare dovevano essere il luogo del nostro incontro, continua a risultarmi un mistero.Miracolosamente sono giunto in Largo della Barriera Vecchia, forse agevolato dalla fantomatica proiezione digitale di James Joyce che sembra mi aiuti ad aprire la porta di un caffé in stile liberty da lui frequentato nei primi anni del ‘900. Ad attendermi due reduci di epoche che ora sembrano remote, due musicisti che hanno attraversato incolumi e ancora attivi gli oltre cinquant’anni che ci dividono dagli anni ’70, periodo che sarà in qualche modo presente nella conversazione a venire.

Ma chi sono i due avventori che vedo già avvolti in un fitto e stranamente pacifico dialogo, seduti nell’antico sfarzo liberty della Pasticceria Caffé Pirona di Trieste? Chi segue queste pagine Arlo Bigazzi: musicista, produttore, regista e scrittore teatrale nonché co-fondatore della storica etichetta discografica Materiali Sonori ha già avuto modo di conoscerlo in una conversazione tenuta a bordo di un vetusto battello a vapore lungo un fiume dimenticato . È con lui e con un altro irriducibile libertario che di nome fa Vittorio Nistri : musicista membro di formazioni antagoniste quali Deadburger Factory e Ossi, da molti soprannominato “My Name Is R.I.O.” e non certo per un suo improbabile amore nei confronti dei Duran Duran, ma per il suo viscerale attaccamento agli Henry Cow e al loro Rock In Opposition, che andremo a continuare quella conversazione che verteva sull’indipendenza artistica e sulla sua estrema difficoltà nel viverla al giorno d’oggi.
“Buongiorno signori e ben ritrovati all’alba di un nuovo inverno della ragione, con il sordido triumvirato che nel giro di sole poche ore, già ha sfregiato gli ideali verso i quali tutti noi poniamo da sempre fede e osservanza. Urge placare lo stato d’ansia con il più naturale dei calmanti: mi si portino le Galanterie di zucchero accompagnate da cioccolata calda e panna montata e non badate ad un mio possibile improvviso stato di assenza, chiamate il 118 e ci penseranno loro.
Mantengo sempre un bel ricordo della cioccolata calda con panna, solitamente andavo a berla in un bar famoso proprio per quella bevanda e soprattutto per la panna montata che lì si produceva, densa e croccante di mille granelli zuccherini dispersi al suo interno. Erano gli anni ’70, periodo dal quale immagino giungiate anche voi.”
Con di fronte l’inseparabile chinotto del Bigazzi e le nostre due cioccolate fumanti, iniziamo questo confronto, una conversazione che ha come fine ultimo il riconoscersi, pur nelle diversità di vedute e professionali, come appartenenti allo stesso pensiero ancora e sempre critico e resistente nei confronti di una realtà che ha come compito l’annientamento dell’indipendenza artistica con la sua vigorosa forza esplosiva.
MS: Mentre, provocando stupidamente me stesso affondo il cucchiaino nella soffice bianca materia zuccherina, parto rivolgendovi la prima sollecitazione che riguarda proprio l’attitudine diffusa nei ’70: la provocazione. Abbiamo ben presente che significassero quegli anni ma oggi si possono in qualche modo attualizzarli, renderli nuovamente vivi ed efficaci come un tempo? Come può svilupparsi una nuova forma di provocazione in una realtà nella quale proprio le provocazioni sono soggetti principali usati dalla cultura massificata? Quale il loro ruolo e la loro possibilità d’impatto?

AB: Non credo che oggi si possa sviluppare una qualsiasi forma di provocazione in ambito culturale, almeno nei modi di come credo tu voglia sottintendere. Penso sia anche inutile. Perché provocatori lo furono i futuristi e i dadaisti, come nella popular music lo furono Elvis Presley, Frank Zappa o The Fugs, tanto per fare qualche nome noto ma oggi, rimanendo nell’ambito musicale, provocatori sono considerati anche Achille Lauro, che si “battezza” a Sanremo, e Damiano dei Måneskin che si esibisce vestito da dottor Frank N. Furter, che tra l’altro era una provocazione in uso una cinquantina di anni fa. Nella loro musica, però, sono piuttosto conformi a quanto già passa l’industria, quella che ti suggerisce, ti vende, ti rende di moda la trasgressione. Parlare di provocazione, trasgressione o quel che vogliamo, non credo abbia più tanto senso. Oggi la provocazione è creata e controllata dal Sistema, che dovrebbe essere il soggetto provocato, e ha l’impatto che l’industria decide debba avere. Atteniamoci alla definizione della Treccani: provocatore è «chi provoca o ha provocato, specialmente all’ira, a un comportamento aggressivo, a una reazione violenta». Forse, alla fin fine, è meglio non provocare ma restare interiormente incazzati e sopravvivere al Sistema. Questa potrebbe essere considerata un’ottima provocazione.
VN: Concordo in pieno con Arlo. Aggiungo che pure i social, dove la provocazione (specialmente nelle sue accezioni più gratuite, becere e regressive) “porta like”, hanno contribuito non poco ad affossare la valenza positiva che in passato veniva associata a questo termine. Ormai anche il più decerebrato degli haters, dopo essersi visto arrivare un licenziamento o una citazione in tribunale (magari per avere inneggiato allo stupro della Carola Rackete del giorno), farfuglia di default: «Non pensavo sul serio quello che ho scritto, voleva solo fare una provocazione».
Per continuare a trovare un senso positivo alla parola provocazione, forse bisognerebbe rimodularne l’obiettivo.
Oggi, per shockare sul serio qualcuno, l’unica sarebbe bruciargli l’iPhone. Né ha più senso continuare a pensare che la provocazione possa creare “scandalo nei benpensanti”, nell’era della patetica brama social dello “scandal du jour”.
Invece potrebbe avere ancora un senso una provocazione a pensare.
Per esempio, in questo periodo storico ossessionato dall’individualismo, una possibile valenza antagonista dell’arte potrebbe essere provare a stimolare una riflessione focalizzata sul noi invece che sull’io-me-myself.
Altro esempio: ell’epoca del culto della velocità, vedo un’attitudine controculturale in un’arte che possa indurre, fosse anche solo per qualche ora, a rallentare il passo, ad approfondire qualche stimolo, a lasciarlo sedimentare dentro di noi.

MS: Dopo le vostre risposte, seduti come agenti provocatori in un antico caffé triestino, mi sento proprio come un agitatore d’epoca intento a stendere un manifesto di incitamento al pensare mentre tra me e me canticchio: Largo all’avanguardia Pubblico di merda Tu gli dai la stessa storia
Tanto lui non c’ha memoria Sono proprio tutti tonti Vivon tutti sopra i monti. Volendo riprendere la conversazione proprio da questo testo, un tempo si era parte della controcultura giovanile che esternava il suo credo attraverso l’estetica e la musica. C’erano coloro che esibivano la propria appartenenza attraverso la forma e altri che rifiutavano le divise agendo comunque con decisione e spirito decisamente “punk” sulla sostanza. Erano soprattutto i figli della classe operaia, spinti da reali esigenze che andavano ben oltre gli estetismi. Quale può essere oggigiorno l’espressione di appartenenza, forse la qualità e il tipo di proposta musicale e quindi culturale, che si propone?
VN: Non so se capita anche a voi, ma a volte dentro di me sento di (o mi illudo di) saper riconoscere, con sufficiente chiarezza, cose che avrei difficoltà a definire o razionalizzare. In particolare, mi sembrano ben discernibili determinate “scelte di campo”, ancorché mi sia difficile mettere a fuoco criteri “oggettivi” per l’attribuzione a quel campo.
Nella maggioranza del cosiddetto indie italiano, così come in alcuni recenti trend musicali aggreganti (ovvero, nei quali trovano identificazione determinati gruppi di ascoltatori), “avverto” nitidamente l’estraneità al concetto stesso di controcultura. Vi ravviso invece piena adesione alla narrativa dominante: spesso come estetica, sempre come valori o disvalori veicolati.
Per contro, non ho dubbi nell’ascrivere alla “controcultura” (quasi fosse l’undicesima categoria aristotelica) opere come – faccio tre esempi di dischi recentissimi, tutti usciti nel 2022 – l’omonimo esordio di The Afrorack (aka Brian Bamanya: sintesi modulare made in Uganda, elettronica autenticamente anticolonialista e anti-global), The Liquified Throne Of Simplicity degli sloveni Širom (immaginifici, inventivi, fuori da ogni binario) o Romance dei newyorchesi Oneida (r’n’r quintessenziale, purissimo, archetipicamente rumoroso, mille miglia lontano dalle parodie di rock che troppo spesso riempiono gli stadi). Così come ravviso la medesima “alterità” in artisti italiani come i folletti OoopopooiooO, o l’omaggio multimediale di Arlo a Majakovskij, o i monumentali commentari sociali dei Maisie.
Se mi venisse chiesto di esporre i “criteri” coi quali giungo a tali giudizi, sarei in difficoltà (il criterio della “qualità” è opinabile per definizione, quello dell’argomento trattato è banalizzante e riduttivo, ecc), però, dentro di me, proprio non ho dubbi.

AB: Penso che in campo musicale sia piuttosto irreale definire la qualità, a patto che non si decida che sia esclusivamente la tecnica esecutiva a stabilirlo. Chi stabilisce la qualità di una proposta musicale? La musica inuit fatta esclusivamente da un tamburo, una voce e suonata su micro scale non è di qualità? Il punk, che può essere suonato fregandosene della tecnica strumentale, non ha valore culturale? La musica ambient, fatta di poche note, lunghissimi reverberi e che da decenni è sempre uguale a se stessa, è una proposta che ha una valenza culturale? E il liscio di Secondo Casadei come lo vogliamo considerare? Va suonato bene – perché altrimenti non lo suoni e non fai danzare i ballerini – ma è certamente diverso dal liscio che alcuni eseguono utilizzando le basi MIDI. L’heavy metal, che devi essere un ottimo musicista per poterlo suonare, cos’è? Per mia opinione sono espressioni culturali, certamente non accademiche, ma che possono racchiudere lo stesso spirito di appartenenza perché l’unico spirito di appartenenza che ci può tornare utile è “aprire la mente”. Magari volgendo lo sguardo a un mondo più equo, che poi lo identificherei con quella “scelta di campo” di cui accennava Vittorio, e con un’evidente onestà intellettuale che stia alla base e che mi sembra fondamentale come requisito. Pretendere di definire la qualità di un genere musicale, di una musica mi sembra pretestuoso. Non esistono la “musica bella” e la “musica brutta”. Esiste piuttosto la musica di cui ho bisogno – magari in un determinato momento della giornata o vita – e la musica di cui non ho bisogno. Si dovrebbe partire da questo banale concetto, da questi due “generi” per poi discernere di musica e magari del suo valore culturale.
MS: Freno il mio disaccordo sull’immobilità del comparto Ambient pensando per esempio all’ultimo lavoro di Giulio Aldinucci. Ma riprenderemo l’argomento in un’altra conversazione, magari. Parto con una breve digressione. Ricordate quando si usavano termini a non finire e si confondeva controcultura con sottocultura. Poteva per esempio il punk essere sottocultura rock o forse la vera sottocultura era quella delle Timberland, dei paninari con i Moncler e Drive In a seguire?
AB: Considero ancora controcultura quelle espressioni che si pongono in opposizione ideologica alla cultura dominante e che non stanno nei meccanismi dell’ex-industria culturale. Oggi è chiamata dell’intrattenimento.
Per definirle quelle espressioni, si usava anche la parola “alternativa” proprio perché in contrasto con i meccanismi dell’industria. Per capirsi, agli inizi, io pensavo di suonare “musica alternativa” come pensavo che Materiali Sonori fosse un’etichetta discografica alternativa. È un termine ormai totalmente in disuso. Peccato. Adesso penso soltanto di fare musica e non mi pongo il problema.
Per sottocultura, invece, ho sempre inteso quelle espressioni di basso livello che stanno dentro il Sistema, che preservano lo status quo della società in modo ancora più volgare, offrendo una visione del mondo guasta e che non porta nessuna riflessione, ma solo uno svago malsano e un totale disimpegno sociale. La cinematografia dei pierino e delle giovannonecoscialunga sono sottocultura, per provare a sintezzare il discorso con un esempio semplice.
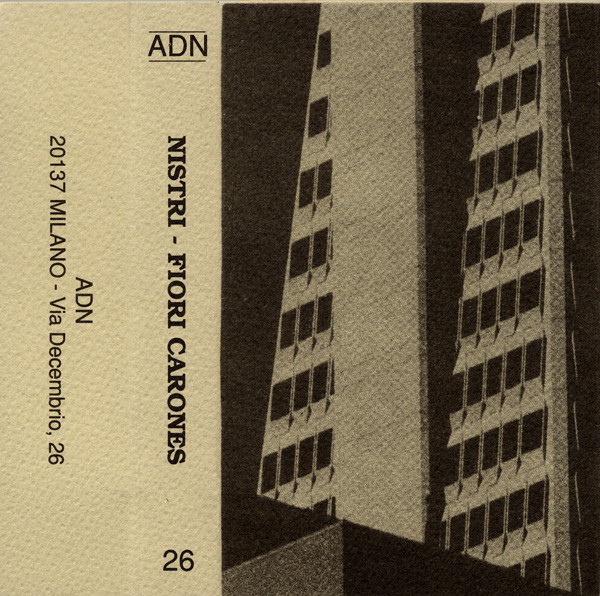
VN: sottoscrivo ogni parola di Arlo. A me il termine “alternativo” comunque piace ancora – è talmente obsoleto da essere di nuovo futuribile.
AB: Concordo. Dovremmo riprendere a usarlo più spesso.
MS: Giungiamo quindi a un tema centrale che un tempo in area di controcultura si dava per certo e oggi in modo scontato e dalla maggioranza di strutture e persone delegate alla diffusione musicale e quindi culturale (repeat) si vende come reale anche se in realtà, proprio non lo è: l’indipendenza musicale che, per come la vedo e per come ripeto ormai da parecchio tempo, è quasi o del tutto scomparsa alla fine degli ’80 con qualche strascico residuale nei primi ’90. Oggi si vendono i Verdena come summa dell’indie, quando in realtà il loro ritorno su disco avviene su Capitol Italia. Come la mettiamo?
AB: Cosa non è e cosa è indie è difficile da affrontare e lo ritengo ormai pure inutile. Non determina niente. Il Clan di Celentano era un’etichetta indipendente tanto quanto lo erano I Dischi Del Sole di Ivan Della Mea e Giovanna Marini e l’Alternative Tentacles dei Dead Kennedys, quindi penso che non lo si debba impiegare per definire un particolare genere o movimento musicale. Poi credo che oggi sia usato per definire quel genere musicale che mi sembra sia soltanto un pop un po’ scarso, fatto un po’ malino, senza tanta ricercatezza sia negli arrangiamenti sia nei contenuti. Non me ne intendo molto, ma mi sembra che stia un po’ così: «Volevo essere David Bowie ma non ci sono riuscito». In ogni modo, per definire “musica indipendente” rimango basico: è indipendente chi produce e distribuisce i propri lavori autonomamente. E questo può essere considerato un valore, ma il contenuto non ne è caratterizzato, se non in quella certa libertà del suonare quello che ritieni più opportuno, senza restrizioni o condizionamenti.
VN: Oggi la parola indie viene usata per tutto e il contrario di tutto – dalla canzoncina melodica sanremese al più apocalittico drone-maker.
Di questo argomento avevo discusso un annetto fa con l’amico Diego Alligatore (di Frigidaire e Smemoranda), per un contributo ad un progetto di libro poi accantonato (spero solo temporaneamente). Mi permetto di recuperare qualche riflessione che avevo fatto in quell’occasione.
Dunque… io credo che l’attuale vaghezza della parola indie sia un tassello di quel processo di svuotamento di significato a cui sono andati incontro – non solo in ambito musicale, ma culturale in senso lato, e pure politico e sociale – svariati termini che, per tanti anni, avevano identificato nuclei precisi di soggetti, convinzioni, comportamenti, lotte, innamoramenti, scelte esistenziali… e che poi, nel mondo cosiddetto post-ideologico (diciamo, a partire dagli anni ’80), si sono un po’ per volta allontanati dal loro senso originario, fino a smarrire ogni effettiva capacità di identificazione e di aggregazione.
Pensiamo ad esempio alla parola “sinistra”, che ha visto, tra i suoi presunti leader, figuri come Blair o Renzi, i quali hanno incarnato l’esatto contrario di ciò che, prima della “fine delle ideologie”, si intendeva per “sinistra”.
O alla parola libertà, che, a partire dal ventennio berlusconiano, è stata fatta coincidere con la licenza di perseguire illimitatamente il proprio tornaconto, anche a danno di altri individui e del contesto sociale tutto. Col risultato che oggi questo termine viene usato anche per veicolare valori antitetici a quelli dei Padri Costituenti, che pure di lotte per la libertà se ne intendevano più di noi. (Si veda l’accresciuta “libertà” di licenziamento, o di non assunzione stabile, che ha minato le sicurezze dei lavoratori in un modo che mal si concilia con una “repubblica fondata sul lavoro”).

AB: Sono d’accordo e anche in questo caso sono basico: “sinistra” per me è chi propone una società alternativa a quella capitalista, altrimenti è soltanto uno che vorrebbe migliorare alcuni aspetti di una società che si basa per forza di cose sull’iniquità e la disuguaglianza. Così come indipendente andrebbe considerato solo chi non fa compromessi e uso di capitali provenienti dall’industria. Ma sinceramente non so più se oggi abbia un senso usare il termine “indipendente” come un valore.
VN: Anche le parole cultura e competenza sono attualmente oggetto di una percezione valoriale esattamente opposta a quella del passato. Mezzo secolo fa, il diritto allo studio per tutti era oggetto di aspre lotte politiche, perché l’istruzione era vista come un tassello fondamentale per l’emancipazione sociale. Oggi invece molte persone avvertono studio e cultura quasi come un disvalore: una roba da ridicoli “professoroni”, lontani dal genuino sentire popolare – e oltre a tutto superflui, giacché ai loro denigratori basta digitare in rete cinque minuti per sentirsi ferrati su qualsiasi argomento, quanto e più di chi ha dedicato una vita intera a studiarlo.
Ecco, nel suo piccolo, la parola indie ha subito un analogo distacco dal suo significato originario.
Per cui ci capita di sentirla usare sia per etichette come Snowdonia e musicisti come Bruno Dorella (che da tutta una vita si sbattono, con coerenza e dedizione, per portare avanti musiche “altre” e circuiti genuinamente underground), sia per artisti il cui repertorio un tempo sarebbe stato senza esitazione considerato musica leggera o mainstream (donde la congenialità a canali promozionali quali Sanremo e X Factor).
Sì, davvero “grande è la confusione sotto il cielo”. Eppure eppure… anche se una parola ha cessato di identificare in modo univoco ciò che rappresentava in passato, per me è un errore pensare che sia per forza venuta meno la realtà che quella parola esprimeva.
Torno al primo degli esempi. Da anni ci sentiamo ripetere che la distinzione tra destra e sinistra è superata dai tempi. È un’affermazione mendace, perché confonde capziosamente l’uso annebbiato e ambiguo che di tali termini oggi viene fatto (…difficile in effetti considerare il PD un partito di “sinistra”…) con la realtà economica e sociale, che ancora oggi, né più né meno che in qualunque periodo storico, vede contrapposti gli interessi di parti differenti della società.
Ogni volta che un governo decide come utilizzare le risorse economiche del paese, può farlo con un occhio di riguardo ai ceti più bisognosi o a quelli dominanti. Questa, comunque la si voglia chiamare, è ancora oggi una scelta di sinistra o di destra. Se, per esempio, agisci a favore della qualità della sanità e dell’istruzione pubblica, e in genere del welfare state… se ricerchi meccanismi che possano incentivare le imprese ad assumere a tempo determinato… se combatti le infiltrazioni mafiose nella cosa pubblica…. stai facendo una cosa di sinistra. Se fai scelte opposte, stai facendo una cosa di destra. La realtà dice il vero più di ogni parola.
Approfondendo e in parte contraddicendo quando diceva Arlo, analoghe considerazioni sono possibili per il termine indie. Non ha volore perché ci sembra divenuto troppo vago, equivoco, omnicomprensivo? Pazienza, lo si può anche abbandonare e sostituire con qualche altro. Ma l’appannamento di un termine non implica la scomparsa delle realtà che quel termine designava.
La realtà è che ancora oggi esistono, tra coloro che fanno musica, attitudini differenti. Non tutti i musicisti sono uguali, non tutti si pongono gli stessi obiettivi né si muovono sulle medesime coordinate. E ancora oggi ci sono tanti musicisti e appassionati che si ostinano a tenere in vita quello spirito che un tempo identificavamo, appunto, con la parola indie.
MS: Sostituisco gli Skiantos con Qualcuno Era Comunista di Gaber nel mio ipotetico immaginario di riferimento dopo aver ascoltato le vostre risposte. Penso sconsolato a concertazzi tipo quelli del Primo Maggio romano, capaci di radere al suolo qualsiasi idea anche romantica noi si avesse della sinistra, mi chiedo quale quindi è il ruolo di noi musicisti, produttori, giornalisti in una realtà che non possiede più uno diffusa ideologia di “pensiero contro”, ma comunque continua a muoversi in una modalità underground (altro vocabolo su cui ci sarebbe da esprimere parere a mio avviso negativo, se ancora usato nelle modalità originarie; anzi per cortesia fatelo e dite la vostra).
AB: Il ruolo è di fare cose e cercare di proporle a un pubblico, limitato o vasto che sia. Perché è quello che sappiamo fare. Almeno per me è così. Non mi pongo la domanda se sono underground e che ruolo debba avere una cultura underground. So di esserlo da sempre. Ho scelto di non stare con l’industria, di starne ai margini, pur avendo “peccato” un paio di volte, la prima pubblicando dati in licenza alla Sire/Warner Bros International, la seconda facendo distribuire i dischi Materiali Sonori dalla CDG/Warner. Ma non me ne pento. Mi ha aiutato a comprendermi e a capire quello che faccio e da che parte stare. L’industria discografica non fa per me. E ti giuro che non è come la volpe con l’uva. L’industria discografica ha dei meccanismi, delle regole ai quali mi adatto poco bene. E poi, in fin dei conti, non amo per niente come funziona il sistema capitalista per cui ho cercato di trovarmi una collocazione indipendente, dove potessi esprimere quello che mi andava di esprimere. In fin dei conti, come ha detto Venturi Venturino, scultore nativo di Loro Ciuffenna, paese dove oggi abito, «io non mi sono mai sentito né uno scultore, né un pittore, né un musicista, né un poeta. Io mi sono sentito e mi sento semplicemente un uomo che esprime; esprime per sé e per gli altri». E lo faccio con quanto ho a disposizione. Il mio ruolo? Fare e proporre. Tutto qui.
VN: Underground era in origine una parola onesta e chiara, indicante un’attitudine “altra” rispetto ai (dis)valori della narrazione dominante. Il fatto che oggi la si senta spesso usata a proposito di “wanna-be-mainstream”, del tutto consustanziali all’ideologia imperante, è l’ennesima conseguenza di quel processo di svuotamento dei significati nel mondo “post-ideologico” del quale parlavo poc’anzi.
Tale processo non significa che non esista più un “pensiero contro”. Arlo ha ogni ragione nel dire: «so di essere underground da sempre». Se le parole possono essere usate in modo contraddittorio, i comportamenti (e, nel caso di artisti, le loro produzioni) chiariscono meglio di ogni definizione le reali scelte di campo.
Non conosco lo scultore di Loro Ciuffenna ma la sua frase è bellissima. Mi permetto anche io una citazione, e pure doppia. Si tratta di due frasi dello scrittore Antonio Moresco, che mi sembrano così “giuste”, e tra loro complementari, da averle usate entrambe nel booklet del più recente album della Deadburger Factory.
La prima: «C’è molto buio intorno a noi e a volte sembra di vivere in un paese e in un mondo di morti. Che chi lo può e lo vuole tenga almeno accesa la sua lucina. Poi si vedrà».
La seconda: «Non si combattono solo le battaglie che si è sicuri di vincere, si combattono tutte le battaglie che sentiamo nostre e che ci sembrano giuste. Si combattono addirittura le battaglie che si è sicuri di perdere. Perché altrimenti assumiamo a poco a poco l’anima di ciò contro cui vorremmo combattere».
Mirco, alla tua domanda su quale possa essere oggi il ruolo di quanto rimane del “pensiero contro”, non trovo risposte migliori di queste: sbatterci per quello che ci sembra giusto (battaglia persa in partenza? Probabilmente si, ma fanculo); e tenere accesa una lucina – poi si vedrà.
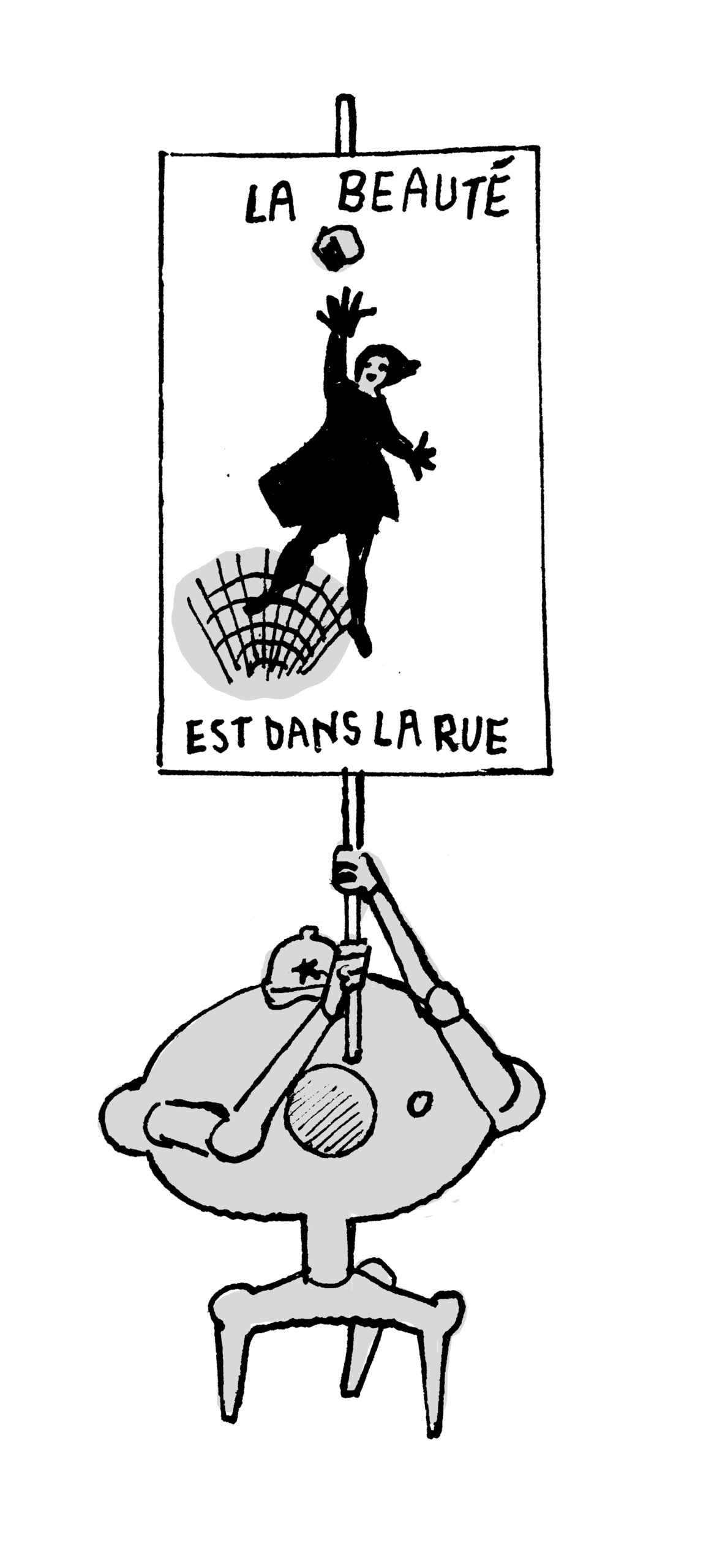
MS: Avviandoci verso la fine di una conversazione che potrebbe continuare ore, amerei togliermi un’altra curiosità chiedendovi cosa ne pensate del sistema di consorterie, sempre pensiate esistano, che iterano le proposte concertistiche o le proprie manifestazioni con le solite playlist di nomi evitando di proporne altri di reale valore artistico, forse perché troppo indipendenti o autonomi, artisti o musicisti o anche giornalisti che mai passeranno a ritirare un premio fedeltà in qualche manifestazione rigorosamente venduta come indie.
AB: Dipende a quali consorterie ti riferisci. Se legate ai meccanismi e alle regole del Sistema, ci sono sempre state e sempre ci saranno. Se pensi alle consorterie diciamo alternative, sono combattuto: o si è maggiormente radicalizzato l’io con il «mi basto e mi avanzo perché sono migliore di te», oppure si tratta di stanchezza, di perdita di curiosità. Perorare una causa per forza d’inerzia. In ogni modo, in questo momento storico, poiché siamo incapaci di proporre alternative culturali se non legate al passato e quindi superate e inefficaci, sta vincendo il Sistema.
MS: Si Arlo, mi riferivo alle consorterie dei circuiti culturali cosidetti alti, colti o anche quelle che si dedicano anima e corpo al pensiero sempre e comunque alternativo: l’indie-rock. Le altre, le istituzionalizzate le do ovviamente per scontate.
VN: Sì, le consorterie ci sono sempre state, originate da interessi economici o paraocchi mentali o meschinerie assortite. Però c’è sempre stato anche chi si è dato da fare per promuovere le proposte artistiche nelle quali credeva. Quello che oggi è cambiato è che le cose si sono fatte più difficili (e ancora meno remunerative) per chi cerca di promuovere proposte “altre”, giacché il pubblico potenzialmente interessato ad esse si è molto ristretto rispetto al passato.
È una conseguenza delle mutate modalità di fruizione. La possibilità di ascoltare gratuitamente in rete tutta la musica del mondo non ha allargato gli orizzonti degli ascoltatori, bensì, paradossalmente, li ha ristretti.
L’asserita neutralità del Web («ci puoi trovare tutto il meglio e tutto il peggio, sta a te scegliere») è illusoria. Di fatto, la fruizione in Rete è più congeniale alle proposte banalizzate e massimamente semplificate. Per dire: in politica, la comunicazione social è più consona a chi procede a colpi di slogan (facili, immediati e mendaci) che non a chi vorrebbe affrontare le complessità del reale con disanime ponderate e approfondite (ma che non arriverebbero a nessuno, non essendo comprimibili nei 280 caratteri di Twitter o nei pochi secondi di Tik Tok).
E similmente, per la musica, la Rete è più congeniale a melodie e ritmi facili, che possano piacere al primo ascolto (e, mi raccomando, entro i primi venti secondi di ascolto, altrimenti l’ascoltatore medio skipperà passando a qualcos’altro), che non a brani che richiederebbero, almeno inizialmente, un po’ di tempo e di attenzione.
Tutto questo massifica e mediocrizza il gusto degli ascoltatori, premiando le proposte più standardizzate (si può dire ‘pre-digerite’?).
Alla luce di quanto sopra, promuovere musiche “altre” oggi è probabilmente diventato, come dice Moresco, «combattere una battaglia che si è sicuri di perdere». Il fatto che alcuni si ostinino ugualmente a farlo a me sembra prezioso e bellissimo: a loro tutta la mia stima e la mia gratitudine.
MS: Non badate al mio iterato assaggio ad alto potenziale glicemico, piuttosto date retta a ciò che ora percepisco: è come un’onda di commozione che invade questa terza tazza di cioccolato caldo appoggiata sul tavolino. Io sento di appartenere agli ostinati descritti dal Nistri: loser, esseri orgogliosamente perdenti che insistono comunque nel perseverare diffondendo contenuti per nulla recepibili dai più. Per questo mi viene spontaneo chiedervi quale visibilità – e non mi riferisco a classifiche o similia – potrà mai ottenere chi si occupa di suono non convenzionale in totale indipendenza, in un paese per giunta vittima dei luoghi comuni scambiati per illuminati asceti abbarbicati sull’Appennino o antichi rockettari un tempo anche bravi artigiani imprigionati ora nel malefico artifizio del “come eravamo”.
AB: Com’è sempre stato: avranno una scarsissima visibilità sui grandi media, a patto che non siano considerati un grazioso oggetto esotico da fagocitare e poi esibire in qualche estroso circo mediatico. D’altra parte, o stai alle regole del Sistema o ne stai fuori. In fin dei conti, se il suono non è convenzionale, non potrà mai avere una grande diffusione. Sta nelle regole del gioco.
VN: Sottoscrivo, aggiungendo però che non è mica obbligatorio che un musicista indipendente debba essere “imprigionato nell’artifizio del come eravamo”.
È cosa buona e giusta coltivare un certo tipo di attitudine che ha le sue radici in stagioni passate, ma secondo me bisognerebbe poi cercare di usare quell’attitudine per approcciarsi al tempo e alla realtà in cui viviamo qui e adesso.
Nel momento in cui smette di confrontarsi con il mondo che lo circonda, lo spirito “contro” smette di essere tale.
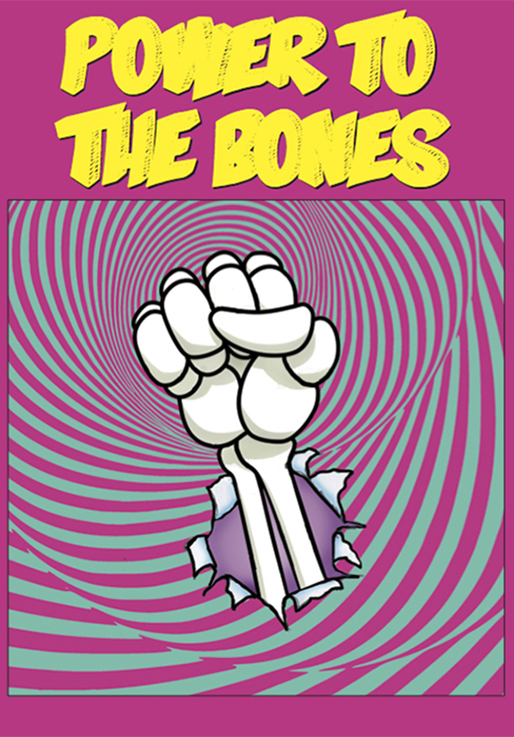
Aggiungo un’ultima cosa, sull’argomento “visibilità”. Premesso che un po’ di visibilità farebbe piacere a qualunque musicista, anche al più scalcinato degli underground, è comunque evidente che non questa è la molla che spinge qualcuno a fare scelte artistiche “fuori dal sistema”. La molla è un’altra, e puramente interiore.
Cito le parole di un marginale e dimenticatissimo artista degli anni ’60, Marzette Watts (sassofonista free jazz, sound engineer, pittore, attivista politico), che ho scoperto in un articolo retrospettivo sulla gloriosa etichetta ESP-Disk: «se sei un artista, ti è stato donato un talento, non puoi pretendere anche i soldi. Non è per il denaro che si fa arte, ma perché spinti da una pulsione irresistibile».
Naturalmente non tutti la pensano allo stesso modo. Billy Corgan nel 1995 dichiarò: «Se l’attenzione e il successo a poco a poco abbandonassero gli Smashing Pumpkins, non so che farei della mia vita, probabilmente mi ucciderei. Non ci sarebbe alternativa. Suppongo sia questa la vera pregnanza del rock’n’roll».
Ambedue le posizioni sono legittime, ma personalmente quella di Corgan mi fa zero simpatia, mentre sento a me più vicina (e persino più rock’n’roll, benchè facesse free jazz) quella di Watts.
Penso alle ultime parole di Nistri mentre immergo il cucchiaino nell’ultimo rimasuglio di bianca neve rimasta a coprire il caldo e dolce lago che profuma di cacao, penso alla sua citazione riguardante un gruppo che so entrambi non abbiamo mai valutato né amato, forse per il suo appartenere ad un mondo, per noi ancora barricaderi nonostante tutto: alieno, di classifica, in fin dei conti assolutamente

