Un «insopprimibile senso di vivere». L’«inverno freddissimo» di Fausta Cialente
di Francesca Rubini
«Non vedevo l’inverno da ben ventisei anni, avevo completamente dimenticato tutti i suoi aspetti e le sofferenze che possono accompagnarlo», ricorda Fausta Cialente in un’intervista degli anni Settanta. Dal 1921, quando ventitreenne raggiunge la famiglia del marito Enrico Terni ad Alessandria, Cialente ha vissuto e scritto l’Egitto: una lunga insistente estate sconvolta dalla Seconda guerra mondiale (che vede l’autrice impegnata nella lotta antifascista al Cairo) e interrotta nel 1947 dal ritorno nell’Italia del neorealismo, dove continua la militanza politica fra le pagine culturali dell’«Unità» e di «Noi donne».
Dal nomadismo di un’esistenza sempre in fuga verso un altrove (alla fine degli anni Cinquanta ricomincerà a viaggiare, per poi stabilirsi e morire, nel 1994, in Inghilterra), lontana dai clamori della scena letteraria, restano splendidi racconti di ambientazione levantina e di interni borghesi, rubriche radiofoniche, decine e decine di servizi giornalistici, importanti traduzioni, e alcuni tra i romanzi più belli del Novecento. Libri sempre fuori tempo, spesso stonati rispetto al clima culturale del momento, sostenuti dalla critica e presto dimenticati, ma ciclicamente svelati come tesori nascosti, perfino inattesi.
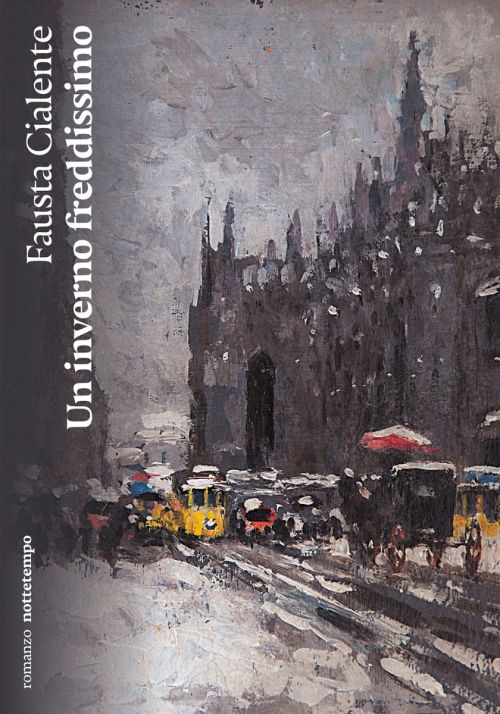
L’ultima riscoperta è quella di Nottetempo, guidata dalla sapiente cura di Emmanuela Carbé, che suggerisce ai lettori un testo assente nelle librerie da oltre quarant’anni. Pubblicato nel 1966 nel clima dello sperimentalismo e della neoavanguardia, Un inverno freddissimo è un romanzo dal carattere quasi teatrale che mette in scena, nel rigido inverno del 1946, la vicenda di Camilla, madre separata dal marito che mantiene figli, nipoti, vicini di casa in una soffitta abusiva, piccolo ricovero contro il freddo di una civiltà lacerata e in lenta ricomposizione.
A Milano, città «così gravemente sfregiata», «stordita e inerte», in cui la guerra ha offeso l’inviolabilità degli luoghi privati (le finestre dei palazzi sono «occhiaie vuote» aperte sull’abisso dei palazzi sventrati), la protagonista si ostina a ricostruire nel perimetro della soffitta la perduta corrispondenza fra gli individui e lo spazio, fra le coscienze e la Storia. La rieducazione alla vita passa per i quieti sospiri delle stuoie, i soffi del camino, lo scricchiolio dei mobili, i gemiti nelle grondaie dove si annidano le ambizioni e il malessere degli abitanti (alcuni destinati ad essere sommersi, altri salvati), i loro egoismi, i loro conflitti, le loro solitudini.
La soffitta non è un’isola felice nel mezzo della metropoli distrutta, ma il frammento di un grande crollo storico che riflette la sorte di due generazioni (quella degli adulti che hanno ridotto il mondo in macerie; quella dei più giovani, che pretendono di ereditare un mondo a misura dei propri desideri), le contraddizioni di un intero paese colto nel passaggio fra lo slancio civile della Resistenza e la nuova corsa al benessere materiale della ricostruzione.
Nella cronaca di un’anonima quotidianità, la prosa intimamente suggestiva e la raffinata tensione stilistica di Cialente costringono a trattenere lo sguardo (senza compiacimenti sentimentali e senza eroismo) sulla paura, la privazione, l’incertezza dell’esistenza interrotta e per sempre ferita. Quando gli esseri umani si scoprono incapaci di immaginare il futuro, la realtà diventa un inverno «feroce», «maledetto», «terribile», che un solo personaggio è in grado di soffrire e superare.
Camilla è la sponda luminosa del romanzo e conserva i termini di una denuncia radicale: priva di qualsiasi preparazione ideologica e di contrassegni esclusivi ma dotata di una spontanea immunità al pregiudizio, di buon senso e di vivace intelligenza etica, la moglie-madre-massaia costruisce la sua identità fuori dalle categorie della morale borghese, rifiuta il suo ruolo di cura come annullamento e difende sopra ogni altra responsabilità il rispetto per se stessa e il suo diritto alla felicità. Non una figura esemplare, ma un carattere esposto alla fragilità, condannata nonostante tutti gli sforzi a fallire nei propri doveri, ma che al cedimento degli affetti e all’incoerenza del destino continua ad opporre un «insopprimibile senso di vivere».
È con questo personaggio che Cialente sfida il tempo freddissimo delle sconfitte individuali e collettive, in un libro che racconta il lutto e il rimpianto, il bisogno difficile e irrinunciabile di vivere attraverso la perdita, senza indulgenza e senza conforto, ma senza disperazione. Scoprendo che per scrivere serve «rimpiangere e soffrire […] ma è pure necessario ambire, godere, stringersi ad altri esseri umani, riceverne il calore, con qualcuno procedere insieme». E che per vivere, forse, non è così diverso.

