L’educazione democratica e il falso progressismo pedagogico
di Giovanni Carosotti
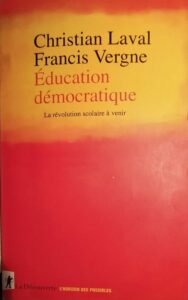
É molto probabile che l’ultimo libro di Christian Laval e Francis Vergne sulla scuola (Éducation démocratique, La Découverte, Paris 2021) non venga tradotto in italiano, come già accaduto ad altri lavori dei due studiosi dedicati allo stesso tema. Se in effetti alcuni riferimenti richiamano lo specifico contesto francese, pure il quadro complessivo che ne emerge, storico-politico-culturale, è decisamente più comprensivo, e costituirebbe un punto di riferimento decisivo anche in Italia, per fare chiarezza non solo sul progetto reazionario e neoliberale che guida la politica di riforma della scuola da ormai troppo tempo, senza trovare alcuna reale opposizione neppure tra le forze progressiste, ma soprattutto per individuare i giusti presupposti di una politica scolastica che il mondo della sinistra dovrebbe fare propria senza divisioni interne.
La scuola, oggi più che mai, è –secondo i due studiosi- istituzione ormai devastata dai poteri economici, che intendono appropriarsi in toto del processo di trasmissione del sapere tra le generazioni, con l’intento di rendere senso comune quei principi del capitalismo neo liberale, destinati a perpetuare la diseguaglianza e a impedire che negli allievi si sviluppi la capacità di immaginare qualsiasi azione trasformativa. Per contrapporsi a tale disegno risulta necessario proporre un paradigma radicalmente alternativo, quello dell’«educazione democratica».
Un paradigma il cui progetto è «superare il sistema capitalistico», per fondare una «democrazia sociale ed ecologica inedita». Il sistema capitalistico, nella sua radicale versione neo liberista, che ne rappresenta la forma concettualmente più pura, ha avuto esiti devastanti non solo per il destino del pianeta, ma per aver nel contempo provocato anche una regressione antropologica: «uno degli effetti tra i più tremendi della società dominata dal neocapitalismo, che si avrebbe torto a considerare secondario rispetto alla distruzione dell’ecosistema, è quello della deresponsabilizzazione dell’individuo nei riguardi della vita collettiva e dei doveri che essa comporta», poiché il capitalismo è responsabile della «negazione assoluta dell’autolimitazione responsabile». La lotta contro il capitalismo è parallela a quella per la scuola democratica, in quanto non ci può essere «eguaglianza a scuola se non c’è eguaglianza nel lavoro», ed è impossibile «realizzare l’eguaglianza scolastica indipendentemente dalla trasformazione sociale».
I progetti riformatori della scuola in atto da più di due decenni, invece, pretenderebbero di ridurre «il problema della diseguaglianza a scuola a questione metodologica», ricercando semmai facili soluzioni nella «psicologizzazione e medicalizzazione delle difficoltà scolastiche». L’autentico obiettivo di questo pensiero riformatore è quello di offrire «eguale opportunità di accedere ai processi di valorizzazione», formando però nient’altro che una «mano d’opera subordinata».
«Opporsi al dominio delle tecnoscienze»
La riduzione a questione metodologica dell’insuccesso scolastico, svincolato dalle cause sociali, conduce alla strumentale messa sotto accusa dei docenti, i quali non applicherebbero modalità didattiche innovative, che assicurerebbero i risultati attesi. Da qui la presunzione della nuova scienza pedagogica di costituire una sfera imprescindibile per la pratica d’insegnamento, ma allo stesso tempo da essa separata; alla quale i docenti dovrebbero essere obbligatoriamente formati. Un grande progetto corporativo da parte dei professionisti della pedagogia, non supportato da alcuna certezza epistemologica né evidenza scientifica. Ma che imporrebbe una forte azione di soggettivazione dei docenti, e il loro asservimento a una sorta di pedagogia di stato.[1]
Per i due autori si tratta di un «nuovo maccartismo», che pone «la libertà pedagogica sotto tutela»; certo, nei paesi democratici tale tutela viene esercitata attraverso una «censura sottile», che agisce con «l’imposizione del programmi», con la «prescrizione dei metodi», ma anche con la «richiesta di adattamento alla realtà», ovvero di adeguamento ideologico ai principi (competitività, mercato, imprenditorialità) che dominano la società neoliberale. La scuola, invece, deve rifiutarsi di «seguire l’opinione corrente»; infatti «non è mai l’adattamento all’evidenza che deve dirigere l’educazione, ma la distanza e la contraddizione».
Basterebbero queste analisi per sgombrare il campo dalla risibile affermazione per cui gli insegnanti non solo sarebbero impreparati dal punto di vista pedagogico, ma addirittura rifiuterebbero la disciplina pedagogica in sé, in quanto strumentale e deviante rispetto alla purezza teoretica dei contenuti disciplinari da loro trasmessi. La diffidenza degli insegnanti si spiega invece proprio da un consapevole atteggiamento intellettuale di resistenza verso una caricatura della scienza pedagogica, che Laval e Vegne indicano giustamente con l’espressione «tecnopedagogia», il cui vero obiettivo è quello di ridurre l’istruzione a merce, per sviluppare nell’alunno solo le capacità adeguate a renderlo un lavoratore subordinato, per umiliarne le doti di immaginazione teoretica, piegandole a un principio produttivistico di corto respiro. Lo «scientismo pedagogico» coincide con la «subordinazione della pedagogia alla psicologia», che «ha permesso “alla scienza della psiche” di proclamarsi autonomamente sovrana dell’educazione. Appoggiandosi sull’obiettivazione psicologica, una “doxa” depoliticizzante si è così imposta in pedagogia». Come scrivevano in fondo già nel 1964 P.Bourdieu e J-C.Passeron in un testo fondamentale [I delfini. Gli studenti e la cultura]: «[…] i sistemi pedagogici attualmente conosciuti […] non avendo alcun altro fondamento che quello psicologico, servono di fatto a un sistema che ignora e vuol ignorare le differenze sociali. Non c’è niente dunque di più lontano dal nostro pensiero che il richiamarci alla pedagogia cosiddetta scientifica che, aumentando in apparenza la razionalità (formale) dell’insegnamento, permette alle diseguaglianze reali di pesare più di prima, ma con maggiori giustificazioni di prima».
Quale didattica per la scuola democratica?
Ma come immaginare –e, soprattutto, come costruire- una scuola che sappia opporsi alla deriva apocalittica prodotta dal neocapitalismo? Laval e Vergne affrontano la questione a partire da diversi ambiti, tutti fra loro però strettamente connessi. L’organizzazione interna delle scuole, gli obiettivi educativi, la condizione del docente e i contenuti dell’insegnamento.
Per prima cosa, una scuola democratica non può che concepirsi come un «Commune», un luogo cioè dove, pur nel rispetto delle funzioni, tutti coloro che ne fanno parte devono confrontarsi alla pari, in vista della formulazione di un progetto didattico condiviso. A partire dal 1968, si è assistito alla trasformazione «dalla scuola caserma alla scuola impresa». Il nuovo modello di scuola deve invece prevedere «un’assenza di gerarchia», con il Dirigente Scolastico eletto dagli insegnanti suoi colleghi, e non esonerato dall’insegnamento. Anche gli organi collegiali devono prevedere una loro ricomposizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (una partecipazione addirittura obbligatoria per i genitori), sempre però nel riconoscimento delle funzioni, in modo da evitare «l’appropriazione familiare della scuola», intesa come «luogo di beneficio privato».
Decisivo, per la realizzazione di una scuola realmente democratica, è il mantenimento del gruppo classe, da svilupparsi proprio in senso comunitario; e da opporsi alla falsa socializzazione che introdurrebbe una frantumazione della classe stessa («residuo del Novecento», l’ha definita con dubbi riferimenti culturali il ministro Bianchi nel suo libro sulla scuola), e che si configurerebbe in realtà come un’atomizzazione delle figure discenti, che lascerebbe indifeso -ovvero privo di strumenti sia culturali sia di solidarietà- il singolo alunno nei confronti dei processi di soggettivazione, di disciplinamento e di condizionamento, messi in atto nei suoi confronti. La classe deve essere eterogenea e in essa devono dispiegarsi confronti socio-culturali attraverso i quali sviluppare una reale dimensione dell’incontro e della solidarietà. Un modello comunitario che esclude, per forza di cosa, la degradante «concorrenza fra scuole».
Per quanto riguarda gli obiettivi che l’educazione democratica deve prefiggersi, in contrasto con l’«utilitarismo educativo», lo «psicologismo individualizzante» e il «patrimonialismo conservatore», bisogna valorizzare negli allievi quella facoltà che gli autori chiamano «immaginazione pedagogica», ovvero «sviluppare una soggettività capace e desiderosa di pensare altrimenti», in modo da «liberare dalla routine dell’alienazione»; l’allievo non dovrà solo socializzare, ma essere capace di «partecipare e determinare collettivamente le regole comuni». L’educazione, «bene comune e non merce», deve rifiutare la concezione proprietaria insita nell’espressione «capitale umano» ed essere «a profitto della conoscenza, dell’arte e della cultura». La falsa idea di “individualizzare il processo di apprendimento”, e la volontà conseguente di «differenziazione dell’offerta pedagogica» non fanno in realtà altro che «rafforzare la segregazione sociale». L’insegnamento, in altre parole –e qui il richiamo dei due autori è alla lezione di Jaurés e Freire- deve produrre senso, e lo può fare attraverso impostazioni che intenzionalmente prendono le distanze dall’utilitarismo pedagogico incentrato sul concetto di “capitale umano”.
Frequente è il riferimento dei due autori alla lezione di Dewey. Non direi però che si possa parlare, come si legge su qualche sito francese, di adesione incondizionata alla teoria dell’educazione del grande filosofo americano. Da una parte i due autori ci tengono a distinguere la lezione originaria di Dewey da tanto «pragmatismo deteriore» che «tende a contrapporre l’universo autonomo del giovane al mondo adulto, a privilegiare il metodo pedagogico a detrimento dei contenuti del sapere, a sviluppare il “fare” indipendentemente dall’ “apprendere”»; ma, soprattutto, non condividono l’idea di Dewey di «non separare la didattica dalle esperienze sociali allievi». Per Laval e Vergne, invece, per «preparare l’allievo all’azione critica», come lo stesso Dewey auspica, e «suscitare il suo interesse», non bisogna «partire dall’esperienza concreta», bensì essere consapevoli del «valore del sapere apparentemente sganciato dalla realtà», con il proposito di «far uscire gli allievi dall’esperienza immediata» e farli «riflettere razionalmente sulla situazione reale del mondo». E proprio in questo risiede la «vera difficoltà dell’educatore». È sbagliato, da questo punto di vista, sottovalutare il «valore della teoria» e del «concettualismo astratto», inteso come «capacità dello spirito di costruire problemi propriamente teorici, stabilire fatti distanti dalla realtà che si percepisce». Solo in questo modo è possibile «dotare i cittadini di strumenti di comprensione del mondo e fornire loro strumenti di resistenza».
La comunicazione didattica deve, invece, donare al vissuto quotidiano una significazione storica e sociale, accompagnando gli alunni verso un processo di liberazione (dalla dimensione alienata dell’esistenza) individuale e collettivo. Laval e Vergne contestano la tendenza attuale a promuovere un abbassamento del livello dei contenuti didattici, e insistono gramscianamente sul dovere di rendere accessibile la cultura “alta” a tutti. Pur in un quadro in cui viene abolita la selezione e la bocciatura. Un principio tutt’altro che impossibile, ma obiettivamente ancora distante dalla mentalità tradizionale con cui alcuni colleghi interpretano la loro professionalità in riferimento alla valutazione. Un atteggiamento che impedisce l’individuazione di nuove strategie per produrre motivazione e coinvolgimento, senza ricorrere allo squallido “saper fare” sostenuto dalla «tecnopedagogia» neoliberista.
L’abbassamento del livello disciplinare, infatti, equivale ad «adattare il sistema educativo alle norme del neocapitalismo e dell’individualismo liberale», poiché «l’adattamento verso il basso rafforza le disuguaglianze», destinando ciascuno a ciò che è più adatto alle sue condizioni di partenza. La democrazia scolastica prevede sì l’«autonomia pedagogica negli alunni», ma non la confonde con «l’anarchia dell’individuo» (una condizione simmetrica all’«autoritarismo pedagogico»), in base alla quale si vorrebbe che «gli allievi siano più avanti e decidano autonomamente cosa apprendere»; una tesi tanto cara al nostro attuale ministro, in particolare quando si riferisce al digitale, peraltro considerato da Laval e Vergne, «uno dei nuovi nemici, che si reclamano portatori della modernità. […] non meno pericolosi per la libertà di pensiero e la capacità di agire, anche per il carattere seducente del loro linguaggio».
Altre sono le priorità: «La cultura comune democratica ed ecologica non si confonde neanche con “il principio comune delle competenze” come le definiscono l’OCSE e la Commissione Europea […] Ne consegue che la scuola egualitaria deve garantire a tutti gli alunni un apprendimento il più completo possibile della lettura, della scrittura e del calcolo e che sarebbe sbagliato prendersi gioco di questa esigenza fondamentale […]». Ci sembra che l’idea di un sapere unitario e universale, difeso da Laval e Vergne, corrisponda a quello che in tempi recentissimi ha espresso anche in Italia Giulio Ferroni: «l’attenzione all’ambiente chiama direttamente in causa le scienze, impone una stretta convergenza tra discipline umanistiche e discipline scientifiche. […] la convergenza tra discipline diverse nel quadro di un umanesimo ambientale non può prescindere da un confronto con i corpi concreti delle stesse discipline, non può esaurirsi nel gioco indeterminato delle competenze, di una flessibilità indeterminata, orientata verso un problem solving che ignori le condizioni in cui il problema è scaturito» [Ferroni, La Scuola del Futuro]. Analogamente, Laval e Vegne: «la situazione attuale sollecita una nuova “antropologia”, che sia alla base di un articolazione ragionata della filosofia, della storia-geografia, delle scienze sociali e delle scienze della vita e della terra». L’obiettivo è quello di far intendere come il sapere sia il «risultato di un’attività collettiva di portata universale», e di mostrare come «le scienze sociali non siano indipendenti dalla natura»; questo consente, nello stesso tempo, di «prendere coscienza del processo di costruzione del sapere che acquisiamo». Ovvero, lo stesso sviluppo di autocoscienza cognitiva, individuale e collettiva, non viene considerato patrimonio esoterico, ricetta segreta di iniziati pedagogisti che la offrono a ingenui insegnanti -che nient’altro saprebbero esercitare se non un’azione di comunicazione caratterizzata da puro spontaneismo-; ma i fondamenti di una pedagogia dell’emancipazione sono presenti potenzialmente nelle stesse discipline, ed è la professionalità del docente che fa emergere tale potenzialità.
Per una figura docente liberata
L’insegnante della scuola democratica non può che porre come prioritario obiettivo il condurre gli studenti a immaginare un percorso personale e collettivo di liberazione; egli deve contribuire a renderli sensibili alle condizioni necessarie perché il mondo del futuro «sia ancora vivibile». Una possibile innovazione -insistono i due studiosi- non può avvenire dall’alto, come sostengono i riformatori, ovvero con l’applicazione di «buone pratiche concepite da una cerchia di esperti»; ma da autonomi, «collettivi critici di insegnanti e ricercatori», svincolati da ogni autorità esterna.
La scuola democratica non può infatti esistere senza riconoscere completa libertà pedagogica al docente, sottraendolo a qualsiasi pressione gerarchica, vuoi dei Dirigenti, vuoi dei pedagogisti o di qualsivoglia esperto; deve invece coltivare una continua relazione con tutte le altre componenti della comunità scolastica, per individuare insieme gli obiettivi critici ed emancipativi del processo educativo, senza confusione però di ruoli. Laval e Vergne sono consapevoli dello stato di demoralizzazione, sofferenza, addirittura di «violenza psichica» cui sono sottoposti gli insegnanti. Il loro essere costretti a esercitare la professione «in un terreno ostile».
Di fronte a questa situazione «dare senso politico alla propria azione è il miglior modo per reagire alla demoralizzazione»; l’ «erotizzazione del sapere», che essi sono in grado di praticare, è l’arma da contrapporre alle continue mansioni burocratiche e alle innovazioni neuro pedagogiche.
Nella Conclusione, segue una straordinaria descrizione dell’educatore democratico, che si interroga:
- «sulla relazione tra la sua azione e il mercato»;
- «di quale cittadino avrà bisogno il mondo perché sia ancora vivibile e abitabile»;
- «quale sorta di educazione politica deve essere messa in atto oggi»;
- come «operare per la transizione ecologica del mondo» nella convinzione che «un altro mondo è possibile»
- come «proporre alle nuove generazioni un orizzonte politico, sociale ed ecologico desiderabile».
Sicuramente si tratta della forma di «insegnamento più invisa alle classi dominanti», che può sembrare per alcuni tratti utopica; ma che rappresenta invece l’unica possibilità per reagire all’orwelliano processo di soggettivazione in atto verso docenti e studenti. L’unico in grado di alimentare la resistenza nei confronti di chi vuole far credere –facendo della scuola uno degli strumenti in questo senso più efficaci – che non sia possibile pensare un mondo diverso da quello dominato dall’economia di mercato.
[1] Pericolo non chiaro a tutti, neanche a sinistra, come dimostra lo strumentale intervento di Massimiliano Fiorucci su Il Manifesto del 22/01/22 (Caro canfora, la formazione non è un belletto), totalmente privo di argomentazioni, in risposta a una giusta valutazione di Luciano Canfora, che identificava questo nuova pretesa pedagogistica con una pratica di indottrinamento e, aggiungiamo noi, di definitivo annullamento della libertà d’’insegnamento.

