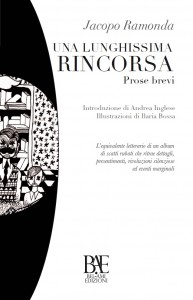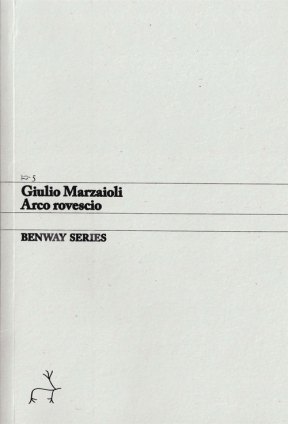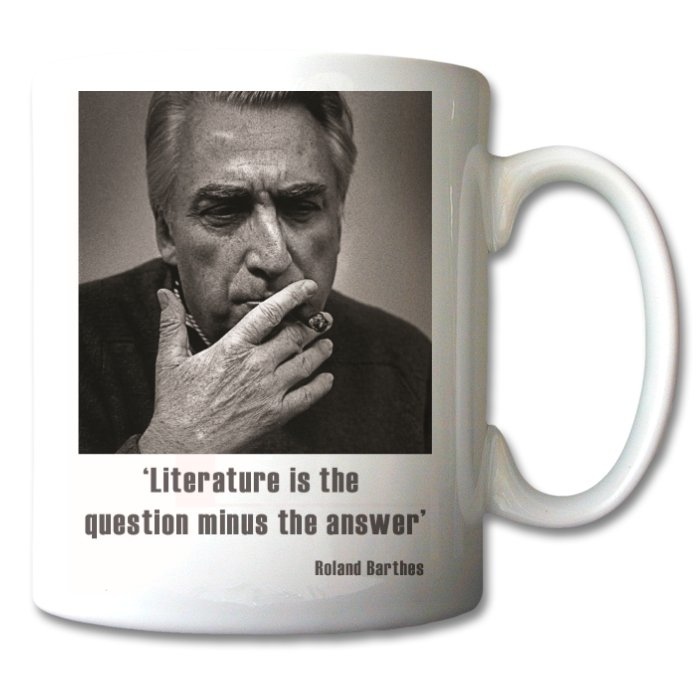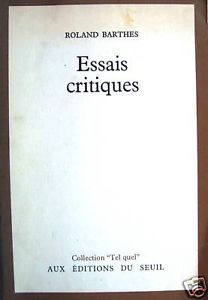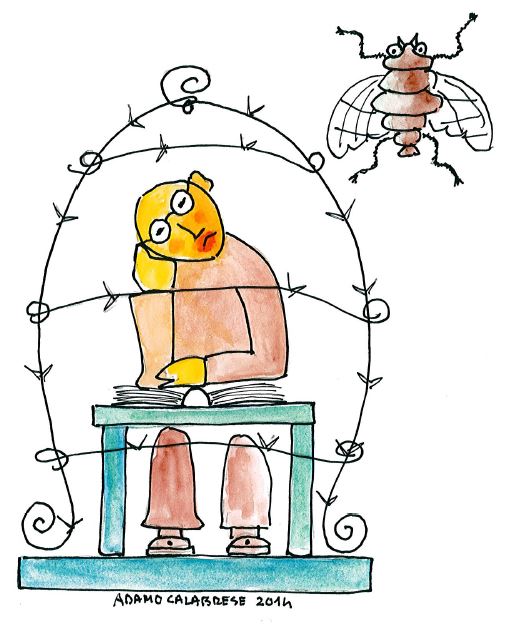Da “Una lunghissima rincorsa”
L’arrivo dell’Uomo
di Marisa Fasanella
(Le prime pagine di Nina, il romanzo di Marisa Fasanella pubblicato da Editori Internazionali Riuniti, 2014)
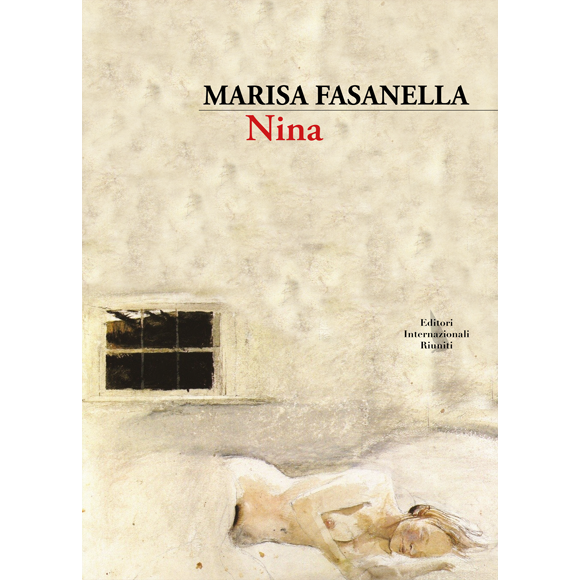
L’Uomo arrivò alla città dei due fiumi con la cremagliera delle diciassette e quaranta. I barellieri, quando scese dal treno, si portavano via i restituiti dal fronte sulle lettighe, tra i batticuori patriottici dei soldati, una folla oceanica, e il grido solitario di qualche anarchico irriducibile. Camminava indietro rispetto agli altri e nessuno avrebbe scommesso un pidocchio sui suoi gradi. Indossava una camicia pulita, un cappello di paglia, e aveva l’aria di un viaggiatore qualsiasi. Il suo passo zoppo, in contrasto con la fermezza dello sguardo, finiva col diventare un dettaglio di poco conto. Era più alto della media e sembrava possedere nelle braccia la forza che gli mancava nelle gambe. Attraversò la stazione e seguì i barellieri all’istituto chirurgico, dove era stata allestita una sala operatoria per i feriti più urgenti. Quando si presentò al distretto e dichiarò di essere l’ufficiale medico che aspettavano, il Superiore della compagnia lo guardò serio come un morto e concluse che aveva poco del soldato. Gli assegnò un letto in una camerata grande come una piazza e un cesso in comune, in uno dei convitti requisiti e trasformati in alloggi per un migliaio di soldati afflitti dalla blenorragia dalla diarrea e dalle cimici che per motivi di disciplina e di strategie militari, ignote alle truppe, stazionavano nella città.
Si portava dietro una valigia con la biancheria e due vestiti, pesante e leggero, il baule dove erano custoditi i libri, le lettere di sua madre e i ritratti di famiglia, un sacchetto di cuoio con la sabbia del deserto e delle vecchie pianelle di almeno tre numeri più piccole.
Il Superiore lo ragguagliò sui comportamenti che un ufficiale era tenuto a osservare, soprattutto in tempi di guerra e in una città che si era mostrata sin da subito ostile. “Un buon soldato gira armato, indossa l’uniforme e si presenta al comandante del distretto” gli disse. “Non si lasci abbindolare dalla folla che ha visto alla stazione, ci caccerebbero via a pedate, se potessero”.
L’Uomo gli rispose che amputare arti e sbrogliare viscere mal si adattavano alla costipazione di una divisa e in quanto ai rivoltosi, se avessero deciso di tendergli un’imboscata, di sicuro non li avrebbe fermati una giubba con le stelle appuntate sul bavero. Si sarebbe cercato un alloggio e avrebbe denunciato le miserevoli condizioni di vita dei soldati: in quell’ambiente ce n’era abbastanza per un’epidemia di colera, con tutti quei germi che galleggiavano nei cessi, i pidocchi e le divise lerce.
Il Superiore, quand’era fresco di studi, aveva partorito egli stesso un seme di rivolta, e sapeva come domarlo. “Accetterà come tutti gli altri quello che non potrà cambiare” gli disse, e lo lasciò al suo periplo.
L’Uomo si affacciò alla balaustra del balcone e lo seguì con lo sguardo nella piazza, dove si scaricavano discese e gradinate come lavine e le donne richiamavano dalla strada i figli svogliati e magri come chiodi e le porte delle botteghe si richiudevano sulla mercanzia. Gli mancò il letto della sposa bambina, morta il giorno dopo le nozze per il morso di una scarpa che le piagò il calcagno e nessuno curò a causa dei ricevimenti che prima della cerimonia nuziale erano andati avanti per giorni fino all’alba.
Gli venne in mente la biblioteca di suo padre e le cosce umide delle serve che lo avevano liberato dal piacere solitario. Un esercito disfatto invase l’edificio come uno sciame d’api e si riversò nelle camere in silenzio sui materassi fradici di sudori raffermi senza spogliarsi.
La caffetteria alle spalle della chiesa madre serviva ancora un goccio di rosolio e un caffè allungato agli ultimi clienti della notte: redattori e copisti che aspettavano la pagina del giornale ancora in stampa e commentavano le notizie. L’Uomo ordinò una tazza di acqua bollente dove sciolse una punta di tè, poi accese un mezzo sigaro e ascoltò i loro discorsi. Discutevano della necessità di chiudere le porte ai mendicanti, venivano dai paesi vicini e si azzuffavano agli angoli delle strade invocando il domicilio di soccorso.
Il proprietario del caffè si avvicinò al suo tavolo per dirgli che non avrebbe servito altro e l’Uomo gli chiese dove poter trovare un alloggio. “Ne ho necessità” aggiunse.
“E tu a me lo vieni a chiedere? Dopo che le autorità si sono accollate il peso di alloggiarvi persino nelle scuole e pure nei convitti, e gli studenti non trovano ricetto e finiscono nei ricoveri delle puttane pronte a sverginarli per pochi spiccioli”.
“Sono un medico” affermò.
“Ma pure un soldato”.
[…]
Aveva scelto quel mestiere per obbligo verso il barone suo padre, militare di carriera prima di lui e dopo suo nonno, e lo aveva umanizzato con gli studi di medicina. Leggeva Marx con la complicità di sua madre, suonava Strauss e amava la poesia. Unico figlio maschio, nato dopo cinque femmine, era cresciuto tra le sottane delle donne, ma aveva anche camminato scalzo e si era sporcato di fango con i figli dei coloni, conosceva i sudori acidi della terra rivoltata di fresco, le braccia nerborute doloranti per il peso delle vanghe che scavavano buche profonde come pignatte. Il barone suo padre, quando era tornato a riprendersi la proprietà e si era messo a complottare con i braccianti riformisti, lo aveva esiliato in un convitto riservato ai figli dei militari, dove forgiavano i futuri allievi delle accademie, e l’obbedienza alle regole era diventata il suo rosario quotidiano, una violenza che era riuscito ad arginare con i libri e la scrittura. Leggeva alla luce di mozziconi di candele e scriveva lunghe lettere alla madre. Il suo futuro era stato già deciso, e il giorno che era tornato a chiedere il permesso di studiare medicina, il barone aveva ceduto solo dopo la promessa di dismettere gli abiti civili e di non avanzare pretese sul patrimonio di famiglia.
La moglie bambina l’aveva conosciuta durante una delle sue brevi visite alla famiglia, era la figlia del guardacaccia e abitava in uno degli alloggi della servitù. D’estate quelle casette diventa vano un forno e le donne cercavano sollievo dalla calura nei corsi d’acqua annegandoci con tutte le sottane. Durante l’inverno sbattevano i denti anche col fuoco acceso. L’Uomo l’aveva vista la prima volta curva sotto un fascio di legni secchi, un metro e una noce di ossa e pelle bianca ammantata di capelli corvini, e aveva deciso di sollevarla da quei pesi.
L’annuncio del suo matrimonio aveva colpito il barone come una frustata, sradicò l’albero più bello del giardino, una magnolia di duecento anni che aveva abdicato alla vecchiaia e partoriva ancora fiori candidi e profumati, e al suo posto piantò sette cactus. Gli disse che non gli sarebbe bastato il gineceo di un sultano per sollevare dalla povertà le donne bambine che si prostituivano ai lati delle strade, o che morivano di stenti nei sobborghi della città: “Lì c’era la vera miseria, non qui, dove il medico viene a visitarle e hanno pane a sufficienza”.
Il matrimonio fu celebrato nella cappella della residenza, ma il barone non si presentò. C’erano circa duecento invitati tra nobili e meno nobili, e una folla di poveri che si accalcò già dalle prime ore del mattino sul piazzale antistante il palazzo per godersi la rappresentazione di una favola destinata all’eternità. La moglie bambina durò un solo giorno. I suoi piedi si erano dilatati nelle pianelle che le costruiva il padre con cuoio riciclato e senza nervature. Quando glieli chiusero nelle scarpe di pelle nuova di capretto non riusciva a muoverli e camminava sulle punte, provvisoria come una foglia secca. Il calcagno si coprì di pustole purulente e provò un dolore più forte della povertà, ma non trovò il coraggio di lamentarsi e la sepsi se la portò via prima dell’alba. C’erano già i fiori bianchi del matrimonio e i confetti che le serve avevano raccolto dai gradoni della chiesa, e l’accompagnarono al camposanto ancora vergine.
La seppellirono nella tomba di famiglia, e il titolo di nobildonna consolò il guardacaccia, che ritornò a mangiare zuppa di cicoria annegata di lacrime, a cacciare lepri e fagiani per il padrone e a sorvegliare i limiti della proprietà altrui. Il barone, per ingraziarsi i coloni, dispose che le venissero resi gli onori riservati alle persone di famiglia, listò a nero il portone e ordinò al prete le messe perpetue per salvarle l’anima, ma il corteo funebre si disperse come un nugolo di vespe quando apparve dietro il feretro.
Da “Sibber”
1.
Questa non è una storia come tutte le altre. Non lo è perché io mi butto via ogni giorno e la storia l’ho cominciata proprio adesso. Quindi, almeno questo lo posso assicurare. Mi butto via in modo sistematico, un po’ alla volta. Apro il giornale, guardo le immagini, i titoli, il taglio della pagina, l’insieme come un’unica immagine. Mi alzo, mi muovo per la stanza: passo molte ore alla finestra. E andrei avanti sempre così, se fossi coerente, se solo ogni tanto non mi facessi prendere la mano dallo studio, che è rimasto la mia ultima risorsa.
Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
di Nicola Fanizza
Il libro di Federico La Sala – Della Terra, il brillante colore, Prefazione di Fulvio Papi, Edizioni nuove scritture, Milano 2013 – si configura come un viaggio nei sotterranei della cultura occidentale. Il protagonista del viaggio è il classico flâneur, che ha la straordinaria capacità di cogliere nell’opacità delle immagini del passato la luce che rende visibile le «perle» e i «coralli»: ossia tutto ciò che, sottraendosi al morso del tempo, è destinato all’eternità!
Nella prima parte del suo lavoro, La Sala adopera una sorta di «scandaglio archeologico» per ricostruire la preistoria del presente: ossia la genealogia dei concetti che strutturano tutt’oggi il nostro modo di pensare e di stare nel mondo. Si tratta di una ricostruzione che, pur comportando il rifiuto sistematico della ricerca, non rinuncia tuttavia alla contestualizzazione dei saperi in gioco. L’origine dei modelli del pensiero, infatti, non viene individuata tanto nella tradizionale storia della filosofia, quanto nella storia delle istituzioni totali: ovvero nella dimensione del Sacro, che con i miti e le pratiche rituali permette – ieri come oggi – la comunicazione fra gli individui e dà un senso alla nostra stessa vita.
Il «luogo d’inizio» è la piccola chiesa di S. Maria del Carmine, a Contursi Terme. Qui nel 1989 – in seguito ai lavori di restauro approntati dopo il terremoto del 1980 –, è stato scoperto un poema pittorico di un ignoto carmelitano degli inizi del XVII secolo. La pittura è espressione dell’immaginario rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana – Prisca Theologia – in sequenza col Cristianesimo. Il poema pittorico di Contursi descrive il viaggio iniziatico di un pellegrino che, accompagnato da dodici Sibille e dodici Profeti, giunge alla presenza di Maria madre del Cristo. Le Sibille di Contursi vantano parentele illustri: sono presenti nella cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel tempio Malatestiano di Rimini e, infine, nella Cappella Sistina di Michelangelo.
Il rapporto di filiazione fra la teologia cristiana e quella pagana – la tesi che la storia del Cristianesimo cominciava prima di Cristo come attestavano le testimonianze profetiche ebree e pagane – non fu instillato nel movimento umanistico sulla scorta di un semplice fraintendimento: ossia la pubblicazione da parte di Gemisto Pletone degli Oracoli caldaici – risalenti al II secolo dopo Cristo – come scritti precristiani. L’Umanesimo più che recuperare il Mondo Classico nei fatti valorizza la cultura della Tarda Antichità. Non vengono recuperati Platone o Aristotele, ma Plotino, gli Oracoli caldaici, gli Scritti ermetici e gli Scritti degli antichi Teosofi che risalgono per l’appunto al II secolo. La stessa cosa si può dire del movimento nazional socialista. Georges Dumezil ha dimostrato che i nazisti pensavano di ridare vita alle divinità degli antichi Germani mentre di fatto riciclavano materiali mitici risalenti all’età medievale. Tuttavia ciò che ci fa decidere rispetto a un movimento non è tanto il recupero più o meno selettivo di un passato mitizzato – ogni movimento rielabora il materiale mitico della tradizione (il mito è nella sua essenza un portatore di senso nei confronti del presente e, insieme, del passato!) –. Ciò che ci fa decidere sono i nuovi contenuti, ovvero la rivendicazione o negazione di forme di sociabilità più giuste e più libere, di nuove pratiche di liberazione e di nuovi percorsi di conoscenza. Su questo piano, a più di cinquecento anni di distanza, va riconosciuto il valore profetico della cultura del Rinascimento: è un’onda lunga che mantiene intatta la sua pregnanza di significato e il suo vigore!
E’ da questo ultimo spunto che s’origina e si articola il discorso antropologico di La Sala, che scorge una evidente analogia fra il ruolo svolto dalle Sibille nelle pratiche cultuali della religione pagana e la funzione che le «figlie del Sole» svolgono nel poema di Parmenide. Anche qui il viaggio-rivelazione del prescelto è tracciato dalle dee-fanciulle, sono le donne a consentire il transito nei riti di passaggio.
La funzione della donna come viatico del transito nei riti di passaggio pervade l’intero immaginario ellenico. Qui erano presenti due diverse rappresentazioni della vita. Il fantasma della zōé indicava la vita che non contemplava la morte: ossia la vita come specie, la vita infinta, priva di determinazioni, senza accidenti. Viceversa il fantasma della bios indicava la vita che contempla la morte: ovvero la vita che ha un inizio e una fine, la vita determinata con i suoi accidenti. Ebbene nella religione dionisiaca la zōé – la vita indistruttibile! – assume la forma maschile, la genesi delle anime assume, invece, quella femminile. Dioniso e Arianna stanno a indicare – dice Carl Kerenyi –, rispettivamente, l’eterno insorgere e trascorrere della zōé nella nascita e nei diversi stadi della vita. Il ruolo di Arianna non venne, tuttavia, compreso da Nietzsche, il quale negli ultimi anni della sua vita si chiedeva in modo ossessivo: «Chi è Arianna?».
Sta di fatto che il venire alla luce del «soggetto» nel mondo ellenico – un soggetto che si costituisce attraverso il discorso profetico, del saggio, del tecnico e del parresiates – si configura come un’emergenza che riguarda solo gli uomini e giammai le donne. Di fatto la Pizia nell’antica Grecia e le Sibille nel mondo latino sono solo il ventriloquo – un corpo senz’anima! – di cui si servono le diverse divinità per veicolare le loro oscure profezie!
Viceversa nell’immaginario rinascimentale le Sibille assumono, sulla base della rivendicazione dell’uguaglianza fra l’uomo e la donna, l’inedito profilo di avanguardie femminili. Di fatto, nelle immagini cultuali che costellano le chiese rinascimentali, le donne vengono rappresentate per la prima volta come soggette sovrane – le donne rappresentate da Michelangelo sono, per la prima volta, pensose! –, poiché svolgono, allo stesso modo dei Profeti, una funzione messianica. La cifra del Rinascimento, pertanto, va individuata proprio nella parola che sta a evocare, per l’appunto, la Rinascenza del soggetto!
Nonostante la spinta propulsiva della cultura rinascimentale, nei secoli successivi la donna non è tuttavia riuscita a farsi riconoscere come soggetto autonomo della comunicazione, come soggetto che dice il vero.
La storia di questo disconoscimento è costellata dalle tante sofferenze che le donne hanno subito nel corso dei secoli e dalle tante lacrime amare che tutt’oggi versano. Una sofferenza che suscita nell’animo nobile un sentimento di pietà che va comunque custodito attraverso i secoli. Non è inutile qui ricordare: la filosofa e scienziata Ipazia – la prima martire del libero pensiero! –, che nel 415, in Egitto, fu trucidata dagli fondamentalisti cristiani per aver rivendicato il diritto di costituirsi come soggetto che dice il vero; la persecuzione delle Streghe, che ebbe luogo non nel Medioevo ma in Età Moderna e, fra i giudici che le condannavano, Jean Bodin, l’«Aristotele del Rinascimento!»; le disposizioni del regime fascista che vietavano alle donne l’insegnamento della filosofia nelle nostre scuole; e, infine, la negazione dei diritti civili e, insieme, politici delle donne nei Paesi islamici. D’altra parte, va rilevato che fino alla Grande guerra le donne avevano il diritto di voto soltanto in quattro Paesi – Nuova Zelanda, Norvegia, Australia e Finlandia –; in Italia l’hanno ottenuto nel 1946 e in Svizzera solo nel 1974.
Nella seconda parte del suo lavoro, La Sala ritiene che sia auspicabile mettersi alle spalle le forme di sociabilità edipiche che fino ad ora hanno precluso alla maggior parte degli individui – non solo alle donne! – l’accesso alla sovranità: ossia il diritto di costituirsi come soggetti autonomi, il diritto di prendere la parola. Sostiene, inoltre, che le dinamiche relazionali che inibiscono l’autonomia delle donne – dinamiche che signoreggiano tutt’oggi nell’immaginario del modo occidentale – sono riconducibili da una parte all’alleanza tra la madre e il figlio – il mito di Edipo! – che ritroviamo nel mondo ellenico; e, dall’altra, all’alleanza fra il padre e il figlio – Il Vecchio Testamento! – che ritroviamo, invece, nel mondo ebraico.
La liberazione è possibile – dice La Sala – solo se usciamo dall’orizzonte teorico che la tradizione dei nostri padri ci ha trasmesso. Le forme della narrazione, della politica, della retorica, della dialettica, insieme all’esiziale corredo di scissioni (anima e corpo, la ragione e i sensi, ecc.) – tutte invenzioni del genio Mediterraneo – sono state adoperate per troppo tempo e, sempre più, appaiono logore. D’altra parte, i miti e i riti del mondo ellenico, ormai, sono diventati letteratura, ossia oggetto di semplice godimento estetico – non sono portatori di senso! – e, a volte, autentici detriti!
Rousseau, Kant, Feuerbach, Marx e Nietzsche – ciascuno per suo conto e con diverse modalità di pensiero – hanno rivendicato l’esigenza di mediare fra le diverse scissioni. Ciò nondimeno non sono riusciti a produrre un paradigma radicalmente nuovo, poiché hanno continuato a pensare con le categorie del mondo ellenico.
Da qui l’esigenza di pervenire a nuova Rivoluzione copernicana, che è possibile solo attraverso una nuova percezione dello spazio. In questo senso La Sala ci invita ad uscire dalla Terra per collocarci alla giusta distanza. La spazializzazione del soggetto con la sua giusta dose di trascendenza ci permetterà finalmente di vedere la Terra con il suo brillante colore come la Nostra Terra. Nondimeno La Sala è altresì consapevole che un nuovo ordine simbolico del mondo è possibile solo attraverso lo sviluppo dello spazio sociale.
Nell’attesa che ci sia una ripresa dell’effervescenza sociale e, insieme, una rifioritura dei movimenti di liberazione, il flâneur può cogliere già da ora in alcune forme di sociabilità disseminate sull’esergo del sistema la luce di una nuova bellezza, lo splendore che emerge dalle pratiche sociali in cui tutti gli individui signoreggiano come soggetti autonomi della comunicazione
Arco rovescio
Venerdì 11 aprile 2014, ore 21.00
Libreria Popolare
via Tadino 18, Milano
Presentazione di:
Arco rovescio
di Giulio Marzaioli
(Tielleci, 2014)
–
Interventi di:
Paolo Giovannetti
Antonio Loreto
Paolo Zublena
Coordina:
Alessandro Broggi
§
da http://puntocritico.eu/?p=6173
Possiamo guardare questo testo partendo da qualsiasi pagina. Il tempo di lettura è il suo residuo materiale.
B. Antomarini
–
Si tratta dell’installazione di uno spazio concettuale il cui perimetro deve essere continuamente ricostituito a partire da una serie di indizi.
T. Iaria
–
‘Arco rovescio’ si può leggere, forse, quale tentativo di infrazione di un tabù.
M. Manganelli
§
Benway Series
web site benwayseries.wordpress.com
info benwayseries@gmail.com
Anteprima dei libri su Issuu
Profilo Facebook
Ich bin ein Berlinguer – vɛltr.onˌʃaʊ.ʊŋ
 Nota sul film “Quando c’era Berlinguer” di W Veltroni
Nota sul film “Quando c’era Berlinguer” di W Veltroni
di Francesco Forlani
Two, three, four, eins, zwei, drei
Es is nichts dabei
Wenn ich euch erzaehle die Geschichte
Due, tre, quattro, uno, due, tre.
Non succede niente se ti racconto la storia,
niente di particolare.
Der Kommissar – Falco
Venerdì 4 aprile sono andato al cinema, al Massimo di Torino, per vedere l’opera che W Veltroni ha dedicato alla figura di Berlinguer nel trentennale della sua scomparsa.
Mi aspettavo e in un certo qual senso speravo di vedere i compagni. Non gli intellettuali, del resto presenti simbolicamente al banchetto che era fuori, per la raccolta firme l’altra Europa con Tsipras, il partito dei pochi eletti, ma i compagni operai che mi è già capitato di incontrare in occasioni simili e che, come ogni volta che vedo La Cosa , mi emozionano; mi commuove, la cosa, perché all’astrattezza dell’ideologia della giustizia sociale, del per cosa lottare, si manifesta in modo tangibile quel per chi.
Di compagni ce n’erano pochi, spettatori tanti, però, e quando nel dibattito finale, in presenza del regista, alcuni di loro hanno preso la parola, sembrava di essere a una seduta di comunisti anonimi. “Quando c’era Berlinguer” si traduce quasi immediatamente in “quando c’erano i comunisti” che nemmeno troppo velatamente si declina in un “Quando eravamo comunisti” e mai, nemmeno in una citazione di sfuggita, negata, subliminale, in perché.
Il successo del film di W Veltroni non è inspiegabile e non meraviglia nemmeno più di tanto che a scatenare un certo entusiasmo sia il nulla.Il Radical Kitsch amministra con mani esperte di pusher la dose minima di memoria storica permettendo all’oblio, al grande Oblio di fare passi da gigante nel General Intellect ormai degradato a caporale e di disertare ogni tipo di conflitto che rischi di non mettere d’accordo tutti.
Prima di capire meglio, però, che cosa accade con questo tipo di narrazione in linea con il nuovo Istituto Luce della Repubblica di Salòt di cui abbiamo raccontato qui e lì, vi propongo un piccolo test rivolto a quanti lo abbiano già visto il film di W Veltroni. Cherchez l’erreur.
Qui la puntata de “la Storia siamo noi” dedicata a Berlinguer
https://www.youtube.com/watch?v=t1gpHcQYQX8
e qui il trailer, per dare un’idea a quanti non lo abbiano ancora visto, del docufilm di W Veltroni.
A parte le interviste in apertura ai giovani ignari di Berlinguer, veloci, contemporanee, girate infatti dai ragazzi di una scuola di cinematografìa, il footage , ovvero recupero e rimontaggio di filmati precedenti, seppure asservito ad una forma di racconto diaristico e personale, sembra ottenere come risultato finale, ma nemmeno fino in fondo, quanto Léger asseriva in questi casi : « [E]mployer des chutes de film quelconque — sans choisir — au hasard.» Caso anagramma di cosa; ma cosa succede quando abbandonata la memoria W Veltroni imbraccia la camera? Il vuoto.
Non solo nella fase di montaggio quando si massacrano con didascalici e fastidiosi ronzii di sottofondo episodi che nella versione integrale, reperibili in rete, basterebbero a dare un senso a tutto, su tutti l’ultimo comizio di Berlinguer, ma anche in quella di creazione, di ripresa, quando come spiegherà il regista alla fine del film, non c’è anima viva nei luoghi chiave della vita del leader comunista; e la scena filmata dall’alto e dal basso, della piazza vuota con degli A3 svolazzanti sull’erba a centinaia delle prime pagine dell’Unità è da brividi.(da grande freddo)
Cut-up, fotocopie, remake fonici, esattamente quanto accade nel rapporto tra l’opera d’arte, la vita di Berlinguer oserei dire, e il kitsch, la visione del regista. In questo senso, come annunciato dal titolo parlerei di vɛltr.onˌʃaʊ.ʊŋ ovvero Weltanschauung veltroniana. E lo farei con chi più di chiunque altro aveva raccolto nel linguaggio cinematografico la grande lezione dadaista: Guy Debord.
« Le spectacle ne peut être compris comme l’abus d’un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, matériellement traduite. C’est une vision du monde qui s’est objectivée.»
«Lo spettacolo non può essere interpretato come abuso del mondo visione, prodotto delle tecniche di diffusione di massa delle immagini: è piuttosto una Weltanshauung divenuta effettiva, tradotta materialmente: una visione del mondo oggettivata ».
Ecco allora i tentativi maldestri di W Veltroni di addomesticare l’immagine e i testimoni a una sorta di propaganda Pop and Corn, in cui ex brigatisti e cantanti di successo ci regalano testimonianze memorabili della cosa, ancora lei, spacciandola come storia. Una storia, quella del PCI secondo W Veltroni che non ci rivela come e perché l’Italia sia il solo paese europeo ad avere avuto il più grande partito comunista in un tempo e nessun partito socialista immediatamente dopo, sul modello degli altri paesi. Una storia, quella degli anni settanta, secondo W Veltroni, che elimina, scarta, rimuove tutto quanto succedeva oltre il brigatismo, il compromesso storico, Diccì, Piccì, e che coinvolgeva migliaia di giovani a cui le maglie dell’ideologia, molto prima della caduta del Muro di Berlino, andavano strette. Sergio Atzeni, una delle voci più autentiche di quella generazione la riassumeva, infatti, così:
« Radio Sirena Libera Informazione, riunione plenaria del lunedì mattina, si progetta la settimana, Ruggero si difende dall’accusa di mandare troppa musica e poca informazione nel pomeriggio del sabato, «lo sai che gliene frega a quelli che il sabato pomeriggio si sdraiano in veranda con l’anguria, il ghiaccio, la birra e l’amica di sentire il deputato tale intervistato per mezzora e dice trenta volte che ha ragione Berlinguer? Vabbene. Ha ragione Berlinguer. Basta un minuto e mezzo per le precauzioni d’uso. Vuoi mettere con la musica afrocubana?»
Sergio Atzeni, Il quinto passo è l’addio
Allora W Veltroni o Viva Berlinguer? Viva Berlinguer, direi, a questo punto. Ma non applauditemi come quando si applaude il pilota all’atterraggio.
video arte #29 – nicolas provost
Nicolas Provost, Illumination (estratto), 2014.
Nicolas Provost, Tokyo Giants (estratto), 2012.
Nicolas Provost, Stardust (estratto), 2010.
Nicolas Provost, Plot Point (estratto), 2007.
Nicolas Provost, Gravity (estratto), 2007.
Nicolas Provost, Induction, 2006.
Via dalla pazza morte
di Mario Sammarone
Gilles Dostaler, Bernard Maris
Capitalismo e pulsione di morte
ed. La Lepre, 2010
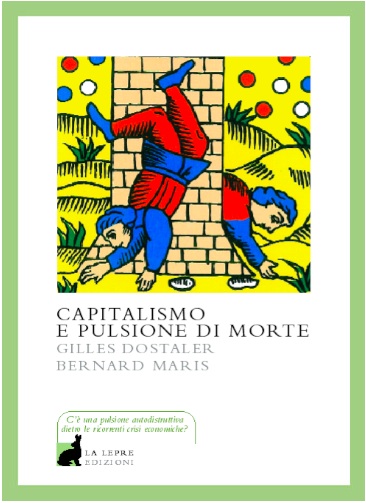 Non tutti gli dei antichi sono stati rimossi dal mondo degli uomini. Segretamente, alcuni di loro operano ancora presso di noi e congiurano con le loro arti oscure, reggendo le sorti dell’odierna esistenza. La loro arma inattesa le strutture psicologiche dell’impulso di vita (Eros) e di morte (Thanatos), che sorprendentemente si trovano alla base della forma economica oggi dominante, il capitalismo.
Non tutti gli dei antichi sono stati rimossi dal mondo degli uomini. Segretamente, alcuni di loro operano ancora presso di noi e congiurano con le loro arti oscure, reggendo le sorti dell’odierna esistenza. La loro arma inattesa le strutture psicologiche dell’impulso di vita (Eros) e di morte (Thanatos), che sorprendentemente si trovano alla base della forma economica oggi dominante, il capitalismo.
Appello per la liberazione dei corpi e del dissenso politico
( Pubblico e con ciò personalmente aderisco a questo appello apparso su http://quaderni.sanprecario.info/2014/04/appello-per-la-liberazione-dei-corpi-e-del-dissenso-politico/, g.m.)
Proponiamo all’attenzione di tutte/i questo appello firmato da alcuni intellettuali e attivisti europei e non solo per denunciare il clima di crescente intimidazione e repressione presente in Italia e in Europa.
Clamoroso è il caso della lotta in Val di Susa, dove attualmente quattro giovani sono sottoposti a un regime carcerario di isolamento, accusati di “terrorismo”, e 54 persone si trovano sotto processo per aver manifestato, in forme diverse, il loro dissenso contro il proseguo dei lavori per l’Alta Velocità a cui da venti anni si oppongono le comunità della zona. Non basta: altri episodi diffusi di repressione del dissenso e del diritto a manifestare ci allarmano grandemente.
Promotori di tale iniziativa sono gli iscritti alla lista Effimera, variegata realtà di ricerca e di pensiero internazionale, nata dopo l’esperienza di UniNomade 2.0. Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore la libertà di espressione e di critica di appoggiare questa presa di parola che ha lo scopo di ribadire il diritto all’autodeterminazione dei corpi e dei territori al di fuori delle imposizioni e delle logiche del capitalismo finanziario contemporaneo.
Per firmare: appello.contro.repressione@gmail.com
* * * * *
Foucault, in una lezione tenuta nel 1978 al Collège de France, scrive che oggi l’arte del governare “ha per bersaglio la popolazione, per forma principale di sapere l’economia politica, per strumenti tecnici essenziali i dispositivi di sicurezza”. Se questo è il piano dentro il quale ci muoviamo, oggi stiamo assistendo ad un salto di qualità dei dispositivi di sicurezza. Osserviamo una complessiva e sottile involuzione autoritaria della società italiana ed europea, dove il conflitto viene patologizzato e interiorizzato e vige la repressione di ogni politica affermativa e di ogni pratica di autonoma gestione di corpi, relazioni, territori. In particolare, ci allarma e ci preoccupa il clima di controllo di un neocapitalismo particolarmente violento nei confronti degli attivisti del movimento No Tav in Val di Susa. Quattro giovani, Claudio, Chiara, Mattia e Niccolò, sono da dicembre in carcere accusati di terrorismo. Altri 54 attivisti No Tav sono sotto processo per i fatti relativi alle manifestazioni del 27/6 e del 3/7/2011, attualmente in corso presso la IV Sezione del Tribunale di Torino, in condizioni in cui, come denunciato pubblicamente dagli avvocati della difesa, si consta “l’oggettiva impossibilità di garantire, nelle attuali condizioni, un sereno e concreto esercizio del diritto di difesa”.
Anche in altre città italiane (Bologna, Milano, Padova, Roma, Treviso, Napoli) negli ultimi mesi sono state emesse ordinanze di “divieto di dimora”, “arresti domiciliari”, “obblighi di firma” destinati a coloro che, più di altri, hanno manifestato dissenso politico.
Noi vediamo nell’esplicarsi di tali durezze fuori misura, il volto di un potere che ha cambiato natura: lontano e dittatoriale, repressivo e dunque “esterno” rispetto alle culture, ai corpi, ai volti, ma contemporaneamente vicino e “intimo”, capace di effettuare un’integrale cattura dell’anima, reclamando di volerla orientare attraverso dispositivi ambientali ed economici che favoriscono l’adesione alla “norma” oppure, viceversa, pronto a espellere, imprigionare, scartare qualsiasi elemento che alla “norma” non voglia adeguarsi.
Un’intera valle e tutta la sua popolazione da quasi venti anni resistono al destino stabilito dalle logiche dello sfruttamento intensivo neoliberista, sordo a ogni desiderio, insensibile ai bisogni della vita e al rispetto dell’ambiente, interessato solo alla razionalizzazione capitalistica dell’esistenza, al calcolo di investimenti in grandi opere inutili ed irragionevoli che debbono essere il più possibile soltanto una fonte di denaro. Di fronte alla fermezza con cui la decisione unilaterale sulla sorte della Val di Susa viene da decenni presentata come una funzione che sottomette tutti i comportamenti agli interessi economici, le comunità hanno messo in gioco i propri corpi, diventando un modello di testarda resistenza alle ragioni del capitalismo-finanziario per il Paese nella sua interezza e anche oltre i confini nazionali. Siamo in presenza di regole oscene che autorizzano a imprigionare quattro ragazzi poiché “l’azione terroristica è idonea ad arrecare danno d’immagine all’Italia” e, aspetto particolarmente significativo, siamo di fronte alla pubblica rivendicazione del lato indecente di questa repressione, con la complicità dei principali media e di buona parte del milieu intellettuale italiano (con poche, ma significative, eccezioni).
Per queste ragioni noi firmando chiediamo l’immediata liberazione degli attivisti imprigionati dietro accuse strumentali e gigantesche. Pensiamo che la moltitudine che si solleva in Val di Susa trasgredisca solo la logica imperante del “capitale umano”. Questi giovani mettono in gioco le proprie vite, rifiutando l’idea della libertà come libera accettazione di una scelta obbligata; hanno sottratto la propria libertà al calcolo, per affidarla alla manifestazione di un’idea.
Non c’è politica che non cominci da lampi come questi, vogliamo ricordarlo. Essi sono i lampi dell’intelligenza e del coraggio imprendibile dell’umanità, gli unici capaci di far tremare la presunta solidità del biopotere contemporaneo. Noi dunque pensiamo che l’avvenire della politica stia nella fedeltà a questi lampi cui chiunque può partecipare, purché sia disposto a mettere davvero in gioco se stesso.
* * * * *
Prime firme in ordine alfabetico:
Giorgio Agamben, Piergiovanni Alleva, Adalgiso Amendola, Emiliana Armano, Thomas Atzert, Chiara Bassetti, Franco Berardi Bifo, Manuela Bojadžijev, Sergio Bologna, Giorgio Bonazzi, Emanuele Braga, Ulrich Brand, George Caffentzis, Vincenzo Carbone, Federico Chicchi, Salvatore Cominu, ricercatore, Italia, Manuela Costa, Carlo Cuccomarino, Anna Curcio, Mariarosa Dalla Costa, Pierre Dardot, Simona de Simoni, Filippo Lucchese, Valerio Evangelisti, Ubaldo Fadini, Roberto Faure, Silvia Federici, Lorenzo Feltrin, Andrea Fumagalli, Pierangelo Galmozzi, Davide Gallo Lassere, Maurizio Gibertini, Mario Gamba,Antonio Gennari, Giovanni Giovannelli, Avery Gordon, Spartaco Greppi, Giorgio Griziotti, Carlo Guglielmi, Michael Hardt, Sabine Hess, Srecko Horvat, Ursula Huws, , Christian Laval, Maurizio Lazzarato, Emanuele Leonardi, Les Levidow, Peter Linebaugh, Dario Lovaglio, Geert Lovink, Stefano Lucarelli, Benjamin Manski, Christian Marazzi, Nicolas Martino, Sandro Mezzadra, Francesco Miele, Cristina Morini, Gianfranco Morosato, Annalisa Murgia, Timothy S. Murphy, Brett Neilson, Antonio Negri, Pierluigi Panici, Leo Panitch, Matteo Pasquinelli, Giuliana Peyronel, Marco Philopat, Anne Querrien, Gerard Raunig, Judith Revel, Paola Rivetti, Adrià Rodriguez, Gigi Roggero, Rosario M. Romeo, Ned Rossiter, Andrew Ross, Cecilia Rubiolo, Francesco Salvini, Raffaele Sciortino, Marco Scotini, Guy Standing, Paul Stubbs, Tiziana Terranova, Lucia Tozzi, Carlo Vercellone, Tiziana Villani, Giovanna Zapperi, Paolo Vernaglione, Soenke Zehle,
Overbooking: Luca Rastello
Un libro a lettere chiare
Nota sul romanzo I buoni di Luca Rastello
di
Francesco Forlani
Dalla casa editrice milanese fondata nel 2007 e con un catalogo all’insegna della sua vocazione, saggistica e d’inchiesta, la nuova collana di narrativa, Narrazioni, ha fatto in questi giorni il suo debutto nel nostro panorama letterario. È da poco approdato in libreria Il primo titolo di Chiarelettere, I Buoni di Luca Rastello cui seguiranno altri due titoli: La figlia del Papa di Dario Fo e Il Direttore di Luigi Bisignani. L’eccellente prova narrativa di Luca Rastello rischia di passare tuttavia in secondo piano rispetto alla polemica che in questi giorni è scoppiata coinvolgendo diverse testate e autorevoli firme, per lo più di opinionisti e personaggi del mondo politico e sociale. Tranne rari casi, su tutti quello di Goffredo Fofi, non si sono lette critiche squisitamente letterarie; si è trattato il testo piuttosto come pretesto per difendere, d’ufficio per lo più, personaggi e associazioni riconoscibili nel romanzo e protagonisti di tutte quelle contraddizioni presenti nel mondo delle associazioni e di volontariato impegnate in cause umanitarie e principalmente intorno al tema della legalità. E questo sarebbe davvero il torto maggiore che si possa fare a uno dei migliori libri di narrativa scritti in questi anni.
“I buoni” raccontano una vicenda che si sviluppa attraverso tre parti, L’uomo dal paradiso, la Scuola di impietà e L’uomo dall’inferno, tre tempi differenti a cavallo del passaggio di secolo e soprattutto della frontiera tra oriente e occidente, con paragrafi veloci e prime righe in maiuscoletto a scandire il passo. La prima è stilisticamente efficace nel descrivere l’Underworld dei ragazzi di strada rumeni costretti a vivere e a drogarsi con colla di vernice nelle fognature di Bucarest, nelle vicinanze della celebre Gare du Nord; ragazzi ostinati a vivere nonostante la violenza che subiscono e da cui è possibile difendersi solo affiliandosi a bande dai codici stabiliti e ferrei come quelle di piccoli eserciti in guerra: la regola di Adrian è lavarsi.
La protagonista, insieme ai due giovani italiani Andrea e Mauro che la trarranno in salvo portandola in Italia è Aza. L’abbiamo incontrata in apertura del libro attraverso la bella illustrazione di Arianna Vairo in una doppia pagina che ha per titolo proscenio. Scapigliata, smunta, fiera ricorda davvero quelle piccole facce d’angelo che furono catapultate nelle televisioni di mezzo mondo occidentale dopo la caduta di Ceaușescu nel 1989. Nell’immagine è seduta su un tombino aperto e sembra sapere che la rinascita avverrà di lì a poco. Nella seconda parte, in una città del nord, l’incontro con il capo carismatico della comunità avviene con uno dei passaggi più belli. Alla proposta di Don Silvano di lavorare con loro: “Lei continua a inghiottire, morde all’ingiù le lacrime che salgono alla gola, la vita che le sta facendo un’offerta”. Sembra di rivivere con lei lo stato di grazia del protagonista dickensiano di America, quella stessa meraviglia che Kafka gli fa provare davanti al Gran Teatro di Oklahoma.
E davvero sembra poco, tutto molto piccolo, fragile come il cartongesso che separa le stanze degli uni dagli altri, quanto con l’energia del migliore Bianciardi, e un’abilità nei dialoghi, Luca Rastello descrive in una fenomenologia della banalità del bene che è senza sconti; questo accade non perché vi siano coinvolti gli uni o piuttosto gli altri; in una comunità a occidente che un liberalismo selvaggio ha ridotto a società a responsabilità limitata, perfino il titolo di ultimo deve essere in qualche modo pagato. Dalla seconda parte in poi infatti e nella terza in modo incisivo si sente pagina dopo pagina, evento dopo evento, una mutazione di prospettiva che sarà proprio Aza a offrire al lettore, come certi poeti dell’Est che nella semplicità di un verso, di un’immagine riescono a dire di noi stessi più di quanto le nostre stesse parole non sappiano più dire.
Del controcanto che anima le pagine dei buoni, dunque, solo figure autentiche, contraddittorie, al di là di ogni morale preconfezionata potevano diventarne gli interpreti; l’autore le chiama Personae, e sono descritte nelle sezioni che anticipano ognuna delle tre parti; dramatis personae le maschere del dramma, tolte le quali non vi rimane più nulla.
Astronomi di costellazioni linguistiche- Gherardo Bortolotti
“Astronomi di costellazioni linguistiche”: serie di incontri con scrittori sperimentali che proseguono da anni una ricerca sulla lingua e sulle forme letterarie. Dialogando con loro, che leggeranno brani editi o inediti, indagheremo il come e il perché delle scelte adottate, in molti casi tese a evadere dai limiti di convenzioni sentite come assurde, restrittive o molto povere rispetto alle potenzialità del linguaggio e del narrare.
Quarto appuntamento: 6 aprile, H. 18.00, con Gherardo Bortolotti, scrittore.
“Quando arrivarono gli alieni, ci trovarono privi di un progetto, pronti ad accedere ad un ulteriore salto di coscienza, verso lo stadio più avanzato della nostra ignavia. Mentre le rivolte attraversavano l’Europa, uscivamo in massa il sabato sera. Il nostro abbigliamento era ciò che restava di un’epoca più grande, in quieta sintonia con l’arredamento dei locali, con i sottintesi commerciali di chi ci rivolgeva la parola.”
Gherardo Bortolotti (Brescia 1972) è autore di poesie, prose e traduzioni. Nel 2009 ha pubblicato un romanzo molto particolare composto da frammenti: “Tecniche di basso livello” (Lavieri, Caserta). Ha partecipato ad antologie di prosa (“Prosa in prosa”, Le Lettere, Firenze 2009) e di poesia (“Poeti degli Anni Zero”, Ponte Sisto, Roma 2010). Nel 2013 è uscita la sua raccolta poetica “Senza paragone” (Transeuropa, Massa). Con Michele Zaffarano cura la collana Chapbooks per Arcipelago Edizioni, che pubblica letteratura sperimentale dalla Francia, dall’Italia e dagli USA. È stato tra i fondatori e curatori del blog di traduzioni e letteratura sperimentale GAMMM (http://gammm.org) e redattore del blog letterario Nazione Indiana (https://www.nazioneindiana.com).
Dell’antidoto o del kalashnikov mentale
Quando verrà il tipo a dirmelo in radio e in televisione, dopo averlo scritto in rete e sui giornali, quando verrà lui, insieme a tutti gli altri, a dirmi:
“Il mondo è complesso, c’è la globalizzazione, alcuni problemi climatici non li possiamo ignorare, inoltre c’è un sacco di gente nel mondo che vive ancora scalza e senza mettersi dei deodoranti, quindi a questo punto, viste le non poche difficoltà cui noi dobbiamo far fronte, qui in Occidente, chiariamo una cosa: chi parla di uguaglianza è un semplice invidioso; chi spreca tempo a fare cose che non si possono vendere alla massa non è solo un perdente, ma un vero malato.
Una storia violenta
di Antonio Soler
(Si terrà a Perugia dal 4 al 6 aprile 2014 la prima edizione di Encuentro. Festa delle letterature in lingua spagnola, una manifestazione dedicata alle letterature di lingua spagnola in Italia, promossa dal Circolo dei Lettori di Perugia e dal Comune di Perugia, con l’Associazione Banana Republic, in collaborazione con Regione Umbria e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia. Encuentro ospiterà autori rappresentativi della letteratura ispano-americana – Luis Sépulveda, Daniel Mordzinski, Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura Fuentes, Bruno Arpaia, Santiago Gamboa e ancora Fernando Iwasaki, Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Antonio Soler, autore dello stralcio che segue – tradotto in italiano e nella versione originale – tratto da Una historia violenta, romanzo del 2013 inedito in Italia).

Io vigilavo. Mi piaceva vigilare.
Sapere da dove veniva la gente. Le ore. I rumori che si portavano dietro. Le loro voci. Come si comportavano quando pensavano che nessuno li osservasse. Vigilavo per strada e vigilavo in casa. Vigilando, stando attento, mi si ripulivano i pensieri. Il cielo azzurro mi entrava in testa e scacciava tutte le ombre. Le trame delle mie idee luccicavano come tubi di nichel. Come quando a scuola la professoressa mi metteva davanti quella lista di numeri e io dovevo sommarli. Li assemblavo, ci facevo delle catene. Sapevo cosa significavano. Vigilavo.
Mio padre diceva di avere un amico poliziotto. Un uomo triste, dalla pelle giallastra. E anche molle, e anche con le unghie troppo lunghe. Come le zampe dei polli. Portava una giacca adatta a un uomo grosso, ma lui era magro e piuttosto piccolo. Io pensavo che si trattasse di un poliziotto finto. E pensavo che i veri poliziotti un giorno si sarebbero portati via mio padre e quel suo amico. Per la questione dei sacchi, per le parole che sentivo. E si sarebbero portati via anche quell’altro amico che mia madre lasciava sempre aspettare sulla porta e che a volte appariva all’angolo della strada in sella a una moto grande e rumorosa sulla quale non c’era bisogno di vigilare perché essa stessa si annunciava da molto tempo prima di sbucare. Aveva un giacchetto di cuoio e quando parlava con mio padre rideva sempre fragorosamente.
Mio padre non aveva amici che lavoravano in ufficio né amici che portavano la cravatta o che dicevano troppo spesso buongiorno. Alzavano le sopracciglia, strizzavano l’occhio, muovevano la bocca e ridevano a voce alta. Ecco quello che facevano. Pareva il loro vero lavoro.
Anziché amici mio padre sembrava avere dei complici.
Io giocavo con gli indiani e i cowboy. Li sotterravo nei vasi dei fiori, fingevo che sparassero e morissero tra i gerani, ma in realtà stavo vigilando.
Il mio indiano con la mano sulla fronte, quello che guardava l’orizzonte, non moriva mai. Non cadeva mai tra i grumi di terra né precipitava dal bordo di un vaso. Io e lui stavamo attenti a ciò che accadeva intorno a noi, a quello che dicevano mia madre e la madre di Mauri, ai movimenti di mia sorella e dei suoi amici, alla strana gente che si affacciava all’imbocco della strada e capendo di essersi persa tornava indietro.
Mi sarebbe piaciuto seguire quelle persone, sapere chi erano e dove volevano andare.
Io vigilavo e fingevo di essere buono. Sempre. Adesso penso che fingere fosse un modo di vigilare.
Persino quando dormivo fingevo di essere buono. Sapevo qual era la postura in cui mia madre riconosceva la bontà.
Sapevo che la mattina seguente l’avrebbe raccontato alla madre di Mauri e la madre di Mauri a un’altra madre. Quella era la mia salvezza. Vigilare e fingere.
Io non nascondevo i miei nervi, nascondevo semplicemente la mia cattiveria.
In principio, nei primi mesi o nelle prime settimane che passai con la signorina Elvira a scuola, seduto al primo banco a guardare le sue ginocchia larghe, pensai che lei sapesse che io fingevo tutto il tempo. Come se tenesse la radiografia del mio cervello in uno di quei cassetti in cui riponeva le gomme, le matite nuove, i quaderni che tagliava minuziosamente in due con delle forbici enormi, sibilanti, proprio nel mezzo, per venderli. Per venderli a noi, i bambini che scrivevano su quei mezzi quaderni.
A me piacevano le metà superiori, quelle che avevano i margini larghi, bianchi, nella parte di sopra, un piccolo cielo bianco che fluttuava sulle righe.
La signorina Elvira tagliava quaderni e io pensavo che tagliasse in due anche la mia testa, e sapesse cosa c’era dentro. Pensai che lei stesse vigilando su di me. Ma poi seppi che stava vigilando solo sui miei occhi, per il tempo che rimanevano fissi sulla vastità marmorea – potente e pallida – delle sue ginocchia o sulle righe del mezzo quaderno che mi aveva venduto quella settimana.
Stava attenta anche ai miei vestiti, ai maglioni che mi faceva mia madre, alla qualità della lana. Solo questo.
In queste faccende mio padre non si intrometteva nemmeno. A volte mi chiedevo se mio padre sarebbe stato capace di riconoscermi in mezzo a un nugolo di bambini. All’uscita di scuola, per esempio. Se avrebbe saputo distinguere a prima vista, con precisione, come fanno i padri, suo figlio, tra tutti quei bambini in movimento.
Mai, proprio mai, non una sola volta e per nessuno motivo, mio padre ha messo piede nella mia scuola, nella scuola della signorina Elvira. Non ha mai saputo che esisteva una signorina Elvira, un edificio con quella facciata verde e un cortile pieno di voci nel quale correvano disperati duecento o forse trecento bambini durante la mezz’ora di ricreazione.
Mio padre non sapeva niente. Guidava il camion e basta, per strada o forse solo fino al porto, e lì rubava dei sacchi o li comprava a un prezzo più basso di quello che avevano, e poi li portava da un’altra parte, in un posto per me tanto remoto quanto la mia scuola poteva esserlo per lui.
Mio padre se ne andava in giro e ogni tanto si fermava a raccogliere quei ramoscelli con cui mi stava costruendo il forte, la casetta dentro alla polveriera – ancora senza tetto -, le palizzate che non finivano mai, la presunta casa del capitano del forte, sul cui suolo, tuttavia, dormiva il mio indiano, con la sua lancia in una mano e l’altra mano sulla fronte.
Rametti, delle specie di matite rugose e senza mina che mio padre tirava fuori dalla tasca del giacchetto e lanciava malamente in un grande barattolo di Cola-Cao che teneva in lavanderia. Rami di alberi strani, rossicci, scuri.
“Queste sono le dita degli alberi”, mi disse un giorno mio padre mentre io vigilavo da lontano su come trafficava con quei bastoncini.
Forse lo disse per spaventarmi, per farmi credere che lui era capace di andare in giro a tagliare dita, o forse lo fece solo perché gli venne in mente lì per lì e per quello si rattristò e lasciò lì i ramoscelli, svogliatamente, come se stesse davvero abbandonando le dita di qualcuno. Di un amico che era morto, per esempio.
Nel barattolo, oltre ai rami, c’erano le corde, gli spaghi, il piccolo girabacchino che adoperavano anche per aprire le bottiglie, un po’ di fil di ferro e qualche chiodo. Il materiale e gli attrezzi che mio padre usava per costruire il mio forte.
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare don Guillermo alle prese con un barattolo come quello e ancor meno mentre entrava nella lavanderia di casa sua in cerca di un girabacchino ogni volta che volesse stappare una bottiglia. No. Nemmeno il padre di Mauri aveva un barattolo simile, acciaccato e macchiato di ossido, messo da parte.
Niente di tutto ciò.
Mio padre aveva quel barattolo. Io un forte ancora a metà. Io avevo un padre che aveva un barattolo come quello.
Quello poteva essere l’indicatore della mia esistenza, il punto che più tardi avrei incontrato in certe mappe di città: “Voi siete qui”.
Mauri aveva un meccano di metallo con una moltitudine di pezzi verdi e rossi, con bulloni di tutte le dimensioni, perfettamente nichelati, talmente ben nichelati che secondo lui erano d’argento. E poi tronchesi e un cacciavite in miniatura. Tutto conservato in una solida cassa di legno, scolorita ma con compartimenti per ogni genere di pezzo.
Ernestito, oltre ai suoi racconti e alla sua collezione di macchinine, aveva il suo castello di plastica, con una torre merlata dalla quale gli arcieri potevano scoccare comodamente le loro frecce. Un castello assemblato con delle costruzioni che sulla superficie esterna delle mura riproducevano le pietre e anche la muffa delle antiche fortezze, e che era circondato da un fosso d’acqua, dipinto di un azzurro uguale a quello del cielo in quei giorni. Aveva indiani, soldati con mitragliette e balestrieri colorati. Tartari con sciabole ricurve, gladiatori. Il mio indiano era verde. Tutto verde, verde la carne e verdi i pantaloni, le piume, la lancia, tutto di un colore verde velenoso.
Ernestito, e anche Mauri, usavano la colla Imedia per incollare le figurine. I loro album di animali sprigionavano da lontano una specie di odore metallico, da profumeria.
Il mio album frusciava. Frusciava come se le fiere, i leoni, la iena e persino gli stambecchi delle figurine ruggissero quando qualcuno gli si avvicinava.
Io attaccavo le figurine con un impasto di farina e acqua che mia madre mi fabbricava in un portauovo, un impasto che io, sconfortato, strusciavo sopra i riquadri dell’album con uno spazzolino da denti e che inevitabilmente produceva dei grumi, bolle di diverso spessore sotto le immagini, deformandole.
Il mio giaguaro, proprio il giaguaro, sembrava come sfigurato per il dislivello che quell’impasto aveva formato sotto la sua mandibola.
Era un album accidentato e frusciante. Il rumore delle pagine, sfogliandole, era uguale a quello che fa una vecchia porta o una persiana rotta. Il mio album aveva le pagine ondulate. Sarebbe stato meglio non avere niente. Non importava quante figurine avessi né quante pagine fossi riuscito a completare. Quando Mauri o Ernestito entravano a casa mia io lo nascondevo sotto il letto.
Le cose stavano così.
Don Guillermo Galiana sapeva di colonia, e mio padre sapeva di strada e di altri uomini. Di uomini che parlavano a voce alta e ridevano a voce ancora più alta. Sapeva di tabacco, di fumo, di posti con poca luce, di covo di Ali Babà.
Forse per questo mi conveniva vigilare. Stare attento a ciò che accadeva fuori da me.
Anche se alla fine non contò, né quanto tempo né con quanta attenzione vigilassi. Un bel giorno, Ernestito si sarebbe avvicinato discretamente alle mie spalle e avrebbe provato sulla mia nuca la durezza della grafite. Di quella pietra nera e brillante che lui, o forse sua zia Tusa, chiamò carbone.
(Traduzione dallo spagnolo di Giovanni Dozzini).
***
Yo vigilaba. Me gustaba vigilar.
Saber por dónde venía la gente. Las horas. Los ruidos que traían. Sus voces. Cómo se comportaban cuando pensaban que nadie los observaba. Vigilaba en la calle y vigilaba dentro de mi casa.
Se me limpiaban los pensamientos vigilando, estando atento. El cielo azul entraba en mi cabeza y se llevaba todas las sombras. Los entramados de mis ideas quedaban como relucientes tubos de níquel. Igual que cuando en el colegio la profesora me ponía delante aquella lista de números y yo debía sumarlos. Los engarzaba, hacía cadenas con ellos. Sabía lo que significaban. Vigilaba.
Mi padre decía que tenía un amigo policía. Un hombre triste y con color amarillento. Hervido también, y también con las uñas demasiado largas. Como las patas de los pollos. Su chaqueta era de un hombre grande, pero él era flaco y más bien pequeño. Yo pensaba que se trataba de un policía falso. Y pensaba que los verdaderos policías un día se iban a llevar a mi padre y a aquel amigo suyo. Por el asunto de los sacos, por palabras que oía. Y también se iban a llevar a aquel otro amigo que mi madre siempre dejaba esperando en la puerta de la calle y que a veces aparecía por la esquina subido en una moto grande y ruidosa a la que no hacía falta vigilar porque ella misma se anunciaba desde mucho tiempo antes de doblar la esquina. Ese llevaba una pelliza de cuero y siempre le hablaba a mi padre entre carcajadas.
Mi padre no tenía amigos que trabajasen en oficinas ni amigos que usaran corbata ni dijeran demasiadas veces buenos días. Alzaban las cejas, guiñaban, movían la boca y se reían en voz alta. Eso es lo que hacían. Ese parecía su verdadero trabajo.
En vez de amigos mi padre parecía que tenía cómplices.
Yo jugaba con los indios y los cow-boys. Los enterraba en las macetas, fingía que disparaban y que se morían entre los geranios, pero en realidad estaba vigilando.
Mi indio de la mano en la frente, el que miraba el horizonte, nunca moría. Nunca caía entre los grumos de tierra ni se despeñaba desde lo alto de una maceta. Él y yo estábamos atentos a lo que ocurría a nuestro alrededor, a lo que decían mi madre y la madre de Mauri, a los movimientos de mi hermana y sus amigos, a la gente extraña que asomaba por el comienzo de la calle y al notarse perdida se daba la vuelta.
Me habría gustado seguirlos, saber quiénes eran y adónde querían ir en verdad.
Yo vigilaba y fingía ser bueno. Siempre. Pienso ahora que fingir era un modo de vigilar.
Hasta cuando dormía fingía ser bueno. Sabía cuál era la postura en la que mi madre reconocía la bondad. Sabía cómo a la mañana siguiente ella se lo transmitiría a la madre de Mauri y la madre de Mauri a otra madre. Esa era mi salvación.
Vigilar y fingir.
Yo no disimulaba mis nervios, simplemente disimulaba mi maldad.
En un principio, en los primeros meses o semanas que pasé con la señorita Elvira en el colegio, sentado en el primer pupitre mirando sus rodillas anchas, pensé que ella sabía que yo estaba fingiendo todo el tiempo. Como si tuviera la radiografía de mi cerebro en uno de aquellos cajones donde guardaba las gomas, los lápices nuevos, las libretas que ella cortaba cuidadosamente en dos con unas tijeras enormes, silbantes, justo por la mitad, para venderlas. Para vendérnosla a nosotros, los niños que escribíamos en aquellas medias libretas.
A mí me gustaban las mitades superiores, las que tenían los márgenes anchos, blancos, en la parte de arriba, un pequeño cielo blanco flotando sobre los renglones.
La señorita Elvira cortaba libretas y yo pensaba que también cortaba mi cabeza en dos y sabía lo que había dentro. Pensé que ella me vigilaba a mí. Pero luego supe que solo vigilaba mis ojos, el tiempo que estaban detenidos en la anchura marmórea -poderosa y pálida- de sus rodillas o en los renglones de la media libreta que me había vendido esa semana.
También estaba atenta a mi ropa, a los jerséis que me tejía mi madre, a la calidad de la lana. Solo eso.
Mi padre ni siquiera reparaba en esas cuestiones. A veces me preguntaba a mí mismo si mi padre habría sido capaz de reconocerme entre un montón de niños. En la salida del colegio por ejemplo. Si habría sabido distinguir a la primera, con precisión, como hacen los padres, a su hijo, a mí, entre todos aquellos niños en movimiento.
Nunca, jamás, ni una sola vez y por ningún motivo, mi padre fue a mi colegio, al colegio de la señorita Elvira. Nunca supo que existía una señorita Elvira, un edificio con esa fachada verde y un patio lleno de voces por el que corríamos desesperados doscientos o quizá trescientos niños durante la media hora del recreo.
Mi padre no sabía nada. Solo conducía el camión, lo llevaba por carreteras o quizá solo al puerto y allí robaba sacos o los compraba a un precio más bajo del que tenían y los llevaba a otra parte, a un lugar para mí tan remoto como mi colegio podía serlo para él.
Mi padre iba de un lado a otro y de paso cogía aquellos palos con los que me iba construyendo el fuerte, la caseta interior del polvorín -todavía sin techo-, las empalizadas que nunca se acababan, la supuesta casa del capitán del fuerte, en cuyo suelo, sin embargo, dormía mi indio, con su lanza en una mano y la otra mano en la frente.
Palitos, una especie de lápices rugosos y sin mina que mi padre sacaba del bolsillo de la chaqueta y echaba descuidadamente en una lata grande de Cola-Cao que guardaba en el lavadero. Palos de árboles extraños, rojizos, oscuros.
“Estos son los dedos de los árboles”, me dijo un día mi padre mientras yo vigilaba desde lejos cómo guardaba los palos.
Tal vez lo dijera para asustarme, para hacerme creer que él era capaz de ir por ahí cortando dedos, o quizá lo hiciera solo porque se le ocurrió en ese momento y por eso se puso triste y dejó allí los palos con desgana, como si de verdad dejara los dedos de alguien. De un amigo que se hubiera muerto, por ejemplo.
En la lata, además de los palos, estaban las cuerdas, los hilos gruesos, el pequeño berbiquí que también usaban para abrir botellas, unos alambres y unos cuantos clavos. Las herramientas que mi padre utilizaba para construir mi fuerte.
Nadie habría podido imaginar nunca a don Guillermo guardando nada en una lata como aquella y menos aún yendo al lavadero de su casa en busca de un berbiquí cada vez que quería sacar el tapón de corcho a una botella. No. Ni siquiera el padre de Mauri tenía una lata parecida guardada en ninguna parte, abollada y con manchas de óxido.
Nada de eso.
Mi padre tenía esa lata. Yo un fuerte a medio construir. Yo tenía un padre que tenía una lata como aquella.
Ese podía ser el indicador de mi existencia, el punto que después he visto en algunos planos de ciudades. “Usted se encuentra aquí”.
Mauri tenía un mecano de metal con multitud de piezas de color verde y rojo, con tornillos de todos los tamaños, perfectamente niquelados, tan bien niquelados que según él eran de plata. Alicates en miniatura y un destornillador igualmente diminuto. Todo eso guardado en una sólida caja de madera, despintada pero con compartimentos para las distintas piezas.
Erenestito, además de sus cuentos y su colección de coches metálicos, tenía su castillo de plástico endurecido, con un torreón con almenas desde las que podían disparar cómodamente los arqueros. Un castillo con paredes ensambladas que reproducían en su superficie exterior las piedras e incluso el moho de las fortalezas antiguas y que estaba rodeado por un foso de agua, pintado de un azul igual al del cielo en aquellos días. Tenía indios, soldados con metralletas y ballesteros de colores. Tártaros con sables curvados, gladiadores. Mi indio era de color verde. Verde entero, la carne verde y el pantalón verde, las plumas, la lanza, todo de un color verde venenoso.
Ernestito, y también Mauri, usaban pegamento Imedio para pegar sus estampas. Sus álbumes de animales desprendían desde lejos una especie de olor metálico, a perfumería.
Mi álbum crujía. Crujía como si las fieras, los leones, la hiena y hasta las cabras montesas de los cromos rugiesen cuando uno se acercaba al álbum.
Yo pegaba las estampas con una masa de harina y agua que mi madre me fabricaba en una huevera, una masa que yo, desanimado, restregaba sobre los recuadros del álbum con un palillo de dientes y que inevitablemente dejaba grumos, bultos de distinto grosor bajo los cromos, deformándolos.
Mi jaguar, precisamente el jaguar, parecía mellado por el desnivel que aquella masa había formado bajo su mandíbula.
Era un álbum escarpado y crujiente. El ruido de las páginas al pasarlas era igual al que hace una puerta vieja o una persiana rota. Mi álbum tenía las hojas onduladas. Habría sido mejor no tener nada. No importaba cuántos cromos ni cuántas páginas hubiera conseguido completar. Cuando Mauri o Ernestito entraban en mi casa yo escondía el álbum debajo de la cama.
Así eran las cosas.
Don Guillermo Galiana olía a colonia y mi padre olía a calle y a otros hombres. A hombres que hablaban en voz alta y reían en voz todavía más alta. Olía a tabaco, a humo, a sitios con poca luz, a cueva de Alí Babá.
Quizá por todo eso más me valía vigilar. Estar atento a lo que ocurría fuera de mí.
Aunque finalmente no importó cuánto tiempo ni con cuánta atención vigilase. Un buen día, Ernestito se colocaría sigilosamente a mi espalda y comprobaría en mi nuca la dureza del carbón cristalizado. De esa piedra negra y brillante que él, o quizá su tía Tusa, llamó carbón mineral.
© Antonio Soler, Una historia violenta, 2013, Galaxia Gutenberg.
Quella vita dove sono io, cioè La Casa in Via Palestro di Franco Buffoni
di Marco Corsi

Una dislocazione autobiografica della realtà: forse coniando qualche nuova formula risulta più accessibile questo ultimo lavoro in prosa di Franco Buffoni. Una dislocazione, agli effetti, che passa attraverso fatti, personaggi, eventi, documenti, e compone in filigrana il Bildungsroman dell’uomo e del poeta, rendicontando il tempo della storia e il tempo della scrittura.
Ave Bernhard: cantus responsorius
di Martial Pyrrhus e Lucretius Porphirogenitus
1 Ave Bernhard
… morte le gore, morte le campagne,
morta la morte e morta la rimorte
(un sole nero in pieno giorno guarda
sul golgota due morti ed un rimorto),
rimorti i morti e i non ancora nati,
morti i sepolti, morti gli esumati,
gli agnelli divorati, con le cagne
morte già prima di averli sbranati …
L’amore e Gödel
Alcune considerazioni su Almanacco del Giorno Prima di Chiara Valerio
di Vanni Santoni
 Ho conosciuto Chiara Valerio dieci anni fa; eravamo due esordienti (anche se lei non lo sembrava, appartenendo a quella categoria di persone che sembrano sempre “nate imparate”) ed eravamo stati invitati a Roma, assieme ad altre due persone, nella sede di una casa editrice un tempo grande e prestigiosa e allora in fase di rilancio, in quanto vincitori, coi nostri romanzi, di un concorso per esordienti. Lì fummo ricevuti dal direttore della casa editrice un tempo grande e prestigiosa, il quale ci fece tanti complimenti, ci disse della fase di rilancio e ci fece parlare con la scrittrice famosa che presiedeva la giuria del concorso, la quale pure ci fece tanti complimenti, distribuì un po’ di consigli e ci rese al direttore, il quale ci fece un contratto (mi par di ricordare che fosse addirittura per tre libri) e ci rimandò a casa tutti contenti. Va da sé che il concorso si rivelò una fregatura, la casa editrice un tempo grande e prestigiosa smise di essere in fase di rilancio e anzi smise proprio di farsi sentire, ci piazzò in standby e poi, solo a fronte di nostre reiterate e via via sempre più rabbiose e disperate richieste di chiarimenti, ci fece capire che quei libri non li avrebbero stampati mai. Va da sé che le quote di iscrizione al concorso non vennero mai rese ai partecipanti, ma noi non pensavamo certo a quei dieci o venti euro: noi pensavamo ai nostri libri e infatti ricordo che con Chiara (gli altri due vincitori dopo un po’ sparirono dal radar) ci scambiavamo delle mail in cui sostanzialmente ci giravano le palle. Io, poi, ero stato così ingenuo da dire a chiunque, parenti, amici, fidanzata, che avevo vinto il concorso nazionale per esordienti della casa editrice un tempo grande e prestigiosa e in fase di rilancio – avevo, come si suol dire, “comprato il vestito buono” – e adesso l’evidenza che invece il libro non sarebbe mai uscito era esiziale (oltre che una bella figuraccia). Non so come andò per Chiara, ma per quanto mi riguarda quella bruciantissima fregatura fu decisiva per diventare uno scrittore. Non restava altro, del resto: se volevo dimostrare che davvero ero quella cosa là, l’unica era pubblicare un libro altrove. Magari con una casa editrice migliore di quella un tempo grande e prestigiosa.
Ho conosciuto Chiara Valerio dieci anni fa; eravamo due esordienti (anche se lei non lo sembrava, appartenendo a quella categoria di persone che sembrano sempre “nate imparate”) ed eravamo stati invitati a Roma, assieme ad altre due persone, nella sede di una casa editrice un tempo grande e prestigiosa e allora in fase di rilancio, in quanto vincitori, coi nostri romanzi, di un concorso per esordienti. Lì fummo ricevuti dal direttore della casa editrice un tempo grande e prestigiosa, il quale ci fece tanti complimenti, ci disse della fase di rilancio e ci fece parlare con la scrittrice famosa che presiedeva la giuria del concorso, la quale pure ci fece tanti complimenti, distribuì un po’ di consigli e ci rese al direttore, il quale ci fece un contratto (mi par di ricordare che fosse addirittura per tre libri) e ci rimandò a casa tutti contenti. Va da sé che il concorso si rivelò una fregatura, la casa editrice un tempo grande e prestigiosa smise di essere in fase di rilancio e anzi smise proprio di farsi sentire, ci piazzò in standby e poi, solo a fronte di nostre reiterate e via via sempre più rabbiose e disperate richieste di chiarimenti, ci fece capire che quei libri non li avrebbero stampati mai. Va da sé che le quote di iscrizione al concorso non vennero mai rese ai partecipanti, ma noi non pensavamo certo a quei dieci o venti euro: noi pensavamo ai nostri libri e infatti ricordo che con Chiara (gli altri due vincitori dopo un po’ sparirono dal radar) ci scambiavamo delle mail in cui sostanzialmente ci giravano le palle. Io, poi, ero stato così ingenuo da dire a chiunque, parenti, amici, fidanzata, che avevo vinto il concorso nazionale per esordienti della casa editrice un tempo grande e prestigiosa e in fase di rilancio – avevo, come si suol dire, “comprato il vestito buono” – e adesso l’evidenza che invece il libro non sarebbe mai uscito era esiziale (oltre che una bella figuraccia). Non so come andò per Chiara, ma per quanto mi riguarda quella bruciantissima fregatura fu decisiva per diventare uno scrittore. Non restava altro, del resto: se volevo dimostrare che davvero ero quella cosa là, l’unica era pubblicare un libro altrove. Magari con una casa editrice migliore di quella un tempo grande e prestigiosa.
Per questo, ogni volta che ne faccio arrivare uno in libreria, c’è sempre una (ormai minuscola eppure esistente) parte di me che gode anche perché è una ulteriore dimostrazione di quanto quelli furono grulli a non pubblicare il mio libro. E quella stessa parte di me gode ogni volta che Chiara Valerio pubblica un libro, poiché ciò rinforza tale dimostrazione. Avevate trovato gli scrittori e non li avete fatti, siete proprio grulli. Se poi, come nel caso di Almanacco del giorno prima, il libro è anche stupendo, allora il godimento diventa anche orgoglio per i risultati di una persona che un destino (inizialmente) avverso mi ha assorellato. Ai tempi in cui eravamo ragazzotti all’esordio, io non avevo molto da lasciarmi dietro per far spazio alla letteratura: avevo lavorato nella formazione e nel giornalismo, ero stato uno studente universitario solo discreto; dal mondo dei romanzi avevo insomma soltanto da prendere; lei invece era una matematica, una vera, di quelle col PhD, e ciò oggi – incluso, si intuisce, l’abbandono di quel percorso – si ritrova in questo romanzo, appena uscito per Einaudi. Nel leggere la sinossi in bandella, che recita, tra le altre cose, “Alessio Medrano è un broker geniale e sentimentale, scommette sui fallimenti come fossero successi: ‘i soldi sono un’idea vecchia, bisogna investire sul tempo’.”, si rischia di finire fuorviati. Lungi dall’essere solo romanzo sulla questione finanziaria postmoderna vista dagli occhi di un addetto ai lavori particolarmente dotato, in Almanacco del giorno prima la matematica, e con essa la finanza, sua figlia cinica, diventa un filtro attraverso cui guardare il mondo. Alessio Medrano siamo tutti noi, anzitutto perché, affidandosi egli a codici interiori che rimandano a un linguaggio che più o meno, a diversi gradi, conosciamo tutti, ci viene facile entrare dentro di lui: il suo codice matematico diventa riflesso chiarificato e metro dei nostri personali e più contorti codici.
Ma facciamo, per l’appunto, ordine: Almanacco del giorno prima è un romanzo in tre parti, di lunghezza decrescente. La prima ci racconta l’infanzia e la formazione di Alessio Medrano. La seconda, per frammenti, il periodo in cui il Medrano si innamora di una persona che non lo ricambia. La terza riagguanta la narrazione e la chiude.
A prima vista, la prima parte è la più potente, perché Chiara Valerio dà una dimostrazione di maestria letteraria pura, di quel tipo di raggiunta maturità della scrittura che non ha bisogno di “fare numeri” ma li tiene sotto la superficie, esprimendo una forza controllata; nel libro si evoca l’opera al rosso, ma Almanacco del giorno prima è una vera e propria opera al bianco, nella sua compiutezza stilistica e formale: le avventure di questo bambino dalla enorme intelligenza analitica (che si trasformerà, ahilui, in un adulto del tutto sprovvisto di intelligenza emotiva) conquistano perché egli, in quanto persona che riduce tutto, anche se stesso, a fattore numerico, è per forza anche noi, tutti conteniamo Medrano e ne siamo contenuti; inoltre, vederlo fare i puzzle al contrario o gabellare i compagni di scuola con trucchi grifagni, è uno spasso, così come è avvincente seguire le sue avventure nei derivati da polizze di fine vita, ovvero, insomma, la speculazione finanziaria sulla morte della gente – i cosiddetti death bond – e seguirlo quando si lancia dentro quegli abissi di senso che sono tutte le cose che mettono in comunicazione vite e numeri, tra cui le polizze ma anche i (solo apparentemente prosaici) elenchi del telefono.
Ho scritto “a prima vista” perché la seconda parte – in cui, per frammenti di vita, brani di discorsi, tic e idiosincrasie della dialettica affettiva, si racconta l’amore di Medrano per Elena, una donna che non lo ama (né però si libera di lui: una stronza, per farla breve) e lo scontrarsi, ineludibilmente tragico, di una visione del mondo che tutto vorrebbe categorizzare con una realtà, quella amorosa, che è per definizione categoria a sé – risulta apparentemente più fredda della prima, ma ciò avviene solo in fase di lettura (vi è del resto, al di là della forma meno narrativa, un ribaltamento: dall’immedesimazione col Medrano bambino si passa al nervoso per il Medrano adulto, alla voglia di urlargli “sveglia, maledizione!”), dato che successivamente, già quando si approda alla terza parte, che del Medrano ricostruisce l’educazione sentimentale e chiude la vicenda professionale e finanziaria, quei frammenti cominciano a comporsi nella memoria e riverberare: a legarsi tra loro andando a ricostruire un puzzle via via sempre più chiaro, che però, come quelli amati dal Medrano fanciullo, è ribaltato, senza immagini, tutto “color das secco”, perché è il puzzle di un amore che non esiste, e di fronte a tale spietata evidenza a poco valgono, a quel punto, i risultati delle speculazioni finanziarie di Medrano e del socio Janak, se non a confermare che, sì, oggi si può ridurre a numero chiunque, ma non colei o colui di cui si è innamorati, poiché l’amore non si misura, né tanto meno si ottiene, con gli strumenti del non-amore (da profano viene in mente Gödel e il suo teorema di incompletezza – mi perdoni Chiara se si tratta di uno sfondone matematico). Il romanzo, con ciò, pone tuttavia un’altra e più grande questione: davvero l’ultima soluzione, l’ultima salvezza che ci è rimasta è l’amor romantico? La coppia, addirittura? Morti gli idoli, finite le ideologie, collassata la famiglia, seppellito il lavoro come fonte dell’identità, superata nostro malgrado un’infanzia e un’adolescenza che abbiamo cercato di prolungare in ogni modo, divenuto tutto fluido (come un liquido, o una stringa di codice), giusto l’amore romantico è un sogno permesso? Se è così, guai allora a chi si innamora senza esser corrisposto. Questa visione del mondo riuscii a evitarla, o almeno a evitare che diventasse univoca e assoluta, buttandomi, grazie anche alla ferita infertami dal concorso farlocco, sulla letteratura. Mi par che Chiara abbia fatto lo stesso, e che la letteratura, prova ne è questo mirabile romanzo, la corrisponda in pieno.
Almanacco del giorno prima, Chiara Valerio, Einaudi 2014, pp.350 €20.
Pesci d’aprile – Una poesia di Rita Filomeni
Ci sono battaglie che nascono con la camicia, altre meno. Lo Stato, di questi tempi, ha la vista disgiunta del camaleonte, e se con un occhio punisce con l’altro assolve e la coerenza è un mestiere per eremiti. Il rimpallo e il rimando, allora, rappresentano il miglior modo per riassicurarsi la parte e o l’impunità per le azioni, omissioni.
Sorte vuole che oggi, 1 aprile, scada il termine per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), più comunemente noti come “manicomi criminali”. Neppure un miracolino, invece, per i “folli rei”. Già, perché – per dirla con Leo Longanesi -, “Alla manutenzione, l’Italia preferisce l’inaugurazione”, e non si poteva non dare e darsi un po’ di tempo (un altro anno, se va bene, prima erano tre) per bandire a riguardo una bella ed eccitante gara d’appalto, così da mettere in cantiere un regionalismo di piccole case con tetto di paglia a venti posti letto dove eseguire le misure di sicurezza, soluzioncina, questa nuova, certo meno contestabile, indigesta e nauseabonda rispetto alla colonia penale, e per di più ineccepibile sotto il profilo dei comfort. La vicenda, che si invita a seguire nelle sue pieghe più da vicino, è scandalosa quanto certamente complessa, ma esorta ugualmente tutti ad opporre alla minaccia dell’insensatezza sociale, un nucleo irriducibile di sopravvivenza dell’amore e dell’etica. R.F.
. pesci d’aprile
al concorso a premi sabbie immobili,
ognuno sa che il gioco e suo è già fatto
come tra amici e niente ostacola niente,
squalifica, a chi l’assale, ‘l pentimento
e monetina a cemento, tutti accontenta
e sì pure ‘l taglio del nastro inaugurale
con il sindaco, la banda e i chierichetti
emoziona ‘l tour le stanze ‘n ipercubo
a otto facce, e per ciascuna a detenuto
che lì spera rinvio a altro non rimandi,
la morte abbia pietà di un pesce muto
Nel bosco degli Apus apus
di Mariasole Ariot
Apus apus: “Una sua peculiarità è quella di avere il femore direttamente collegato alla zampa, tanto che il nome scientifico deriva dalla locuzione greca “senza piedi”. Questa sua caratteristica fa sì che non tocchi mai il suolo in tutta la sua vita; infatti se disgraziatamente si posasse a terra, la ridotta funzionalità delle zampe non gli consentirebbe di riprendere il volo”. Quindi dorme in volo.
—
Il corpo urta sugli spigoli non per eccesso di ossa ma per un compendio di niente. Mi accorgo della grande solitudine del cielo, di questo filo tirato tra un muro e l’altro per appendere gli impiccati.
Ce ne stiamo lì a guardare, ogni mattina, come fossimo un pubblico in fila al concerto, o alle poste, ci spintoniamo per guardare il massacro.
Io vivo, lui non vive, io non vivo. Lui si ritrae nella cantina. Io mi affaccio. Lui vede il bulbo, io vedo il fiore. Lui mi pettina i capelli con il rastrello, io preparo la camomilla.
Quanto manca al primordiale? Amare ha un nome proprio. Io ho perduto il mio.
—
Amarcord Poétique : Italo Testa
Nota
di
Alida Airaghi
Questi versi di Italo Testa interrogano il lettore -emozionandolo, anche- già dal titolo, che (al di là del riferimento al gruppo punk inglese Joy Division) non allude come ci si aspetterebbe a una “condivisione” della gioia (tra l’autore e chi legge, tra protagonista recitante e deuteragonista che ascolta), bensì a una sua “divisione”: quindi a una frammentazione, a una non totalità e non completezza, ribadita in tutti e tre i capitoli che compongono il libro. La cui nota dominante è senz’altro una rassegnata malinconia, attualissima però, disincantata in un soliloquio che tenta vanamente il dialogo, con alle spalle uno scenario grigio, silenzioso, di smobilitazione post-industriale. E opportunamente il poeta cita, in esergo alla seconda, splendida sezione, una frase di Edward Hopper: perché proprio agli interni disadorni e ai desolati esterni del pittore americano sembra rifarsi l’ambientazione dei suoi versi (“I was more interested in the sunlight on the buildings and on the figures than any symbolism”).
Eccoli, dunque, gli interni raccontati da Testa nelle quattro parti in cui si suddivide la sezione che dà il titolo al volume: “un interno spoglio e taciuto…a telefono spento…nello specchio marmoreo di un tavolo…le grate che spartivano il vetro…i gradini lucidi…di sbieco su una sedia…in una stanza anonima, spoglia…in una stanza vuota”: un crescendo di non appartenenza, in cui si muove la coppia di amanti. Il poemetto (che è poi una lunga lettera d’amore, sfiduciata eppure tenera, delusa dalla propria non-passione, rivolta a una lei sempre lontana anche quando viene descritta nella sua fisicità più intima), ha un ritmo lento e avvolgente, assolutamente musicale, nella pacatezza delle sue rime e di una metrica tradizionale però mai scontata, priva di qualsiasi brusco scarto formale. Una bassa marea di sonorità, che accompagna queste immagini dal sapore cinematografico (campi lunghi, sfondi dai colori tenui, una natura indifferente se non ostile alla presenza umana): i luoghi sono quelli, padani, pianeggianti, del delta del Po. E gli echi letterari (una presenza costante del primo Montale: come non ricordare Dora Markus?) rimandano forse alla narrativa di Bassani (le bellissime pagine de “L’Airone” trovano un’empatica rispondenza in questi versi); ma anche a Celati, a Tonino Guerra, e ad altri visionari della pianura tra Veneto ed Emilia.
Gli esterni non sono più partecipi dell’avventura umana di quanto lo siano gli interni: “spazio deserto…sotto un lampione astioso…la fissità del cielo…statue mute…i tetti opachi e le lamiere arroventate…la distesa dei campi d’acqua…case abbandonate…fabbriche addormentate…l’armatura dei pilastri…erbe matte sul terreno…mattoni e lamiere ondulate…”). E la nebbia, il silenzio, in cui si muovono i due protagonisti, sospesi, incapaci di vera comunicazione. Italo Testa recita le sue parole in prima persona, si rivolge a un tu che stenta a raggiungere, a toccare concretamente: i due amanti sono descritti spesso in piedi, “appoggiati”, “affacciati”, zitti e in attesa, quasi a chiedere conforto e sicurezza alla realtà dei muri, dei balconi, degli oggetti. E non trovano certezza nei loro gesti, nei pensieri, nei reciproci abbandoni: “così aspettiamo giorno per giorno,/ un foglio in mano, lo sguardo perso”, “la fragilità ci insidia dall’interno”, “stiamo lì, col capo arrovesciato/ un po’ assonnati sopra il letto,/ le gambe appena reclinate/ contiamo le pieghe sul lenzuolo”, “il braccio nascosto tra le gambe, la luce sulle mie cosce nude,/ la mano a coprirti il pube”. In un’estraneità sofferta, immodificabile: “saremo corpi in attesa, tronchi/ riversi, distesi tra le cose”.
La stessa incomunicabilità che ricorda i film di Antonioni, e, come già detto, l’angosciante desolazione dei quadri di Hopper, la ritroviamo nelle altre due sezioni del volume: “Cantieri” e “Delta”. Quest’ultima ancora centrata sui temi sentimentali della precedente, espressi in versi più veloci e orecchiabili, al limite del cantato, con qualche concessione alla retorica di più facile presa. Il paesaggio è sempre segnato da pioppi e argini, nebbia e neve, rami-confluenze-strade come si conviene in un delta, entro i cui confini i due protagonisti si cercano e si sfuggono, trincerandosi in rapporti sessuali veloci e talvolta colpevoli, chiedendosi e negandosi aiuto reciproco. I colori non transigono, severamente sfumando dal bianco al grigio, “nel polverio/ di una geografia remota” che non sembra conoscere l’indulgente abbandono al sole, al calore, alla luce.
Decisamente più originali sono invece le poesie della prima parte, ambientate nelle periferie industriali di Marghera, tra pale meccaniche, cisterne, torri e silos, container, gru, pilastri di cemento, cavi dell’alta tensione, tralicci, rimorchi; tra fabbriche disumane dai nomi inclementi (Fincantieri, Saipem, Crion), in orari albeggianti di “luce polverosa” e proletaria. Eppure in questi versi privi di rabbia e semplicemente descrittivi, che si limitano a constatare una realtà perdente e umiliata, aleggia uno stupefatto e accorato sentimento di solidale comprensione, e pietà, per le persone, la loro vita e la loro storia, che avvicina il lettore alla verità disadorna della poesia più autentica.
Italo Testa, La divisione della gioia – Transeuropa Ed-Massa 2010 – Euro 9,50 – Pagine 75