di Sergio Baratto

“Seduto in soggiorno, cercava di leggere. Si era preparato un whisky e soda al suo piccolo mobile bar e teneva il bicchiere in mano mentre era immerso in un testo di fisiologia. Dall’altoparlante sopra la porta del disimpegno usciva a volume altissimo la musica di Schoenberg.
Ma non bastava. Riusciva comunque a sentirli, lì fuori, a sentire i loro bisbigli, i passi, le grida, il ringhio e le risse tra loro. (…)
Ed erano tutti lì per la stessa ragione.”
Richard Matheson, Io sono leggenda
Ma che orrore la faccenda dei 37 sudanesi imprigionati per giorni su una nave e ora imprigionati in terraferma.
E poi la farsa delle identificazioni: sono veri profughi in fuga dalla guerra (Darfur: oltre un milione di sfollati interni, 160.000 profughi, dai 10.000 ai 30.000 morti) o sono soltanto veri desperados? Ma se anche fossero solo 37 banalissimi ghanesi o nigeriani in fuga dalla miseria, dico, cambierebbe qualcosa? Comunque sia, a quanto pare 37 negretti assediano l’Europa. Pazzesco.


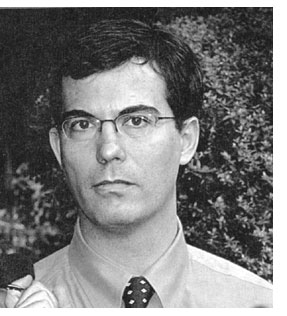 La politica corre dietro ai suoi tempi, dimostrando che se esiste un concetto primario di identificazione tra messaggio e ricezione dello stesso, quello risiede nella priorità dell’immagine. L’identità politica dunque è oggi un complesso mostro sociale che prende forma dallo “stimolo” televisivo promosso dalle nostre trasmissioni. Il mezzo televisivo acquisisce la sua caratteristica e soggettività, come pure l’idea di società e di politica che proietta, non (solo) attraverso il suo palinsesto, per via delle sue trasmissioni, ma (anche) grazie al rapporto economico dettato dalla compagnia proprietaria dell’emittente televisiva stessa.
La politica corre dietro ai suoi tempi, dimostrando che se esiste un concetto primario di identificazione tra messaggio e ricezione dello stesso, quello risiede nella priorità dell’immagine. L’identità politica dunque è oggi un complesso mostro sociale che prende forma dallo “stimolo” televisivo promosso dalle nostre trasmissioni. Il mezzo televisivo acquisisce la sua caratteristica e soggettività, come pure l’idea di società e di politica che proietta, non (solo) attraverso il suo palinsesto, per via delle sue trasmissioni, ma (anche) grazie al rapporto economico dettato dalla compagnia proprietaria dell’emittente televisiva stessa. Non è difficile voler bene alle architetture di Frank Owen Gehry. Non ostante lo stile “terremotato”, l’accartocciarsi e il frantumarsi dei suoi volumi edilizi, non ostante l’insistente sensazione di perdita dell’equilibrio, il disprezzo per le regole base della statica e della “buona educazione” urbana, le opere di Gehry, canadese di nascita ma statunitense d’adozione, sono per loro natura amichevoli. Lo sono per l’insita spettacolarità barocca, certo, ma questo non basterebbe, lo sono perché hanno, caso non unico ma di certo raro in tutta la storia dell’architettura, un gran senso dell’umorismo.
Non è difficile voler bene alle architetture di Frank Owen Gehry. Non ostante lo stile “terremotato”, l’accartocciarsi e il frantumarsi dei suoi volumi edilizi, non ostante l’insistente sensazione di perdita dell’equilibrio, il disprezzo per le regole base della statica e della “buona educazione” urbana, le opere di Gehry, canadese di nascita ma statunitense d’adozione, sono per loro natura amichevoli. Lo sono per l’insita spettacolarità barocca, certo, ma questo non basterebbe, lo sono perché hanno, caso non unico ma di certo raro in tutta la storia dell’architettura, un gran senso dell’umorismo. Sguazzavano nel sangue fino alle ginocchia, i cavalli nel Tempio. Anche questa era stata un’immagine di Medioevo, quello europeo, delle croci infuocate sui manti bianchi, resi immacolati dalla benedizione del Papa, partiti per sollevar polvere a Gerusalemme. Quel Medioevo, però, lucidato e rimpennacchiato, giungeva nei lieti palazzi in scrigni di libri, illuminati e ingentiliti da cornici, come i chiostri da ombrose e istoriate fontanelle. Quei libri portavano immagini d’amore e galanteria, nelle ore pomeridiane, con misurata grazia, e Orlando, e Artù, e il più romantico tra loro, Lancillotto, tracciarono con le loro lance, quasi fossero i lunghi pennelli del vecchio elegante Degas, merletti, e vesti di vaghi colori per le dame, perché potessero sorridere un po’, e un po’ potessero piangere delle scure trine purpuree con cui la morte, talvolta vincitrice, miniava i fregi gotici delle loro corazze.
Sguazzavano nel sangue fino alle ginocchia, i cavalli nel Tempio. Anche questa era stata un’immagine di Medioevo, quello europeo, delle croci infuocate sui manti bianchi, resi immacolati dalla benedizione del Papa, partiti per sollevar polvere a Gerusalemme. Quel Medioevo, però, lucidato e rimpennacchiato, giungeva nei lieti palazzi in scrigni di libri, illuminati e ingentiliti da cornici, come i chiostri da ombrose e istoriate fontanelle. Quei libri portavano immagini d’amore e galanteria, nelle ore pomeridiane, con misurata grazia, e Orlando, e Artù, e il più romantico tra loro, Lancillotto, tracciarono con le loro lance, quasi fossero i lunghi pennelli del vecchio elegante Degas, merletti, e vesti di vaghi colori per le dame, perché potessero sorridere un po’, e un po’ potessero piangere delle scure trine purpuree con cui la morte, talvolta vincitrice, miniava i fregi gotici delle loro corazze.
 Il 15 febbraio 2003 l’Europa sembrava qualcosa che stava per nascere, per nascere letteralmente, un fiume sgorgato da tutte gambe che si univano in manifestazione, una fioritura che si schiudeva nelle bandiere arcobaleno che comparivano persino alle finestre dei palazzi patrizi, delle villette isolate, dei casermoni periferici.
Il 15 febbraio 2003 l’Europa sembrava qualcosa che stava per nascere, per nascere letteralmente, un fiume sgorgato da tutte gambe che si univano in manifestazione, una fioritura che si schiudeva nelle bandiere arcobaleno che comparivano persino alle finestre dei palazzi patrizi, delle villette isolate, dei casermoni periferici. Anche nel giochino della “letteratura” succede la stessa cosa. Anche qui ci sono griglie interpretative e piccoli sistemi che tengono fuori tutto il resto, autorappresentazioni antropocentriche che vorrebbero stabilire ciò che “sta dentro” e ciò che “sta fuori”, anche se, a ben vedere, quello che sta fuori sembra proprio la parte più grossa. Nelle settimane scorse, ad esempio, c’è stato un articolo scritto da un umano scrittore di nome Covacich e apparso su “L’espresso”. Il solito refrain sugli scrittori italiani che non sarebbero in grado di parlare della realtà e di fare quello che fanno invece gli scrittori umani di altri paesi, che abbiamo letto già tante volte – declinato in modi e forme diverse – sui nostri giornali. «Ragazzi, perché non riusciamo a suonare?» si domanda Covacich. «Perché la musica ci resta sempre lì, sul tavolo della pizzeria?» Ecc… «Parla per te!» verrebbe da rispondere, e la cosa sarebbe finita lì. Invece c’è qualcos’altro da dire. Sulla “realtà”, per esempio.
Anche nel giochino della “letteratura” succede la stessa cosa. Anche qui ci sono griglie interpretative e piccoli sistemi che tengono fuori tutto il resto, autorappresentazioni antropocentriche che vorrebbero stabilire ciò che “sta dentro” e ciò che “sta fuori”, anche se, a ben vedere, quello che sta fuori sembra proprio la parte più grossa. Nelle settimane scorse, ad esempio, c’è stato un articolo scritto da un umano scrittore di nome Covacich e apparso su “L’espresso”. Il solito refrain sugli scrittori italiani che non sarebbero in grado di parlare della realtà e di fare quello che fanno invece gli scrittori umani di altri paesi, che abbiamo letto già tante volte – declinato in modi e forme diverse – sui nostri giornali. «Ragazzi, perché non riusciamo a suonare?» si domanda Covacich. «Perché la musica ci resta sempre lì, sul tavolo della pizzeria?» Ecc… «Parla per te!» verrebbe da rispondere, e la cosa sarebbe finita lì. Invece c’è qualcos’altro da dire. Sulla “realtà”, per esempio. Fra qualche giorno partirò di nuovo. Riattraverserò di nuovo l’oceano assieme a Giovanni, tornerò a Buenos Aires, dove ci sono già Laura e Nic. Da lì scenderemo nella Patagonia, quella argentina o forse quella cilena, non lo so ancora, ma sempre più a sud, sempre più a sud, sulla curvatura della terra, fino alla fine del mundo.
Fra qualche giorno partirò di nuovo. Riattraverserò di nuovo l’oceano assieme a Giovanni, tornerò a Buenos Aires, dove ci sono già Laura e Nic. Da lì scenderemo nella Patagonia, quella argentina o forse quella cilena, non lo so ancora, ma sempre più a sud, sempre più a sud, sulla curvatura della terra, fino alla fine del mundo.

 Di Marco Giovenale
Di Marco Giovenale In un saggio famoso, scritto quattro anni prima di metter mano alla Ricerca, Proust riflette sull’età d’oro delle sue letture, l’infanzia, e sulla passionale sudditanza da lui allora sperimentata nei confronti dell’autore del suo romanzo prediletto, Capitan Fracassa:
In un saggio famoso, scritto quattro anni prima di metter mano alla Ricerca, Proust riflette sull’età d’oro delle sue letture, l’infanzia, e sulla passionale sudditanza da lui allora sperimentata nei confronti dell’autore del suo romanzo prediletto, Capitan Fracassa: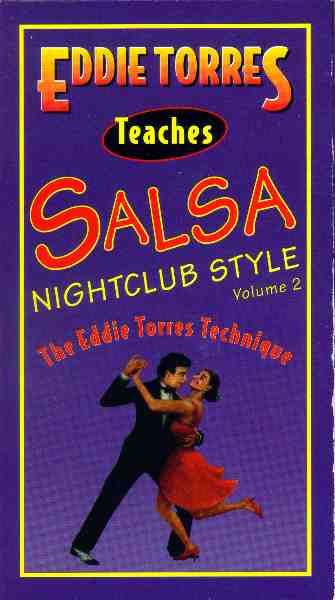 Da novembre dello scorso anno ho cominciato un corso di ballo latino americano; gli inizi sono stati faticosi e non poteva essere diversamente. La mia frequentazione di discoteche, benché assidua per anni, non aveva contribuito in alcun modo a sciogliere le mie rigidità.
Da novembre dello scorso anno ho cominciato un corso di ballo latino americano; gli inizi sono stati faticosi e non poteva essere diversamente. La mia frequentazione di discoteche, benché assidua per anni, non aveva contribuito in alcun modo a sciogliere le mie rigidità. Qualcuno, in una taverna, ha appena raccontato un fatto di cronaca nera: un ragazzo e una ragazza, appassionati di romanzi d’amore, sono stati uccisi dal marito geloso. Il commensale è ancora stordito da ciò che ha ascoltato. Ma è tardi, deve alzarsi da tavola, riprendere il viaggio, andare a negoziare con gli alleati diffidenti, in quella città livida che si intravede all’orizzonte, cavalcando sotto l’acquazzone. Piove forte.
Qualcuno, in una taverna, ha appena raccontato un fatto di cronaca nera: un ragazzo e una ragazza, appassionati di romanzi d’amore, sono stati uccisi dal marito geloso. Il commensale è ancora stordito da ciò che ha ascoltato. Ma è tardi, deve alzarsi da tavola, riprendere il viaggio, andare a negoziare con gli alleati diffidenti, in quella città livida che si intravede all’orizzonte, cavalcando sotto l’acquazzone. Piove forte.