Overbooking: Qui non possiamo più restare
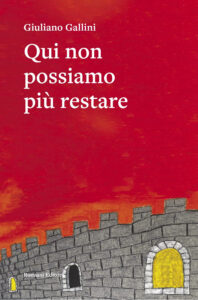
di Romano A. Fiocchi
Ho conosciuto la scrittura di Giuliano Gallini attraverso un progetto comune: nel 2020 siamo stati coinvolti entrambi nella Piccola antologia della peste di Francesco Permunian, corposo prosimetro dell’Italia ai tempi del Covid cui hanno preso parte trentaquattro autori di varia provenienza, da Franco Buffoni a Dacia Maraini, per fare due nomi tra i più noti. Il contributo di Gallini consisteva in un racconto suggestivo ambientato sulle rive del Po: Il portalettere. Una scrittura pacata, fluente come una piena, talvolta forbita e comunque sempre rispettosa della lingua, alla ricerca di una compostezza da grande narratore.
Qui non possiamo più restare, pubblicato da Ronzani Editore nel marzo 2022, ha la stessa intonazione. Soprattutto, al di là dello stile, riprende e sviluppa un tema che nel racconto è appena accennato: i miserabili, ossia quei «diseredati del nuovo millennio, vittime delle periodiche crisi del mercato globale» (il termine miserabili si rifà ovviamente ai poveri di Victor Hugo della Parigi di inizio Ottocento). La comunità del Monte Verità che si inventa Gallini, con tutti i personaggi positivi che la guidano, dalla fondatrice Marcenda Werefkin a Livia, da Nabilah a Simon, rappresenta quella parte buona dell’umanità che continua a battersi per i più deboli, che cade e poi risorge, che magari finisce per fallire (come succede nel romanzo) ma sa che qualcun altro ci riproverà, altrove e in altro modo. Perché gli idealisti non finiranno mai di lottare per le loro utopie. Eppure non sono eroi, non sono uomini e donne tutti d’un pezzo, anzi: hanno la debolezza degli esseri umani che combattono continuamente contro se stessi, contro la tentazione di arrendersi e di mollare tutto, che sentono il peso e l’ambiguità subdola del male che li circonda. Male che finisce per affiorare anche tra gli abitanti di Murata, prima pronti ad accogliere compiaciuti la comunità del Monte, che ridà vita alla struttura del monastero abbandonato, e poi a diventarle ostili.
Qui non possiamo più restare è un romanzo di impegno sociale, una sorta di reportage di fantasia che permette a Gallini di denunciare situazioni reali. In primo luogo l’atteggiamento opportunista delle istituzioni verso i centri di accoglienza e la grettezza di parte della popolazione, condizionata dall’ignoranza e dal pregiudizio. Ma anche una denuncia generale verso i meccanismi spietati dell’ultracapitalismo, quello che si affida solamente alle logiche di mercato, quello per cui il dio denaro giustifica tutto:
«Viaggiando attraverso le campagne del nostro paese vidi riunite le tre malattie della società occidentale: l’abbandono, la violenza, l’ingiustizia. I più deboli erano abbandonati a se stessi, la grande finanza spingeva alla violenza tra gli uomini e sulla natura, gli uomini lavoravano nell’ingiustizia. Una realtà che non riguardava più solo la società dominata dalla criminalità, o i mestieri umili, ma anche imprenditori e aziende di fama, insospettabili».
È anche una storia di sentimenti, di relazioni che si instaurano e si dissolvono. Tant’è che il lettore finisce per innamorarsi di Marcenda, con quel suo gesto di toccarsi il petto per calmare la tachicardia del suo piccolo cuore. O della combattiva Livia, che si infila l’abito rosso vivo prima di affrontare la lotta. Con un’analisi introspettiva dei personaggi, Gallini spinge in superficie i dubbi e le angosce dell’uomo contemporaneo, i sogni e gli ideali, le bassezze e le incomprensioni, che sono poi – queste ultime – alla base del male, ossia la più profonda idiozia dell’uomo.
È un romanzo che non dà soluzioni perché, in fondo, dare soluzioni non è il compito della letteratura. È un testo che non aspira alla perfezione dell’intreccio perché il suo obiettivo è altro: parlare dell’umanità di oggi. Ma ci sono anche pagine descrittive molto poetiche, oserei dire quasi manzoniane. Pagine ormai rare nella produzione editoriale di questi ultimi tempi.
Una curiosità del libro, che è poi una caratteristica della collana Carvifoglio: nelle ultime pagine un codice Spotify riporta alla colonna sonora scelta dall’autore. Per iniziare l’ascolto basta inquadrarlo con la videocamera del cellulare attraverso l’apposita applicazione. Un modo innovativo per avvicinare musica e letteratura.
I commenti a questo post sono chiusi


Mi incuriosisce… lo leggerò
AD.
Sono d’accordo, credo che il compito della letteratura non sia dare soluzioni, ma porre domande e stimolare riflessioni che possono anche andare in direzione ostinata e contraria.