Nei regni di Michele Mari
di Antonella Falco
Michele Mari, Le maestose rovine di Sferopoli, Einaudi 2021
Con Le maestose rovine di Sferopoli Michele Mari torna a una delle forme letterarie a lui più congeniali, il racconto. È questa, infatti, la sua quarta raccolta. Tra i generi prevalenti, oltre che più efficaci, spicca ancora una volta il fantastico, spesso declinato in chiave horror.
Argilla rielabora l’antico e sempre affascinante mito del Golem (che Mari aveva già brillantemente evocato in Tutto il ferro della Torre Eiffel), partendo da una periodica competizione fra rabbini che però sfugge loro di mano, fino a conseguenze catastrofiche.
Con gli occhi chiusi è articolato in forma di carteggio tra un affittuario e la padrona di casa, in un crescendo di suspense e di inquietudine. La confidenza fra i due aumenta di pari passo al carattere perturbante della vicenda, fino al colpo di scena finale, degno di un racconto di Stephen King.
In Tema in III C il compito assegnato da un maestro elementare funge da pretesto per un maleficio ordito dalla classe ai suoi danni. Resta da capire se il maestro si sia autosuggestionato, rimanendo vittima dell’argomento da lui stesso assegnato ai bambini per il tema in classe, o se quella classe sia costituita realmente da bambini stregoni in grado di operare un maleficio al maestro. La cosa più interessante di questo racconto è tuttavia il modo in cui Mari, simulando la scrittura, anche un po’ sgrammaticata, dei giovanissimi allievi esplori in realtà il genere del racconto fantastico con tutti i suoi paradossi, regalandoci dunque una trattazione di carattere metaletterario, sebbene camuffato da compitino in classe. Alla luce di tutto questo appare ancora più potente l’irruzione, nel finale del racconto, di una situazione realmente fantastica nella vita del professore.
Sempre attorno al concetto della parola che ammalia ed è in grado di attuare un sortilegio è costruito il racconto intitolato Sghru, in cui uno studente impreparato riesce a risollevare le sorti di un esame universitario facendo sfoggio di una lingua sconosciuta che suscita nel professore un rapimento soprannaturale.
Parola apotropaica è invece quella pronunciata dal protagonista di Scioncaccium: il neologismo prodotto dalla crasi fra più vocaboli, tra cui i nomi dei suoi attori preferiti, funge da formula magica in grado di esorcizzare la malattia e tutto il male diffuso nel mondo.
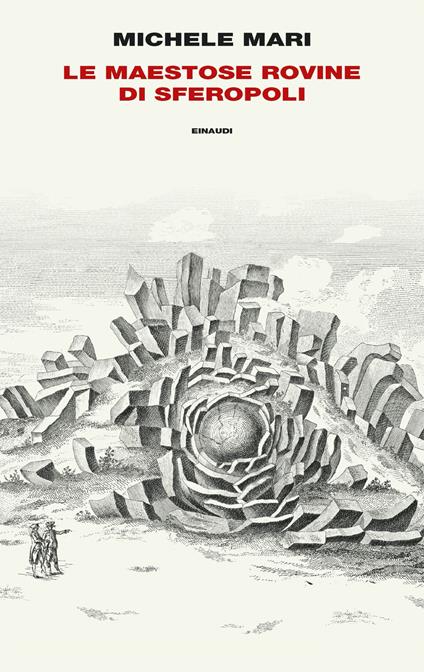
Altro tema ricorrente nella raccolta, e variamente declinato, è quello del cibo: si va dalla indiavolata (e uso questo termine perché, a un certo punto, sembra davvero che il diavolo ci metta lo zampino) competizione fra due parroci dell’alta Val Seriana, appassionati cercatori di funghi, di Boletus edulis, al Dialogo fra Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart e un venditore di formaggi, che già nel titolo sembra riecheggiare un’operetta morale di leopardiana memoria, passando per L’ultimo commensale, racconto in cui due personaggi continuano a conservare frammenti di cibo (ormai putrefatto) dell’ultimo pasto consumato in un’osteria – nel suo ultimo giorno di attività – al fine di potersi fregiare del titolo, appunto, di “ultimo commensale”, fino al succulento In cauda, nel quale reminescenze del periodo universitario si fondono al tema del cibo in un excursus letterario-gastronomico, di chiara ascendenza gaddiana, che culmina nella dettagliata ricetta della coda alla vaccinara. I racconti Boletus edulis e L’ultimo commensale sono collocabili anche in un altro sottogruppo di racconti che caratterizzano questa raccolta, ossia quello della competizione portata fino alle estreme conseguenze, in una sorta di agonismo ostinato e spesso insensato, che può anche rivelarsi letale. Altri racconti dello stesso filone sono Argilla e Il bambino tristissimo.
Alcuni racconti della raccolta sono inediti, altri sono già stati pubblicati. Il falcone, ad esempio, era già presente nel volume miscellaneo Nuovo Decameron che la casa editrice HarperCollins ha pubblicato nel febbraio del 2021 chiedendo a sette scrittrici e tre scrittori contemporanei di sostituirsi ai dieci novellatori del Decameron di Giovanni Boccaccio e di fornire una personale reinterpretazione di una novella, o riscrivendola alla propria maniera, oppure scrivendo un racconto ex novo incentrato però su uno dei temi di giornata del libro. È così che Mari riprende la IX novella della V Giornata, ossia quella di Federigo degli Alberighi, mantenendosi fedele al testo boccaccesco solo nella prima parte, per poi trasformare la novella in un racconto gotico infestato di apparizioni larvali che si susseguono in un crescendo di tensione non privo, come nella migliore tradizione marista, di colte citazioni (la «libbra di carne» di shakespeariana memoria) e di risvolti metanarrativi (come quando a manifestarsi davanti agli occhi del febbricitante Federigo è lo stesso «Giovanni Boccacci da Certaldo», il quale vaticina di un altro misterioso scrittore, «di me assai più oscuro», che «passati da sei a sette secoli verrà», e racconterà la vicenda di Federigo in termini ben diversi da quelli tramandati dall’autore del Decameron. Annuncio profetico dentro il quale si nasconde un rimando allo stesso Mari e alla sua rilettura della IX novella della V Giornata). Il racconto è reso particolarmente realistico e coinvolgente anche grazie alla ormai ben conosciuta capacità mimetica dello scrittore milanese che come già in precedenti occasioni – basti pensare, per fare solo un esempio, all’italiano sette-ottocentesco del giovane Leopardi in Io venia pien d’angoscia a rimirarti – riesce a ricreare meravigliosamente la lingua del Trecento, consegnando al lettore un altro magistrale apocrifo letterario.
Anche Panopticon è un testo già edito (uscì nel 2014 nella raccolta L’isola delle storie, ed. Ultima Spiaggia). Il racconto nacque in occasione della partecipazione di Mari alla terza edizione del festival Gita al faro, un festival letterario che ha luogo in estate sull’isola di Ventotene e che si conclude con un reading durante il quale gli scrittori leggono al pubblico i racconti scritti durante il loro soggiorno, racconti ispirati all’isola e dall’isola. Il racconto di Mari prende le mosse dalle suggestioni di una gita al carcere di Santo Stefano, compiuta in quei giorni.
Com’è noto il Panopticon è una struttura architettonica, adibita a carcere, ideata dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham nella seconda metà del XVIII secolo. La pianta dell’edificio è circolare, le celle dei detenuti sono munite di due finestre, una rivolta verso l’esterno per fare entrare la luce, l’altra verso l’interno, in direzione di una torre centrale nella quale siede il sorvegliante. La peculiarità di questa tipologia di carcere è che al detenuto non è mai dato di sapere quando e se sia sottoposto a sorveglianza, poiché appartiene al custode la potenziale facoltà di osservare tutti nel medesimo momento: questo farebbe sì che la docilità di comportamento, il rispetto delle regole, il mantenimento dell’ordine divengano per il detenuto un atto pressoché automatico.
Osservando dall’alto il carcere di Santo Stefano, la cui forma a ferro di cavallo ne fa un panopticon perfetto, ci si accorge che il panopticon non è altro che un anfiteatro: «la circonferenza di un edificio formato da tre ordini di logge», può infatti idealmente tradursi in una serie di palchi che si affacciano tutti sulla stessa scena, ma nella dialettica infinita del vedere e dell’essere visti, il gioco ottico si inverte e la rappresentazione del castigo e del controllo si sposta all’interno delle singole celle. Ogni cella, un piccolo teatro. Ogni detenuto, un attore che recita il proprio personale dramma. D’altra parte non è un caso che Mari inizi il suo racconto collocando proprio dentro un teatro il momento fatidico in cui Bentham ebbe l’illuminazione del panopticon: «l’idea mi venne a teatro una ventina d’anni fa. […] Ebbi la netta sensazione che Amleto, voglio dire Kean, stesse guardando dritto verso di me, anzi che il suo sguardo cercasse il mio, intercettandolo e ricacciandolo indietro, come a voler invertire il rapporto, o meglio come se in quel momento, nel palco, io fossi lo spettacolo, e lui, sulla scena, lo spettatore».
Ma nel racconto di Mari quella che va in scena non è soltanto la punizione dei condannati ma anche, e soprattutto, l’ossessione del carceriere. L’inconscio piacere perverso, a metà strada tra voyeurismo e sadismo, che deve aver ispirato Bentham e che Mari trasfonde nel protagonista del suo racconto si fa infatti accanimento, trascinando il sorvegliante in una spirale di follia allucinata che si traduce in una vera e propria discesa agli inferi. Il finale di questo racconto – uno dei più efficaci che Mari abbia scritto – è di grande potenza immaginifica e mostra il sorvegliante soccombere al proprio stesso potere, sopraffatto dalla medesima ossessione di sopraffare gli altri spiandoli. Nel turbinoso delirio che ne consegue, la scena che si apre davanti agli occhi dell’Ispettore – e di conseguenza del lettore – è un possente affresco dantesco: le celle divengono gironi infernali rapiti in un vortice incessante e sempre più rapido, in una ridda di immagini che si fanno via via più indistinte e «trascorrono l’una nell’altra in un’unica scia, tre scie sovrapposte come gli anelli di Saturno». È un’implacabile discesa all’inferno, una catabasi senza possibilità di ritorno. Che cosa attenda l’Ispettore laggiù, nell’abisso, Mari non lo dice espressamente ma lo lascia intuire. Eppure la vera domanda è: cosa si cela dietro l’essere luciferino che attende il sorvegliante nello sprofondo? Non è forse la sua stessa follia, contemplata nell’atto preciso di compiersi? «L’istante in cui la mente delirante piomba per sempre nel buio», scrive Mari in un’altra sua opera, raccontando un’altra storia, che è pur sempre la storia di un faccia a faccia con l’Altro che abita in noi, il lato folle, oscuro, mostruoso, ossessivo.
Se nella visione di Foucault il panopticon di Bentham è inteso come modello del potere nella società contemporanea, nella visione di Mari è metafora del potere magnetico e perverso che può esercitare un’idea quando questa si radica in modo ossessivo nella mente di una persona, fino a pervadere la vita intera e sostituirsi ad essa. In questo racconto, infatti, il dominatore viene dominato dalla sua idea dominante. Essa, fattasi ossessione, innesca un processo di vampirizzazione dell’esistenza che, svuotata di tutto, si riduce a null’altro che alla reiterazione dell’idea, libera ormai di contemplare sé stessa senza più distrazioni: «non più visto da tempo immemorabile, non ho più viso: se mi imbattessi in me stesso non mi riconoscerei. Sono arretrato in me fino a perdere i miei contorni: nemmeno dei miei occhi ho coscienza, perché tutto è rappresentazione mentale, sovranamente libera dai sensi».
Le fonti del mondo è un racconto sui generis, uscito per la prima volta su Vanity Fair nell’agosto del 2014. Per farvi un’idea dell’orizzonte formale entro cui collocare questo racconto pensate al centone della tarda letteratura greca e latina, o, se preferite, al suo derivato postmoderno, il pastiche. Pensate a Roland Barthes secondo cui «ogni testo è una nuova tessitura di passate citazioni». Pensate all’intertestualità teorizzata alla maniera “ortodossa” da Julia Kristeva o riconsiderata alla maniera di Chambers e di Riffaterre secondo i quali il rapporto intertestuale è da considerarsi più in relazione ai lettori che alla produzione del testo: sarebbero i lettori, infatti, a individuare i nessi di affinità tra i vari testi, a farli dialogare gli uni con gli altri, a intuirne i legami più o meno nascosti. Pensate infine alle potenzialità combinatorie e agli infiniti accostamenti resi possibili dall’utilizzo informatico degli ipertesti. Il mondo cui fa riferimento il titolo è quello cantato da Jimmy Fontana nell’omonima canzone del 1965. Tutto il resto, ossia le fonti, deriva da quel meraviglioso labirinto di luoghi letterari, citazioni, sogni, incubi, storie e ossessioni che da sempre si agitano, inquieti e fecondi, nella mente visionaria di Michele Mari: in fondo essa stessa un centone, un collage di pagine e pagine di autori antichi e moderni, italiani e stranieri, rimescolati e ricombinati all’infinito in opere ogni volta originali e tuttavia già classiche.
Le fonti del mondo traendo spunto dalla canzone di Fontana individua per ciascun verso tre ipotetiche fonti apocrife della più svariata provenienza, che in modo autonomo e nondimeno pertinente esprimono un concetto analogo. Nella visione di Mari «le tre “fonti” di ogni verso non sono in alternativa fra di loro, ma cooperanti, come se il verso in questione nascesse dalla loro intersezione-convergenza». Le fantomatiche fonti si susseguono verso dopo verso chiamando in causa autori quali Edgar Allan Poe, Jack London, Adolfo Bioy Casares, Giordano Bruno, Italo Calvino, Dino Buzzati, Stephen King, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, Howard Phillips Lovecraft, Stendhal, Fabrizio De André, Roland Barthes, John Steinbeck, Albert Camus, Cesare Pavese, Franz Kafka, Giacomo Leopardi, Eugenio Montale, Fedor Dostoevskij, Dante Alighieri, Carlo Emilio Gadda, Cormac McCarthy, il Vangelo secondo Matteo, Primo Levi e molti altri, in un avvicendarsi di voli pindarici la cui enormità, come lo stesso gioco combinatorio, sicuramente non sorprende i più affezionati lettori di Mari, ormai da tempo abituati a vedere nel loro scrittore prediletto una sorta di ventriloquo che estrae da sé voci altrui con stupefacente naturalezza.
Tuttavia quello sin qui descritto è soltanto l’orizzonte formale del testo, il suo semplice impianto strutturale. Ma dietro tale ossatura citazionistica, dietro il pretesto nazional-popolare della canzone di Jimmy Fontana, dietro lo sfoggio erudito, qual è l’intima scintilla che ha risvegliato il demone dell’ispirazione marista? Verrebbe da pensare che quanto affermato da Gianfranco Contini a proposito della mescolanza, nella lingua letteraria dell’amico Carlo Emilio Gadda, di tecnicismi, arcaismi e dialettismi, ossia che tale pastiche di linguaggi non fosse altro che il palesarsi di una commistione «di risentimento, di passione e di nevrastenia», sia applicabile anche al presunto divertissement ideato da Mari in questo racconto. Come dire che se chiodo scaccia chiodo, ossessione scaccia ossessione e quello che all’apparenza potrebbe sembrare un semplice divertimento letterario nasconda invece un occulto malessere: potrebbe trattarsi infatti di un gioco erudito dietro cui celare una segreta inquietudine, un oscuro turbamento, il quale, se non propriamente eliminato, possa almeno trovare una distrazione letteraria, una cristallizzazione su carta e quasi uno smemoramento di sé nello stemperarsi di un’ossessione nell’altra: quella personale e privata in quella letteraria, condivisibile col pubblico dei lettori. D’altra parte più volte Mari ha sottolineato, riguardo alla propria prassi letteraria, come più la materia trattata si fa intima e incandescente, a tratti scabrosa, più questa viene maneggiata mediante le pinze formali del mascheramento, dell’erudizione, del gioco colto e citazionistico. È lo stesso Mari ad affermare che «la letteratura libera l’inconscio e più lo libera quanto più è sorvegliata».
Oniroschediasmi è un racconto in forma di diario inizialmente pubblicato in un volume intitolato Sogni dalla casa editrice Humboldt Books, insieme ai disegni dell’artista Gianfranco Baruchello. Trascrivendo i propri sogni, ricorrenti e ossessivi, in questo diario Mari finisce per interrogarsi sulla natura stessa del sogno. Protagonista indiscussa di queste esperienze oniriche è la casa, o meglio «le case, le incase e concase», come lui stesso scrive, sottolineando il ripresentarsi sotto forme diverse di quella che potrebbe essere un’unica, e tuttavia cangiante, casa. Questo protagonismo della casa nel mondo onirico di Mari non desta particolare stupore in quanto è da sempre uno dei topoi principali della sua narrativa e le “case-Mari” – autentiche case-mondo – sono state immortalate, dal fotografo Francesco Pernigo, in quella vera e propria autobiografia per immagini che è Asterusher.
I sogni che Mari racconta in questo testo hanno tutta l’apparenza di essere stati veramente sognati e costituiscono un portato della sua vita reale, in altri termini sono l’ennesima trasposizione in chiave narrativa delle sue idiosincrasie, dei suoi demoni interiori, dei suoi pensieri ossessivi, morbosamente e feticisticamente coltivati nel corso degli anni e più volte sublimati e trasfigurati in forma letteraria. Le case che Mari sogna appaiono perturbanti, e, ogni volta, sembra che portino a galla un elemento rimosso e tuttavia da sempre familiare: rimosso proprio perché familiare. D’altra parte non è una novità la consuetudine di Mari con il proprio personale mondo onirico, del quale ha dato testimonianza altre volte in racconti (si pensi a Un sogno bruttissimo in Euridice aveva un cane), romanzi (ad esempio, in Rondini sul filo o in Leggenda privata) e finanche articoli.
Altri racconti, come Il buio, in cui un padre e suo figlio dialogano sul buio e sui motivi per cui è normale averne paura, in un botta e risposta serrato che conduce a un finale sorprendente, richiamano alla memoria vecchi racconti come La legnaia (in Euridice aveva un cane) anch’esso incentrato sulla paura del buio.
Scarpe fatidiche racconta invece di un paio di scarpe “magiche” che condizionano non poco la vita della loro proprietaria.
Ma tanti altri sono i racconti contenuti in questa raccolta che lasceranno il lettore stupito e ammirato. Ogni nuovo libro di Michele Mari, infatti, è prova di grande intelligenza e acume: una collezione di fantasmi e di chimere letterarie, di sogni e di superstizioni in cui lo scrittore concentra l’essenza stessa della sua poetica, in una continua sfida ai generi e alle convenzioni letterarie, supportata da un’immensa passione per la lingua italiana, sempre usata in maniera strabiliante. Il tutto permeato da un sottile velo di ironia che assume di racconto in racconto sfumature diverse. Al lettore, che come al solito dovrà essere dotato di una vasta e robusta cultura letteraria, per poter cogliere i colti e raffinati riferimenti intertestuali disseminati qua e là, nonché le mirabolanti acrobazie lessicali e sintattiche che sorvolano diacronicamente l’intera nostra storia linguistica, non resta che sospendere, ancora una volta, l’incredulità e godersi questo stupefacente viaggio nei regni della letteratura dove ogni testo può riservare un finale spiazzante e nessuna storia significa solo quello che appare sulla pagina.

