Flavio Ermini: “dalla parte dell’ombra”
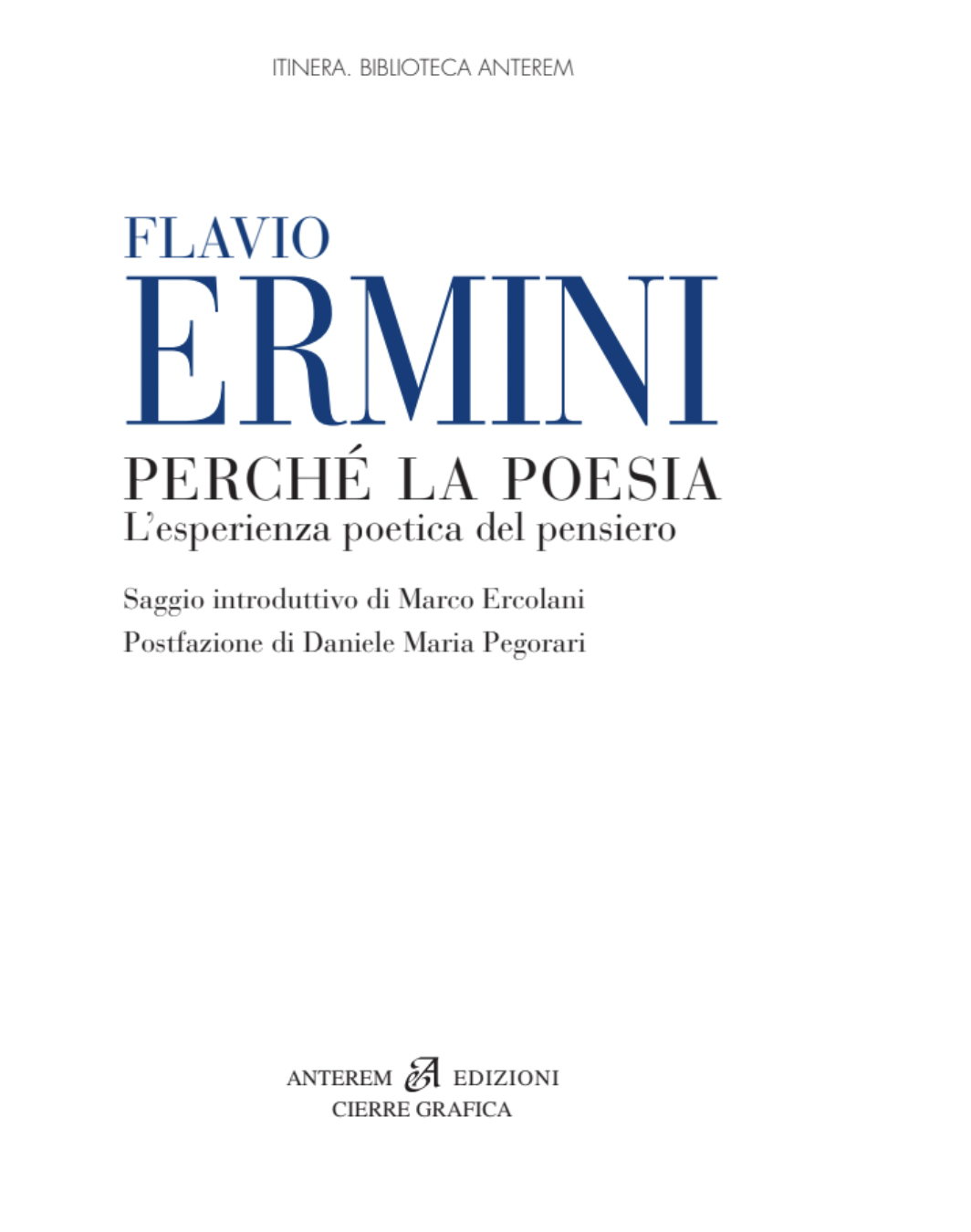
Anterem ha recentemente pubblicato Perché la poesia. L’esperienza poetica del pensiero di Flavio Ermini. Come scrive Daniele Maria Pegorari: «La rilettura degli editoriali degli ultimi ventinove numeri di “Anterem”, stesi fra il 2006 e il 2020, qui ben introdotti da Marco Ercolani – che opportunamente ricorda la precedente analoga raccolta dei ventuno editoriali scritti fra il 1995 e il 2005 –, ci documenta la continuità e l’invidiabile coerenza del discorso poeticofilosofico di Flavio Ermini e della rivista che egli ha condotto per una così lunga stagione.»
Ospito qui un estratto dal libro, per gentile concessione degli editori.
DIRE LA VITA
[…] l’incessante apertura dell’apparire […]
Pascal Gabellone
Nella poesia interminabilmente viene alla vista il non-veduto della vita. Per altro verso: la parola poetica è esposta a un “fuori” invisibile, e quel “fuori” mette l’opera alla prova del mondo. Ma come accade?
Scrive Pascal Gabellone: «La possibilità della poesia poggia sulla certezza sensibile che il mondo, prima di essere semplicemente “ciò che è apparso”, la cosa nel suo riposo, il visibile dato come tale, sia l’incessante apertura dell’apparire che, nell’apparso, resta sepolto, invisibile, eppure reale; meglio, il reale stesso».
Vediamo benissimo i limiti della poesia quando è priva di un richiamo alla presenza, ovvero fine a se stessa e separata dal pensiero. Per questo crediamo, con Max Loreau, che si debba «cercare una scrittura che non sia affatto un fine in sé = che non sia per l’esattezza “letteraria” o “estetica”».
Tale decisione richiede di meditare ulteriormente sull’essenza della parola poetica e sul suo destino.
Il cercare persiste nel domandare, e lo fa proprio perché si trova in fondamentale rapporto con ciò che nella vita si rifiuta a ogni inchiesta e si sottrae alla risposta, in una finitudine senza fine. È quanto fa “Anterem”, che in ogni numero si costituisce come opera che torce lo sguardo sempre verso un nuovo inizio, là dove ogni volta – con una domanda – tutto comincia.
Leggiamo cosa dice Heidegger: «Il nostro scopo è il cercare stesso. Che cos’altro è il cercare se non il più persistente essere-vicino a qualcosa che si nasconde, qualche cosa a partire dalla quale proviene ogni bisogno e si accende ogni esultanza? Il cercare stesso è lo scopo e, nel contempo, il ritrovamento».
Ecco perché il dire del poeta è un pre-dire che reca l’annuncio di ciò che viene nel suo carattere di evento che è sempre a venire.
In questo senso siamo autorizzati a parlare qui di ricerca della verità: trovare nomi nuovi per ridefinire il permanere della parola nell’orizzonte della domanda, facendo emergere le prospettive che essa dischiude; lasciando risuonare l’inespresso, custodendolo e serbandolo come inviolabile segreto, irriducibile alla rappresentazione.
«Il problema» scrive Schelling «non è se e come esista realmente fuori di noi quell’insieme di fenomeni e di cause e di effetti che chiamiamo vita della natura, ma come esso divenga reale per noi, come quel sistema e quell’insieme di fenomeni abbiano trovato la via per giungere al nostro spirito […]»
Si tratta insomma di capire come la poesia possa ancora salvare il gesto della prossimità all’animale, al silenzio, al fiorire della physis, e nella nominazione renderlo intellegibile.
Intanto va detto: che ci sia poesia testimonia che c’è desiderio di relazione con ciò che è a venire.
Stando dalla parte di ciò che si offre come ignoto – dalla parte dell’ombra – la poesia testimonia che la vita non coincide con ciò che è.
Nemmeno l’origine è più vista soltanto come fondamento, ma anche come ritrarsi, come rimosso. Da qui la persuasione dell’essere agiti e dominati da un Altro che è fuori di noi.
Il discorso – ciò che appare ben definito e formato – è il muro che comunemente si erige contro i pericoli che nascondono il thauma dell’origine e l’Altro che, in costante metamorfosi, lo abita.
È questo particolare pensiero arrischiante che prende forma di poesia. Il poeta, annota Keats, guarda nella nebbia e «lascia imperturbato che la bellezza passi come un rivo sotto la sua soglia».
L’opera si manifesta con un movimento di insurrezione che, lasciandosi alle spalle il discorso diurno, punta a una regione notturna, verso un rischio ulteriore.
Dire il non-veduto della vita, dopo che la lingua si è liberata dalla sua funzione rappresentativa, significa dire la “nebbia”: allearsi con la parola accanita che vuol parlare con la pietra.
Sorgere è quell’erompere dall’inapparente per il quale la physis appare, diviene manifesta, senza tuttavia che il celato da cui proviene possa mai compiutamente mostrarsi.
L’esercizio della nominazione, in questo particolare processo di svelamento, richiede che ci si interni nel profondo del cogito: nella parola che l’ha pensato.
Solo così il lavoro poetico – questa attività sottostante al pensiero esplicito – potrà riflettere l’Altro da sé. Quell’Altro da sé che è il suo più proprio se stesso.
Ecco perché l’opera non è affatto un luogo sicuro, saldo, fidato, ma è tale da contenere in sé l’estremo pericolo: il non che si lega alla parola: il suo opposto, che la salva.
Di queste originarie “forme di vita”, nella consapevolezza della centralità di un’aporia, siamo chiamati a fare esperienza: come giungere a conoscere e comprendere ciò che nella sua essenza appare ogni volta in modo diverso?

