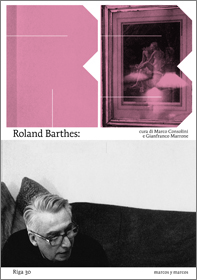di Luca Lenzini
1. Quando, nel dicembre 2009, Barack Obama ritirò a Oslo il Premio Nobel per la Pace, nel discorso di accettazione(1) non mancò di notare – e lo fece in esordio, senza tanti preamboli – che il fatto di avergli assegnato quel premio poteva, per più ragioni, sollevare legittimi dubbi. In primo luogo, osservò, egli era all’inizio, e non alla fine, del suo impegno «sul palcoscenico del mondo», perciò a confronto con i risultati ottenuti da «giganti della storia» come Schweitzer, King, Marshall o Mandela, che avevano anch’essi ricevuto il Premio Nobel per la Pace, i propri meriti erano poca cosa. Il secondo motivo, «forse più profondo», era dato dall’essere egli Comandante in capo dell’esercito e non dell’esercito di una nazione qualsiasi, bensì di una nazione impegnata in due guerre. Guerre diverse tra loro, ma in ogni caso: « … siamo in guerra, ed io sono responsabile dello spiegamento di migliaia di giovani americani che combattono in terre lontane. Di essi qualcuno ucciderà. Qualcuno sarà ucciso.»