The Pale King
The Pale King, di David Foster Wallace
(Little Brown & Co., USA + Hamish Hamilton, GB per Penguin Europa – pagine 547, Aprile 2011)
(Einaudi, IT – metà Ottobre 2011, traduzione di Giovanna Granato)
Lo scrittore stenografo – Di Charles Dickens si sa che a 16 anni, dopo 2 o 3 di sfruttamento in fabbrica dove sgobbò per risarcire i debiti di suo padre (finito in carcere col resto della famiglia: metodi Vittoriani, sapete – ndr), imparò la stenografia, e a 18 era il più veloce e preciso stenografo del Parlamento inglese: ci avrete fatto caso, nelle sedute parlamentari c’è sempre qualcuno, in genere una donna, seduto a un banchetto posto al centro, tra gli scranni del consiglio dei ministri e l’emiciclo opposto (l’intero, appunto, arco parlamentare), che digita meccanicamente su un apparecchio – sta stenografando per verbalizzare la seduta in corso, ora in tecnologia digitale, ai tempi del grande romanziere in erba con carta inchiostro e pennino. Dickens imparò bene quel mestiere per non tornare a lavorare in fabbrica, dove, come poi avrebbe raccontato sempre, l’infanzia veniva sfruttata, come le donne, secondo un sistema assistenziale e vessatorio mai messo realmente in discussione, anzi ‘religiosamente’ dato per scontato: Dickens lo denunciò, anche se non rinunciò mai al tono comico, all’ironia lieve, arrotondandone forse troppo la ferocia, per quanto la sua cosiddetta “letteratura per ragazzi” è zeppa di criminali prostitute orfani ragazze–madri violenze e violazioni, e tutta una società attorno costruita e mantenuta uguale per vessare i deboli e conservare i privilegi ai forti.
Udite: questa non è fiction! – Nel suo romanzo postumo, David Foster Wallace ci avvisa che tutto ciò che il libro contiene è autentico, è anzi basato perlopiù su un materiale freneticamente e doviziosamente annotato molti anni fa, nella fase sua più compulsiva della scrittura, e cioè negli anni del primo periodo universitario (come studente ancora, non ancora come docente) e soprattutto tra il 15 maggio 1985 e giugno 1986, cioè nei tredici mesi che Dave Wallace trascorse come impiegato di infimo livello (GS-9) negli uffici di una localissima filiale (a Peoria, IL.) della Agenzia delle Entrate americana (IRS = Internal Revenue System). La gran mole di quei materiali non è stata propriamente stenografata ma certamente raccolta a velocità supersonica e con lena instancabile visto che “gli appunti” che nel libro sono stati elaborati contengono persino le trascrizioni fedeli di conversazioni tra impiegati o le sedute di addestramento dei nuovi ‘rotes’ reclutati a cura dell’amministrazione, riportando anche, anzi soprattutto, il fitto chiacchiericcio insulso, tra gossip e luoghi comuni, tra gergo impiegatizio e commenti sui manager delle alte sfere o anche delle sfere appena di poco superiori, che in genere sarebbe saggio ‘tagliare’, specie per il fatto che, essendo materiale autentico, gronda superfluo.
Anche l’editor vuole la sua parte – In effetti Dave Wallace non ha finito questo lavoro. Non lo ha portato a termine perché si è tolto la vita prima, esattamente il 12 settembre 2008, quando sua moglie tornando a casa lo ha trovato impiccato nel patio della loro casa. Dunque, a mettere le mani sull’immensa mole di appunti e capitoli (appena abbozzati, a volte consistenti in sole scalette, altre volte dall’aria più compiuta o quasi definita: mille pagine, pare, in 150 unità non sempre assimilabili a capitoli), è stato il fido editor Michael Pietsch, che pare proprio (se per grande mestiere o grande confidenza col mondo di DFW, talento dolente e perfezionista, o se per magica miscela di entrambi) abbia esaltato, nello sfoltimento e nell’assortimento, l’arte che conosciamo esser propria di Dave Wallace, e abbia anche saputo far passare indenne e nitido l’intento narrativo di questo libro, crediamo dolorosamente chiaro a un certo punto al suo autore proprio nel corso di quell’esperienza prodigiosa che è l’attraversamento nella scrittura.
Minute misery – Bene, immergendovisi fin sopra i capelli, lo scopo dell’autore è proprio mostrare quella miseria di cui dicevamo, pur vissuta da chi ne è opaco protagonista come necessaria e insostituibile (lo sappiamo, tutti anneghiamo, seppure spesso riluttanti, nella cronaca, nelle minuzie, nella minutaglia che zavorra implacabilmente le nostre già non lievi esistenze): proprio perciò tutto quel plumbeo di più viene tenuto, e diventa l’oggetto, con poche distrazioni, con poche valvole in cui rifiatare, di quel narrare, con molta insistenza sui dettagli, con scarsa economia di scrittura benché il ‘core business’ del libro non sia poi altro che l’economia americana e il sistema esattorial–fiscale sul quale essa poggia, con scricchiolii lontani più di recente divenuti crolli e tradotti dai fatti in sconcertante declassamento.
Attenzione, il materiale non è stato lasciato grezzo in assoluto – Viceversa quel materiale è stato sapientemente trattato da questo magnifico artigiano e molatore della lingua, con un tale mestiere, così ricco di risorse tecniche e fonomorfologiche, che il tessuto di questa scrittura va rimandato alla fonte prima della indomita urgenza narrativa umana, la poesia, il format per eccellenza dei grandi romanzi modulari antichi. Ricorrono gli amatissimi acronimi e le spontanee allitterazioni, è tutto un fiorire di litòti che sono indizi anzi prove di una filosofia dell’esistenza in cui non c’è spazio per l’ipocrisia o la superficialità d’approccio alla realtà, ma vige invece una irrinunciabile immersione, senza risparmio e senza rinunce, proprio in ciò da cui chiunque distoglierebbe infastidito o atterrito lo sguardo.
La scrittura come gorgo – Segno di questa idea di scrittura concepita come un gorgo non innocuo (eccovi scodellata una bella litòte), come un abisso che afferra e attrae, cui dunque non si resiste (sussistendo in Dave Wallace scarsa volontà di resistenza), sono i periodi lunghi, classificabili come composti–complessi, intessuti d’una sintassi vertiginosa, ma anche, direi parimenti, il numero ingente di note a piè di pagina (le cosiddette ‘footnotes’) che contaminano il libro (già ibridato come mémoir, dunque non–fiction, benché il procedimento d’esposizione sia poi d’impianto narrativo saldo) con una sostanziale struttura saggistica, per un intento appunto preciso.
Dunque intanto una lode speciale va alla traduttrice, Giovanna Granato, che già per gli ultimi titoli del nostro DFWtradotti in Italia, cioè da quando i diritti sui suoi libri sono stati acquisiti da Einaudi, è la eroica traduttrice di questo grande scrittore, dotato di un talento immenso che è stato per lui anche una dannazione e credo (azzardo) lo abbia alla fine divorato.
Dunque, l’intento preciso del libro: raccontare per conoscerlo il tragitto perverso che ha reso gli Stati Uniti un Grande Paese che pure ha incubato tutti i prodromi della propria autodistruzione: un colosso d’argilla a lento sgretolamento, un re glorioso ora in affanno, smunto, pallido, malaticcio, febbricitante di una febbricola che ogni tanto ha dei picchi massimi particolarmente sfibranti. Accadde nel 1929, è accaduto parzialmente nel corso del doppio mandato del Presidente/Attore, Ronald Reagan, in piena Reaganomics (la linea sportiva dell’economia americana che generò parimenti lavoro e inflazione, allegria d’investimenti e principio di ogni successiva débacle), fino a tutti i frutti maturati nelle rovinose gestioni (Bush, ndr) successive e approdati al crollo dal 2004 in poi, fino al declassamento recente di cui si diceva.
Il sottosuolo dostoevskjiano è un fortino insidiato – L’obiettivo su cui insiste ciò che Dave Wallace ci documenta e ci racconta qui ‘trovandolo’, cioè rivelandolo anche a se stesso attraverso quello strumento conoscitivo formidabile che è la scrittura, è comprendere quanto, e quanto a fondo, l’economia e la sua ricaduta sociale entrano non solo nel quotidiano delle persone, ma nella loro mente, nei loro cuori, nelle loro relazioni, spesso determinandoli.
Nel libro si aggirano creature grigie, opacizzate dalla continua disconnessione di sé da sé stesse a causa della particolare realtà che domina le loro vite, e tende, perlopiù riuscendoci, ad allontanarli dalla loro vita vera. Il libro è in effetti la documentazione del braccio di ferro, meglio ancora del tira–e–molla degl’individui con la realtà che spesso, soverchiante, viene confusa con la vita e accettata come normalità, pur essendo tragedia latente riconoscibile.
Rotes & routines – La maggior parte dei personaggi che volteggiano in questo walzer amaro è costituita dai rotes (esaminatori dei profili fiscal-esattoriali dei contribuenti americani – sapete bene quanto negli Stati Uniti ‘il contribuente’ sia agitato come spauracchio dai politici nelle loro campagne elettorali), ultime ruote impiegatizie (ma è solo un’assonanza, ‘rote’ ha a che fare con ‘routine’) del sistema esattoriale, e i loro istruttori e dirigenti. Creature assorbite totalmente nelle proprie mansioni al punto di coincidere con esse, ma dopotutto umane, con delle vite sotto la crosta della divisa di lavoro: l’abito completo, e i loro cappelli – non vi ricorda questo certi film con Jack Lemmon, e certe scene di telefoniste freneticamente intente a infilare spinotti per facilitare connessioni con formule d’espressione stereotipate, tutti asserragliati dietro una condivisa moda media borghese?
I dirigenti e le donne – Anche i dirigenti sono temuti ma scoloriti – come Leonard Stecyck, alunno diligente alle elementari (1969), che i compagni di scuola buttavano a terra per pisciargli addosso, ma poi fu l’unico a mostrare prontezza e competenze per soccorrere Mr Ingle, docente pure lui ostile, quando nel laboratorio di carpenteria costui maldestramente rimase preso con la mano nella sega a nastro. Un leader, Stecyck, modesto e accurato, ora scolorito nella sua identificazione routinaria di travet della burocrazia economica, con una sua vita vera, dunque individuo degno.
Donne poche. Ma quelle poche o sono delle manager infernali oppure sono gli oggetti prediletti di uomini violenti e rapaci rispetto ai quali le madri le sorelle le nonne le figlie devono difendersi escogitando soluzioni di sottrazione. È memorabile e toccante la scena che vediamo nel capitolo 8 in cui una bambina, per sottrarsi alle vessazioni di uomini arrapati e dispotici, per minuti giace, come le è stato insegnato, immobile senza chiudere le palpebre e senza respirare, fingendosi morta. Non si fa così anche con gli orsi – per fare in modo che l’orso, annusandoti e credendoti senza vita, ti lasci perdere e se ne torni nella boscaglia? Dave Wallace sigla questo episodio con una protesta che è un grido: “for a child is no doll, and does need to blink and breathe” (poiché una bambina non è una bambola, e deve pur chiudere gli occhi e respirare – trad. mia, ndr).
La bocca solleviamo dal fiero pasto – A libro chiuso, attraversato con lena e resistenza, e con recisa riconoscenza (e so di far parte di una truppa bella corposa), l’affollamento e il caos di attori e scene non impediscono (litòte, di nuovo) di conservare netti i doni che il libro ci lascia. Non solo il nodo aggrovigliato del continuo alternarsi di persona pubblica e persona privata nell’individuo tirato tra percezioni multiple della realtà e del proprio starci dentro, dell’io e del suo allontanamento dal sé, processo irresistibile che può finire per essere dannato e irreversibile, e allargare nella testa un buco dolente tra ricordo vago di una appartenenza e stringente nostalgia del proprio mondo perduto. Ma anche questa definizione del singolo come biella di una macchina complessa in cui il piccolo anello deve roteare governato da un moto meccanico uniforme e finisce macinato via anche quando non si oppone al congegno superiore.
Dave Wallace sparisce – diviene creatura del sistema. Lo scrittore, che fu un rote per una sorta di servizio civile reso a Peoria (IL) in quei tredici mesi tra il 1985 e il 1986 dopo esser stato scoperto come il ghost writer o autore a pagamento dei research papers dei suoi colleghi di college, volente o nolente fu ingoiato dal sistema. Dovette crescere, perdere l’aura della giovinezza o temporaneamente separarsene. Fu separato da se stesso. Molti anni dopo, anche per ragioni alimentari, ha rielaborato la scottante materia in questo mémoir pur incompiuto. Ho ripensato con prepotenza al saggio di Cynthia Ozick che ho tradotto anni fa per Il Dovere della Felicità (saggio Baldini&Castoldi Dalai del 2000, autori F. La Porta e A. Carrera) in cui l’autrice ebrea americana, analizzando I Sommersi e I Salvati, ultimo libro di Primo Levi, dimostra due cose: dopo decenni finalmente in quel libro esplose la rabbia di Levi tenuta sopita negli altri libri sul lager, e, una volta lasciata esplodere quella rabbia come una liberazione, Primo Levi si uccise.
Il re è pallido: sbiadisce – Dave Wallace in questo mémoir rimesta nei documenti di una propria parentesi, privata e pubblica a un tempo: rimesta nel grigio opaco delle minute maglie burocratiche in cui vide che individui macinati dalla macchina di base dell’economia del Paese o erano quasi felici o non erano abbastanza ribelli e vide se stesso confuso con essi. Il ragazzone con la testa tante volte cautamente fasciata, ironico e depresso, acuto, facondo, prolisso e digressivo, pieno di fiducia nella letteratura e nella potenza della scrittura, ha visto sbiadire le promesse della propria fede. E si è ritirato dalla partita.

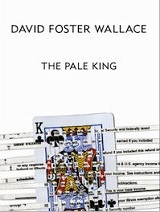

Grazie all’autore. E al postatore.
A radiorock lo speaker ha da mesi incominciato l”impresa titanica di leggere 20min Inifinite jest tutte le mattine dalle 7.10. Peccato che la sua lettura incerta non restituisca intatto il DFW “acuto, facondo, prolisso e digressivo”. Comunque troppo, per me. Chapeau alla sua opera, superiore alle mie forze comprensive.
Grazie anche da parte mia ll’autore a al postatore.
Come per “L’originale di Laura” di Nabokov queste sono operazioni che mi disgustano. Non si capisce che bisogno ci sia di leggere un editor che sistema gli appunti di uno scrittore. Mah.
Un bel fraintendimento, Alessandro.
?
@Alessandro Ansuini Non ho ancora letto “The Pale King”. Però non credo sia un’operazione dello stesso tipo. Le reazioni di molti miei amici americani che lo hanno fatto fanno anzi pensare che sia una bella esperienza leggerlo. Io ho trovato interessante leggere l’introduzione del suo Editor in cui spiega come ha deciso di mettere insieme questo libro: http://goo.gl/iWMW4
Roberto: grazie della segnalazione, l’ho letta con interessa, e la mia idea è semmai peggiorata. Perlomeno nell’originale di Laura si sono degnati di non metter mano agli scritti, ma di pubblicarli così com’erano, una spechie di fantasma del libro che sarebbe potuto essere. Qui c’è di peggio. Una valanga di materiale alla rinfusa assemblato dall’editor. Una cosa che solo a scriverla mi fa venire i nervi. Come se uno scultore avesse lasciato una pietra e dopo la sua morte qualcun altro l’avesse rifinita e spacciata per un’opera dello scultore originario. Come se un musicista lasciasse delle registrazioni fatte in casa e qualcuno gli arrangiasse i pezzi. Ma come si fa. Un po’ di rispetto. Se lo avesse voluto pubblicare, se fosse stato così fondamentale per lui l’avrebbe fatto. Ma ci vuole tanto a capirlo? La cosa che mi indigna è che si continua a far passare l’opera per prodotto, chissenefrega se si è ammazzato prima, il brand david foster wallace ce lo mettiamo lo stesso e va bene uguale. Se poi l’ha messo insieme qualcun altro chi se ne accorge. Che tristezza, che mancanza di rispetto.
@Alessandro Te lo dirò quando lo avrò letto(*). Però so che tutti coloro che seguono da vicino l’opera di Wallace che lo hanno fatto, e nonostante molti di loro condividessero a priori i tuoi più che legittimi dubbi, si sono dovuti ricredere. Forse il tuo ragionamento varrà per “lOdL” di Nabokov (su cui non ho trovato recensioni positive). Ma leggi cosa scrive Nick Maniatis sul sito degli Howling Fantods; “the maturity of emotion and refined (even muted) style delivers some of the best writing of DFW’s career. The Pale King is a catalyst for reflection and celebration, not mourning. We all have much to learn from the contents of this book.” http://goo.gl/AEuCQ
Non stiamo parlando di pubblicità editoriale, capisci? Beh, inutile parlarne senza averlo letto, mi sembra…
(*) ma perché in ogni modo dubitare di Pietsch, di Bonnie Nadell etc… Se Wallace ha lasciato che lo trovassero avrà avuto i suoi scopi (ragioniamo anche al contrario, no?). E in ogni modo preferiamo tutti che Max Brod non abbia distrutto l’opera di Kafka, vero?
Roberto, ti dico, se avessero pubblicato gli appunti così come li hanno trovato, avrei capito di più. Non mi pare che Brod abbia stravolto l’ordine del Processo, o cambiato l’ordine dei capitoli nei libri di Kafka. Qui c’è una presunzione. C’è un assemblaggio postumo, e non di Wallace. Per me come l’autore decide di farmi leggere una cosa conta. Non ci posso fare niente. E non credo proprio che leggerò il libro.
@Alessandro Gli appunti completi saranno presto disponibili nell’Archivio Wallace a Austin (Texas) per tutti coloro che vorranno consultarli. Quanto a Brod, a me risulta proprio il contrario, come dice la critica unanime, per esempio Clayton Koelb http://goo.gl/z1niV (in particolare parlando del processo a p. 154: “the form in which the novel exists today is Brod’s construction not Kafka’s.”)
Siamo d’accordo che l’assemblaggio conta (anche se quello di Infinite Jest è un bel mistero), ma sembrerebbe proprio che almeno una metà del libro pubblicato fosse già editato e pulito. La letteratura, dai presocratici a Gogol’, è fatta di frammenti e ripensamenti. L’intenzione dell’autore conta, ma perché privarci di qualche cosa che funziona (o potrebbe funzionare)? Non siamo alla “morte dell’autore” (anche se in questo caso di questo si tratta..), ma anche noi i lettori, e gli editori e i critici, lavoriamo tutti sui testi per creare qualcosa, siamo la sponda che riprende e rilancia il gioco dell’autore, anche di un autore che ha smesso di giocare. Poi ovviamente si puo’ “non giocare”; ma senza provare “disgusto” per chi invece vuole farlo… (ehm, io chiudo qui con questa discussione).
Caspita, non lo sapevo. Di Brod e del processo intendo. In ogni caso, per chiudere, non ce l’ho con chi ha la curiosità di vedere gli appunti o l’assemblaggio postumo dell’editor, capisco il lettore, io stesso mi sono letto l’originale di Laura trovando anche spunti d’interesse in un fantasma di libro, ce l’ho con chi porta avanti l’operazione permettendosi di metter mano e presumere cose come fosse l’autore. Mi urta il sistema nervoso, non ci posso fare niente.
In ogni caso, resta la differenza fra il pubblicare un autore postumo sconosciuto e pubblicare il libro incompleto di un autore famoso. Una bella differenza.