Antropocene fantastico
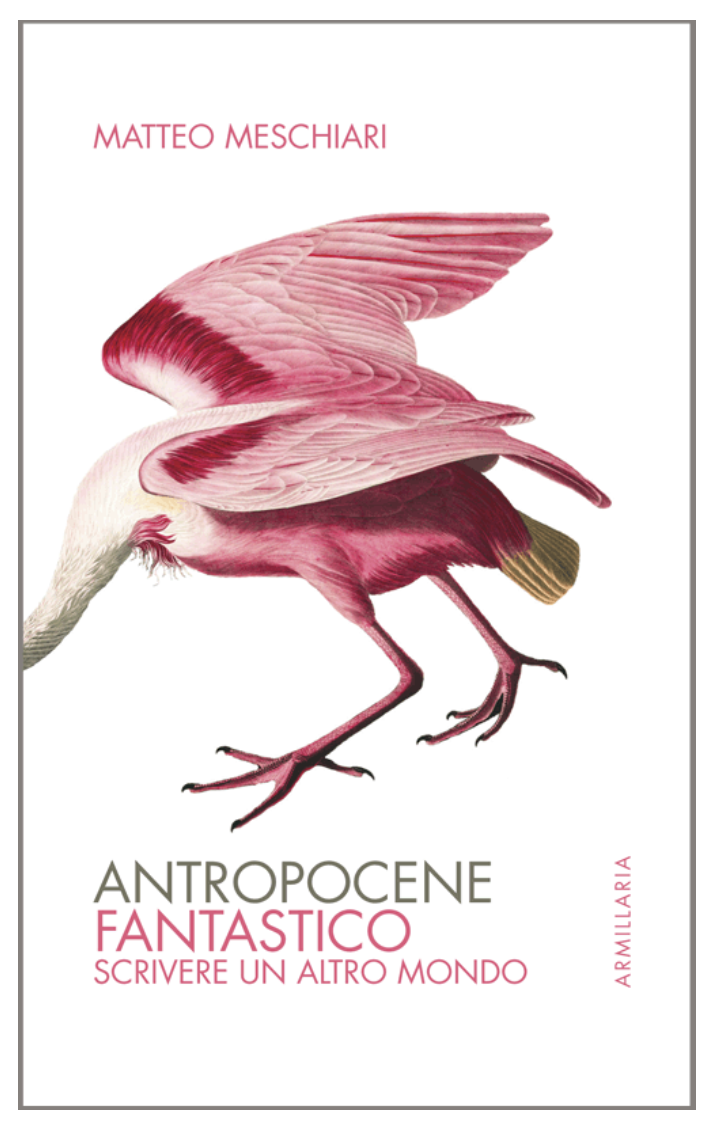
In questi giorni è uscito nelle librerie Antropocene fantastico. Scrivere un altro mondo, il nuovo pamphlet di Matteo Meschiari, pubblicato da Armillaria.
Ne ospito qui un estratto in anteprima, tratto dal capitolo Kairocene.
KAIROCENE – RIFONDARE IL TEMPO
Quale passato si annida nel futuro? In che cosa Paleolitico e Antropocene si somigliano? La parola Antropocene è irritante, un’irritazione che viene essenzialmente dalla sua proteiforme adattabilità ai contesti, dalla sua eccessiva carica di seduzione e facilità d’uso. Ma, concettualmente, quello che non convince è la sua perenne atmosfera alla Blade Runner, il suo sapore di futuro a tinte fosche, reale ma banale, come una quinta teatrale fissa, scontata. L’esperienza di Covid-19 ha smentito ogni visione distopica: l’Antropocene è qui senza mutare la percezione del presente. Anzi. Nei comportamenti e nelle atmosfere il presente è venato più di preistoria che di fantascienza. Filosofi oscurantisti e virologi impotenti ci fanno sentire più in un passato immaginato che in futuro promesso. È inquietante, certo, ma si apre una possibilità inedita all’immaginario del dopo: un Antropocene dagli attributi diversi, più debitore a J.R.R. Tolkien che a Philip K. Dick. E Tolkien per me è il vero scrittore-guida in questo momento storico, perché se un Antropocene Fantastico è possibile è solo tornando alla radice di chi ha riflettuto sul fantastico in modo ineguagliato. Come dicevo in precedenza, Tolkien non è il Fantasy, perché lo scarto è tutto tra i due mondi è tutto nell’idea di studio, nella filologia della parola e dello sguardo, e soprattutto nella credenza: Tolkien ci ha lasciato delle istruzioni per l’uso, a una guida mitopoietica del presente e del dopo che ci attende. Fiaba, subcreazione, storytelling fantastico non sono cose da conoscere sulla carta, non sono il destino di un singolo autore, ma sono pratiche sociali, collettive, performative, che hanno il potere di aiutarci a reimmaginare la realtà: «Tutte le narrazioni si possono avverare; pure alla fine, redente, possono risultare non meno simili e insieme dissimili dalle forme da noi date loro, di quanto l’Uomo, finalmente redento, sarà simile e dissimile, insieme, all’uomo caduto a noi noto».
La citazione chiude un testo in cui all’inizio si pongono le basi: Feeria «è un reame che contiene molte altre cose accanto a elfi e fate, oltre a gnomi, streghe, trolls, giganti e draghi: racchiude i mari, il sole, la luna, il cielo, e la terra e tutte le cose che sono in essa, alberi e uccelli, acque e sassi, pane e vino, e noi stessi, uomini mortali, quando siamo vittime di un incantesimo». Il tono apparentemente discorsivo, a tratti bonario, del saggio Sulle fiabe, non deve distrarci con la sua apparente semplicità. Tolkien sta leggendo una conferenza (una Andrew Lang Lecture tenutasi all’università di St Andrews l’8 marzo 1939) in bilico tra filologia e autopoetica. Proprio la sua natura ambigua, duplice, rende difficile estrapolare delle coordinate “utili” a ottant’anni di distanza, ma quello che si dice qui è soprattutto un invito ad aggiustare lo sguardo, una cosa difficile da proporre e da apprendere. Tolkien ci avverte: Feeria non è solo storie di fate o storie di umani tra le fate, Feeria è un luogo, e non dobbiamo smettere di pensare che in quanto luogo è fatta anche di cose “comuni”, “normali”, che in realtà comuni e normali non sono. Su posizioni non troppo lontane da quelle di Viktor Šklovskij sullo straniamento, Tolkien sta dicendo che abbiamo perso la vocazione a guardare il mondo “primario” con attitudine meravigliata. Come recuperare allora lo stupore verso un sasso o una foglia uscendo «dalla tediosa opacità del banale o del familiare»?
La strada non è semplice perché bisognerebbe comprendere e accettare una frase densissima che il filologo e il linguista storico cala nel suo saggio come un fendente: «le lingue, soprattutto le europee moderne, sono una malattia della mitologia». Tolkien, contrariamente a chi dice di eliminarli, elogia la funzione poietica degli aggettivi: «La mente che pensò leggero, pesante, grigio, giallo, immobile, veloce, concepì anche la magia atta a rendere cose pesanti, leggere e atte a volare, a trasformare il grigio piombo in giallo oro, l’immobile roccia in acqua veloce». Questo atto di subcreazione è lo stesso che ritroviamo negli inventori del mito: la mitopoiesi è un atto linguistico primario molto più articolato di una mera architettura allegorica. Il mito non è il tuono che diventa un dio o un irascibile contadino dalla barba rossa elevato a rango divino, il mito è la zona di coesistenza di tuono, Thor e contadino, un luogo di simultaneità narrativa e ontologica che Tolkien chiama appunto Feeria. Feeria è allora la co-possibilità. E dove la co-possibilità dei piani si interrompe, per stanchezza creativa, per cinismo, per disordine cognitivo, per usura, allora ci troviamo di fronte a una specie di “malattia del mito”, una sfiducia della lingua per cui subcreazione e sospensione dell’incredulità sono solo giochi temporanei, fittizi, senza la “credenza” profonda di poter “fare mito” anche nel quotidiano. Il problema, ovviamente, non è solo un nodo epistemologico del mondo contemporaneo. Sono e saranno sempre molto pochi i portatori di parola disposti a credere in un commercio diretto tra mito e tempo presente, in un reale scambio di fluidi tra Feeria e il mondo primario.

Ora, che ci piaccia o meno la parola, siamo entrati nell’Antropocene. Possiamo vedere quest’epoca di transizione e la futura prossima come un’ennesima declinazione distopica, come una serie Netflix da guardare a distanza stando seduti sul divano, oppure possiamo intercettare nell’Antropocene i grandi flussi mitici che, come accade a ogni epoca, lo attraversano e lo alimentano. Tolkien lo dice così: «Costruire un Mondo secondario dentro il quale il sole verde risulti credibile, imponendo Credenza Secondaria, richiederà probabilmente fatica e riflessione, e certamente esigerà una particolare abilità, una sorta di facoltà magica. Pochi si cimentano in compiti così ardui; ma quando li si affronta e li si attua in misura maggiore o minore, si ottiene un risultato artistico senza pari: arte narrativa, insomma, elaborazione di racconti nella forma primaria e più pregnante». È chiaro che chiedersi come sarà la “letteratura del dopo” ha più a che fare con questo, con un sole verde, che non con potenziali e anodini romanzi su Covid-19, distanziamento sociale, contenzione domestica e mascherine a passeggio. Nel collasso e nella Pandemia, e forse proprio per questo, dovremmo ricordarci di quelle che Tolkien chiamava «le cose più permanenti e fondamentali».
Tolkien concepisce il Silmarillon nel 1917. Suo figlio Christopher lo pubblica postumo nel 1977. Christopher aveva 53 anni e Guy Gavriel Kay, tra il 1974-75, ne aveva appena 20. Kay, canadese a Oxford, aiutò Christopher nella riscrittura delle parti più tardive. Il libro, che Tolkien voleva pubblicare assieme al Signore degli anelli, ha avuto una genesi di 60 anni. E nonostante la riscrittura postuma resta un incompiuto. Al suo interno ci sono tempi narrativi e tempi redazionali che formano un intrico così complesso da aver immobilizzato il loro stesso autore. Per noi invece sono un invito a riflettere non sul worldbuilding ma sull’etica della parola: dalla cronaca alla cronologia, dalle agenzie stampa agli annali. Un cambio di prospettiva che potrebbe aiutare a stendere un balsamo calmante sulla fretta di correre a registrare tendenze intellettuali e mode sulle testate on line. Il futuro è crollato. Abbiamo tutto il tempo adesso. Tolkien era sintonizzato su Kairos non su Kronos. Noi certamente non siamo Tolkien, ma siamo lettori e scrittori davanti a una scelta. E questa scelta è di vita o di morte.


[…] leggi un estratto su Nazione indiana […]