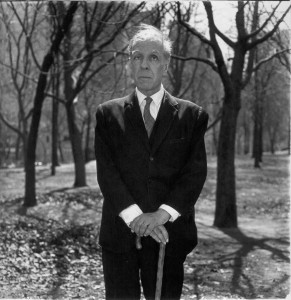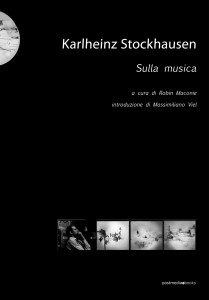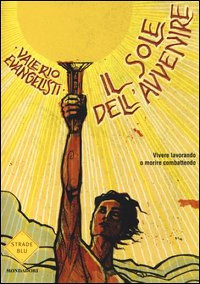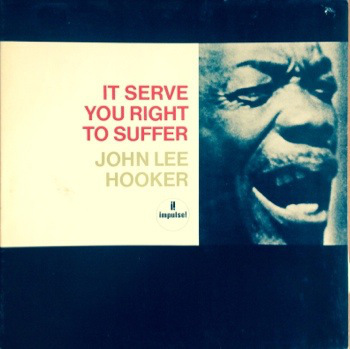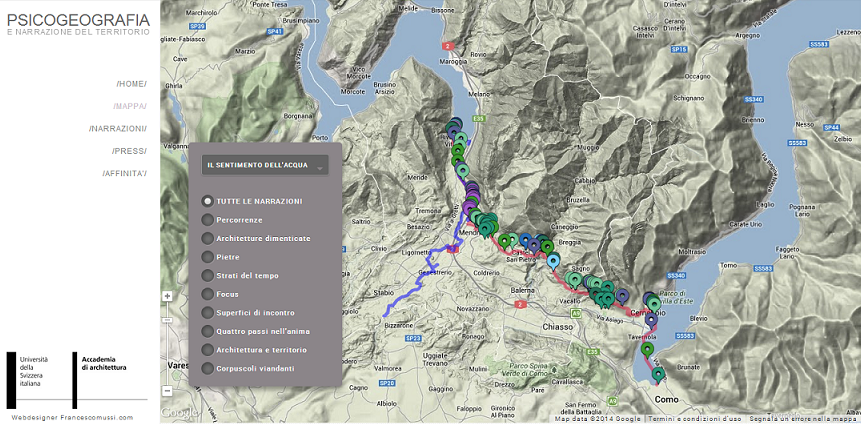In occasione della presentazione “torinese” del bel libro di Francesco Trento La guerra non era finita, I partigiani della Volante Rossa (Editori Laterza) ho chiesto all’autore di darci un’anticipazione per Nazione Indiana. Pubblichiamo qui di seguito le pagine dedicate ai convulsi giorni che seguirono l’attentato a Togliatti del 14 luglio 1948. effeffe
dal capitolo La rivoluzione mancata
di
Francesco Trento
“Tornate a casa”
La notte del 15 luglio la Volante Rossa è all’Innocenti, assieme a duecento operai. Lì giungono notizie su quanto sta accadendo a Torino, a Genova e nelle altre città: “Allora”, ricorda ancora C., “ci siamo riuniti per decidere cosa dovevamo fare. Se attendere o iniziare immediatamente il movimento di trasformazione della lotta in lotta armata”
Secondo il piano predisposto il giorno precedente, il 16 luglio la Volante Rossa decide di attaccare la più importante caserma dei carabinieri della città, quella dove sono tutti i mezzi corazzati.
La Volante Rossa era quel giorno al completo, una cinquantina di uomini. Coi panzerfaust chi ci fermava? Distruggevamo mezza caserma. […] Chi poteva tenere in una lotta a Milano erano i mezzi corazzati e noi ci eravamo attrezzati per batterli. Partiti noi, sarebbero poi partiti tutti gli altri. Comunicato che partivamo, erano già partite le staffette in direzione dei diversi centri della città
L’ora X sembra dunque arrivata: un camion carico di partigiani si dirige verso la caserma dei carabinieri. Le staffette avvisano la Federazione milanese del partito: minuti di caos puro. Che fare?

Dalla Federazione parte immediatamente una macchina, ma intanto i partigiani sono in marcia. L’auto del Pci corre, mentre il Dodge, lasciata la Casa del Popolo, supera Lambrate e arriva al Campo Giuriati. Proprio lì la vettura della Federazione riesce finalmente a intercettare l’autocarro. A bordo, secondo la testimonianza di Finardi, c’è proprio Alberganti. Dice agli uomini di Paggio che non è il momento: gli americani interverrebbero, si finirebbe come in Grecia Lo sciopero è finito, bisogna rientrare. Il dirigente comunista è inamovibile. Guarda il camion carico di armi e scuote la testa: “Ma siete pazzi a girare con tutti questi esplosivi? Potreste saltare in aria da un momento all’altro. Tornate a casa”
La Volante Rossa obbedisce, non senza rimpianti: “Se arrivava cinque minuti dopo”, ricorda C., “Milano era un fuoco solo” Certo, l’assalto alla caserma non coinvolge solo gli uomini di Paggio, ed è anzi assai plausibile ipotizzare un piano comune, concordato con altre forze armate collegate al partito, con altre “organizzazioni paramilitari”.
Anche perché, nonostante il ricordo dell’anonimo testimone di Bermani, sul camion quel giorno la Volante non è assolutamente al completo. Walter Fasoli ad esempio, non ricorda l’intenzione di attaccare i carabinieri , e nemmeno Leonardo Banfi:
No, no. Assolutamente. I carabinieri si erano rinserrati nella caserma, ma non abbiamo mai pensato di… la preoccupazione principale è stata quella di occupare le fabbriche a Lambrate. Di piazzare sulla pensilina dell’Innocenti la mitraglia, questo è vero. Infatti c’era la camionetta della polizia che girava per Lambrate per verificare cosa succedeva: fu accolta da una raffica di mitra, rientrarono in caserma e si chiusero dentro. Ma noi restammo lì. Restammo lì.
Banfi e Fasoli non sono i soli della Volante a rimanere dentro l’Innocenti occupata, quella mattina del 16 luglio. Tuttavia anche Sante Marchesi ricorda l’intervento della staffetta:
eravamo in 30 sul camion… ma eran più le armi che noi… poi è arrivato il compagno Alberganti: “basta, lo sciopero è finito, tornate a casa”…
Le parole di C. sembrano abbastanza chiare: “partiti noi, sarebbero poi partiti tutti gli altri” (le “non meno di trecento persone” e i “molti armati” di cui C. parlava in un altro passaggio). Paolo Finardi (“Pastecca”) ricorda ad esempio che quel giorno con la Volante ci sono “molti gruppi. Il più grosso era quello della Breda di San Giovanni” .
La testimonianza di Arnaldo Cambiaghi, responsabile della Commissione dei Giovani comunisti alla Pirelli, conferma le parole di Finardi:
Guarda che la miriade di gruppi ce n’erano tanti. […] Io per esempio ero armato lì alla Pirelli, durante l’attentato a Togliatti, e siamo riusciti a tenere la maggioranza dei lavoratori dentro. […] E noi abbiamo detto al partito: “assaltiamo le caserme della polizia!”. C’è stata questa proposta: andiamo là, occupiamo, prendiamo le armi e prepariamoci per, non dico l’insurrezione, ma la resistenza. Ma i dirigenti massimi han detto: no… Alla Pirelli va poi Giancarlo Pajetta, per convincere gli operai a smettere l’occupazione e tornare al lavoro

Dal 15 luglio, in effetti, il Pci è all’opera per sedare la rivolta. Al di là delle motivazioni di facciata, legate alla fedeltà del partito alle istituzioni repubblicane e all’“impegno democratico assunto con l’approvazione della Costituzione” , la molla principale di tale scelta è rintracciabile in un sano realismo. Pietro Secchia, poco dopo l’attentato, aveva già espresso i suoi dubbi sulla riuscita di un’eventuale azione di forza: “L’America certamente interverrebbe: primo perché ha da noi le sue basi, secondo perché non le mancherebbe una giustificazione politica. Non dimenticate compagni che siamo a soli due mesi e mezzo dalle elezioni che hanno dato una maggioranza assoluta al governo” Il pomeriggio del 15, tra l’altro, ci si rende conto che lo sciopero generale sta fallendo. Dai telegrammi dei prefetti, scrive Walter Tobagi, emerge, oltre all’“Italia che sciopera”, una “seconda Italia”:
è “l’Italia che non sciopera”, vuoi per indifferenza, vuoi per convinzione politica; e sono milioni di persone, quasi intere regioni […] che non scendono in piazza, però costituiscono quel potenziale di riserva, che ha garantito alla Dc il trionfo del 18 aprile.
E questa “seconda Italia” […] è strettamente collegata ad una “terza Italia”, l’“Italia dell’ordine pubblico”, dai prefetti fino al carabiniere del più sperduto paesino di campagna. Anche questa Italia fa sentire il suo peso sociale e politico: […] è convinta di battersi per una causa che sente giusta; e perciò interviene con la stessa, durissima decisione per rimuovere un blocco stradale come per garantire la libertà di lavoro.
L’ala sindacale democristiana, inoltre, di fronte al protrarsi dello sciopero, minaccia la scissione . Non c’è più scelta: nemmeno l’obiettivo delle dimissioni del governo è più raggiungibile senza arrivare a uno scontro frontale. Secchia, nel Comitato centrale del 15 luglio, mette in guardia i compagni meno convinti: l’Italia del Sud non si è mossa, in alcune città non si è riusciti a fare nemmeno un comizio, e anche al Nord un’insurrezione avrebbe delle chance di riuscita solo nelle grandi città, mentre le campagne non sono affatto sicure: “i compagni riflettano: per ora né la polizia né l’esercito sono intervenuti, se lo faranno disporranno di cannoni e carri armati contro cui non si potrà resistere”.
Non bisogna fare grandi sforzi di immaginazione per prevedere un simile scenario: nella vicina Grecia, i partigiani sono tornati sui monti nel 1946, ma la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno appoggiato la monarchia, sostenendola in una feroce guerra civile. Inoltre, se anche vi fossero mai stati piani d’appoggio a una rivoluzione italiana da parte dell’Urss, ora, consumatosi nel giugno lo scisma nel blocco sovietico con l’espulsione della Jugoslavia dal Cominform, tali piani non sono neanche lontanamente ipotizzabili.
A fugare ogni possibile dubbio, una telefonata dell’ambasciata sovietica proibisce agli italiani ogni tentativo rivoluzionario.
Tutti i maggiori esponenti del Pci si trovano infine d’accordo sulla necessità di evitare la “prospettiva greca”. Inoltre Togliatti sta meglio: l’operazione è andata bene e il leader del Pci si sta rimettendo. La Cgil, sostenuta dal Partito comunista e da quello socialista, dichiara la fine dello sciopero per mezzogiorno del 16 luglio.
Presa la decisione, tutti i dirigenti sono mobilitati per portare la linea del partito nelle fabbriche occupate, nelle piazze incandescenti. I membri della direzione ancora a Roma vengono spediti d’urgenza nelle loro rispettive sedi nei capoluoghi di provincia. Spano corre a Genova. Negarville vola a Torino su un aereo messo a disposizione dalla Fiat, per trattare il rilascio di Valletta. È un compito non facile, quello che aspetta i dirigenti: bisogna convincere i militanti a smantellare le barricate, togliere i blocchi stradali, liberare gli ostaggi e tornare ordinatamente al lavoro. Ed è un compito ingrato: a Milano, piazza particolarmente calda, è quasi impossibile farsi ascoltare dai militanti. Ricorda Luciano Gruppi:
Dovevamo dire: “attenti, compagni, questo è uno sciopero politico, che ha come obiettivo le dimissioni del governo. Questo e niente più di questo. Attenti! Non siamo alla vigilia dell’insurrezione”. Andai nella mia sezione, quella di Porta Volta. I compagni accolsero le mie parole piuttosto freddamente.
Raffaele De Grada, di fronte agli operai infuriati che gli impediscono di portare le direttive del partito, è costretto a mettere sul tavolo la pistola e a ricorrere alla sua autorità di ex comandante partigiano. Infine, però, anche i compagni più riottosi vengono convinti: lo sciopero termina senza aver raggiunto alcun obiettivo.

Tuttavia, nota Bocca, “privato del capo a cui si rivolge per le grandi decisioni, il partito ha perso per qualche ora l’orientamento, si è mosso in modo sentimentale, ha lasciato andare, se non allo sbaraglio, allo scoperto, la sua organizzazione paramilitare, ha dimostrato agli italiani che essa non è una invenzione propagandistica di Scelba, ma una realtà”. Anche Leo Valiani si dice certo che “l’apparato armato” del Pci “agì dopo l’attentato a Togliatti del ’48: ma evidentemente allora ricevette un contrordine e tutto rientrò”.
In quest’ottica, probabilmente l’assalto alla caserma dei carabinieri (uno dei punti strategici della città) risponde a un piano preordinato che il Pci o il suo apparato di sicurezza tengono pronto “in caso di bisogno”, e a cui infatti il partito rinuncia non appena diviene chiaro che l’attentato al suo leader non corrisponde a un tentativo di colpo di Stato.
Finita l’agitazione, in ogni caso, cominciano le speculazioni della Dc e dei suoi alleati. La stampa “indipendente”, i settimanali illustrati, la “Settimana Incom” (il cinegiornale dell’epoca) si impegnano subito a fondo nel descrivere con dovizia di particolari il “piano K” dei comunisti, la ferocia degli insorti, l’eroismo delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio del 16 luglio, la polizia sbarca in forze ad Abbadia San Salvatore, munita di autoblindo, artiglieria e addirittura di un aereo. A coadiuvare le forze dell’ordine c’è anche un intero reggimento di fanteria, il 78° Lupi di Toscana. Avviene un vero e proprio rastrellamento, casa per casa: la popolazione è selvaggiamente picchiata, mentre la “Settimana Incom” monta un clamoroso falso documentario che mette in cattiva luce i “ribelli del Monte Amiata”.
È solo l’inizio: nei giorni seguenti una campagna serrata da parte dei mezzi di informazione crea terreno fertile per il durissimo intervento del governo. Settemila lavoratori vengono arrestati o denunciati. A Milano finisce in carcere anche il padre di Ferdinando Clerici, l’ex partigiano Edoardo (“Nan”) La repressione antioperaia degli anni a seguire è durissima: tra il luglio 1948 e la prima metà del 1950 si registrano 62 lavoratori uccisi, di cui 48 comunisti; 3.216 feriti, tra cui 2.367 comunisti; 92.169 arrestati, di cui 73.870 comunisti. Pallante, l’attentatore di Togliatti, resterà in carcere meno di sei anni: condannato a 13 anni e 3 mesi in primo grado, a 7 anni in appello, a meno di 6 anni in cassazione.

Il tramonto del “doppio binario”
Con il no del Pci all’insurrezione, si chiudono i sogni di molti militanti. E tramonta per sempre l’idea, assai diffusa, che il partito si stia muovendo su un “doppio binario”. Il rifiuto di trasformare in rivolta armata lo spontaneo sollevamento della base rivela “alle masse e agli avversari politici la patente contraddizione tra il linguaggio massimalista usato per tenere viva la combattività delle masse e la reale volontà d’azione rivoluzionaria”
La sconfitta elettorale da una parte, e il rifiuto del metodo rivoluzionario dall’altra, precludono al Pci nel breve periodo ogni prospettiva di conquista del potere. Nella base la delusione è cocente: in molti abbandonano il partito o, senza rompere apertamente, si ritirano ai margini della vita politica. Chi ha ancora delle armi nascoste si affretta a sbarazzarsene, per amarezza, o perché vista la nuova ondata repressiva diventa troppo rischioso tenerle. Fucili, mitra, bombe a mano vengono abbandonati in aperta campagna, gettati nei fiumi o nel mare. Per evitare conseguenze giudiziarie, interi depositi sono segnalati alla polizia. Anche la Volante Rossa nasconde le armi: Paggio si reca a casa di Luigi Colnago, in campagna, e vi sotterra una cassa di fucili. Non è difficile immaginare il disappunto degli uomini di “Alvaro” di fronte alla mancata insurrezione. Il ricordo più amaro è senz’altro quello di Sante Marchesi:
“Tornate a casa”, ci ha detto la staffetta della federazione, proprio come il proclama di Alexander ai partigiani in montagna. Per me è stato un errore, però… siamo sempre dentro a ’sta politica del cavolo […]. O non si doveva uscire, allora si stava tutti calmi, oppure quando una volta uno è uscito, armato soprattutto, o vai o spacchi, eh.
Secondo “Santino”, nella Volante il disappunto è tale che qualcuno vorrebbe andare avanti ugualmente, fare la rivoluzione nonostante il divieto di Alberganti. “Ma noi cosa facciamo se tutti gli altri si tirano indietro, se dopo c’abbiamo addosso anche il partito, o tutto?” Anche il tono divertito della rievocazione di Fasoli non riesce a celare una certa amarezza:
È stato bello dopo, a venir via quando è finito tutto… venir via dall’Innocenti a piedi, alla spicciolata, con le armi dentro ai pantaloni. Sembra una stupidata, ma infilati un mitra o un fucile dentro, nei pantaloni. Ohé, mica potevi venir via con le armi in spalla. Eravamo in luglio, faceva caldo. Avevamo su i pantaloni da sci, coi giubbotti, e il fucile infilato dentro. Una mano in tasca per trattenerlo… eh, insomma… c’è stata una certa delusione. Dopo praticamente siamo tornati alla normalità, come se non fosse successo niente.
Secondo C., invece, tornare alla normalità è impossibile, perché il 16 luglio segna il crollo di tutti i sogni della Volante Rossa: “Ci siamo resi conto che la rivoluzione non era possibile, mentre noi si era pensato di essere alla vigilia della presa del potere da parte della classe operaia”
È una vera e propria “mazzata”, che “chiude un ciclo” e apre un periodo di grande crisi all’interno della formazione di Lambrate. C., deluso dalla politica del partito, giunge addirittura a chiedersi se abbia un senso continuare C’è anche chi paga duramente i due giorni di lotta: la sera del 16 luglio, Paolo Finardi torna a casa per cena e ha un litigio furibondo con i genitori: “Dove sei stato fino a adesso?”. “Eh, han sparato a Togliatti, son stato alla Casa del Popolo…”. “Bravo, allora adesso vai a mangiare là”. La discussione degenera, e “Pastecca” torna a via Conte Rosso, dove rimarrà a dormire per vari mesi. Intanto, all’Innocenti, le direttive del Pci vengono lungamente discusse da un’infuocata assemblea di tre-quattromila operai. Mario Muneghina, in questo caso portavoce della direzione del partito, sostiene che occorre rientrare e utilizzare la grande forza di cui si è data prova nelle battaglie sindacali a venire. Lo stesso Banfi, pur facendo parte del nucleo dirigente della Volante Rossa, spalleggia l’ex comandante partigiano
Alla fine, prevale la tesi di Muneghina: le armi vengono nuovamente nascoste nei cunicoli e il lavoro riprende. La lotta politica e sindacale all’interno della fabbrica riceve un nuovo slancio.
Quel giorno, tra gli operai che assistono al comizio, c’è anche il comandante della Volante Rossa, Giulio Paggio, che non si schiera. Tanto che Banfi non ricorda se fosse o meno d’accordo con la decisione di rientrare nella legalità: “Non gliel’ho mai chiesto… in realtà non si pronunciò mai”. Secondo Banfi, però, quella del Pci è una valutazione politica: non essendoci le condizioni per una rivoluzione, occorre operare una ritirata strategica, e “continuare con un’azione di massa ancora più vasta fino al momento della messianica ora X” Del resto, la Volante Rossa ha sin qui vissuto sull’equivoco del “doppio binario”, e quando scopre che il Pci ha scelto un’altra strada non tenta di portare avanti la sua attività rivoluzionaria in opposizione ad esso, né tantomeno di pungolarlo dal basso. La linea del partito è quella giusta o, comunque, quella accettata. […]