
di Anna Toscano
Nella città di provincia del nord est dove sono nata e dove sono vissuta fino ai diciotto anni si faceva la coda per il pane, nella panetteria più in voga in quegli anni, guardando in faccia i morti. Sono stata abituata così sin da piccola, a stare in coda e guardare gente morta.
Allora, tra i Settanta e i Novanta, la panetteria più buona, o più di moda, era all’angolo tra due strade pedonali lastricate di sanpietrini, un’ampia vetrina piena di ceste di pane su entrambi i lati: il negozio da una parte dava sui banchi di frutta e verdura e su una tabaccheria, dall’altra su un negozio di dolciumi. L’angolo, tra le due vetrine, era di marmo, veniva usato per appendere le epigrafi mortuarie: grandezza A4 in verticale, nome e cognome della defunta o del defunto, una foto formato tessera in alto a destra, un breve testo di commiato, le informazioni per il funerale.
Così, si stava lì, estate e inverno, sole o pioggia, in coda ad attendere il proprio turno per il pane, facendo la conta dei defunti. Gli adulti commentavano se il defunto fosse vissuto troppo o troppo poco, di chi fosse parente o amico – nelle piccole città ci si conosce tutti – e chi fossero i nomi citati nel testo. L’esclamazione che si sentiva più spesso, mentre ci si avvicinava all’ingresso del negozio e dunque le epigrafi divenivano man mano leggibili, era: “Varda chi sé morto”.
Per noi bambine e bambini estranei, chi più chi meno, al sottotesto che accompagnava la fototessera, era un guardare in faccia volti che assomigliavano molto a quelli dei nostri nonni e delle nostre nonne, colori prevalentemente scuri nell’abbigliamento, quasi tutti coi capelli bianchi, le donne con la permanente taglio corto, occhiali da vista. L’attenzione veniva attirata maggiormente dalle poche foto che ritraevano giovani, quelli che la cronaca locale aveva già riportato nei giorni precedenti prima per incidenti stradali, all’epoca erano le strade delle discoteche il sabato sera o per i lidi in estate. Gli scatti nelle epigrafi in questo caso cambiavano, era netta la percezione che fossero fotografie ritagliate da altri contesti e ci si immaginava subito la foto di classe della quinta superiore a cui mancava un ovale, avevano ritagliato quel volto. Erano anni in cui non c’erano i cellulari ma nemmeno gli scanner, le foto erano su pellicola e la loro riproduzione era molto farraginosa rispetto a oggi.
Tuttavia avere una fototessera era facile all’epoca, le cabine per produrle infatti erano distribuite nelle città – seggiolino che si avvitava per salire o per scendere, tendina acrilica sempre troppo stretta e corta e buona la prima, mica come oggi che si possono fare più pose e poi scegliere – producevano quattro tutte uguali (più tardi sei) e le due o tre rimanenti stavano nel portafoglio o in quello dell’innamorata/o. Ma c’erano anche molti negozi di fotografia e i fotografi erano forniti di un angolo apposito per fare fototessere.
Basta andare con la memoria alla foto della prima patente o di un abbonamento al bus degli anni della scuola o alla tessera universitaria e sentire una punta di dolente disagio per quelle immagini che ci ritraggono scuri, fissi in un tempo che fisso non era affatto.
Perché le epigrafi erano appese tutte su quella colonna? Era il luogo principale di passaggio del centro storico, sede di mercato e di commercio spiccio per l’alimentazione quotidiana, non esistevano ancora gli ipermercati e tantomeno i centri commerciali, solo i supermercati cittadini e i negozi al dettaglio del centro storico. Altre epigrafi, singole e sparute, comparivano nei luoghi della città abitati e frequentati dalla deceduta o dal deceduto.
All’inizio degli anni Novanta apre, nella stessa città, una pizzeria nella piazza centrale, piazza dei Signori, che prima ospitava gelaterie molto eleganti e negozi esclusivi e poi, al posto di alcuni di questi, una pizzeria con molti posti a sedere anche all’esterno che poteva accogliere intere famiglie e classi di studenti: la blasonata piazza centrale, luogo di struscio di diverse età a seconda dei giorni e delle fasce orarie, diviene più popolare e più ciarliera.
Gli anni in cui Virna Lisi interpretava la cassiera al Ristorante Soffioni sono ormai lontani, per intenderci. Così, nel salotto buono della città, nella colonna del portico più esposta agli occhi di tutti, iniziano a venir attaccate tutte le epigrafi che trovano spazio. L’unica pizza che ho mangiato lì la ricordo, perché erano di più i volti che mi guardavano dalla colonna dei nomi delle pizze nel menù che tenevo aperto sotto il naso. Ora tutto è cambiato, va da sé, la pizzeria c’è sempre ma la colonna di ostentamento della morte è dalla parte opposta del portico. Ma Il muro d’angolo del panificio è sempre, protetto da un supporto, affollatissimo di epigrafi, il panificio è chiuso da decenni, i banchi della frutta e verdura trasferiti per lasciare il posto ai plateatici chic di bar chic, il tabaccaio ha lasciato il posto a un negozio lussuoso, resiste solo il negozio di caramelle, rimasto come allora.

Le città cambiano, ma non è questo il punto.
Sin da piccola sono stata abituata a frequentare i cimiteri, andare in visita da parenti defunti, accompagnarli nel loro ultimo viaggio, attraversare camposanti pieni delle stesse fototessere: anziani coi capelli grigi, occhiali, sfondo chiaro, abiti scuri. Mia madre e mia nonna, tuttavia, hanno iniziato a pensare alla loro morte anzitempo, ogni due anni eleggevano una foto come quella per la tomba e per l’epigrafe: mia nonna chiedeva a me di scattargliene qualcuna da cui scegliere, mia madre andava dal fotografo per rendere la riuscita dell’operazione più perfetta. Entrambe avevano in orrore l’idea di avere a ricordo eterno una fotografia di quando erano giovani come facevano in molti, volevano essere riconoscibili nelle loro ultime versioni. Così mia nonna ha sulla lapide, e ha avuto sull’epigrafe affissa proprio sulla colonna del panificio, una foto di grandi dimensioni che le ho scattato a un matrimonio: sorride rivolta a qualcuno, capelli grigi con la permanente, abito molto scollato oro e marrone, due fili di perle al collo, rossetto. Aveva quasi centodue anni alla morte, la foto di poco tempo prima era pronta.
Mia madre, deceduta cinque mesi dopo mia nonna, svetta sulla lapide con una grande fotografia fatta da un fotografo – la scelse con grande riluttanza, certo era venuta molto bene a suo parere ma il fotografo, amico di famiglia, una volta divenuto vedovo quasi da subito era andato a vivere con un’altra donna gettando mia madre nell’indignazione – appare glaciale, in una maglia di lino azzurra, occhi azzurri sgranati sull’infinito alle spalle del fotografo, sfondo azzurro scuro, capelli bianchi legati in una coda ordinata, una collana blu, viso impassibile in una espressione a un passo dal mistico. Per fortuna aveva lasciato detto che non voleva venissero affisse epigrafi, poi il panificio aveva appena chiuso quando è morta.
Mio padre ha seguito mia madre di cinque mesi, per lui, a cui non importava nulla di epigrafi e tombe nel suo orrore verso la morte, abbiamo scelto l’ultima foto scattata a Venezia: era sull’imbarcadero del 2 che aspettava il vaporetto, indossava un cappotto cammello e per la foto aveva fatto il possibile per stare dritto con la schiena. Mia madre gli era accanto, e ricordo nettamente che mentre scattavo lui guardava in macchina, lei guardava lui e diceva “Sto stronzo malato com’è ha ancora i capelli scuri, non ha una ruga e riesce pure a stare dritto”. Lei, malata da tempo, aveva una giacca di camoscio marrone e i capelli bianchi legati in una piccola coda. Lui è venuto in foto con un piccolo sorriso, che la malattia ha trasformato in un debole ghigno, ma simpatico come ghigno, non per me che stavo lì con la analogica ma per la frase di mia madre. Anche questa foto è grande, colorata, con molta luce.
Quando poco più di dieci anni fa ho, con mia sorella, predisposto le foto per questi tre funerali, quando poi abbiamo accompagnato ogni sepoltura e poi siamo tornate a portare fiori e lavare lapidi, ho notato che le foto della mia famiglia, come di altre tombe recenti, foto comunque di anziani, già una decade fa, si staccavano dalle altre foto: erano più luminose, non erano fototessere, nessuno era vestito di nero, non era solo il volto ma un mezzo busto quasi.
Filando dietro questo allenamento alle fotografie e alle epigrafi non mi perdo una colonna di morti. Qui a Venezia, dove vivo da oltre trent’anni, sono concentrate in alcune zone le epigrafi, stesso formato e stessa disposizione, guardo le foto e l’età delle persone, come sono stata abituata a fare. Ci sono casi in cui spavento Gianni perché l’epigrafe che incontro all’improvviso parla di qualcuno che conosco o mi è molto caro. Quando c’era il volto del caro Ruggero da lontano ho urlato forte, facendo trasecolare tutto il campo; ma va da sé che questi episodi accadono sempre più spesso. Ma non si parlava di ciò.
Volevo mettere a fuoco il fatto che in questi ultimi cinque, sei, sette anni le immagini dei defunti su lapidi ed epigrafi sono cambiate: se prima erano fototessere scure con capelli bianchi e una età avanzata o immagini più colorate per persone più giovani, oggi, un poco alla volta, la fotografia che ricorda i morti ha fatto un balzo in avanti. Sono sempre di più, infatti, le anziane e gli anziani ritratti in foto di dimensioni più grandi di una fototessera, anche molto più grandi, e con scatti che provengono da momenti di vita, in molti scatti compare il mare o la montagna, alcune hanno un cane o un gatto in braccio, i colori sono di gioia e spensieratezza. Ovviamente, va da sé, le persone anziane dimostrano in queste foto molto meno anni di quelli che avevano al momento del decesso e non perché avessero scelto fotografie datate ma perché oggi i corpi, i volti, le acconciature, ci parlano di un altro tipo di anzianità, del mondo contemporaneo, dei corpi e dei volti di oggi.
Le foto raffigurano gli ultimi anni della persona, il tipo di foto scelta ci parla di altro: non sono più scatti fotografici per la morte, ma scatti che ricordano la vita. Sono spesso scatti presi dai social, da fotografie che ritraggono i tempi della vita. Certo ora è uno scherzo scattarsi una foto, anche le persone più avanti con gli anni lo fanno con agilità o hanno chi lo fa per loro, tuttavia è un certo decoro e timore della morte che è venuto meno: il dress code è ormai cosa di altri tempi, i giovani vanno a discutere la tesi di laurea vestiti come se andassero in discoteca, le persone si stupiscono quando entrando nei luoghi di culto viene loro chiesto di coprirsi, e via dicendo, così anche come presentarsi in foto per l’eternità è diventata una questione meramente personale.
Ciò che si nota nelle foto delle epigrafi appese ai muri in questi ultimi anni è la vita che straripa, fino al punto che a volte i bordi paiono espandersi, e basta tendere una mano, un braccio, alla persona per farla uscire di là e trovarsela in corridoio, come in un vecchio video degli a-ha.





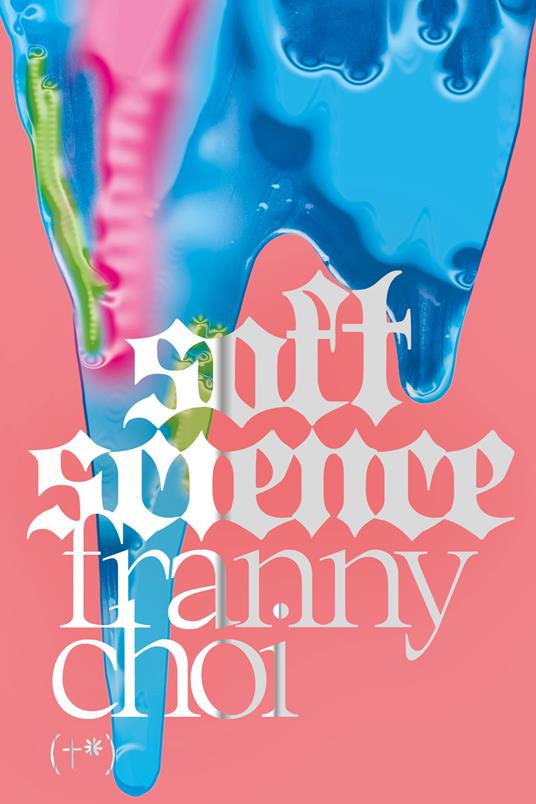

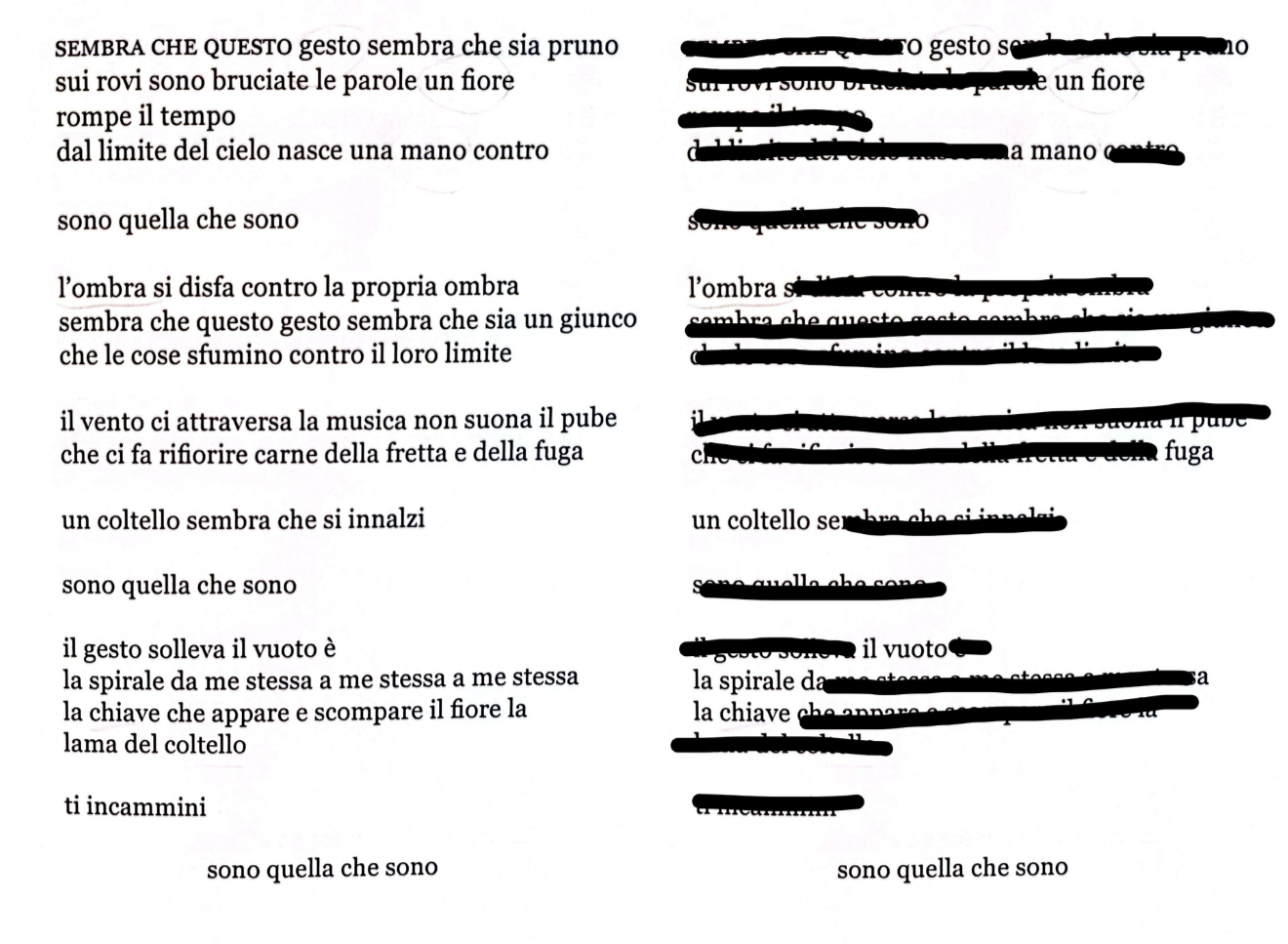


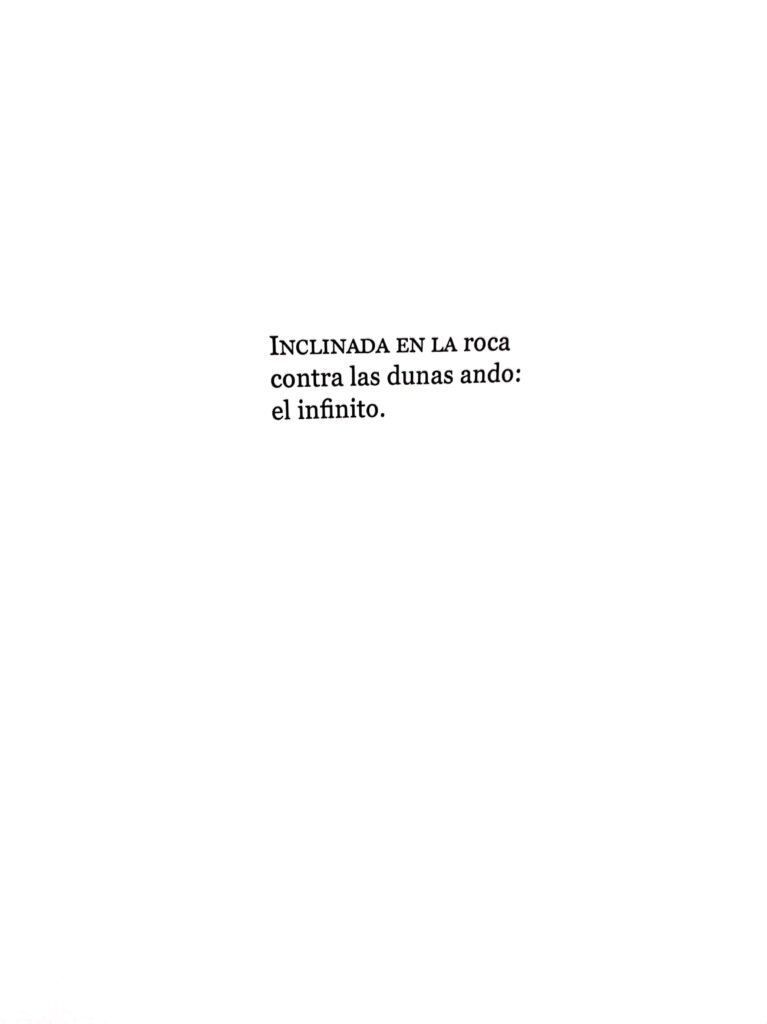









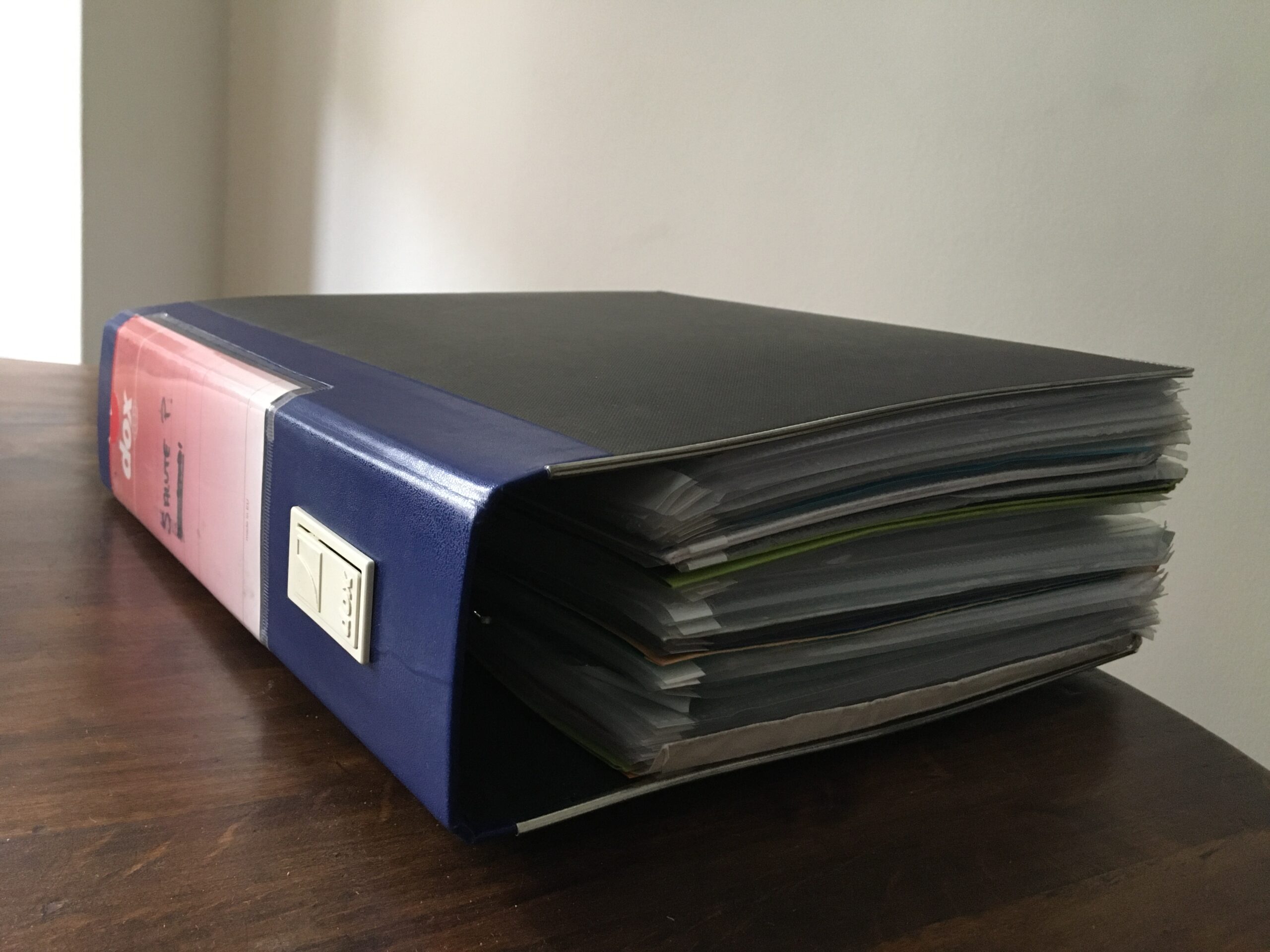
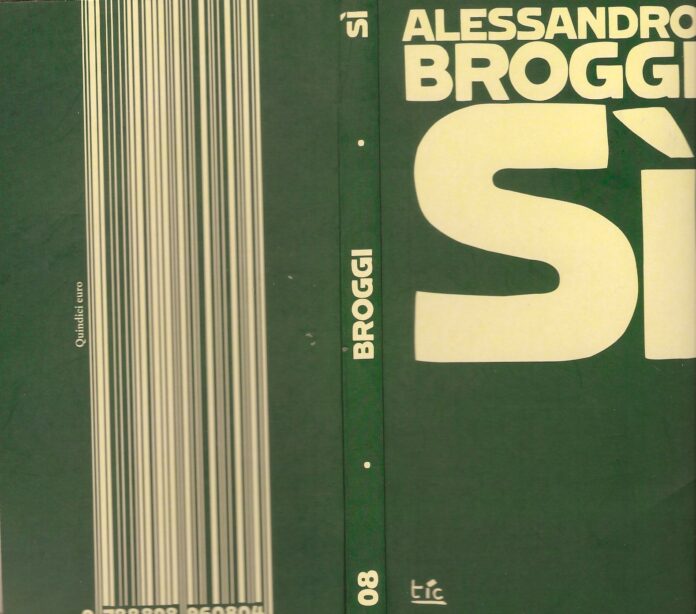

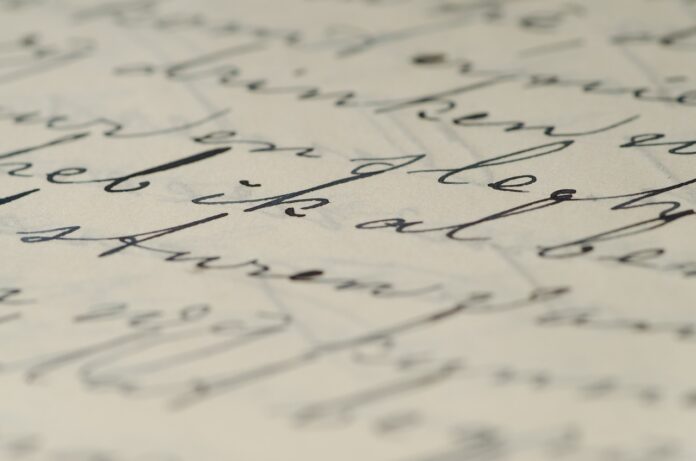
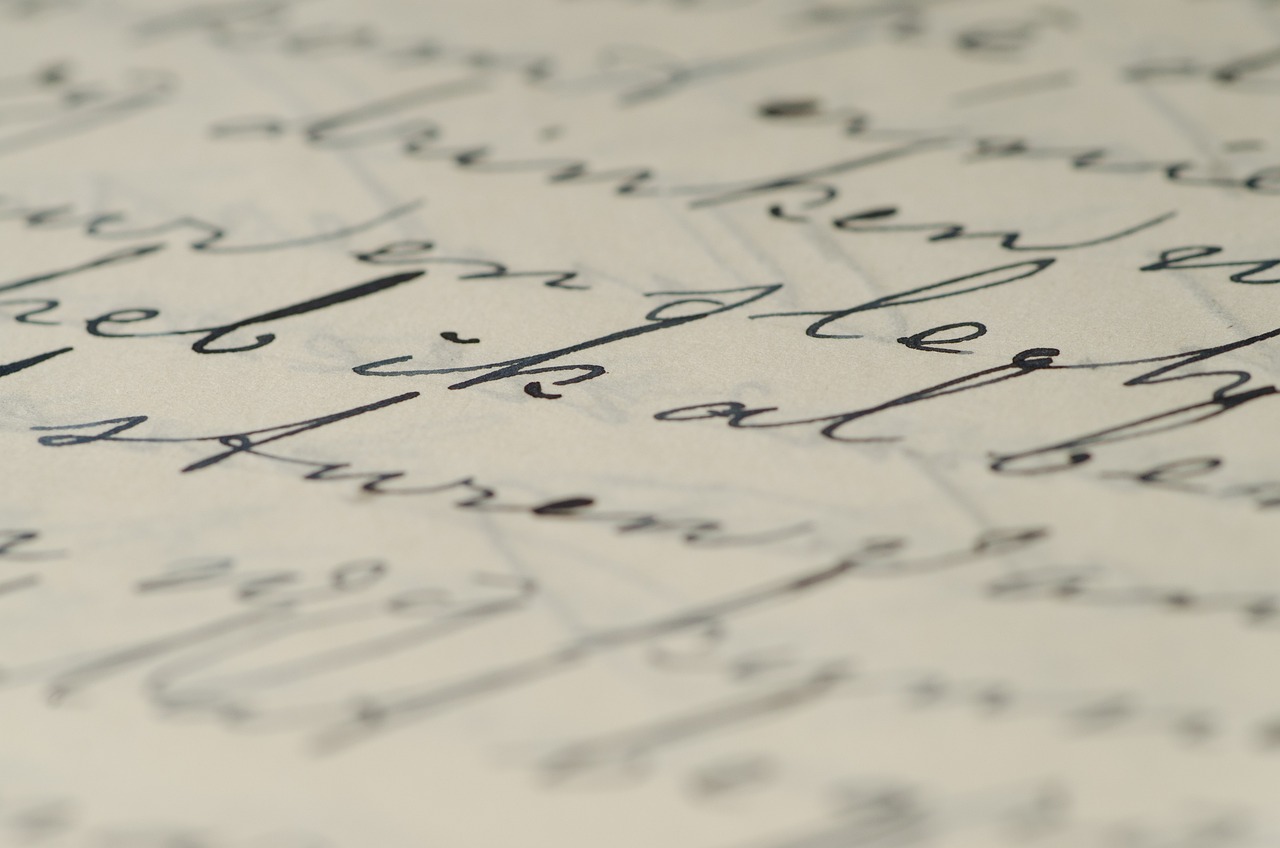
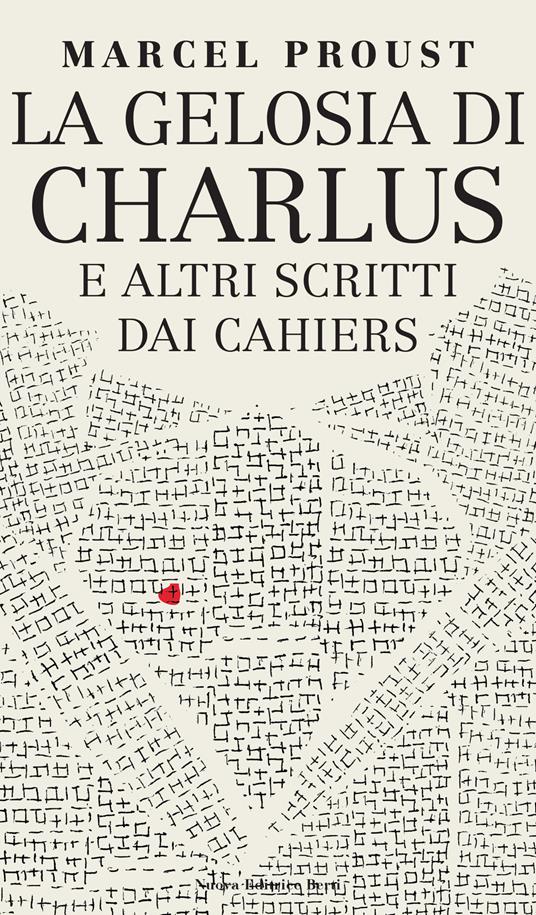



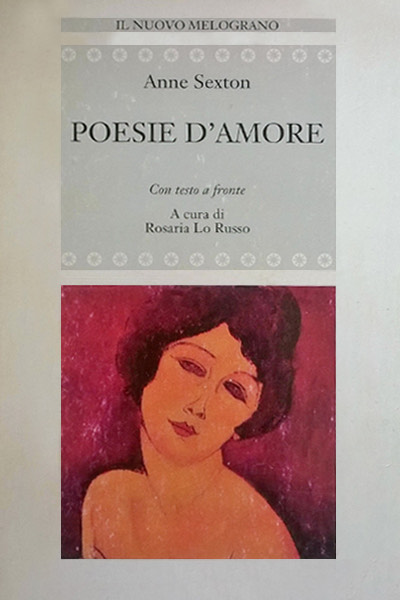

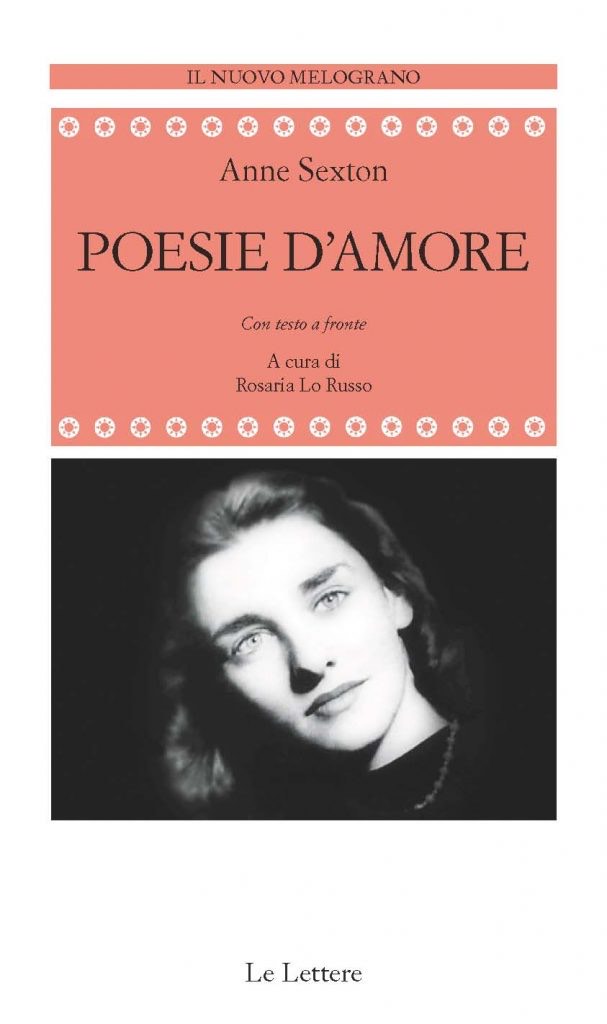

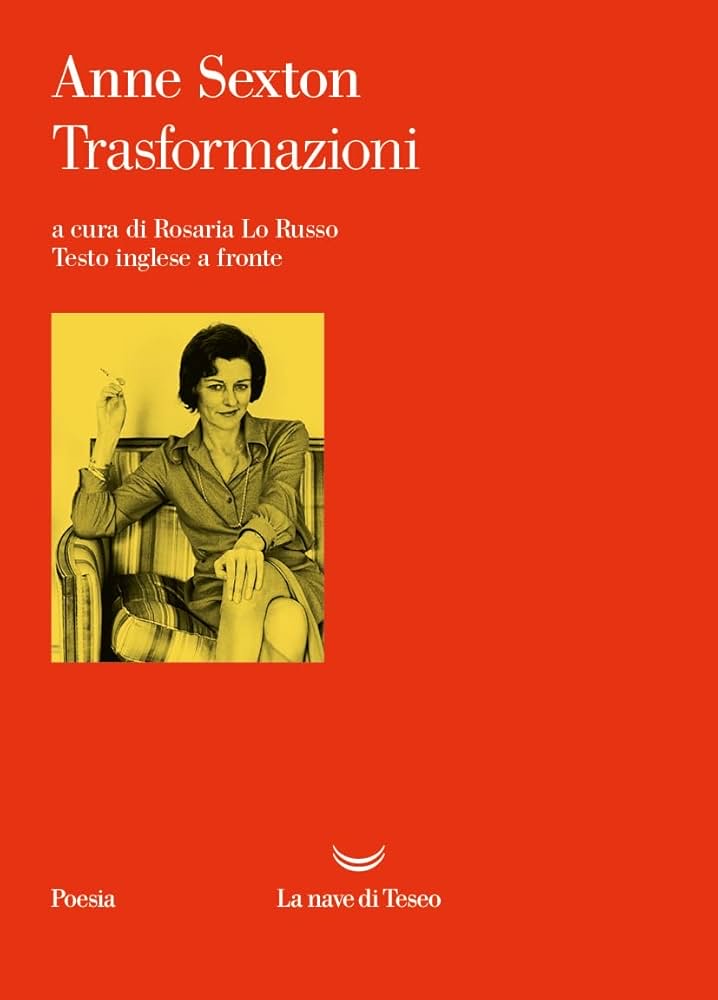










 di
di 