di Monica Jansen
“Caution Church Van. An excited Church with an Exciting Mission”: guardando questa avvertenza sul retro di un pulmino di parrocchiani, posteggiato accanto alla ‘cappella’ di Hyde Hall sul campus della University of North Carolina a Chapel Hill, mi sono chiesta se potesse valere anche per la congregazione che per tre giorni, inizio maggio, lì si è ritrovata per discutere i pro e contro della “Anomia della terra” (titolo del convegno). Il progetto veniva da una rete internazionale di ricerca creatasi l’anno scorso tra le università di Amsterdam e Utrecht, Parigi (Nanterre), Michigan e Chapel Hill con il titolo generale “Precarity and Postautonomia: the Global Heritage”. Una delle conclusioni più sorprendenti del convegno-“assemblea”, almeno per me, è stata che l’autonomia concepita nell’Italia travagliata degli anni Settanta, non solo ha conquistato l’intellighenzia accademica statunitense in questi primi anni 2000, ma starebbe perfino cambiando la società americana nei suoi fondamenti. Gustavo Esteva, professore/attivista trasferitosi negli USA dal Messico nel 1954, nel dibattito conclusivo ha complimentato gli americani per il loro risveglio politico, con un (ironico?) “welcome to the boiling!” Ma cosa vuol dire applicare la (post)autonomia alla realtà sociale e economica delle due Americhe: dico due perché l’America del sud è ampiamente rappresentata nelle università dell’America del nord e lo spagnolo è ormai seconda lingua se è lecito trarre conclusioni dalle doppie scritte inglese/spagnolo nei servizi pubblici. E cosa si intende per “autonomia” se si estrae il concetto dalle sue origini operaistiche degli anni Settanta in Italia, segnati non solo da rivolte di studenti e operai ma anche dal terrorismo, di destra, di sinistra, e di Stato? Come ha osservato giustamente Andrea Righi, autore di Biopolitics and Social Change in Italy (2011), i pensatori che negli Stati Uniti vanno per la maggiore, da Negri e Virno a Bifo, son tornati alle giovani generazioni italiane dopo la loro riabilitazione nei campus americani. Un altro partecipante faceva notare invece che il nesso tra i Black Panthers e Autonomia non era stato indagato a sufficienza mentre era essenziale per comprendere il valore sociale del pensiero radicale negli Stati Uniti. E che risposta dare all’indignazione di una relatrice, rappresentante dei diritti degli indigeni americani, i first nation, non inclusi da nessun relatore nella ‘moltitudine’ dei richiedenti diritti, da Autonomia a Occupy ad Anonymous? Intanto, seduta accanto a me, una signora legge un giornale locale recante in prima pagina la foto di un poliziotto con sotto la dicitura “Life without Activism would be dull”, la vita senza attivismo sarebbe noiosa. In quale quadro concettuale si deve allora concepire l’attivismo, che per molti dei presenti al convegno andrebbe diretto contro lo Stato? Per tornare alla domanda sugli indigeni: forse, come ha suggerito un relatore, la strategia Occupy di diventare invisibili, di fondere la propria soggettività con quella dei passanti che popolano la strada, è più difficile da realizzare quando si appartiene a una minoranza “visibile”? Osservazione contraddetta da altri secondo i quali nel movimento Occupy negli Stati Uniti sono state proprie diverse minoranze specifiche, come i caraibici newyorkesi, a prendere l’iniziativa per azioni locali tipo ‘urban gardening’ che hanno funzionato come nuclei di aggregazione. Ma allora come la mettiamo con un episodio Occupy in Messico, dove il comitato organizzatore ha violentemente rifiutato i rituali iniziatici di un gruppo indigeno, provocando la scissone del gruppo d’azione? Contraddizioni su contraddizioni, paradossi che generano altri paradossi: in questo convegno, l’ambivalenza sembrava il punto di partenza per intravvedere le possibilità di legare l’astrazione teorica a modalità nuove di intervento politico. Karen Pinkus, per esempio, professore di letteratura italiana, ha preferito lasciare da parte l’intervento sulla fiction preannunciato, per richiamare l’attenzione sul gigantesco problema del cambiamento climatico e sull’azione concreta degli attivisti nella zona della sua università, Cornell, contro le tecniche di sfruttamento chiamate ‘fracking’; questi attivisti fanno leva, paradossalmente, su uno dei provvedimenti americani più conservatori, ovvero il prevalere della sicurezza dei cittadini in situazione di pericolo. Però, un altro partecipante aveva apposto sul suo “mac” un adesivo con lo slogan: “the green scare”, affermando che occorre resistere contro ogni strumentalizzazione della paura del cambiamento climatico, che distoglie la nostra attenzione da altre emergenze più problematiche. Nonostante le controversie interne, tutti i presenti sembravano d’accordo con la “missione” di cui gli intellettuali dovrebbero farsi carico per –almeno – limitare i danni. Molti di loro sono attivi sia nell’università sia in movimenti, che talvolta sono anche accademici: Elise Danielle Thorburn, dottoranda e rappresentante di EduFactory, ha lanciato un appello a favore degli studenti in Quebec, le cui manifestazioni contro l’aumento delle tasse sono state represse con violenza dalla polizia, con tanto di feriti e arrestati, e quindi notevoli costi legali per il movimento. George Caffentzis, professore di filosofia dell’università di Southern Maine invece ha chiesto solidarietà con la lotta studentesca contro il debito del prestito di studio, che negli Stati Uniti pare sia ancora più grave di quello della carta di credito. Si sentiva insomma che alcuni partecipanti provenienti da varie aree di attivismo, si aspettavano che i relatori non offrissero solo analisi teoriche ma concepissero anche strategie pratiche. E si è creata anche una divisione tra gli antagonisti del capitalismo e chi sosteneva che il capitalismo ormai capillare sia piuttosto un nemico interno; tra chi sosteneva una visione anti-umanistica della lotta, proponendo una dimensione impersonale allargata alle entità di animali e molecole, e chi riteneva essenziale riportare i problemi a realtà concrete e soluzioni pragmatiche; tra chi si sentiva attratto all’‘anomia della terra’, che oltrepassa il concetto territoriale di Stato, e chi invece rigetta una critica irresponsabile e elitaria dello Stato. Un esempio: l’autonomia sanitaria può funzionare senza l’assistenza da parte dello Stato?
Per me, partecipare a questo convegno, è stata un’esperienza davvero molto eccitante, ma che perde la sua pertinenza se non ci si sforza di comprenderne le ambivalenze, le contraddizioni e i paradossi. Non per fermarsi all’impotenza della complessità, ma proprio per poter aprire altri orizzonti di pensiero. E perciò la sfida posta dall’anomia della terra, lanciata dall’organizzatore Federico Luisetti sulla scia del filosofo tedesco Carl Schmitt, ha funzionato bene come propulsore provocatorio che ha liberato diversi tipi di vitalismo, complementari e conflittuali.
Per ulteriori informazioni: postautonomia.org



 Ciò che colpisce immediatamente sul sito web è l’uso professionale e sofisticato della rete e dei social network. Dove una campagna tradizionale avrebbe chiesto la firma ad una petizione ed al massimo una donazione, Facciamo Luce su Enel cerca di usare tutte le possibilità sociali della rete per divulgare il messaggio e coinvolgere più strettamente i sostenitori. Per farlo utilizza tecniche di gamification (ludicizzazione) che trasformano il sostegno alla campagna in un percorso personale, fatto di riconoscimenti, premi e rinforzi sociali, e progettato per divertire ed appagare il sostenitore.
Ciò che colpisce immediatamente sul sito web è l’uso professionale e sofisticato della rete e dei social network. Dove una campagna tradizionale avrebbe chiesto la firma ad una petizione ed al massimo una donazione, Facciamo Luce su Enel cerca di usare tutte le possibilità sociali della rete per divulgare il messaggio e coinvolgere più strettamente i sostenitori. Per farlo utilizza tecniche di gamification (ludicizzazione) che trasformano il sostegno alla campagna in un percorso personale, fatto di riconoscimenti, premi e rinforzi sociali, e progettato per divertire ed appagare il sostenitore.









 di Gianluca Veltri
di Gianluca Veltri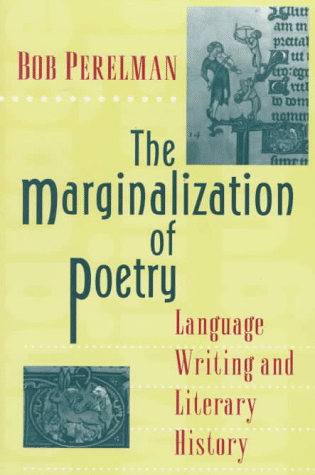
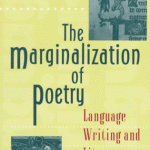
 E così, senza neppure portare l’acqua alta (che pure sarebbe stata molto in tema), nell’ultimo giorno d’Agosto 2008 la piccola Ponyo era giunta a Venezia. E il giorno prima ero arrivato in laguna anche io, che Ponyo già la conoscevo piuttosto bene, dato che per tutto il mese mi ero occupato della stesura del copione italiano per il sottotitolaggio del film. Io e Ponyo ci siamo così rincontrati al Lido, insieme all’autore di lei, ovvero quel Miyazaki Hayao che sempre allo stesso Lido, solo due anni prima, avevo visto ricevere un Leone d’Oro alla carriera. Una carriera fatta di ormai molte opere, soprattutto tante pellicole per me tutte così significative. Questa volta, oltre che l’opera del caso, ho avuto la fortuna di conoscere anche l’autore, anzi gli autori, visto che non riesco a considerare il ruolo di Suzuki Toshio meno rilevante di quello di Miyazaki Hayao stesso.
E così, senza neppure portare l’acqua alta (che pure sarebbe stata molto in tema), nell’ultimo giorno d’Agosto 2008 la piccola Ponyo era giunta a Venezia. E il giorno prima ero arrivato in laguna anche io, che Ponyo già la conoscevo piuttosto bene, dato che per tutto il mese mi ero occupato della stesura del copione italiano per il sottotitolaggio del film. Io e Ponyo ci siamo così rincontrati al Lido, insieme all’autore di lei, ovvero quel Miyazaki Hayao che sempre allo stesso Lido, solo due anni prima, avevo visto ricevere un Leone d’Oro alla carriera. Una carriera fatta di ormai molte opere, soprattutto tante pellicole per me tutte così significative. Questa volta, oltre che l’opera del caso, ho avuto la fortuna di conoscere anche l’autore, anzi gli autori, visto che non riesco a considerare il ruolo di Suzuki Toshio meno rilevante di quello di Miyazaki Hayao stesso.