Loca V: ISCA
di Orsola Puecher
 Isca.
Isca.
Isca di Eduardo.
Eduardo,
che io ricordo
come
il re delle isole.
Uomini e luoghi, a dispetto del tempo che cerca di cancellarne i contorni, restano legati al ricordo di un’immagine: la prima che si mette a fuoco nel pensarne all’improvviso i nomi. Una sola che la vince fra tante e che diventa il Ricordo. Di un luogo l’alba di un certo giorno, la sua luce, uno scorcio di tetti, finestre accese. L’essere curva e immensa di una piazza che hai visto bambino e che, se la rivedessi ora, si ridimensionerebbe a piccolo slargo insignificante. Di una casa le persiane accostate nell’immobilità della controra, nel frinire delle cicale che si interrompe di colpo e allora là sarà per sempre estate. Di qualcuno un certo sguardo e allora sarà per sempre amato. E così, nel rivedere una vecchia registrazione di Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, all’ambientazione dimessa e invernale della commedia, al poveruomo infreddolito, con la scialla e le chianelle, si sovrappone una figura secca secca, Sik Sik, nel sole e nel mare di un isola: il re delle isole, in piedi a prua della barca bianca, il gozzo San Pietro, fra scie e scogliere verso Positano. Panama, sahariana di lino, chiaro nella luce forte di un agosto lontano. Un ricordo a sprazzi luminosi, a salti di inquadrature, come solo sanno essere i fotogrammi dell’infanzia e di certi sogni.
 Un viaggio.
Un viaggio.
Avventura
di terra
e di mare.
Una bambina. Vagone letto da Milano. Sonno spezzato da sussulti di traversine e scambi. Stazione di Napoli. Viadotto che le si avvita accanto. La spiaggia di Nerano, scura di limatura di ferro e lapilli. Una barca per raggiungere l’isola di Eduardo, ché lui, davvero, come in un racconto di Conrad, come Prospero ne La tempesta, di un’isola, chiamata Isca, quasi lisca – Isca lisca di un qualche grande pesce mitologico – era il signore e padrone. E dove meglio che in un’isola starsene in ritiro a scrivere e pensare?
 E il mare
E il mare
inquieto.
Cielo sul mare. Quella barca, dove salire con un salto, che barcolla nella risacca e riparte. Il motore che scoppietta e s’avvia. Folate di gasolio nel salso. Americo, al timone, il marinaio custode dell’isola, sorriso e viso e nome da nume ricciuto. Personaggio antico scordato su quelle rive da Odisseo nel suo vagare.
 E presto
E presto
l’isola
che si avvicina
nel dondolio.
Galea con le vele ammainate, appoggiata sul blu cupo. Scheggia ripida di scoglio verde e grigio, ferma all’ancora, in quel tratto di mare, e messa così a ridosso della costa che parrebbe sempre pronta alla partenza, se potessero le isole, talvolta, navigare.
 E la casa.
E la casa.
Arrampicata in alto, bassa, sdraiata a seguire il crinale.
 E Guaglione.
E Guaglione.
Sul molo la sagoma massiccia di Guaglione, mastino napoletano grigio, gigantesco nel ricordo perché forse piccola io. Occhi tondi dei cani nelle grotte a guardia de L’acciarino magico di Andersen.
– Bel soldato, ti piacerebbe guadagnare un sacco di monete?
– Monete?! Farei qualunque cosa per un po’ di denaro…
– Bene! – riprese la strega – Vedrai che non sarà difficile! Devi calarti nel tronco vuoto di quell’albero finché troverai un grosso cane con occhi grossi come tazzine da tè a guardia di un grosso forziere pieno di monete di rame: dietro la seconda porta un tesoro di monete d’argento sarà difeso da un cane con occhi grossi come macine del mulino. Infine, se aprirai la terza porta, troverai un altro cane con gli occhi grossi come la base di un torrione, vicino a un tesoro di monete d’oro.
Un cerbero da fiaba a cui non erano state tagliate né coda, né orecchie, come d’uso. Eduardo che racconta di averlo salvato da cucciolo in un vicolo, udendone i guaiti disperati, chiuso in un sacco, dalle botte a bastonate fitte che l’avrebbero fatto cattivo, comprandolo dai suoi aguzzini.
– Piccirè… sono le botte a fare cattivi i cani… e pure l’omm’ne.
Dice. In due parole le cose profonde, così nel suo teatro. Così era Eduardo. Cose che capisce e non dimentica neppure una bambina: la cattiveria sempre motivo e radice di altra cattiveria. Non a caso la sua attività politica in Senato e soprattutto la sua prima interpellanza parlamentare (un testo esemplare sul Sud, sulla questione morale, sulla sua poetica e sul ruolo sociale dell’arte e dell’artista, ma pieno di tenerezza, di ironia e di fervore) da Senatore a vita, nominato da Pertini al posto di Montale, sono per i ragazzi delle carceri minorili, del Filangieri e di Nisida. In anticipo su tante esperienze seguenti Eduardo vedeva nel teatro un mezzo di cura e di riscatto dalle botte della vita.
 E l’isola vista
E l’isola vista
dall’acqua.
E Guaglione, non fatto cattivo, buonissimo si lascia cavalcare e nell’entusiasmo ti atterra di feste. Nella caletta davanti all’isola, nuota intorno, rumoroso di spruzzi e schizzi. Lucidi e brucianti pomodori di mare sugli scogli e i ricci. Le pietre scivolose di verde del piccolo imbarcadero. Ed Eduardo che, no, non lo fa il bagno: seduto all’ombra della casa, guarda dall’alto, sulla tolda, con quell’alone di soggezione e rispetto, indiscutibili, quella fama di essere severo e scostante, a volte, se non sapevi scovargli i lampi negli occhi e decifrare l’accenno dei sorrisi, brevissimi.
 E c’è
E c’è
dietro la casa,
oltre un viottolo,
un orto.
Coltivato a fatica fra le rocce: i suoi frutti gioielli e i pomodori seguiti nella loro preziosa crescita come criature. E girovagando, curiosa, la bambina, uno ne ha raccolto e salita su di ulivo piccolo e storto, lo strofina ben bene per mangiarselo, quando vede arrivare, in controluce, un Don Chisciotte, un ascetico Gandhi, che, squadrando l’ortaggio fra le sue mani, contrariato, scurisce dapprima una faccia burbera, ma poi sorride e regalmente concede:
– Beh… vabbuò… piccirè… mangialo… mangialo pure, quello – pausa densa – ormai… ma non ne raccogliere altri, eh?!?!
Pomodoro caldo di sole, salato di mare, il sugo che sbrodola sul mento. Pregiato più di un frutto esotico. E, per rimediare e sdebitarsi del furto, la bambina regala a Eduardo e al suo orto dei miracoli, prima di partire, dei semi dell’anguria mangiata a pranzo avvolti in un pacchettino fatto con un foglio di quaderno.
– Così le puoi piantare e io torno qui e le mangio! – dice, convinta.
– Sì… picciré… lo pianterò ‘o mellone!
E ridono scavati gli zigomi e gli occhi di scintille scure: per l’improbabile idea di veder crescere angurie su quell’isola assetata, in cui l’acqua arrivava con la nave cisterna.
 E la nave
E la nave
cisterna.
Contrattazione del prezzo dell’acqua, all’arrivo della nave davanti all’isola, dura a lungo ed Eduardo la conduce personalmente, in dialetto stretto. Tirando sul prezzo fino al centesimo. Lui sul molo, in piedi che grida nel vento. A volte non si mettono d’accordo e la nave riparte dopo reciproci dinieghi, finte e ironia. Un vero pezzo di teatro.
 E Maria
E Maria
cuoca fata
del ragù
e moglie
di Amerigo.
Eduardo scalzo nella cucina luminosa che segue il rito della preparazione, lenta e paziente, della transustanziazione di carne e pummarola in ‘O rraù.
– Piccirè, ‘o rraù a Napoli è carne con la pummarola, non pummarola con la carne!
 E le sere
E le sere
sulla terrazza
belvedere.
Stelle, costellazioni, il velo della via Lattea e i grandi parlare fino a tardi di teatro.
 E il teatro
E il teatro
di Eduardo.
Una fortuna, un privilegio, poterne vedere le registrazioni, perché del teatro resta poco, testimoni i testi scritti certo, ma il resto sfugge: vive di fisicità, di presenza, di aria attraversata da suoni e rumori, di respiri mescolati di chi guarda e di chi recita, d’improvvisazione e irripetibilità: di scrittura scenica. Seguendo insieme testo e video, ci si può rendere conto delle infinite variazioni e sfumature, dell’occasione unica di trovarsi di fronte a un grande attore che è anche autore e regista di se stesso, come Molière e come Shakespeare. Non ce ne sono molti altri. Se la sua scrittura, a uno sguardo superficiale, può sembrare semplice, lo è perché è solo il canovaccio per la successiva scrittura recitativa: nell’intercalare di quella mezza risata, vocalizzo in è-hè-hè-è, di quando descrive il Presepe al figlio scettico, o in quei suoi no di risposta, solo l’apparente semplicità permette di aggiungere una tale serie d’intenzioni, che una penna potrebbe fissare unicamente in numerose prolisse pagine. Le categorie della critica letteraria per questo tanto male si adattano ai testi teatrali. Più essi sono semplici più lasciano campo all’oscuro, e in queste disgraziate famiglie descritte da Eduardo, ondate di oscurità irrompono continuamente sotto la crosta dei fatti e delle parole.
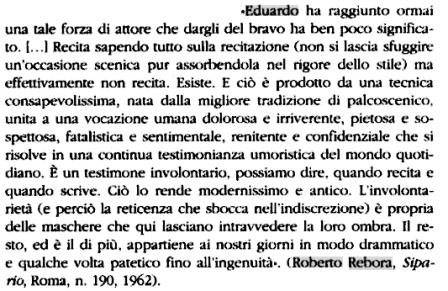
Il primo atto di Natale in casa Cupiello descrive il risveglio gelido della famiglia Cupiello, siamo alla vigilia di Natale.
[ 1977, Eduardo De Filippo e Luca De Filippo ]
 E il caffè.
E il caffè.
Caffè, filo sottile attraverso il testo. Caffè che sostiene nel dolore, unico piccolo lusso nel gelo dell’Inverno, nella casa ghiacciata, che fa scetare dal letto Luca, il capofamiglia, insieme naturalmente al pensiero del Presepe che sta costruendo amorosamente, altro filo conduttore piccolo ma importante. Il Presepe che non piace, quasi per ripicca generazionale, al figlio Tommasino che alle ripetute domande del padre:
LUCA Te piace ‘o Presepe?
Risponde ostinatamente un no che è il rifiuto di un mondo, di una filosofia di vita, quasi di una categoria dello spirito.
CONCETTA Sì Lucariè fa freddo. (spazientita) Fa freddo! e basta.
LUCA Eh… Questo Natale si è presentato come comanda Iddio. Co’ tutti i sentimenti si è presentato. (Beve un sorso di caffè e subito lo sputa) Che bella schifezza che hai fatto Concè!
La povera Concetta (Pupella Maggio, un altro monumento di recitazione) aggiunge surrogati, per risparmiare.
LUCA Col caffè non si risparmia… questo feta ‘e scarrafone..
Battuta epocale, come quella famosa di Totò: Questo caffè è una vera ciofeca.
E il consumo di caffè diventa unità di misura del dolore e della tragedia che si abbatte nel terzo atto sulla casa. Luca sarà colpito da una specie di paralisi per il dispiacere di aver scoperto che la figlia Ninuccia (una giovane e nervosa Lina Sastri) tradisce il marito e la moglie Concetta dirà:
CONCETTA In tre giorni se n’e andato più di un chilo e mezzo di caffè.
 E il confetto
E il confetto
‘e caffè,
E torna in mente, a sorpresa, il confetto ‘e caffè, che Eduardo insegna a confezionare alla bambina come fosse una rara leccornia. Si fa lasciando scivolare, chiano chiano però!, un cucchiaino pieno di caffè nella zuccheriera e poi rotolando, gira e rigira, fino ad avvolgere la pallina, il confetto è pronto.
– … eh i bambini, una volta, le caramelle non le avevano e pure il caffè non è cosa per loro…
Ma così potevano, in una goccia di sapore e di profumo, assaggiare in po’ del piacere da cui erano esclusi. Cose piccole.
 E le cose
E le cose
piccole.
Il teatro di Eduardo pare fatto di cose piccole, ma i piccoli gesti racchiudono e avvolgono le cose grandi in un basso continuo in sottofondo, che ne trasfigura e universalizza il realismo. Danno la misura di un quotidiano povero, quasi minimalista, ma denso del senso che sta dietro ad ogni gesto della vita.
La storia, l’intreccio, marcia via semplice, in binari che hanno il procedere geometrico della farsa. Una farsa rivisitata, però, e asciugata degli eccessi, quasi alla Cecov, in cui le manie i tic, le frustrazioni, la scontentezza cosmica dei personaggi, si dipanano in un misto di tragicità dimessa e familiare e di comicità amara, che muove un ridere sempre un po’ accorato e pieno di pietà.
Il Natale in casa di Luca Cupiello sembra svolgersi su piani diversi, che si sfiorano continuamente, senza mai riuscire ad incontrarsi, a parlarsi. Luca, perché un po’ lo ascoltino e lo assecondino, perché apprezzino il suo Presepe con tutto quello che rappresenta, deve restare quasi invalido e paralizzato. Lasciando spazio anche al sottile sospetto che un po’ la reciti questa sua malattia, per mettere alla prova tutti, per punirli. Solo un grande attore è capace di queste finezze, di questi doppi piani sfumati. Di queste cattiverie soavi.
Si direbbe che a crederci, ad un senso profondo della festa, sia solo lui, Luca, con il suo sogno, piccolo, fatto di casette di legno, colla e cartapesta, di un Presepe che non teme confronti, che vincerà con la sua bellezza composta tutte le miserie che gli scivolano accanto: la vita quotidiana insidiata dal freddo, dalla povertà, dai figli a cui dai tutto e che tutto ti prendono. Tommasino, il figlio minore, che approfitta dell’influenza dello zio Pasquale per vendersi le sue scarpe il cappotto e pure le bretelle. Ninuccia, la maggiore, sposata controvoglia, imbronciata e scontrosa, pronta a fare un colpo di testa e a lasciare il marito buon partito per il giovane amante. Sarà lei in un impeto di rabbia a fare letteralmente a pezzi il povero Presepe in costruzione. Luca si metterà a rifarlo pazientemente con la complicità di Concetta, la moglie, che si barcamena come un ago della bilancia, tutto sapendo e tutto cercando di nascondere e rimediare: la rovina della casa la definirà Luca per questa sua indulgenza materna. Eppure è la controparte, la spalla delle continue punzecchiature, di cui lui stesso non può fare a meno.
E cos’e il Presepe, se non il sogno di un mondo in cui tutti i contrasti possano essere ricuciti e ricomposti dall’amore e dal perdono? Come se il solo guardarlo potesse aprire qualcosa nei cuori. La cattiveria, così diceva parlando dei cani, e degli uomini, è la conseguenza delle mazzate della vita, nessuno è cattivo e nessuno è buono. Tommasino ruba la cinque lire allo zio, ma l’indignazione si stempera scoprendo che a sua volta lo zio l’aveva rubata a Luca. Il bisogno rende tutti fratelli nella colpa.
A che serve, forse, punire. Sembra, ma solo sembra, forse, che il Natale e il Presepe e la bontà, riescano a stendere ancora il loro mantello d’indulgenza sulle meschinità comuni a tutti gli uomini, la cui buona volontà pare non potersi mai attuare, tentata e violentata continuamente dalla miseria.
Natale in casa Cupiello finisce in minore, con il sospirato Sì che Luca ottiene, malato e sofferente, alla sua eterna domanda al figlio: Te piace ‘o Presepe? Ma anche questo sì lascia un brivido d’inquietudine, così, quasi estorto a forza. E’ del grande teatro mandare a casa lo spettatore un po’ inquieto e dubbioso.
FINALE ATTO TERZO: “Ottenuto il sospirato “si”, Luca disperde lo sguardo lontano, come per inseguire una visione incantevole: un Presepe grande come il mondo, sul quale scorge il brulichio festoso di uomini veri, ma piccoli piccoli, che si danno un da fare incredibile per giungere in fretta alla capanna, dove un vero asinello e una vera mucca, piccoli anch’essi, come gli uomini, stanno riscaldando con i loro fiati un Gesù Bambino grande grande che palpita e piange, come piangerebbe un qualunque neonato piccolo piccolo…”
LUCA (perduto dietro quella visione, annuncia a se stesso il privilegio) Ma che bellu Presepe! Quanto è bello!
Cala la tela.
Le parole prima della battuta finale solo una didascalia, una specie di sottotesto, di voce interiore dell’autore, non dette, lasciate, con discrezione, senza retorica, sulla pagina.
Eduardo De Filippo
Natale in casa Cupiello.
Volume in cofanetto con la videocassetta della commedia
Einaudi, 2000
Loca I: Poschinger strasse,1 di Giorgio Zampa
Loca II: Le città sottili. 3. Armilla di Italo Calvino
Loca III: Le ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini
Loca IV: Qui riconosco tutto, e perciò penetra subito in me: in me è di casa di Rainer Maria Rilke
I commenti a questo post sono chiusi


Grazie Orsola. Come leggevo, aprivo gli occhi incantati. Dall’arancia natale danza come regalo il pomodoro luccicante sotto fondo il mare.
dentro la casa, l’olore del caffè come amaro della vita. Si legge la prima onda come ricordo bagnato dal paesaggio di Campania e la saconda onda come scène familiare, intima.
La presentazione del testo o rappresentazione è bellissimo, delicato.
Gli appunti sono molto interessanti per me, una straniera.
E credo che in questo giorno Orsola sarà incantare molti lettori che per un momento lasciano il mondo adulto, per entrare in un universo d’arte e di magia.
è bellissima, delicata
” Un ricordo a sprazzi luminosi, a salti di inquadrature, come solo sanno essere i fotogrammi dell’infanzia e di certi sogni”
Complimenti a Orsola.
Si legge la prima onda come ricordo bagnato dal paesaggio di Campania e la saconda onda come scène familiare, intima.
Sarai straniera, Veronique, ma quando scrivi di Napoli e Campania ti trasfiguri. Grande!
Orsola, resto affascinato da questo collage di rara sensibilità e cultura. La mia terra di origine, che alquanto detesto, getta i suoi stracci e si mostra da gran signora qual è.
Quante volte ho nuotato verso Isca e quante ho visto un piccolo scafo approdare a Nerano e il marinaio tornarvi con il piatto di spaghetti di Maria Grazie. Chi sa capisce.,
@Capone: capiamo, capiamo..-);
un ricordo “sinestetico” intenso Orsola: io mi ritrovo molto nella bambina col pomodoro..Eduardo era un attore eccezionale, arrivato alla fine allo zen del silenzio sul palco; peccato non esser presente alle contrattazioni sull’acqua… anche se come drammaturgo il mio cuore era e resta con Viviani. Un abbraccio, V.
Carlo Capone,
Grazie mille. La Campania dà immensità e gioia al mio cuore. E’ una terra
che ti accoglie nell’innocenza e l’abbandono. La Campania ha qualcosa dell’infanzia.
Un abbraccio
Avrei voluto lasciare un commento sulla Nunziatella, ma non c’è spazio per commentare.
Se solo Eduardo non avesse la sua parte di responsabilità, bella grossa, nella costruzione dell’auto-compiacimento partenopeo, tutte quelle vestaglie e gli scialletti e le ciabatte e i pigiami e susete che c’è a zupp e latte e ha da passà a nuttata, il cuore in mano, le persiane socchiuse, poveri e rassegnati ma arguti e in fondo contenti di come siamo, quei borborigmi le pause impietrite, l’ironia sulla fame, il covaticcio dei bassi, l’universo auto sufficiente che non è né popolo né sotto-popolo, né borghesia impoverita, né sotto borghesia, ma sembra piuttosto una compagine media di impauriti, di traumatizzati dall’esperienza storica della ferocia in cui quella città può declinarsi, dunque un necessario terreno comune tra tutti e tutti è la sentimentalità inter classista sotto cui nascondere l’essere diavoli…
Véronique sta coniando piano piano una nuova lingua!!!! Il Vergéiano
Capone e Viola… aumma… aumma… non si sa cosa capiscano e sappiano di traffici di spaghetti via mare… dicano… dicano suvvia!
Nadia, grazie, non so quanto del sogno e della realtà ci sia in questo ricordo. Sono i casi in cui non conviene il ritorno.
Viola sui furti di pomodori negli orti e su Viviani compartecipo e concordo: Tuledo’e notte è un capolavoro
In merito, Pecoraro, alle supposte responsabilità di Eduardo (con chi le dividerebbe poi? Con Totò? Con Troisi? Con il grande Pappagone? Mario Merola? Forse Pulcinella… Maccus delle Atellanae… magari…) sul formarsi di quel bozzettino lì dell’autocompiacimento, del paravento consolatorio, della sentimentalità interclassista che nasconde i diavoli ecc ecc… il teatro di De Filippo e i suoi graffi… conoscendolo… il teatro di De Filippo… è quanto di più lontano ci sia.
Ma si lasci ad ognuno la sua impressione su ogni argomento… per carità.
,\\’
Per me Eduardo è quello del disperato “Fuitevenne!”, altro che autocompiacimento…
Stupendo. Tutto. Sia la parte narrativa, sia quella teatrale. E’ difficile persino commentarlo. Si ha timore di sciuparne la perfezione. L’unica è rileggerselo, con più calma.
@ gianni biondillo
Nessun autocompiacimento in questo pezzo. Ma solo la trasfigurazione poetica di una profonda esperienza umana e artistica. Qualsiasi attento lettore del brano se ne può accorgere: non c’è una sola parola, una sola frase che sia detta gratuitamente, senza il giusto pathos che la motivi e la renda necessaria. Tutto qui – teatro e vita – scaturisce dall’anima e ne conserva le vibrazioni, che ci raggiungono come gioia estetica e indefinibile nostalgia.
Pecoraro è tra i pochi commentatori cui valga la pena dedicare attenzione (come Puecher tra i pochissimi blogger che meritano una lettura). Stavolta però è fuori strada. E’ uno stereotipo che la “napoletanità” sia sempre uno stereotipo: men che mai lo è quella di Eduardo. Si tratta in realtà di un “sentire” profondo nella sua umanità, lacerante quanto può apparire scontato, assoluto quanto può fingersi superficiale. “Semplice” sostiene Puecher della scrittura di Eduardo, e ha ragione: nel senso di “classica”, accessibile nella sua bellezza, eterna nella commozione che (con semplicità ma non semplicisticamente) induce. Luca Cupiello è tutti, caro Pecoraro, col suo scialbo presepe, col suo naso che cola, coi suoi affetti banali e le sue benali certezze banalmente tradite. Perciò anche Eduardo è tutti. Perciò i suoi funerali sono stati un momento di napoletanità toccante, a rischio forse di autoconpiacimento e retorica, ma in cui si piangeva davvero.
puecher mi disce che non conosco il teatro di eduardo ed è per questo, secondo lei, che lo vedo come lo vedo.
pare invece che io lo conosca, che l’abbia persino visto a teatro.
certo non ne sono un cultore, ma non ne nego la bravura, persino la grandezza.
tuttavia non bisogna confondere le capacità di un artista dal ruolo che gioca nei suoi tempi presso la società cui appartiene.
tuttavia non mi dilungo.
dico solo che tutti quelli che hai nominato servono a perpetuare l’eterna capsula culturale napoletana.
tranne totò.
lui, anche se a napoli lo mettono negli altarini assieme a troisi e peppino e eduardo e maradona, è un altra cosa.
no “dal”, ma “con” (il ruolo).
questo della napoletanità è un discorso cruciale.
napoli comincerà a cambiare solo prendendone le distanze e alla fine abrogandola.
solo vedendola come storia, solo sottoponendola a critica radicale, solo ridicolizzandola, dimenticando i suoi alfieri, grandi o piccoli che siano.
Pecorà, se ‘il’ zuppone di latte è un luogo comune passa agli spaghetti di Maria Grazia, senti a me. Madò, che compiacimento.
Per arrivare da Maria Grazia. Da Meta si sale a Sant’Agata sui due Golfi, si piglia per Santa Maria alla Neve, passando davanti al cimiterino che reca sul cancello la scritta in oro ‘Resurrecturi’, e poi giù verso Nerano, sfiorando gli ulivi e ascoltando le cicale. Più giù, dove l’acqua è più blu (?), c’è Marina del Cantone, la baia che viene prima di Positano. La trattoria Ristorante Maria Grazia affaccia sulla spiaggia, rigorosamente in ciottoli, chi ha i piedi fracidi non vada. L’Isca è a un miglio, un canale di acqua limpidissima la separa dalla costa. Dal mare la villa non si vede. Un modesto gommone e una barchetta a due posti sono ormeggiati a una scalinata in pietra. Quando Eduardo ha voglia, si manda qualcuno a Marina del Cantone a prendere gli spaghetti di Maria Grazia. Ricetta rigorosamente segreta (ma dopo 30 anni credo dia aver capito come si ottiene la sua ‘crema’). Altra cosa, chiedere il vino bianco nella brocca con dentro le percoche.
Orsola, riconfermo, ‘pescare’ lo scoglio di Isca è roba da intenditori. Io la penso così.
Comunque nel pezzo di Orsola Puecher non è in discussione l’opera di Eduardo, né sono indiscussione i suoi riflessi psico-sociali. Lei sorvola sugli aspetti critici, per soffermarsi sulla propria esperienza di donna e di artista in rapporto al grande maestro. E in modo tale che il brano perde quasi il suo valore di testimonianza – il suo interesse in quanto documento – per assumerne uno autonomo, di vera e propria narrazione poetica.
Quanto all’attualità di Eduardo il discorso è molto complesso. Quel che è accaduto alla nostra società, e a noi personalmente, negli ultimi sessant’anni, non può non aver tolto presa e mordente – per così dire – anche a lui. Forse siamo diventati ormai così diversi (nel nostro intimo) dai suoi personaggi, che li capiamo molto, molto di meno di quanto non li capissero i nostri genitori o i nostri nonni. L’arte invecchia, non perché invecchia, ma perché il suo materiale, l’uomo, cambia, e non capisce più le opere che una volta gli parlavano. Le opere così diventano mute, perché gli uomini non possiedono più le orecchie e l’anima adatta per ascoltarle.
pecoraro a volte è interessante, ma quando parla di cose che conosce poco è fiacco e superficiale
«Recentemente, alla Biennale di Venezia, ho goduto della mia prima esperienza di autore teatrale, sia pure con documenti falsi: infatti avevo saccheggiato e manipolato un certo numero di fogli sparsi e insanguinati di William Shakespeare. Ma non di questo, ovviamente, intendo parlare. L’astuta patacca è stata variamente recensita, ma con notevole frequenza sono apparse due considerazioni: che il testo era difficile, dato che il pubblico era di incolti metallurgici, disavvezzi a quella sorta di linguaggio; e che pertanto il pubblico non avrebbe capito nulla o quasi. Naturalmente, non sta a me discutere se il linguaggio di Manganelli sia o meno difficile; ma posso discutere con moderata incompetenza sulla difficoltà del mio prestanome William Shakespeare. Ora, Shakespeare è estremamente complesso e difficile, anche sul piano linguistico; i suoi testi brulicano di metafore, di giochi verbali, di invenzioni linguistiche di ogni sorta: e tuttavia Shakespeare fu uno scrittore estremamente popolare, di successo, e cercavano persino di rubargli i testi per non pagare i diritti. Ora, se il difficile Shakespeare era popolare ai suoi tempi, bisogna pensare che gli spettatori, i plebei elisabettiani fossero tutti geni; e se noi il linguaggio difficile non lo capiamo più, se non con un certo allenamento, vorrà dire che siamo diventati bischeri. Io penso che le cose non stiano a questo modo: ho l’impressione che quel linguaggio sia diventato da difficile incomprensibile semplicemente perché è cambiato il nostro atteggiamento verso il linguaggio, verso l’uso che se ne può fare. Questo cambiamento è avvenuto all’incirca da un secolo, forse anche meno. Grazie a giornali, radio e televisione oggi la nostra società parla il linguaggo più misero, affranto, falso, ripetitivo, morto, neghittoso che si sia mai parlato; sono convinto che se noi, gli astronauti analfabeti, incontrassimo gli uomini dela pietra, non riusciremmo assolutamente ad afferrare il loro linguaggio che suppongo sottile, fantasioso, complesso, assolutamente shakespeariano. Può essere che il linguaggio shakespeariano agisca in modo traumatico su un pubblico – qualsiasi pubblico – : ed è il trauma della totalità nei confronti della settorialità burocratica; è, infine, il trauma del linguaggio normale perché ricco nei confronti di un linguaggio focomelico e intimamente sventurato. Un mondo psicologico ricco esige un linguaggio ricco, ed un linguaggio povero comporta la frustrazione, l’avvilita elemosina di un mondo squallido. Vorrei essere chiaro: nel nostro mondo esiste l’assoluto contrario teatrale di Shakespeare: è Eduardo. Eduardo può ‘andar bene’ per i metallurgici: ama i poveri ed è di sinistra; ma il suo linguaggio teatrale è probabilmente il più perfettamente reazionario che esista nell’intera Europa. Certo, Eduardo lo si capisce: come no? E’ fatto per essere capito, cosa che non è assolutamente di Shakespeare […]»
(G. Manganelli, Quella volta che mi tuffai tra le masse, “L’Espresso” 8 dicembre 1974)
Mi fa piacere che De Filippo sparigli ancora, è segno di vitalità, comunque.
Oh eccolo qua, un Manganelli arcinoto e d’annata, (mi dicevo ma chi lo citerà… attendendolo ansiosamente) snob il giusto e autoassolutorio, a mezzo Eduardo, in surplus… regge abbastanza fino a quando lo tira in ballo, Eduardo, poi sbraca assai…
La lingua, l’uso del dialetto come lingua, di De Filippo è apparentemente semplice, così come quella di Shakespeare all’epoca non appariva affatto complessa.
Su Shakespeare complesso e i plebei elisabettiani la questione è di sicuro nella capacità minore di percepire la parola detta, l’oralità, che nei secoli si è rallentata e non solo nei plebei e nei metallurgici poveri di sinistra, ma in tutti.
Un testo che scivolava via in due ore, nel battere della metrica dei versi, ora ne dura almeno quattro. Si è rallentata, o meglio disallenata, essendo la nostra civiltà dell’immagine, la capacità di associare parola detta a immagine mentale. Ad esempio ciò che era una necessità, la descrizione di luoghi e tempo a parole, la scenografia verbale cosiddetta, ché il teatro elisabettiano aveva una scenografia unica, oggi forse appare come complessità e lingua colta. Ma non lo era affatto.
Citerò io anche, massì dai… si citi… la prefazione di quello che fu l’ultimo lavoro di De Filippo.
,\\’
Ringrazio i commentatori per la varietà dei punti di vista.
Come straniera, apprezzo il teatro d’Eduardo de Filippo,
per il senso della realtà, i colori dei personaggi. Ho avuto
la fortuna di vedere Filumena Marturano e ascoltare la
musicalità del dialetto. Il dialetto napoletano sposa l’anima,
gli emozioni, viene dal cuore. Diventa canto della passione,
del dolore, della rabbia. Nel teatro si sente una vibrazione
che oltrepassa il cliché. I personaggi sono nell’ambiente
napoletano, nell’intima della vita, nelle piccole cose della
vita napoletana, ma parlano anche con l’anima, la sincerità.
Se puo dire che Eduardo di Filipo mi mette appetito.
Grazie a Orsola per la bellezza e la precisione del commento :-)
E’ abbastanza ridicolo definire “arcinoto” un testo di Manganelli uscito su un settimanale 35 anni fa e poi raccolto in un volume (“Cerimonie e artifici”) edito da Salerno che avrà venduto al massimo qualche centinaio di copie. E’ talmente arcinoto che in rete non esiste la versione integrale di questo articolo e in buona parte l’ho dovuta ricopiare io dal testo. “Snob” è pensare che quanto conoscono poche centinaia di happy few sia “arcinoto”.
Eh vita dura cercare di stupire a colpi di citazioni…
Esiste un’arcinotorietà che esula dai risultati di google.
Per fortuna.
E non è questione di fortuna o di élite. Di snobberia.
Ma di studio e documentazione quando si scrive un testo.
Se uno segue un seminario a una Scuola di Teatro, se si documenta per scrivere qualcosa su De Filippo, si imbatte in questo articolo di Manganelli, non particolarmente interessante e pregnante. Più piccato per le critiche negative alle sue patacche shakespeariane, che altro… forse… e vagamente sgradevole e razzista e non condivisibile nelle sue conclusioni… e se lo dimentica… per quel che mi riguarda.
,\\’
Capone, a questo punto, dopo la bellissima descrizione della passeggiata ulivi&cicale verso la mitica trattoria della Maria Grazia, non si può sottrarre alla rivelazione del trentennale segreto della crema… che Véronique ha appetito…
Grazie a Sandro Dell’Orco per aver compreso lo spirito e il cuore che anima questo post. L’essere attuale di un autore o di un testo è l’ultima cosa che mi interessa. Sono in toto per l’inattuale. In questi tempi bui.
niky lismo grazie. La commozione non è sempre sentimentalismo, per fortuna.
Eduardo… non sarà mica uno di questi fantasmi…
,\\’
Spaghetti Maria Grazia
Ingredienti (per 6 persone):
– 500 g. di Spaghetti
– 800 g. di zucchine
– 3 dl olio d’oliva
– 50 g. burro
– 100 g, parmigiano grattugiato
– 100 g. caciocavallo
– sale e basilico
Preparazione
In una padella friggete con olio d’oliva, un poco alla volta, a fuoco vivace, le zucchine tagliati a cubetti lasciandoli appena dorati. Una volta fritti, disponeteli a strati in una terrina condendoli con sale, con parmigiano grattugiato e con basilico freschissimo. Aggiungete, alla fine, due cucchiai dell’olio di frittura e lasciate insaporire per 1 ora. A questo punto lessate al dente gli spaghetti e rimetteteli a fuoco con un mestolo di acqua di cottura, con il burro, con le zucchine e il caciocavallo tagliuzzato sottile. Profumate il tutto con ottimo basilico.
grazie martha
questà è poesia
ma lei cosa c’entra con Maria Grazia… e con Capone… mah…
,\\’
“Esiste un’arcinotorietà che esula dai risultati di google”
se l’arcinotorietà di un testo si misura dal numero dei partecipanti a un seminario sul teatro di eduardo allora non esula solo da google, esula anche dalla logica. cose che càpitano quando si è “piccati” per una critica negativa.
@martha
nutro dubbi. Le zucchine erano tagliate a fettine sottili, questo è certo. A cubetti no. Il formaggio, che non ho mai capito di che tipo fosse, non era tagliuzzato. Era una crema, insuperabile. Se poi la innaffi con vino bianco alle percoche…..
Comunque invito tutti ad andarci, a Marina del Cantone. Prenderete la barca, rigorosamente a remi, nuoterete sotto Isca e al ritorno pranzerete da Maria Grazia. Non so oggi chi ne perpetui la tradizione, perchè i fatti narrati rislagono ai 60,massimo ai 70.
Una notte di quegli anni, sere quando la luce di luna schiarisce Li Galli, andammo alla spiaggia del Fornillo.La si raggiunge da Positano per un sentiero a saliscendi che poi depone verso il mare. In questa conca minuscola l’organizzazione dell’evento ( un evento anni 70, ruvido e misurato) aveva montato un palco con gradinate in legno. Saremo stati un centinaio, massimo duecento.
Eduardo arrivò dal mare insieme a Laurence Olivier e Joan Plowright, grandi suoi amici, ospitati a Isca e reduci dai successi inglesi di ‘Ieri, oggi e domani’. Olivier e sua moglie ne avevano riarrangiato il testo in slang londinese per conferirle immediatezza ( ma a Leningrado aveva recitato Filumena in napoletano e i russi, entusiasti. avevano capito tutto).
Dunque rividi (o rivissi? le gradinate erano alte e e io ero in cima) il Maestro, come sempre alto magro allampanato, vestiva un completo beige con foulard alla gola.Si rivolse agli ospiti in italiano e quelli sembravano capire. Chiese che recitassero un brano del Mercante di Venezia. Il fitto dialogo a me parve molto misurato in tipico stile teatrale ianglosassone.
Poi toccò a lui. Joan, cui sembrava legato da un affetto speciale (non a caso lei aveva ricoperto il ruolo di Titina in Filumena, sempre a Londra) gli chiese da dove trovasse ispirazione per i suoi personaggi. Calò un telo e si vide Eduardo che passeggiava per i vicoli di Napoli insieme a un amico, cui rivelava che stava andando da un giovanotto dei Quartieri, dal viso del Pulcinella che da anni cercava.
“Ma tu non glielo dire – si raccomandò- fai fare a me”. Il giovane era un tipo allegro e un po’ grullo, dal profilo adunco e le labbra pendule. Eduardo gli disse: “Uagliò, fai vedere come canti”.Prima che l’altro inziasse prese a sè l’amico e gli confidò sotto voce : “Guardagli il profilo, fai attenzzzione”. Mentre il giovane ragliava come un ciuccio Eduardo lo incitava ” Vai avanti, continua!”, e mentre cantava gli storceva un po’ il mento per stimarne il profilo.
Ad un tratto si fece da parte e confidò alla cinepresa, “lo vedete il naso? stesso naso! e la voce! esattamente chiòchera come quella di Pulecenella Cetrulo”. Cavò dal nulla una maschera nera e la sistemò sul viso. E quell’altro cantava.
Eh sì… si finisce sempre a disquisire fra cubetti e fettine… è una questione di taglio.
Di piccati al limone o al vino bianco.
,\\’
Che piacere! Ringrazio Martha, Carlo Capone e Orsola per la ricetta. Ho già fame, ma purtoppo alla mensa, non è cucina italiana :-( e quando si mangia la pasta, non è buono. Ho stampato per avere la ricetta e provare. A Napoli si mangia divinamente! Con un vino fresco è il paradiso. Stasera, dopo il consiglio di classe, vedo a casa Filumena Marturino. Mi faccio una serata a Napoli.
Un abbraccio a tutti.
@eduardo
tutto quello che conosco, lo conosco poco.
@ sergio garufi
“(…)Eduardo può ‘andar bene’ per i metallurgici: ama i poveri ed è di sinistra; ma il suo linguaggio teatrale è probabilmente il più perfettamente reazionario che esista nell’intera Europa. Certo, Eduardo lo si capisce: come no? E’ fatto per essere capito, cosa che non è assolutamente di Shakespeare (…)”
Caro Sergio,
un brano così non è assolutamente giustificabile, neanche se scritto da Manganelli, neanche se inserito nella particolare temperie culturale di quegli anni. Un intellettuale, e tanto più un intellettuale della statura di Manganelli, non può lasciarsi andare ad un uso così sciatto e volgare dele parole, ad un uso così irriflesso dei concetti.
@sandro
non so se “reazionario” sia il termine adatto, però non mi sembra che si tratti di “uso sciatto e volgare delle parole”.
mi sembra una reazione fuori misura.
tutto il teatro di eduardo (tradizionale e naturalistico, magistralmente recitato, ma sempre nel medesimo registro, che mette in scena sempre la stessa figura…) serve alla ri-conferma della napoletanità dei buoni sentimenti, dell’arte di arrangiarsi eccetera.
però toccare eduardo non si può
è un sacro santino partenopeo.
insorgono i partenopei, indignati.
amen’s.
Insomma critica chi critica
e insorge chi insorge
siamo qui apposta
Comunque basta vederlo recitato da Da Berardinis o da Carlo Cecchi e ti accorgi invece di come la sua drammaturgia regga anche senza la sua maschera e il suo registro.
Molto bello quel ricordo, invece, Carlo Capone.
Spesso mi chiedo che senso abbia scrivere qui, ecco se smuove, se risuona in chi legge cose così, ho meno dubbi.
Ne ho altri due di ricordi, stavolta pescati in rete, uno fra questi bellissimi ricordi aneddoti è di Camilleri:
http://www.vigata.org/eduardo/eduardo.shtml
che non conoscevo e che è di sicuro quasi contemporaneo al mio viaggio ad Isca ( sopportando lo sbaglio del cognome!)
“Aveva un uso tutto particolare degli avverbi. Io non so se fa parte del napoletano. Questo mi è stato raccontato da una persona degna di fede. A Napoli andarono Giorgio Strheler, Virginio Pueker, Paolo Grassi e Ruggero Jacobbi, per trattare la traduzione e la messinscena di non so quale Molière. Andarono a mangiare; Virginio Pueker, che portava la macchina, l’aveva lasciata sotto un evidentissimo cartello di divieto di sosta. Quindi, via via che si avvicinavano, finito di mangiare, verso la macchina, vedevano un agente, un vigile, che stava prendendo una multa, io credo con particolare soddisfazione, dato che la macchina era targata MI, Milano. Allora Virginio va dal vigile e gli dice : ” Senta io non avevo capito che era un divieto di sosta”. ” Perché Milano dov’è ? Non è in Italia?” dice il vigile. In quel momento però scorge Eduardo. Quindi avviene naturalmente una sorta di sfida all’OK Corral, cioè a dire Giorgio Streheler e Ruggiero da un lato, Virginio Pueker e Paolo Grassi dall’altro, il vigile urbano ed Eduardo che si fronteggiano. Allora il vigile fa: ” Sono vostri?” indicando gli uomini ed Eduardo risponde: “Eventualmente!”. Straordinario! Cioè a dire è un uso incredibile. Voleva dire in quel caso: ‘A seconda di come ti metti’. “
Il secondo ricordo è questo, a Taormina, il 15 settembre 1984, poco più di un mese prima della sua scomparsa.
,\\’
Caro Sandro, quel brano è in risposta a chi gli obiettava di non andare incontro ai gusti dei “metallurgici”. Per il resto io lo trovo profetico, e tutto fuorché “sciatto e volgare nelle parole” o “irriflesso nei concetti”. La verità è che Manganelli bisogna meritarselo, e questo paese non se lo merita. Vogliamo il santino, la cartolina, l’ironia e l’intelligenza stanno altrove.
Consiglio la lettura de La Grande Magia, così magari si sgombra un po’ il campo da napoletanità, arte di arrangiarsi, dal santino, dalla mancanza di ironia&intelligenza e tutto lo scontato repertorio critico d’accatto. Anche dalla metallurgia, magari.
meno male che ci sei qui tu a elevare il livello, orsola.
spostare la discussione su questo piano che livello sarebbe, invece?
sì.
per me il problema non è la sostanza artistica et culturale di eduardo, che non sto discutendo, anche se non mi interessa particolarmente, ma il ruolo che ha giocato la sua figura e le modalità di percezione presso il grande pubblico.
perché quello di eduardo fu ed è tutt’ora, numericamente, un grande pubblico.
ora sono convinto che in genere un grande pubblico lo si guadagna prevalentemente consolandolo dello stare al mondo.
però posso sbagliarmi, certo.
Caro Garufi,
io amo moltissimo l’ironia e l’intelligenza di Manganelli, le sue strabilianti invenzioni e il suo straordinario giocare con la lingua , ma amo anche il teatro di Eduadro De Filippo, che tutto è tranne che la retorica dei buoni sentimenti. Non è colpa di De Filippo se di lui se n’è fatto un santino, cosa inevitabile, quando certi autori diventano popolarissimi e , loro malgrado, vengono trasformati in personaggi e/o monumenti. Però, una volta caduto via il ciarpame, rimane comunque l’essenza del suo teatro, e quella è forte e grande e travalica tempo e mode.
Insomma ,due modi di fare arte che non necessariamente si elidono. Tutt’altro. Non è il caso di citare il Dante che argomentava “contra li spregiatori de lo volgare”, vero? E sul concetto di “volgare” non credo ci siano equivoci, giusto?
Insomma, quel suo testo va storicizzato e contestualizzato, e soprattutto non va preso alla lettera, altrimenti, anche di Manganelli – seppure in sedicesimi – si rischia di fare il santino.
se accusi i tuoi interlocutori di dire cose “scontate” e “d’accatto” che ti aspettavi? un approfondimento? i complimenti? almeno dacci consigli di lettura meno arcinoti, che “la grande magia” l’han letto tutti al seminario di salsa e merengue.
sempre più giù
Orsola e Sergio, se continuate a beccarvi perdiamo di vista Eduardo. Che almeno, “reazionario” com’è, ci “consola dallo stare al mondo” (sarà una colpa? e lasciarsi consolare?)
Ma no, sono divertenti queste cose, la tua stroncatura di Manganelli, quella di Inglese a Scarpa, sono talmente comiche e fuori bersaglio che valgono pure qualche offesa. E’ come quella gag di Totò, “Mica sono Pasquale io”, in cui si fa insultare e prendere a schiaffi da uno che lo scambia per un altro e pensa “chissà ‘sto stupido dove vuole arrivare”.
@ sergio garufi
@ francesco pecoraro
La mia non era una critica all’opera di Manganelli, e tanto meno alla sua persona. Volevo solo dire che non è giustificabile, in un così grande scrittore, quel linguaggio e la concettualizzazione da esso sottesa. L’affermazione che Eduardo “può andar bene” per i metallurgici: ama i poveri ed è di sinistra” è un capolavoro di volgarità e di classismo. Degli uomini, delle persone, vengono sprezzantemente ridotti alla loro funzione e senza possibilità di riscatto. Un maestro della parola come Manganelli, che ben conosce le sottili vibrazioni emananti da ogni vocabolo, non può non sapere che pronunciare la parola “metallurgico” in quel modo, significa inchiodare gli operai alla loro ignoranza, farne quasi una condanna antropologica – e dunque l’epiteto assume una colorazione para razzista. C’è pura cattiveria, in quella parola, nessuna umana e benevola comprensione per una condizione di minorità intellettuale che non è colpa di chi la porta, ma della società antagonista che la impone. Che larga parte dei dominati siano amusici è un fatto, ma è dovere di chi ha il privilegio di non esserlo rendersi conto della pura casualità della propria condizione, e non infierire su chi è stato solo meno fortunato. Ché poi, tutta questa arroganza, che è sintomo di ignoranza umana – dell’essere umano nelle sue fondamentali componenti morali e spirituali – diventa alla fine anche cecità assoluta nei confronti di un opera d’arte riuscita e oggettivamente riconosciuta come quella di Eduardo.
Che a Eduardo, la storia dell’ultimo sessantennio, abbia in qualche misura sottratto gli spettatori a cui mirava, quelli che potevano pienamente “capirlo”, e che quindi il suo teatro oggi in qualche misura giri a vuoto, è senz’altro vero; ma da questo ad affermarne la nullità ce ne vuole, e solo una arrogante visione avanguardistica, tutta schiacciata su una prospettiva linguistica dell’opera d’arte, può arrivare a tanto.
sandro, non hai capito. l’ho detto e lo ripeto: manganelli citava le obiezioni di un critico che stroncò un suo testo andato in scena al petrolchimico di marghera sostenendo, seriamente, che non andava bene per i metallurgici. citava e prendeva per il culo, capisci? la volgarità, il classismo, il razzismo e quant’altro ti ha offeso in quell’espressione vanno quindi addebitati a un altro. (davvero la scenetta di totò è esemplare in questo senso)
@ francesco pecoraro
“sì.
per me il problema non è la sostanza artistica et culturale di eduardo, che non sto discutendo, anche se non mi interessa particolarmente, ma il ruolo che ha giocato la sua figura e le modalità di percezione presso il grande pubblico.
perché quello di eduardo fu ed è tutt’ora, numericamente, un grande pubblico.
ora sono convinto che in genere un grande pubblico lo si guadagna prevalentemente consolandolo dello stare al mondo.
però posso sbagliarmi, certo.”
Caro Francesco, credo che tu ti sbagli. Il destino sociale di un’opera d’arte non è in potere del suo autore. Un’opera d’arte infatti può venir fraintesa. E se accettiamo il presupposto che essa è sempre un’espressione di libertà, se consola essa E’ fraintesa.
@ sergio garufi
Ti credo, ovviamente, ma anche così le sue valutazioni rimangono eccessive – in fondo è un articolo su una rivista, non un alterco dal vivo. E se mi hai convinto sul valore da dare all’epiteto “metallurgico” , rimane l’affermazione “il suo linguaggio teatrale è probabilmente il più perfettamente reazionario che esista nell’intera Europa.” che è comunque inaccettabile per un maestro del valore di Manganelli.
Consiglio, a chi ha la fortuna di scovarlo – io ho provato con YouTube, senza esito – di vedere Sik Sik l’artefice magico, c’è tutto il veleno del vivere, l’inutilità degli stenti, la rabbia assassina per la sorte immutabile. L’opera è un atto unico di metà anni 30 (lo recitavano i tre De Filippo). Quando vidi Sik Sik al San Ferdinando, nel 79, ebbi le convulsioni. C’erano: Angelica Ippolito nel ruolo di Madamigella, Luca in quello della spalla infedele e Sik Sik.
Sik Sik è l’ultimo dono che Eduardo volle fare alla città che ha più amato dopo Napoli (ma è una bella lotta). Lo dico perchè i grandi trionfi di Le voci di dentro, Questi Fantasmi, Filumena, per citarne alcuni, targano indiscutibilmente Milano. Unica piazza per la quale Eduardo aveva accettato di emendare alcune incomprensibilità del dialetto. Pochi si accorgevano che fuori Napoli il suo dialetto non era quello del piccolo ceto, tipico del suo teatro, bensì la lingua parlata dalla media borghesia napoletana. Che è tutt’altro.
Vi tornò ottantenne, a Milano, portando al Manzoni l’atto unico di Sik Sik e i due di Il berretto a sonagli. Ogni pomeriggio di quell’aprile sereno chiunque poteva scorgere questo vecchio, non ancora afflitto dalla malattia agli occhi, passeggiare tranquillo per Via Manzoni. Loden beige, occhiali e baschetot. Qualcuno lo salutava, altri si giravano, altri magari additavano. A tutti rispondeva con un sorriso triste, identico a quello di mio padre.
Di Eduardo ho un altro ricordo diretto. Fu la sera in cui, al termine di Gli esami non finiscono mai, uscì come sua abitudine a dialogare con la platea. In genere leggeva poesie, o proproneva suoi ‘pinzieri’, cose così insomma. Quella volta uscì e disse subito: “stasera voglio farvi sentire un gruppo di bravi ragazzi, hanno riscoperto l’antica musica delle Zeze, delle villanelle, delle tamurriate. Non vi dico chi sono, ascolatateli solo, so’ e’ uagliun nuost!”. E d’incanto comparvero sul palco Peppe Barra, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò. Maurellio. Attaccarono con piffero, nacchere e tamburo, seguendo un ritmo avvolgente e sincopato. Quando il suono raggiunse l’acme le strida sguaiate ma armonicamente perfette di Barra la Pacchiana e Bennato il pescatore imposero al canto una svolta di selvaggia bellezza. Una temepesta di suoni e fonemi mi prese in petto, sentivo leggero il riandare del tempo, scoprivo in estasi radici lontane e le mie parti scollate congiungersi a incastro.
Restammo impietriti, quanto era bella la Tammurriata nera, e chi l’avave amai sentita così ‘arraggiata’.
Era nata La Nuova Compagnia di Canto popolare, sotto l’egida eduardiana e l’impegno di ricerca di quel talento assoluto che è Roberto De Simone.
Grazie Carlo che bei ricordi… la memoria è l’antidoto al tempo che si porta via tutto.
Su Sik Sik c’è solo questo documento sonoro infatti:
Dell’Orco, a me, contestualizzato, come rileva giustamente D’Angelo, l’articolo di Manganelli non stupisce poi tanto, anche i grandi maestri possono scrivere testi, come dicevo in un commento precedente, con intento auto assolutorio, appoggiandosi prima a Shakespeare, imbrigliandolo superficialmente nell’equazione difficile, colto, uguale rivoluzionario, alto e, invece, semplice, povero uguale a reazionario e basso perchè comprensibile ai poveretti, e poi, con un tipico finale retorico, alla non mi capite e allora vi meritate De Filippo (o Alberto Sordi… o chiunque altro…), servirsi di qualcuno come capro espiatorio.
Da un punto di vista critico Manganelli non da indicazioni interessanti sul perché e su come il linguaggio di Eduardo sarebbe reazionario. Sui suoi meccanismi. Si limita ad un mero dualismo di valore.
Penso poi che il problema non sia che un testo sia frainteso o meno, il teatro vive della sua interpretazione scenica, della reazione del pubblico a caldo, ha meccanismi particolari. Un testo teatrale si muove su piani diversi, a strati, ad indizi progressivi, ci può essere un primo livello, che fa si che Aspettando Godot, o Sogno di una notte di mezza estate possa essere messo in scena sia dalla filodrammatica del dopolavoro che da Peter Brook, con esiti diversi, ma leciti.
Un attore, un regista, sceglie i piani, a volte anche volutamente in modo arbitrario, provocatorio, è nel gioco, e sa quanto diversi siano anche i vari pubblici dei teatri, delle città dove recita, quello della prima, quello delle repliche, lo spettatore che tossisce da quello che sta lì col fiato sospeso.
Sceglie di mettere in scena un determinato testo in un preciso momento storico.
E’ nel conto essere capiti o non essere capiti.
Inseguire l’attuale o l’inattuale.
Tutto è immediato, in vivo.
Il giorno dopo della Prima in edicola trova tante critiche quanti sono i critici dei giornali, destra, sinistra, centro, incensature e stroncature che siano.
Tutto sul filo, a curve pericolose.
Un capocomico senza l’ombrello delle sovvenzioni statali, la pania di un teatro stabile, mette in gioco il suo denaro anche.
,\\’
@sandro
l’autore ha molti modi per indirizzare il destino sociale della propria opera.
primo tra tutti è, sotto sotto, massaggiare i destinatari.
prova.
eduardo è un grande attore. punto. le opere di eduardo senza l’attore eduardo ,,,,
@ francesco pecoraro
Io parlavo degli autori con la A maiuscola. Come per esempio Eduardo. Essi non si curano del pubblico, ma dell’intrinseca coerenza dell’azione che vogliono rappresentare. Gli altri non sono qui in discussione.
Se poi quel “prova” era indirizzato a me, hai sbagliato indirizzo, non sarei capace di farlo neppure volendolo.
@ orsola puecher
Condivido ogni cosa che dici, al limite anche l’ammiccamento o la provocazione al pubblico di volta in volta presente, ma naturalmente senza sacrificare la struttura, l’ossatura, la consequenzialità dell’azione drammatica: cose che costituiscono l’autonomia INVALICABILE dell’opera rispetto al pubblico. Hic rodhus hic salta: questo dice ogni opera degna di questo nome al pubblico: non vengo io da te, ma fai tu lo sforzo di venire da me e di percorrere la strada, l’itinerario che io stessa sono.
@ orsola puecher
“Da un punto di vista critico Manganelli non da indicazioni interessanti sul perché e su come il linguaggio di Eduardo sarebbe reazionario.”
Su questo invece totale accordo. Insomma, se ogni tanto anche Omero sonnecchiava, si può ben capire che ogni tanto anche Manganelli dicesse cose insensate.
@sandro
scusami.
era una prova tecnica di invio commento.
tu non c’entri nulla.
va beh dai… mettiamoci d’accordo, se massaggio sia, per un massaggio shiatzu: fa male e cura, per una catarsi sempre un po’ amara e malinconica e molti dubbi irrisolti, però…
Sandro Dall’Orco
“cose che costituiscono l’autonomia INVALICABILE dell’opera rispetto al pubblico”
allora rinunceremo a un La dimora unica ambientato fra gli echi della cattedrale polverosa della stazione della metropolitana dismessa City Hall Station
(si scherza eh…)
,\\’
@ orsola puecher
Scherzo per scherzo (ma non tanto). Se avessi la fortuna di esser rappresentato a NY, stai sicura che mi andrebbe bene anche la City hall station. Che tra l’altro sembra uscita pari pari da un frammento ritrovato di Amerika di Kafka.