Dentro il cappotto di Proust
di Mauro Baldrati
Chi ama Proust, chi ha letto la Ricerca e ne è rimasto affascinato, o impressionato, spesso ama anche le sue cose, gli oggetti, le notizie della sua vita. E’ come se da questo romanzo immenso, abissale, si sprigionasse un fascino che coinvolge il suo autore, l’angelo notturno, la macchina di scrittura totale che fonde la vita con la letteratura, tanto che, con Kafka, potrebbe affermare, e di fatto afferma: “Io sono letteratura.”
E’ carica di fascino, non privo di sfumature dark, la figura dello scrittore che, dopo una vita dissipata nei salotti della Belle Epoque parigina, una vita spesa a cercare l’amore, forse senza mai trovarlo veramente, si rinchiude in una stanza gelida, perché il calorifero peggiora la sua asma, foderata di sughero, perché è ipersensibile ai rumori, e vive a letto, accudito da una fedele governante, per portare a termine la sua vera, unica, ultima missione: scrivere il romanzo della vita, sulla perdita di tempo, sulla memoria involontaria, sulla curvatura del tempo che fa transitare il passato nel presente, e il presente nel futuro, attraverso la personificazione del desiderio e un complesso sistema di segni, la discesa agli inferi della ricerca dell’amore e dell’amato, dell’amicizia, della bellezza e del dolore.
Steso sul letto, coperto da uno strato inverosimile di coperte, e con un cappotto foderato di lontra sulle gambe, con un quaderno tenuto alto, davanti a sé, come il soffitto della Cappella Sistina per Michelangelo, Proust scrive, in una lotta serrata contro il tempo, cercando di tenere a bada la morte, la sua “locataria troppo premurosa”. E quando, finalmente, appone la parola “fine” sull’ultima pagina del quaderno, sorride, diventa allegro, e si rivolge a Céleste, dopo giorni, settimane di silenzio assoluto: “ora posso morire” le dice. Ovviamente Céleste, che conosce bene il suo amato padrone, è scettica, perché sa che continuerà a correggere, a scrivere note, fino all’ultima stilla di energia. Così François Mauriac descrive il suo incontro con Proust, il 28 febbraio 1921: “Rivedo quella camera sinistra di rue Hamelin, il caminetto nero, quel letto in cui il cappotto serviva da coperta, quella maschera di cera attraverso la quale il nostro ospite sembrava guardarci mangiare, e di cui solo i capelli sembravano vivi.”
Il cappotto. Quel cappotto. Proust lo indossava sempre, anche d’estate. Nella Ricerca è quasi un personaggio. Mitica la scena in cui l’amico Saint Loup salta sui tavoli allineati e li percorre di corsa, per prendere il cappotto per l’amico infreddolito. Episodio realmente accaduto nel 1911, quando Jean Cocteau, suo grande amico, eccitato da un discorso che stava tenendo sulla grandezza di Nijinsky, salterà sul tavolo di un ristorante per portarglielo. Proust gli dedicherà questi versi: “Onde coprirmi di pelliccia e di seta/Senza rovesciare il nero inchiostro dei suoi occhi vasti/Come silfo al soffitto o sciatore su neve/Jean saltò sulla tavola, accanto a Nijinsky.” Compare anche in numerose testimonianze, per esempio quella di madame Bibesco: “venne a sedersi davanti a me, su una piccola sedia dorata, come se uscisse da un sogno, col suo cappotto foderato di pelliccia, il suo volto di dolore e gli occhi che vedevano la notte.”
Il cappotto di Proust è il titolo di un piccolo libro di Lorenza Foschini, giornalista televisiva, 68 pagine di testo più una serie di foto e disegni, pubblicato – per ora – nel 2008 dall’editore Portaparole di Roma, che racconta di una lunga ricerca, e un’ossessione: trovare oggetti appartenuti allo scrittore, qualunque oggetto, fogli sparsi, prime edizioni dei suoi libri, biglietti, dediche, mobili, tappeti. Qualunque traccia di lui, solida, materiale, come se la materia, l’oggetto, potessero trattenere una parte delle sue emozioni, o della sua arte. D’altra è lo stesso Proust che, in una pagina di Swann, trova “ragionevole la credenza celtica secondo la quale le anime di coloro che abbiamo perduto sono imprigionate in qualche essere inferiore, un animale, un vegetale, un oggetto inanimato, perdute davvero per noi fino al giorno, che per molti non arriva mai, nel quale ci troviamo a passare accanto a un albero o a entrare in possesso dell’oggetto che ne costituisce la prigione. Esse allora sussultano, ci chiamano e non appena le abbiamo riconosciute, l’incantesimo si spezza. Liberate da noi, hanno vinto la morte e tornano a vivere con noi.”
L’idea è venuta a Lorenza Foschini – esperta e appassionata di Proust – durante un’intervista al costumista di Luchino Visconti, Piero Tosi, inviato a Parigi nei primi anni ’70 dal regista per alcuni sopralluoghi in vista di un possibile film sulla Ricerca (mai realizzato, forse irrealizzabile). Tosi incontrò vari personaggi che avevano conosciuto lo scrittore, finché gli fu dato il biglietto da visita di un collezionista che possedeva molti oggetti, manoscritti, libri autografati . E qui, nella villa di Jacques Guérin, industriale dei profumi, bibliofilo, inizia l’avventura. L’autrice si mette sulle tracce del collezionista, che è sulle tracce di Proust, alla ricerca continua, tenace, di oggetti, di reliquie. Tutto ha inizio con una malattia: Guérin, a Parigi, nell’estate del 1929 ha un attacco di appendicite. A operarlo arriva un famoso chirurgo, il dottor Robert Proust, fratello minore di Marcel. Il fratello rimosso, di lui non c’è traccia nella Ricerca. Proust è morto da sette anni, ma è già un mito. E quando Guérin va a casa del medico, per ringraziarlo, e per pagarlo, come si usava all’epoca, questi gli mostra i mobili che erano appartenuti al fratello: un tavolo e una libreria di legno scuro, quasi nero, pesanti, tetri. Apre gli sportelli e uno spettacolo grandioso abbaglia il collezionista Guérin: i quaderni originali della Ricerca, accatastati sugli scaffali. Guérin li sfoglia, colmo di emozione, e arriva all’ultimo, quello con la parola “fine.”
Da quel giorno inizia il suo viaggio, la sua missione: trovare, ovunque siano, pagandoli qualunque prezzo, i suoi oggetti, i suoi biglietti, le lettere, per salvarli dai traslochi, e dalla furia incendiaria della vedova di Robert, che, rimasta sola, infelice e in difficoltà economiche, vuole sbarazzarsi di quel materiale bizzarro e “sconveniente”. Calata nella sua educazione borghese, prigioniera delle rigide convenzioni della sua epoca, strappa le pagine dei libri con le dediche di Proust, perché non vuole che il suo cognome circoli in ambienti peccaminosi e svergognati, gli ambienti che frequentava quel “tipo eccentrico” del fratello di suo marito. Guérin riesce a comprare libri, foglietti sparsi, lettere, ma una quantità incalcolabile di documenti è andata perduta. Riesce a comprare anche i mobili, e in un locale del suo appartamento ricompone la stanza dello scrittore, una sorta di museo privato. Ricostruisce un pezzo del suo ambiente, dove il ricordo di Proust – il suo avatar, diremmo oggi – possa rivivere.
Ma Guérin non si dà pace. Deve esistere qualche oggetto che è sfuggito alla sua ricerca, altri quaderni, altre lettere. Va ai funerali degli ultimi parenti e amici, fa domande, indaga, cerca indizi, si mimetizza, come un predatore. Finché, un giorno come tanti in cui martella di domande il rigattiere che ha curato la vendita dei beni di Marcel per conto della cognata, questi gli rivela, con un certo imbarazzo, che qualcosa ci sarebbe, ma forse non è il caso… Guérin immediatamente si eccita, insiste. Ci sarebbe, dice il rigattiere, un indumento, un vecchio cappotto: “A me piace la pesca e così ogni domenica vado sulla Marna, dove ho una barca. Madame Proust che è così buona un giorno mi ha detto: ‘Voi siete pazzo a prendere tanto freddo con quella umidità del fiume. Tenete il cappotto di Marcel e avvolgetevelo intorno alle gambe’. E vi confesso che da allora lo arrotolo attorno ai miei piedi.”
E’ l’ultima reliquia. Guérin entra in possesso del vecchio, leggendario cappotto, sdrucito dall’umidità, crivellato dai tarli, coi bottoni spostati, buttato in un ripostiglio. Lo fa lavare, restaurare, gli costruisce una cassa per riporlo, e lo sistema nella camera di Marcel, in casa sua.
E qui andiamo all’inizio del libro, con Lorenza Foschini che fa aprire una scatola di cartone con la scritta Manteau de Proust dal direttore del Museo Carnavalet, a Parigi, dove è finito – insieme ai mobili – dopo la morte di Guérin, e guarda, tocca, accarezza il cappotto di Marcel Proust.
Il Cappotto di Proust è un libro è interessante, scritto con stile piacevole che sembra fondere la narrativa con la saggistica e la nostalgia. L’autrice indaga sull’investigatore, caccia il cacciatore, e descrivendo, con precisione chirurgica, l’amore quasi morboso del collezionista per lo scrittore, fa filtrare il suo amore, la sua ammirazione e la sua attrazione, sia per Marcel, che vediamo in varie scenografie della sua vita privata, con riferimenti a fatti e personaggi che sono transitati nella Ricerca, e Guérin, quest’uomo bello, colto, tenace, spinto da una forza quasi demoniaca verso gli oggetti del suo desiderio solitario.
Anche il backstage della pubblicazione è interessante. Stampato di soppiatto per un pubblico di nicchia, in Italia e in Francia, il maître Pierre Assouline scrive un pezzo lusinghiero su “Le Monde” che fa scattare la curiosità degli ambienti proustiani esclusivi, come Les amis de Combray. Poi, come talvolta accade, inizia a finire nelle mani giuste nei momenti giusti. A Procida, dove la Foschini ha una casa, viene diffuso in un’edicola-tabaccheria e suscita l’interesse di una regista francese, che lo compra, lo spedisce a Eric Karpeles, pittore e critico americano ottimo conoscitore di Proust, che lo passa alla leggendaria agente letteraria newyorkese Ellen Levine. A questo punto nulla sembra più in grado di fermare la forza di penetrazione del minuscolo libro. La Levine arruola la Foschini e organizza un’asta fra tre editori. Harper-Collins si aggiudica i diritti e lo pubblicherà nell’agosto del 2010; poi lo pubblicherà Portobello, per tutti i paesi angolofoni, e sono in atto trattative con la Spagna e la Germania. E in Francia ci penserà un altro editore, dopo che, come racconta la giornalista dell’Espresso Denise Pardo, un austero signore con una folta chioma bianca, durante una cena chiede alla Foschini: “Mi dica, madame, il nome della nonna del protagonista della Ricerca.” Domanda insidiosa. Provi, un lettore di Proust a rispondere. Il Narratore la nomina, credo, una sola volta. Ma Lorenza Foschini La Ricerca la conosce bene, e risponde, senza esitare: “Si chiama Bathilde, monsieur”. Risposta esatta. Quel signore era Jean-Paul Enthoven, ex fidanzato di Carla Bruni, che diventerà poi suo suocero naturale, visto che la Bruni farà un figlio con suo figlio Raphael, nonché direttore editoriale delle Edition Grasset, che fu il primo editore di Marcel Proust.
I commenti a questo post sono chiusi

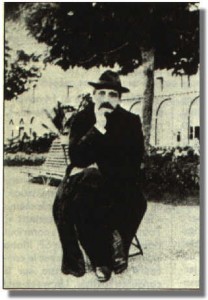

Sinceramente non ho mi capito il feticismo che porta taluni ad adorare ed inseguire sputacchiere e serviziali, pancere e pedalini degli scrittori famosi. L’ozioso snobismo di molti ‘proustiani’, poi, raggiunge punte davvero irritanti. Con tutto il rispetto per questo articolo che è anche scritto in modo intelligente. Mah.
Ma perchè mai il pover’uomo malato d’asma avrebbe “sfumature dark”?
L’abusato aggettivo albionico cosa diavolo c’entra?
E la “scena mitica” verso la fine sarebbe come dicono le ragazzette ai concerti di Giggi D’alessio MIITICOOOOOOOOOOOOOOOO?!
Per l’approccio necrofilo alle vite degli scrittori e l’idolatria dei loro oggetti:
Michele Mari
da “Tutto il ferro della Torre Eiffel”
Einaudi, 2002
“Combray non si chiama Combray ma Illiers: oggi però i cartelli stradali e le guide lo designano per Illiers-Combray. Quivi, un museo intitolato a Marcel Proust: otto sale di prime edizioni, fotografie, calamai, flaconi di pastiglie per l’asma, giacche da camera, fazzoletti cifrati, canne da passeggio, ricco materiale tuttavia svalutato dalla sua stessa collocazione, che distendendosi dalla seconda all’ultima sala lo fa successivo all’unico oggetto presente nella prima sala, in una teca di plexiglas cm 35x20x25: la madeleine.
Nei primi anni del museo la madeleine era di autentica frolla: ad essa provvedeva il custode, che ogni lunedì mattina apriva la teca, rimuoveva il biscotto e lo sostituiva con uno fresco. Cosa poi il custode facesse del vecchio non è dato sapere: è verosimile lo mangiasse, non per questo deducendone alla crassità dei suoi lobi illuminazioni mnemoniche. La sostituzione settimanale della madeleine era dovuta alta sua impossibilità di indurirsi seccando: anzi come porosa e burrosa l’instabile pasta tendeva a disgregarsi perdendo dopo una dozzina di giorni uno spolviglio di forfora rancia, cui si aggiungevano più cospicui frammenti se qualcuno urtasse la teca. Il direttore del museo aveva chiesto al pasticcere di mettere più burro nell’impasto, ma l’esito non era stato buono: concotto dal calore degli interni faretti, quel sovrappiù di manteca allargava ben presto nella superficie spugnosa della madeleine fiori brunastri che le davano un incongruo aspetto leopardato: quando non evocassero la sofferenza della foglia di vite arrugginita dalla peronòspora. A non dir delle camole e dei piccoli vermi che, a dispetto di ogni ermetismo, nascevano sponte nella pasta rafferma: uscendone poi per darsi all’avventurosa esplorazione del loro tabernacolo-mondo, come a irridere ancora, i putrigeniti, alle positive dimostrazioni di Spallanzani e Pasteur.
Cosi il custode sostituiva, e continuò a sostituire fino al giorno in cui andò in pensione. Quello stesso giorno il direttore si trovò ad affrontare un problema sindacale. Il nuovo custode fece notare che il proprio mansionario non prevedeva quella speciale corvée, e che se proprio si doveva, gli fosse pagata a parte. Uomo puntiglioso, il direttore non volle sottostare: onde, dopo aver lasciato invecchiare quell’ultima madeleine ben oltre i limiti tollerabili, elaborò la soluzione che vige tuttora. Fu cosi che, commissionata a un laboratorio di giocattoli di Rouen, venne acquisita al museo una madeleine di plastica: un’imitazione perfetta, non fosse per il segno della saldatura fra le due valve della conchiglia-biscotto: secondo infallibile legge del PVC.
Tu la vedi, questa cosa, e ridi: ma è un pianto; e dici: se la letteratura genera questo, è questo, la letteratura. Ed è la vendetta del mondo, perché la letteratura che non si difenda dal mondo cos’è, se non mondo? E il mondo è qui polimero fuso: ma fuso a forma di letteratura, così, volessimo uscire, sappiamo che non si può, nemmeno ogni tanto.”
Proust ha esaltato la bellezza poetica di un luogo ( in particolare il fiore centro raggiante del ricordo), dell’invisibile, della percezione. La prima parte evoca il luogo stretto della camera, punto di partenza verso il ricordo che dà uno spazio immenso. La scrittura sentita come giardino
sensuale, quando il corpo soffre, la respirazione manca. Con la scrittura
si delinea un quadro che supera la realtà: i frammenti del mare o di una piazza a Venezia sono cangianti, entrano nella camera, come i fantasmi della madre o della nonna.
Mi sono incantata dalle prime pagine. Il bacio aspettato dalla madre mi ha conquistato il cuore. La lettura di Proust è diversa per ciascuno. Non ho tutto letto, nemmeno nell’ordine.
Per parlare dell’oggetto, traccia della presenza, mi pare magico. Si immagina che l’oggetto ha accaturato una forma della presenza,
ha assorto la vibrazione di una mano o la profondità di uno sguardo.
Senza parlare di feticismo, direi un’attrazione …
articolo simpatico
non sapevo della Foschini
ma di Karpeles http://www.erickarpeles.com/
e del suo libro molto molto bello
Sul presunto feticismo di alcuni appassionati di scrittori, ma non solo, in parte è lo stesso Proust che risponde, nel passo che ho campionato: un caricare gli oggetti di significati, di segni, come se conservassero tracce o essenze della personalità di chi li ha posseduti. Il senso mi sembra proprio questo, il significato di “possesso”.
Poi: un’opera che il suo traduttore Raboni ha definito “una discesa agli inferi”, e l’autore – che è parte di essa come un tutto organico – definito tra l’altro “l’angelo della notte” o “angelo notturno” (Giovanni Macchia), sarebbe esente da sfumature dark. Bene, questioni di opinioni direi. E la scena di Saint Loup che balza sui tavolini e corre a prendere il cappotto per l’amico infreddolito non ha nulla di mitico. Beniamino – intanto ti ringrazio per il passo che hai riportato – tu non credi all’esistenza del “mitico”, e non sarò certo io a contraddirti.
Grazie anche a Véronique e Robin –
Un grazie a Mauro.
ero d’accordissimo con fabrizio finché non ho letto il libro.
la storia della madeleine al museo nel bel libro di mari è divertente e sagace. Resta il fatto che, per chi esce dalla recherche, nel nome Illiers-Combray è il primo a non esistere, non il secondo. Il che forse dovrebbe far desistere dal visitarla, questo ci sta. Ma pure…
Segnalo un filmato (in tre parti) sul mondo di Proust, con molte immagini e testimonianze, tra cui Céleste, Mauriac e Cocteeau, realizzato a cura di Attilio Bertolucci:
http://www.youtube.com/watch?v=-VMQYjA5nBc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iBsqX992NZM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dnG2avgBnCw&feature=related
Grazie Mauro: è une bello regalo!
Caro Mauro, bell’approfondimento il suo articolo, e grazie per aver citato Portaparole, tuttavia, la prego non mi giudichi antipatica, le segnalo che in italiano non si usa Ricerca per riferirsi a Alla ricerca del tempo perduto, ma Recherche, come in francese. Le perdono più volentieri le altre tante imprecisioni presenti in questo articolo perché sono retaggio dell’articolo dell’Expresso.
Cordialmente, Emilia Aru