di Davide Orecchio

“C’era un uomo coi capelli rossi, che non aveva né occhi né orecchie. Non aveva neppure i capelli, quindi dicevano che aveva i capelli rossi tanto per dire. Non poteva parlare, perché non aveva la bocca. Non aveva neanche il naso. Non aveva né braccia né gambe. Non aveva neanche la pancia, non aveva la schiena, non aveva la spina dorsale, non aveva le interiora. Non c’era nulla! Insomma, non sappiamo nemmeno di chi stiamo parlando. Meglio non parlare di lui mai più”. – Daniil Charms
Molti anni fa. Pochi anni fa. Conoscevo uno scrittore italiano.
Se non fosse stato italiano, lo scrittore che io conoscevo, potrei dire della sua altezza media, dei suoi capelli soffici e neri, della sua lieve miopia. E che portava gli occhiali di John Lennon: rotondi, dorati, sottili. E che indossava felpe di cotone e pantaloni larghi. E giacche di velluto. E che mangiava kebab. E che non era interessato alle cose attuali della vita, alla cronaca, ai fatti e ai misfatti. E che amava i libri. E che cercava la vita nei libri.
Molti anni fa. Pochi anni fa. Conoscevo quindi anche un lettore. E se fosse stato solo un lettore, colui che io conoscevo, potrei dire della sua grandezza. Aristocratica. Perché molti anni fa, pochi anni fa, oggi: ciascun lettore che è solo un lettore, che non vuol essere altro, ha una grandezza. Aristocratica. Una libertà. Una completezza. Ed è raro. Ed è pregiato.
Ma lui, che io conoscevo, non era solo un lettore, era anche uno scrittore, era solo uno scrittore italiano e dunque dovrò dire che non era né alto né basso né di altezza media. Che non aveva capelli. Che non aveva occhi né occhiali. Che era nudo. Che non vestiva alcun abito. Che non mangiava. Che non beveva. Che era invisibile. Che nessuno aspettava la sua scrittura: non per un giorno, non per un mese, non per vent’anni. Che a nessuno interessavano le sue correzioni, i suoi progressi, le prime stesure, le seconde stesure. Che nessun editore gli versava anticipi e attendeva consegne da lui.
Non per un giorno, non per un mese, non per vent’anni.
Molti anni fa, pochi anni fa, oggi, nel nostro tempo questo scrittore italiano non aveva le mani per digitare sui tasti e non arrivava all’altezza del tavolo e, privo di un corpo, non poteva sedere, accendere, guardare, correggere, moltiplicare le pagine, mettere al mondo capitoli, diventare nonno di paragrafi, zio delle digressioni, bisnonno di indici e ringraziamenti.
Non per un giorno, non per un mese, non per vent’anni.
Ma c’era la casa. Lo scrittore per sua fortuna aveva una casa. Piena di libri, questa era davvero la casa ideale per un lettore, e per lo scrittore. I libri erano migliaia ed erano creature che si offrivano come in un parco di giochi (sali sulla mia giostra), o come in un quartiere a luci rosse (scegli me, vieni a divertirti). La casa era la madre dei libri, o forse la ruffiana, e li conosceva tutti e nella casa lo scrittore non era invisibile. Nella casa lo scrittore aveva gli occhi, gli occhiali, l’altezza media, le mani per scrivere, le dita per accendere il computer, la forza di mettere al mondo capitoli, diventare nonno di paragrafi, zio delle digressioni, bisnonno di indici e ringraziamenti.
E aveva i libri.
Alcuni li portò lo scrittore. Altri già erano nella casa, i più misteriosi: perché erano vecchi, più vecchi dello scrittore, perché erano nati prima di lui e avevano polvere, odore antico, un colore giallo di fossile, benda di mummia. Lo scrittore, che abitava la casa da sempre, si fidava di lei, la notte si addormentava sereno dentro di lei, non temeva spettri né fantasmi e nessuna imboscata nei corridoi fitti di scaffali e volumi. Ogni tanto prendeva un libro, lo leggeva e qualcosa di lui cambiava. Questa era la scrittura del mondo. E il mondo entrava nello scrittore.
Ma lui cercava una voce. Molti anni fa. Pochi anni fa. Prima ancora che io lo conoscessi. Lo scrittore era stato giovane. E aveva iniziato a cercare una voce. Questa voce, pensava lo scrittore, un giorno verrà fuori e sarà solo mia, inconfondibile, forse roca, forse acuta, ad alcuni piacerà, ad altri farà schifo, ma sarà pur sempre la mia voce e io non sarò più invisibile. Nel frattempo lui esercitava la voce. Perché aveva i libri per esercitarsi.
Lesse Carver e iniziò a scrivere frasi brevi per racconti concisi. Lesse Proust e per imitarlo si perse in un proprio journal intime di periodi incatenati. Erano solo stagioni della sua scrittura. Mentre cercava una voce. Esercitava lo stile. Non sapeva chi fosse. Rubava agli altri lo stile. Si infilava in un ventriloquio di stile. Erano solo stagioni. Molti anni fa. Pochi anni fa. Della sua scrittura. Lo scrittore ne usciva sempre. Lasciava Proust alle spalle. Lasciava Carver alle spalle. E andava avanti.
Finché da uno scaffale, una notte, tirò giù un libro.
E tutto, all’improvviso, cambiò1.
La copertina del libro era una cornice di blu. Il libro era enorme. Il libro contava più di mille pagine. Eppure lui non si scoraggiò, decise di leggerlo, aprì la prima pagina e il sole tramontò quattro volte sulla sua lettura e alla fine del quarto giorno e della quarta notte lo scrittore italiano che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, era diventato un marinaio, anzi un nocchiero, e viaggiava nel paese delle Femmine, e solcava i mari dello scill’e cariddi e il sole lo aveva raggiunto
«COL SUO FREDDO RIFLESSO DI MORTE. DALLE ISOLE, E OLTRE, DA GIBILTERRA, LA SUA LUCE RASENTE AL MARE APPRODAVA UN’ULTIMA VOLTA A QUELLA RIVA, SENZA PIÙ PESO NÉ FULGORE, E PIGLIAVA A SALIRE, OSCURANDO PER LA SPIAGGIA E LA PLAIA: DIETRO, FRA IMPROVVISE SERPENTINE, BIANCHE E ROSSE, DI FIAMMA, SI FACEVA VIAVIA L’OMBRA, COME SE GLI ULTIMI RAGGI SI CONSUMASSERO DA SOLI IN UN GUIZZO, RIDUCENDOSI IN CENERE E CARBONELLA, CONFUSI AI GRANELLI DI SABBIA».
E lui leggeva, viveva, s’inoltrava nel viaggio, arrivò persino a «nuotare un bel pezzo fra tenebre e trasparenze azzurrastre, andando e venendo in giro fra gli scogli sabbiosi (…) in un silenzio senza schiume». Nuotava «il nuotare del pesce che nuota nel verso del pelo marino». Però lo scrittore, che adesso era un lettore, e che abitava una lingua potente, «gira gira, non si ritrovava, qualcosa gli sfuggiva sempre e questo qualcosa gli pareva di averlo sempre alle spalle e gli pareva per questo di inseguire se stesso».
Insomma era pieno di dubbi, ma senza il tempo di coltivarli perché già gli appariva l’orcaferone che intitolava il libro di polvere dalla cornice di blu, e questo «animalone» affiorò proprio tra lo scill’e cariddi che lui andava leggendo, e aveva una «piagona sdilabbrata» il cui fetore raddoppiava nel sole e lui, lo scrittore che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, fece il gesto di turarsi il naso mentre la bestia enorme, terribile «andava sfilando» «da mare a mare e nella gran solitudine dello scill’e cariddi, attorno alla sua mole gigantesca, attorno alla sua sagoma tenebrosa e rabbrividente» e «sembrava spirare un alone di spaventevole fatalità, come di essere fantastico e irraggiungibile» e lo scrittore – ormai un lettore – pensò – nella lingua che lo possedeva tutto, con le parole esatte del libro che diventavano anche sue proprie, anzi era lui che apparteneva a quelle parole – di assistere a «un essere dell’altromondo, per il quale vita e morte facevano una cosa sola, e lui aveva, contempo, tutte e due le cose insieme e nessuna delle due», e ascoltò poi «il fischio o sibilo, sgraziatissimo» dell’orcaferone che nel suo «massimo nuoto» gli passava accanto (a lui, allo scrittore che io conoscevo) e sfiatava, spruzzava, pigliava l’acqua «sfacciatamente». E si spaventò di quello che lesse e di quello che vide.
Al quinto giorno interruppe il libro. Si alzò dal letto. Accese il computer. Provò a scrivere ma non trovò più la sua voce. Trovò invece un pupazzo parlante. Il pupazzo parlava la lingua di Horcynus. Il pupazzo era lui. Legava i vocaboli in nuove parole. Lessicava in dialetto. Non faceva che nominare fere e femminote, e pellisquadre e femminotari, naviscuola porpose e uomini insoldatati e vermiditerra. E vedeva solo lo Stretto, e le isole, e l’isola grande, e i delfini feroci, e il più grande dei pesci, e non aveva più nomi se non quelli nominati da Horcynus, e non aveva più verbi se non quelli coniugati da Horcynus. E di nuovo si spaventò. Anche ai pupazzi capita di spaventarsi. Avrebbe potuto fare l’inchino come un gatto di legno. E, come un orsetto di pezza, avrebbe potuto, fino all’esaurirsi delle sue batterie, cantilenare il verdone che, «si sa, è lui il vero pellesquadra, lui è lo sguardo di nome e di fatto, lui è l’origine, pelle per squadrare, rasposa come la cartavetrata».
Allora spense il computer. Pupazzo horcynusorcizzato. Scrittore di una scrittura d’altri. Immaginatore di fantasie in prestito. Creatore di creature già create. Pensò: faccio ancora in tempo a salvarmi? E già correva al libro dalla cornice blu. E lo prendeva. E apriva un ripostiglio di cappotti e coperte. E ci seppelliva il libro di Horcynus. E chiudeva il ripostiglio. E chiudeva la stanza dov’era il ripostiglio. E andava lontano, nella casa, nel punto più distante dal ripostiglio. E pensava: forse mi sono salvato, adesso riprendo a parlare e vediamo se sono ancora un pupazzo.
Molti anni fa. Pochi anni. Lo scrittore che io conoscevo parlò e gli tornarono in bocca fere e femminote, e pellisquadre e femminotari, naviscuola porpose e uomini insoldatati e vermiditerra.
E gli tornò in bocca l’animalone.
Allora era finito. Era posseduto. Non aveva più la sua voce. Moriva la speranza di trovare una voce.
Moriva la speranza.
Ma da uno scaffale, a quel punto, cadde un libro. Questo volume s’intitolava Una storia di amore e di tenebra, ed era dell’israeliano Amos Oz. Il libro cadendo si aprì su una pagina. Lo scrittore che io conoscevo raccolse il libro e lesse la pagina, dove il padre di Oz (studioso di polvere, navigatore di tomi e biblioteche) raccontava questa storiella: “Se rubi la tua sapienza da un libro solo sei un ladro letterario. Un plagiatore. Ma se rubi a piene mani da cinque libri, non sei più un ladro bensì uno studioso, e se poi ti industri a saccheggiare da ben cinquanta libri, allora assurgi al grado di luminare”.
Adesso ho capito – esclamò lo scrittore rivolgendosi alla casa –, hai fatto cadere questo libro per mostrarmi la cura. Posso guarire da Horcynus solo con un altro libro e poi con un altro e un altro ancora. Centinaia di libri mi guariranno da Horcynus. Questo consiglia il padre di Amos Oz. Ma da dove iniziare? Io sto soffrendo. Cosa mi indichi?
E da un altro scaffale cadde un secondo libro. E lo scrittore che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, si precipitò a raccoglierlo e subito lesse e si ritrovò in una squadra che ‘era giunta ai piedi dell’ultimo pendio’ e vide che Johnny sospirava ‘al calvario che esso comportava: era così plasmato di fango lievitante che la superficie ne pulsava tutta. L’argilla bulicante aveva pochissimi, quasi ironici cespi di erba fradicia’. Attorno non c’era mare, non c’erano mostri marini, né fere né animaloni. C’era giusto Johnny con la sua squadra, Johnny che ‘prese ad inerpicarsi sui ginocchi, ancorandosi al fango con la mano libera; s’inerpicò e ricadde. Così gli uomini’, così lo scrittore che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, ‘l’angoscia strappando loro bestemmie ed insulti. In una scivolata si perdeva in un lampo quel che era costato minuti di penosa ascesa. Il ricadente precipitava su quello che saliva speranzoso, ed entrambi crollavano al fondo in un abbraccio di disperazione ed ingiurie’.
Al fianco dello scrittore che io conoscevo ‘JOHNNY GIACEVA A MEZZA COSTA, ANSANTE E PAZZAMENTE ASSETATO, IN QUELL’ORGIA D’ACQUA; ATTRAVERSO LE MANICHE IL FANGO GLI SI ERA INSINUATO FINO ALLE ASCELLE. SI VOLTÒ A GUARDARE DALLA PARTE DEL NEMICO; FRA UNA FASCIA DI VAPORI VIDE L’AVANGUARDIA FASCISTA A MEZZO CHILOMETRO (…) ALLORA SBATTÉ PIÙ SU LA MITRAGLIATRICE, COME UN TRAGUARDO EMBEDDED NEL FANGO, LA RAGGIUNSE SALENDO SUL VENTRE, LA RISBATTÉ PIÙ SU ED ANCORA LA RAGGIUNSE, FINCHÉ EMERSE, UNA STATUA DI FANGO, SUL CIGLIONE’.
Molti anni fa. Pochi anni fa. Conoscevo uno scrittore. Che si rivolse al partigiano Johnny e gli disse: io qui, su questa altura, sono felice al tuo fianco. Adoro la tua lingua di foresti, valli e macchioni. Adoro la tua browning. Il tuo fango. I tuoi altipiani. Partigiano Johnny. Qui ci sono solo fascisti. Uccidiamo fascisti. Questa è vita. Questa è lettura. Forse sono guarito. Guarda laggiù verso il campo nemico: se tutti dormono, possiamo attaccare, e possiamo vincere. Raggiungeremo il campo passando per il lago che l’affianca. Non hai visto quel lago? Non c’è nelle tue pagine? Vieni con me. Il lago esiste. Immergiamoci. Nessuno ci vede. Il nemico dorme. Saranno poche bracciate. L’acqua non è fredda. L’acqua è calma. L’acqua ci è amica.
Ma molti anni fa, pochi anni fa, lo scrittore che io conoscevo si sbagliava su tutto. Si sbagliava sull’acqua. Si sbagliava su Horcynus. Perché nell’acqua di quel lago, mentre il partigiano Johnny spariva, mentre lo scrittore avanzava in un nuoto sottomarino, all’improvviso, ancora una volta, riassommò l’orcaferone, persino nell’acqua dolce, «aggallando come d’abitudine, veniva ormai da dire, simile a un isolotto lavico in ebollizione, che raffreddandosi si mostrava ribellato, qua e là, da macchie di filamenti bianchi, striato d’argentature, di tenebrosi luccichii».
E mentre lo scrittore che io conoscevo lo seguiva in silenzio, attentissimo, «e lui si metteva a sfiatare l’acqua imbarcata, impalmandosi la testa con lo zampillo», molti anni fa, pochi anni fa, lo scrittore, «come non si potesse trattenere», come se gli venisse proprio dal cuore, gridò all’animalone: «anima pia, animona generosa e pia», sono ancora il tuo pupazzo, sono ancora prigioniero di Horcynus.
Molti anni fa. Pochi anni fa. Conoscevo uno scrittore. Che cercava una voce. Che perse la voce. Che si spaventò. Che lasciò il libro di Johnny. Che cadde sul pavimento della propria casa e le disse: non ha funzionato, sono perduto, tutto è perduto. Ma da un nuovo scaffale cadde un terzo libro, e poi ne cadde un quarto. E lo scrittore che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, si precipitò a raccoglierli e subito lesse e si ritrovò su un sentiero di nidi di ragno assieme a un bambino di nome Pin, e tutti e due, bambino e scrittore, camminavano << nel gracidare delle rane >> che << nasce da tutta l’ampia gola del cielo >>, e << il mare è una grande spada luccicante nel fondo della notte >>. Camminano assieme << per i campi coltivati a garofani e a calendule >>. Cercano di tenersi alti << sul declivio delle colline, per passare sopra alla zona dei Comandi >>.
Poi scenderanno al fossato. Questi sono i loro luoghi.
<< FRA GRANDI SASSI BIANCHI E IL FRUSCIARE CARTACEO DELLE CANNE. IN FONDO ALLE POZZE DORMONO LE ANGUILLE, LUNGHE QUANTO UN BRACCIO UMANO, CHE A TOGLIERE L’ACQUA SI POSSONO ACCHIAPPARE CON LE MANI. (…) ECCO IL BEUDO, ECCO LA SCORCIATOIA CON I NIDI >>.
Riconoscono le pietre. Dissotterrano una pistola. Poi, il bambino Pin e lo scrittore che io conoscevo, si addormentano. E al risveglio vedono << i ritagli di cielo tra i rami del bosco, chiari che quasi fa male guardarli. È giorno, un giorno sereno e libero con canti d’uccelli >>.
Sereno. Così si sentiva lo scrittore leggendo. Immerso in una scrittura rasserenante. Perspicua. Ragionevole. Non mostruosa. Rispettosa di lui. Una scrittura che non l’avrebbe mai potuto trasformare in pupazzo. Molti anni fa, pochi anni fa, lo scrittore che io conoscevo pensò che forse stava guarendo da Horcynus e prese l’altro libro e tutto andò sempre meglio intanto che lui viaggiava tra le città invisibili. Per un breve periodo visse a Sofronia, una città sottile che
<< SI COMPONE DI DUE MEZZE CITTÀ. IN UNA C’È IL GRANDE OTTOVOLANTE DALLE RIPIDE GOBBE, LA GIOSTRA CON LA RAGGIERA DI CATENE, LA RUOTA DELLE GABBIE GIREVOLI, IL POZZO DELLA MORTE COI MOTOCICLISTI A TESTA IN GIÙ, LA CUPOLA DEL CIRCO COL GRAPPOLO DEI TRAPEZI CHE PENDE IN MEZZO. L’ALTRA MEZZA CITTÀ È DI PIETRA E MARMO E CEMENTO, CON LA BANCA, GLI OPIFICI, I PALAZZI, IL MATTATOIO, LA SCUOLA E TUTTO IL RESTO. UNA DELLE MEZZE CITTÀ È FISSA, L’ALTRA È PROVVISORIA E QUANDO IL TEMPO DELLA SUA SOSTA È FINITO LA SCHIODANO, LA SMONTANO E LA PORTANO VIA, PER TRAPIANTARLA NEI TERRENI VAGHI D’UN’ALTRA MEZZA CITTÀ >>.
Proprio in questo intervallo lo scrittore che io conoscevo si stancò di Sofronia e decise di partire per Despina, << città di confine tra due deserti >>, città che si raggiunge in due modi: << per nave o per cammello >>, << e si presenta differente a chi viene da terra e a chi dal mare >>. Lo scrittore che io conoscevo, molti anni fa, pochi anni fa, decise di raggiungerla dal mare e, << nella foschia della costa >>, dal ponte del veliero, già gli sembrava di scorgere la gobba di un cammello, ossia la città di Despina.
Ma si sbagliava. Si sbagliava sull’acqua. Si sbagliava su Horcynus.
Al suo fianco, molti anni fa, pochi anni fa, c’era un marinaio. Viaggiava con lui. Lo scrittore però non s’era accorto di lui. Solo adesso lo vedeva. Studiò il suo profilo, il naso d’aquila, i capelli di corvo, e poi gli chiese: tu sei Calvino? E quello rispose: sono io, mentre tu sei un illuso.
Perché?, domandò lo scrittore che io conoscevo.
Perché non posso aiutarti, rispose Calvino, e tu non puoi fuggire da Horcynus.
Che vuoi dire? Io sono sereno nella tua scrittura. Raggiungeremo Despina. E poi un’altra città. Già si vede la costa.
Non è la costa che vedi, lo corresse Calvino. Quella gobba laggiù, che affiora dal mare, non è la città. Guarda bene. Cos’è che vedi? Non vedi?
Molti anni fa, pochi anni fa, lo scrittore che io conoscevo guardò meglio la gobba che affiorava dal mare. E iniziò a piangere. Senza rimedio. Perché vide che non era la gobba di un cammello, né quella di una città. Invece era il dorso di un animale che «brancolava ancora cieco e sonnoso, oscuro e inavvertito come tutti i cataclismi nelle loro sotterranee origini, quando non se ne ha ancora segno e sono già sotto i nostri piedi. La sua immensa mole» apparve «affusolata» allo scrittore che io conoscevo mentre «saliva preceduta dall’alta pinna dorsale ad ascia, come un sommergibile dal suo periscopio, e salendo, dalle bocchette dello sfiatatoio sprigionava un sibilo come di fuoco che va per acqua, di lava di vulcano che erutta dagli abissi e raffreddandosi, forma un isolotto in superficie. E qui, alla superficie, dall’apertura occhiuta dietro la grande testa incorporata, rigettava acqua soffiando come una tromba marina».
Era di nuovo il pupazzo, lo scrittore che io conoscevo. E la nave affondava. E Calvino annegava.
E l’animalone nuotava «sempre dov’era rema morta, come se lo attirassero acque d’abisso, fredde e ferme, in cui appiccionarsi senza temere sconzo. Era l’Orca, quella che dà morte, mentre lei passa per immortale: lei, la Morte marina, sarebbe a dire la Morte, in una parola».
Dava morte anche a lui, allo scrittore che molti anni fa, pochi anni fa, cercò una voce, e poi cercò scampo, e non lo trovò, e pianse, e nuotò nel suo pianto, e poi si stancò, e annegò nel suo vasto mare di pianto.
Ma, di nuovo nella casa, trovò l’ossigeno che serve per sopravvivere. Adesso sveglio. Rincasato. Risorto. Sconfitto. Horcynusorcizzato. Rimproverò la casa: non mi hai aiutato. Si alzò da terra. Raccolse i libri. Li chiuse. Li ripose negli scaffali. Molti anni fa, pochi anni fa, lo scrittore che io conoscevo liberò il libro di Horcynus dal ripostiglio, poi disse alla casa: è evidente, il padre di Amos Oz il libro di Horcynus non lo conosceva. Il suo consiglio dunque non vale. Cento libri non nascondono il libro dell’orca. Io invece, che lo conosco, mi sottometto al libro dell’orca. Non fuggo più.
Che sia fatta la sua volontà.
***
Le citazioni
Tra « … »: Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca.
Tra “ … ”: Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra.
Tra ‘ … ’: Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny.
Tra << … >>: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Le città invisibili.
Nota
1 «Nei racconti si trova spesso questo “all’improvviso”. Gli autori hanno ragione: la vita è così piena di cose inaspettate». Anton Čechov, La morte dell’impiegato.
Questo testo è un intervento tenuto al convegno «Horcynus Orca. Il quarantennale», 9-10 ottobre 2015, Arcinazzo romano -Trevi nel Lazio. Successivamente è stato pubblicato su «Lo Straniero», Aprile 2016 – N. 190.

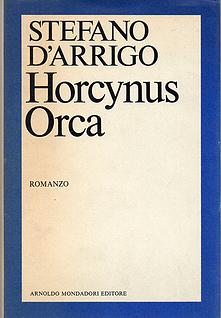
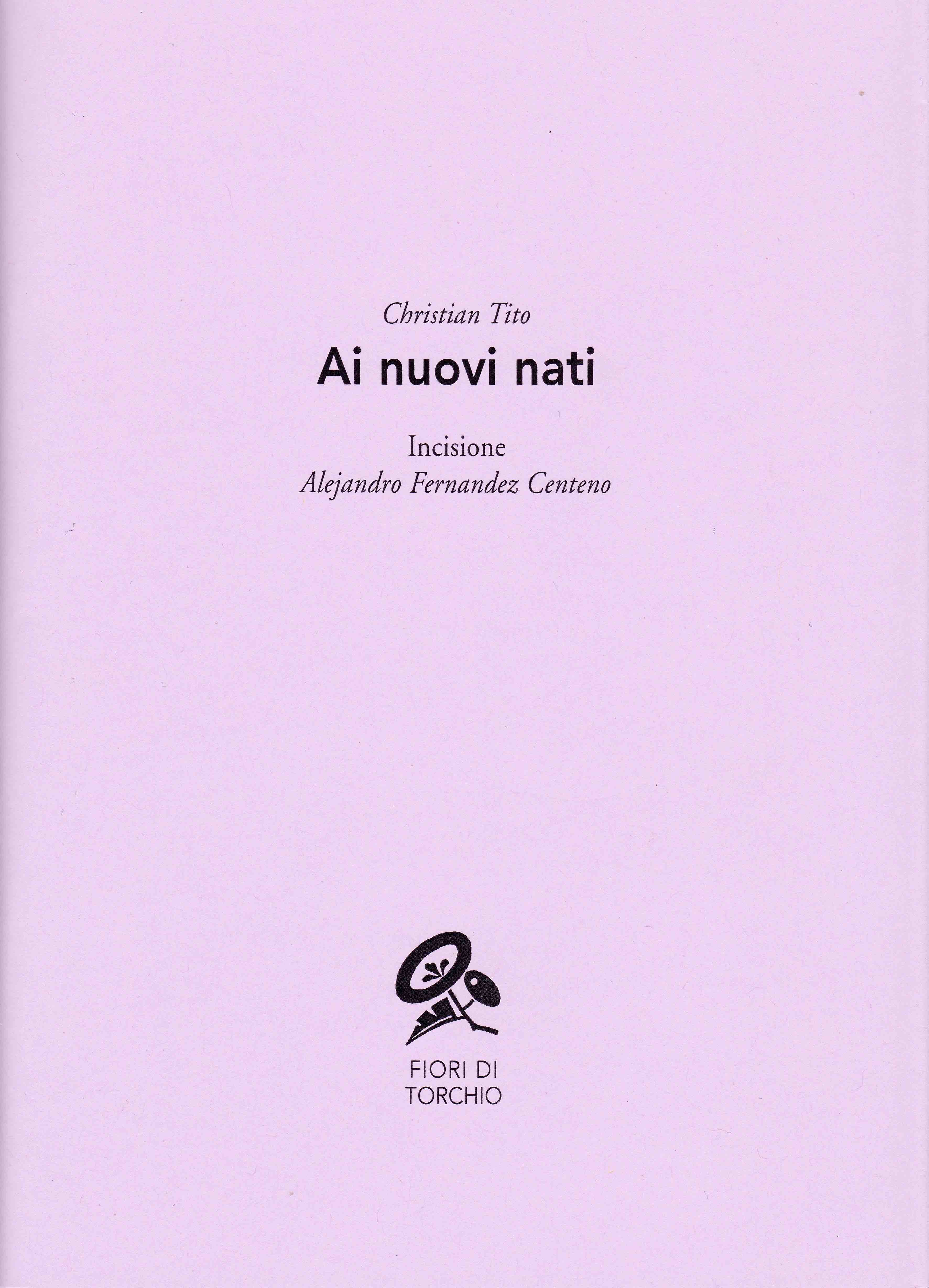




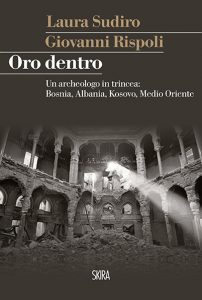 Oro dentro. Un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente è un libro che bisognava scrivere: Laura Sudiro e Giovanni Rispoli lo hanno fatto nel migliore dei modi. L’ ‘oro dentro’ del titolo è quello, metaforico, di chi ha il cuore abbastanza grande da spendere la propria vita per salvare un bene comune (proprio quel patrimonio culturale: e cioè la memoria e il futuro, di paesi in guerra). Ma è anche quello, purtroppo letterale, che l’uranio impoverito delle bombe Nato esplose in Kosovo ha fatto penetrare, insieme ad altri metalli, nel corpo in cui batteva quel cuore: fino a ucciderlo. Sono queste le due terribili facce della breve, ma meravigliosa, vita di Fabio Maniscalco.
Oro dentro. Un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente è un libro che bisognava scrivere: Laura Sudiro e Giovanni Rispoli lo hanno fatto nel migliore dei modi. L’ ‘oro dentro’ del titolo è quello, metaforico, di chi ha il cuore abbastanza grande da spendere la propria vita per salvare un bene comune (proprio quel patrimonio culturale: e cioè la memoria e il futuro, di paesi in guerra). Ma è anche quello, purtroppo letterale, che l’uranio impoverito delle bombe Nato esplose in Kosovo ha fatto penetrare, insieme ad altri metalli, nel corpo in cui batteva quel cuore: fino a ucciderlo. Sono queste le due terribili facce della breve, ma meravigliosa, vita di Fabio Maniscalco. Fabio cresce a Napoli, dove la progressiva distruzione del patrimonio artistico pare – come molte altre cose – fatale, irreversibile, immutabile. Se crolla un Lungarno nella mia Firenze (giustamente) il mondo tiene il fiato sospeso: ma se l’ennesima chiesa storica della Napoli in cui ho scelto di insegnare sprofonda nell’ennesima voragine, la notizia non arriva nemmeno al telegiornale regionale. Non inganni la propaganda di Pompei che rinasce e della Reggia di Caserta che risplende: chiunque vive in Campania conosce il vero stato delle cose.
Fabio cresce a Napoli, dove la progressiva distruzione del patrimonio artistico pare – come molte altre cose – fatale, irreversibile, immutabile. Se crolla un Lungarno nella mia Firenze (giustamente) il mondo tiene il fiato sospeso: ma se l’ennesima chiesa storica della Napoli in cui ho scelto di insegnare sprofonda nell’ennesima voragine, la notizia non arriva nemmeno al telegiornale regionale. Non inganni la propaganda di Pompei che rinasce e della Reggia di Caserta che risplende: chiunque vive in Campania conosce il vero stato delle cose.






 La notte della pianura – di Orazio Labbate
La notte della pianura – di Orazio Labbate Nella città, la notte – di Mariasole Ariot
Nella città, la notte – di Mariasole Ariot
 A ognuno di questi poeti, Nicola Vacca regala un ritratto stringato ma sempre teso a cogliere l’essenziale delle loro formule, delle loro parole, delle loro esistenze. Se vogliamo indicare un filo rosso che lega i ventidue medaglioni, diremmo che la voce dei poeti prediletti dall’autore è quella che pone il verbo in “disarmonia con l’epoca” (per forzare una formula di Caproni il cui ritratto, forse non a caso, sta in apertura di volume).
A ognuno di questi poeti, Nicola Vacca regala un ritratto stringato ma sempre teso a cogliere l’essenziale delle loro formule, delle loro parole, delle loro esistenze. Se vogliamo indicare un filo rosso che lega i ventidue medaglioni, diremmo che la voce dei poeti prediletti dall’autore è quella che pone il verbo in “disarmonia con l’epoca” (per forzare una formula di Caproni il cui ritratto, forse non a caso, sta in apertura di volume). Esiste un modo incantevole di fare le parole. Proprio farle: giostrarle, accarezzarle, impastarle con le mani, sporcarsi con quelle fin sulla punta del naso per un gesto distratto; e odorarle così, come fossero un pasto allettante preparato con cura e poi offerto agli affetti più cari. Sono il prodotto di lettere ammonticchiate e vivaci che si incuneano tra i ricordi e l’esperienza, disegnando un luogo comune che funga da ritrovo per molti: sono una piccola cosa che per avere un senso vero e forte, deve conoscere la stretta buona dell’alleanza.
Esiste un modo incantevole di fare le parole. Proprio farle: giostrarle, accarezzarle, impastarle con le mani, sporcarsi con quelle fin sulla punta del naso per un gesto distratto; e odorarle così, come fossero un pasto allettante preparato con cura e poi offerto agli affetti più cari. Sono il prodotto di lettere ammonticchiate e vivaci che si incuneano tra i ricordi e l’esperienza, disegnando un luogo comune che funga da ritrovo per molti: sono una piccola cosa che per avere un senso vero e forte, deve conoscere la stretta buona dell’alleanza.


 Sciopero Sncf del 12 maggio. Manifestazione a Parigi, Montparnasse.
Sciopero Sncf del 12 maggio. Manifestazione a Parigi, Montparnasse.




