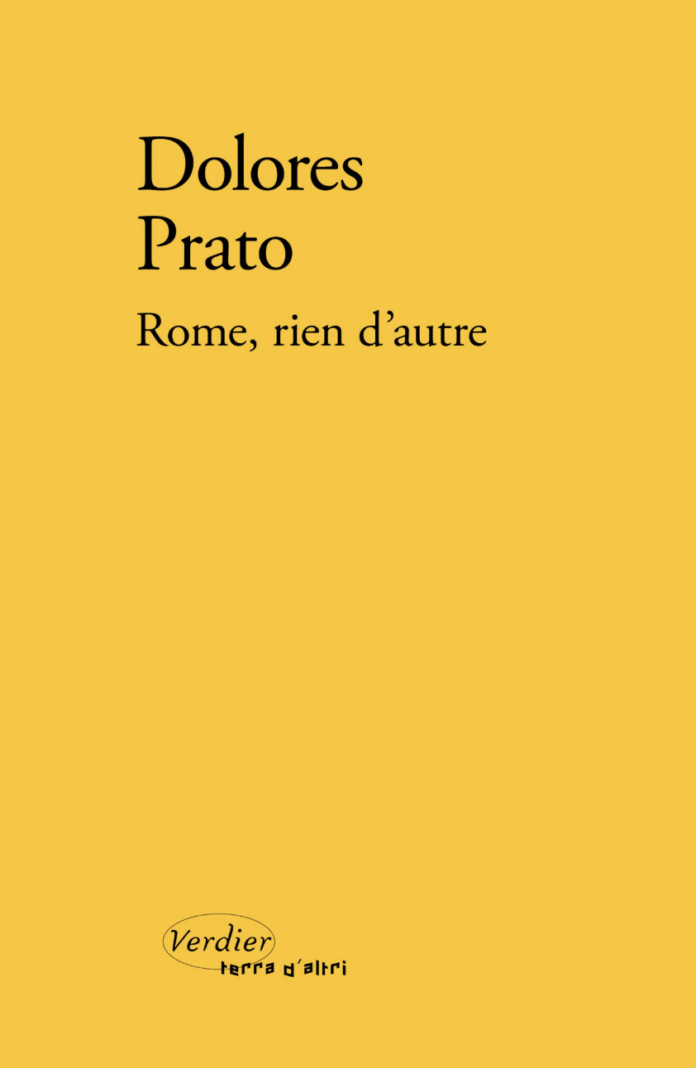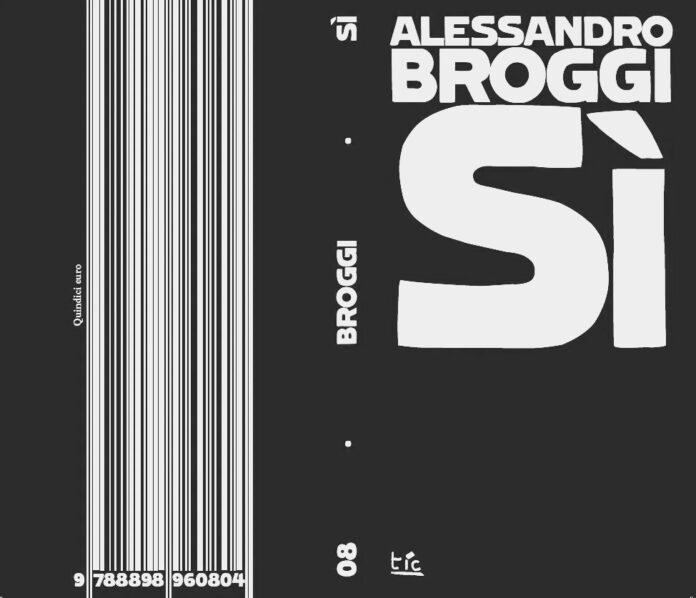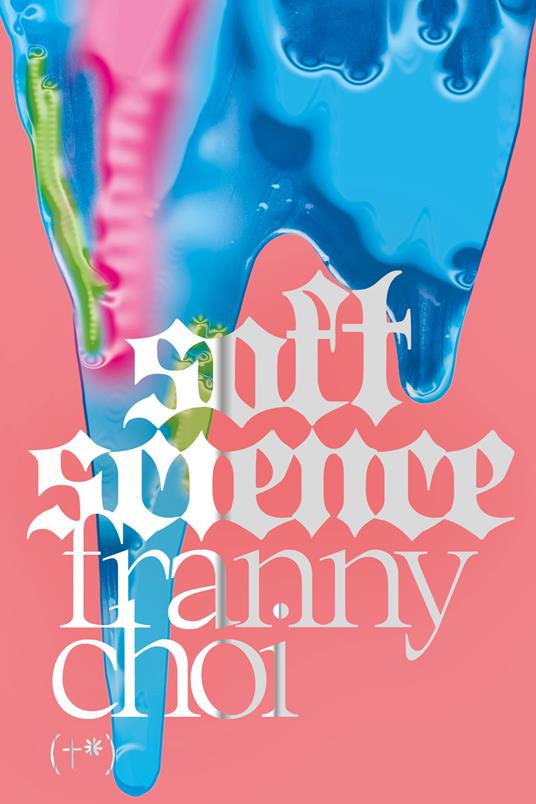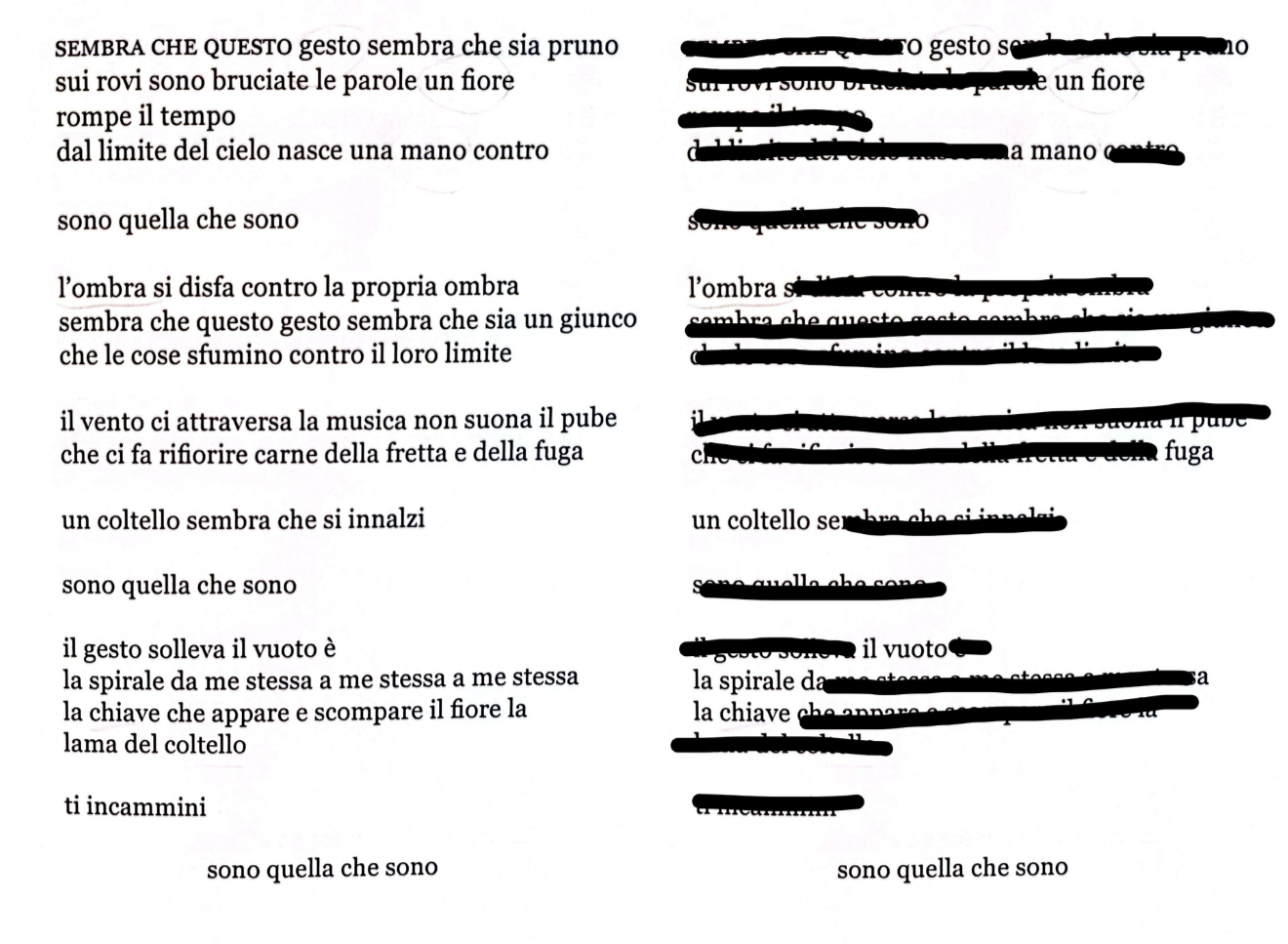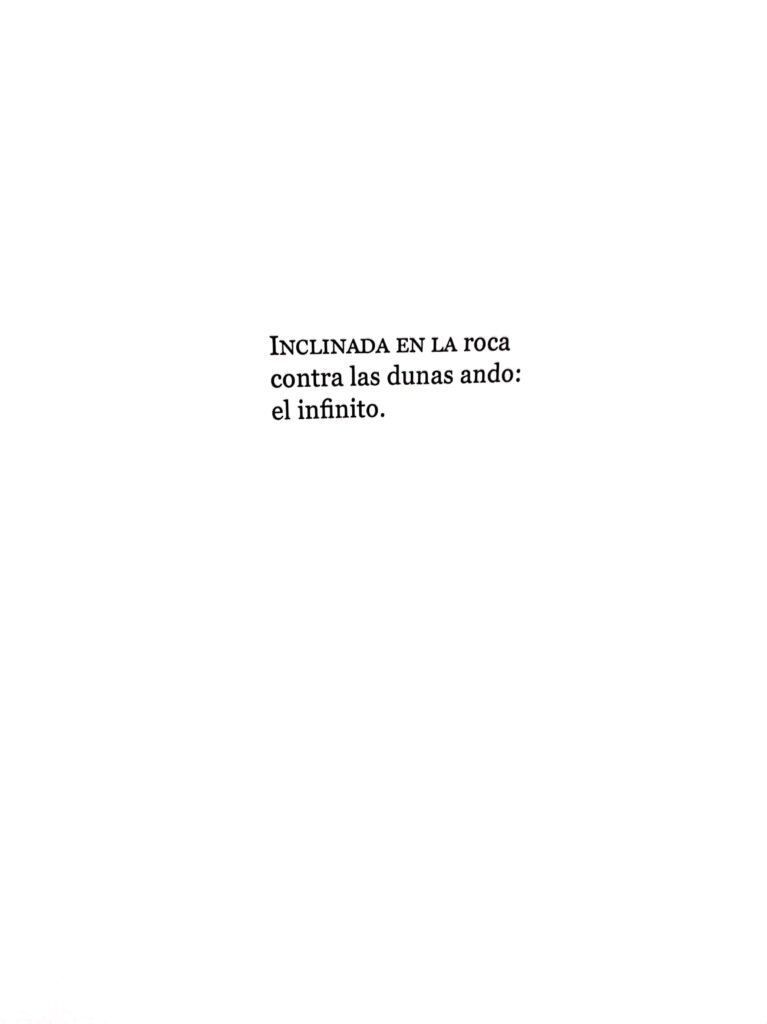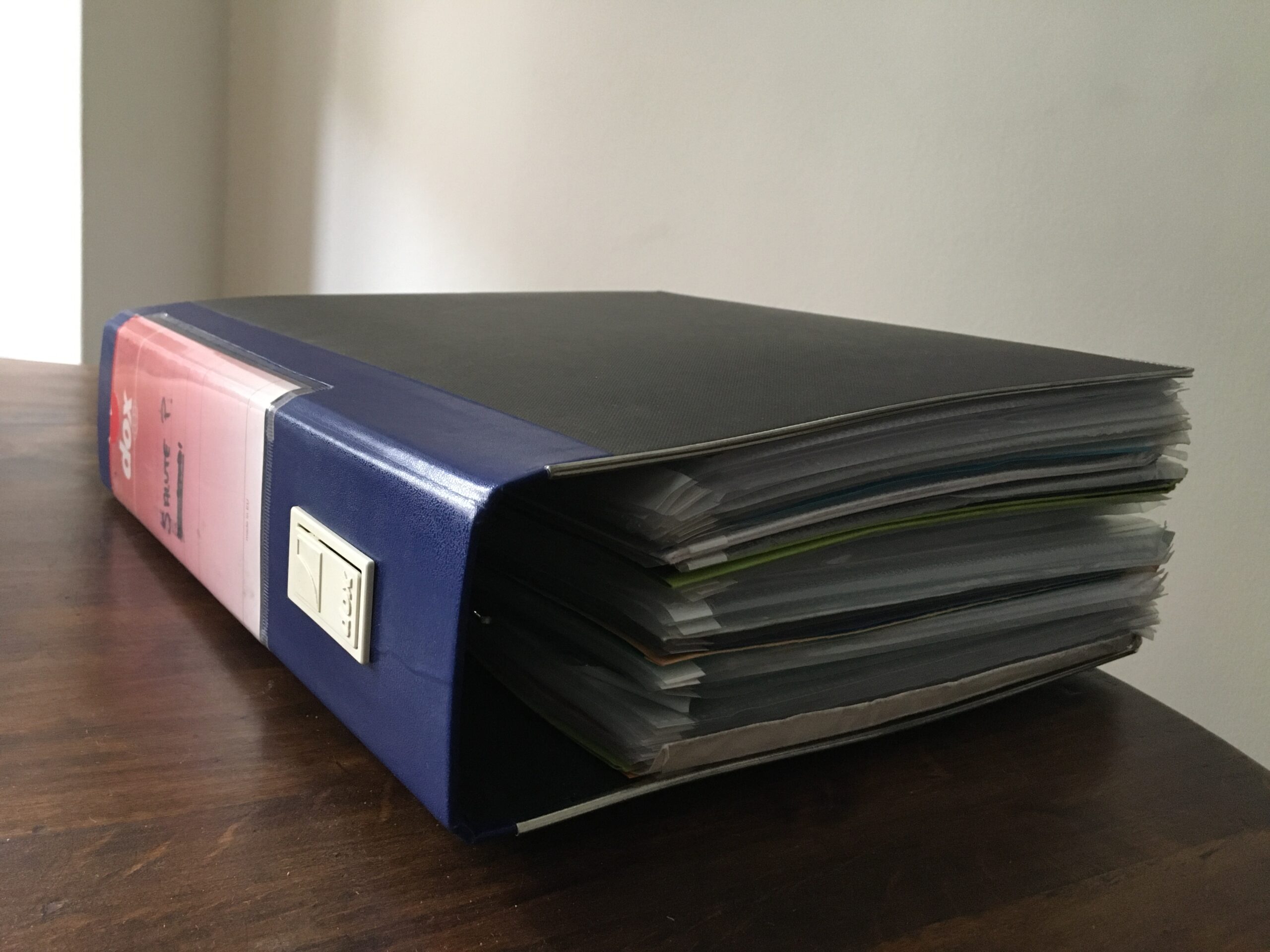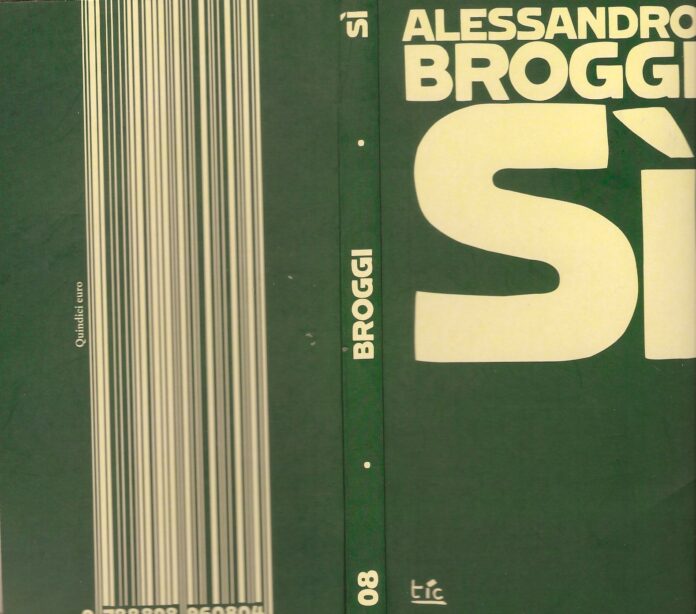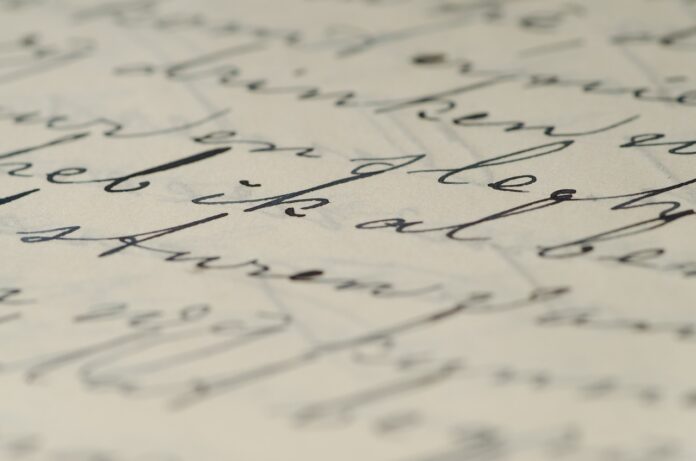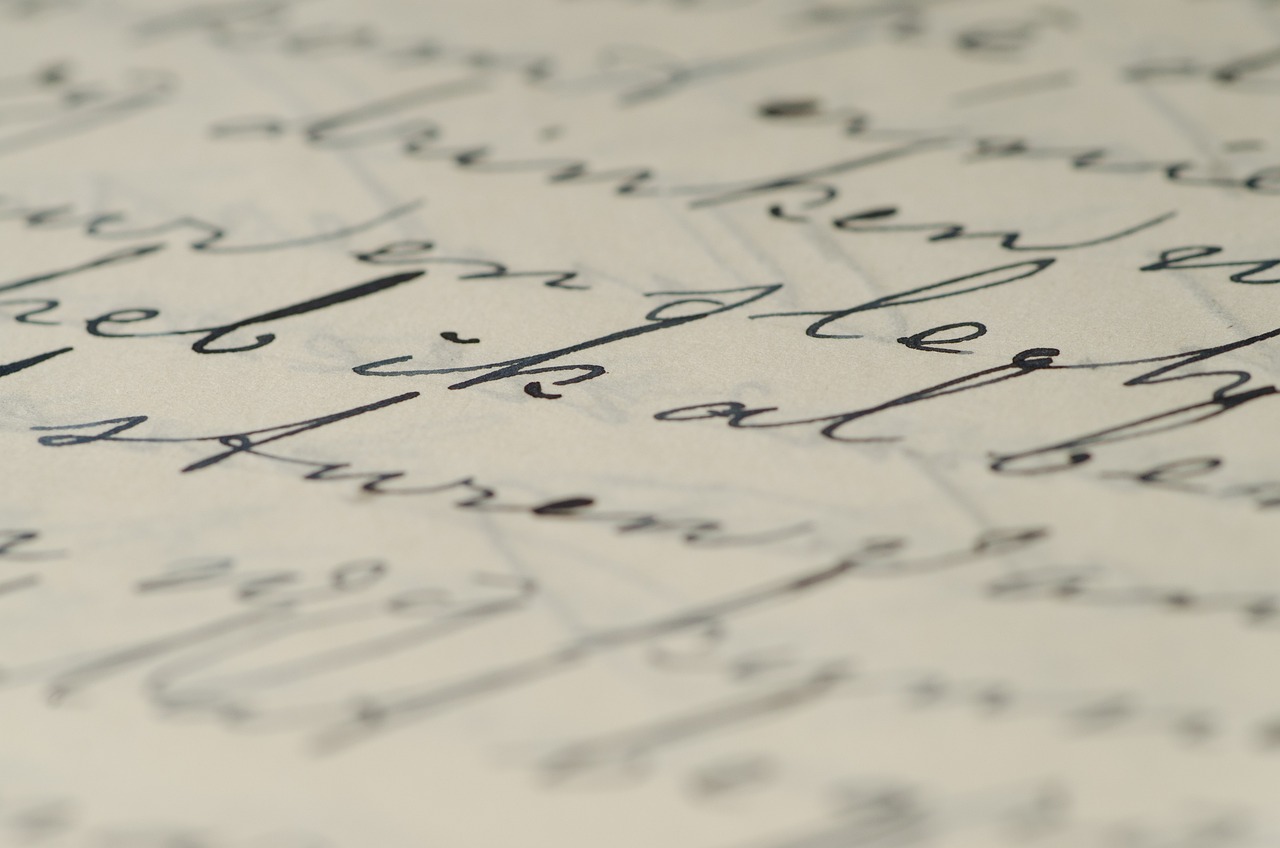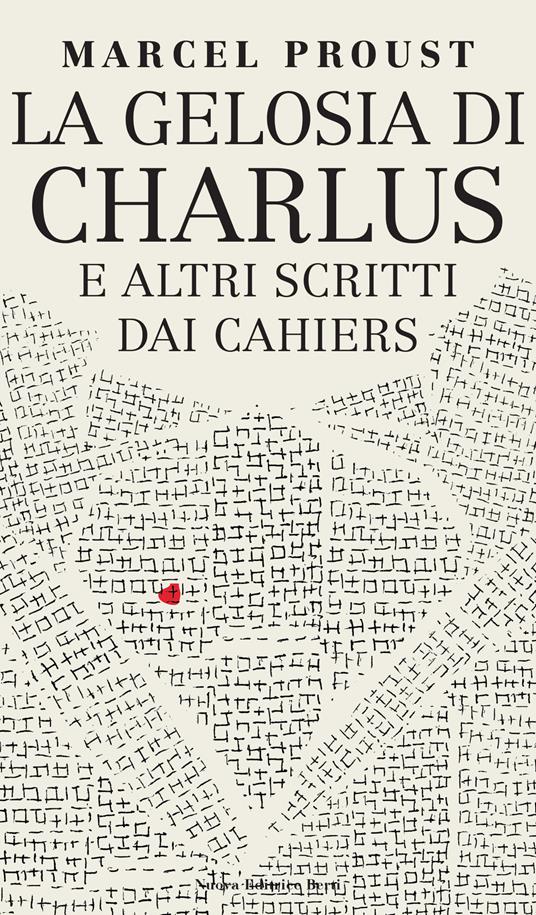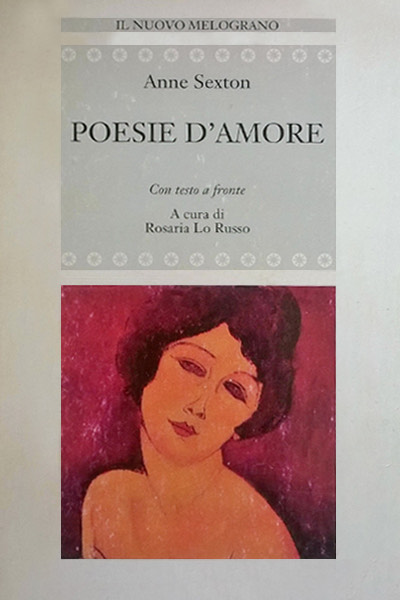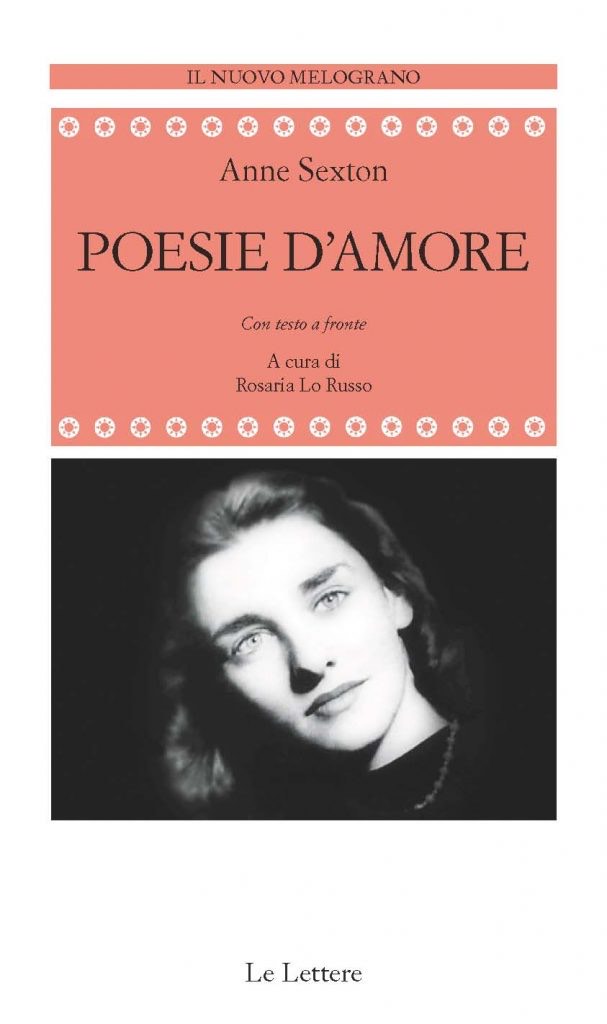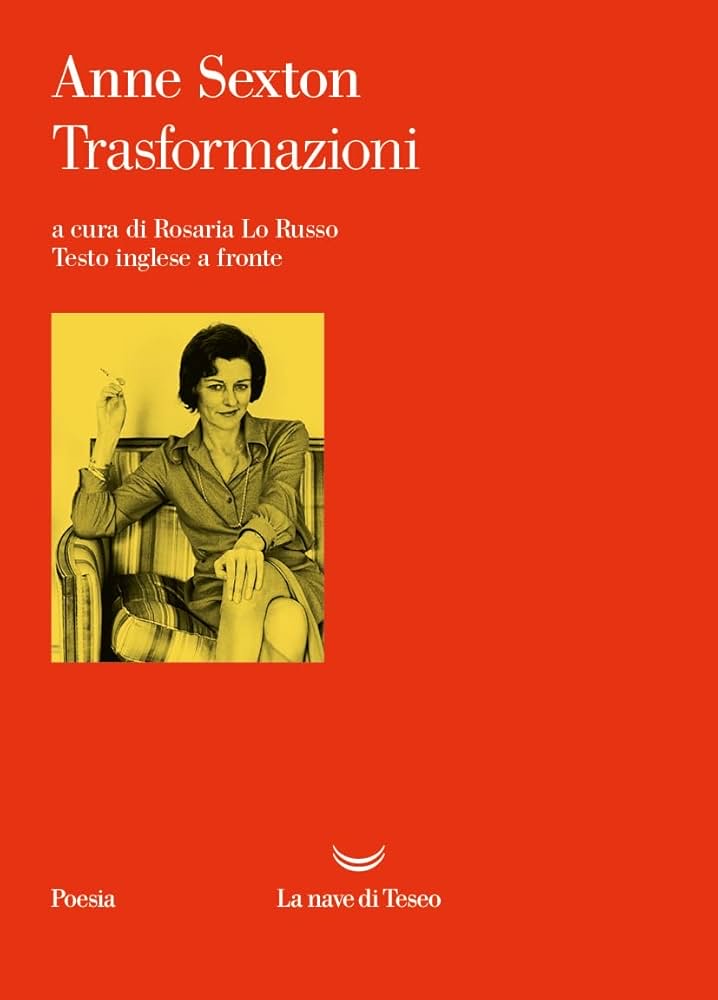Intervista di Elena Frontaloni
a Jean-Paul Manganaro

È uscito il 4 ottobre per Verdier Rome, rien d’autre, raccolta di elzeviri su Roma di Dolores Prato, a cura di Jean-Paul Manganaro e Laurent Lombard. Si tratta di scritture che, nel caso di Dolores Prato, non sono tanto d’occasione ma trovano in qualche evento d’attualità propizio l’occasione per sgorgare da appunti o progetti già abbozzati e che, tra l’altro, testimoniano un atteggiamento narrativo verso le fonti tipico dell’autrice: le raccoglie e fa finta di sperderle mentre in realtà le valorizza dentro racconti dal carattere «antico», in cui trovano veloce e meravigliato spazio saperi raffinatissimi, conflitti interpretativi insieme ad abbandoni voluti alla leggenda, alle personificazioni, alle paretimologie, così da manifestarsi come tratti di prosa fermati sulla carta per generare e rigenerare stupore su fatti all’apparenza bigi, o anche attenzione polemica su pensieri ricevuti e distruzioni inavvertite.
Se la morte di Dolores Prato ha impresso sulle sue carte una sorta di specializzazione dei due luoghi dentro sedi di scrittura dissimili – a Roma gli elzeviri e i progetti di pamphlet, a Treia le narrazioni, i lavori, i libri autobiografici (si legge nel racconto Una giornata di Dolores Prato, del 21 settembre 1978: «l’infanzia la passai a Treja e ora ci sto facendo un lavoro») –, vale la pena anche di ricordare che Giù la piazza non c’è nessuno filologicamente nasce dall’esplosione di un brogliaccio dal titolo E lui che c’entra? (1949) dove a un certo punto si parlava anche di Roma e, come urgenza di scrittura, dalla contestazione della lingua e dell’esperienza del collegio racchiusa negli appunti siglati Ed (stesi a partire dagli anni Quaranta), ma matura alcuni suoi tratti fondamentali – per esempio le epifanie treiesi nel tessuto romano – anche dentro il pensiero e la scrittura su Roma (recita un appunto degli anni Sessanta: «Nelle “Vie d’Italia” del 1957, a pag. 905, si parla di un fiume Treia che sarebbe vicinissimo a Roma, tra la Cassia e la Flaminia. // Leggere, fare accostamenti, forse si spiega «piazza dell’olmo di Treia» e soprattutto, vederlo. // Ne so oggi, per la prima volta, 3-6-60»). Un nome così familiare, era a due passi da me e non lo sapevo.).
Uscito nel 2022 a cura di Valentina Polci in Italia col titolo Roma, non altro (Quodlibet), Rome rien d’autre gode da ora non solo della traduzione in francese, ma anche della lettura di Jean-Paul Manganaro, che in questa intervista analizza le ragioni della traduzione, le contiguità e differenze tra gli elzeviri romani di Prato e Giù la piazza non c’è nessuno, fino a anticipare alcuni spunti critici su Educandato, prossimo libro di Dolores Prato in corso di pubblicazione per le sue cure, sempre presso Verdier. [ef]
Perché, dopo Giù la piazza non c’è nessuno, Verdier ha scelto di tradurre questo libro?
La fortuna di critica e di pubblico ottenuta da Giù la piazza imponeva di offrire una continuità alla traduzione e alla pubblicazione della suite editoriale, immediata ed evidente con Roma, non altro. Tanto più che in Giù la piazza l’autrice aveva già messo l’acquolina in bocca con alcune allusioni e soprattutto dando risalto alle posizioni assunte e ai rimproveri rivolti a chi aveva gestito le ultime decisioni sui destini della città. Il punto di vista essenziale scelto per giustificare impressioni e opinioni personali era così molto preciso: la cancellazione dell’universalismo di Roma – universalismo che la città ha ereditato dal suo passato «romano» e perseguito poi nell’universalità della religione cattolica – a causa della decisione di farne la capitale d’Italia: non più città universale, ma solo città «capitale d’Italia». Tanto preciso, inoltre, da alimentare le colpe attribuite senza mezzi termini dall’autrice ai Savoia re d’Italia, critiche che si riassumono nel loro «prendere indegnamente il posto» di papi e pontefici. Critiche a volte molto violente, vicine all’insulto. Questo aspetto era già delineato chiaramente in Giù la piazza: ecco in poche parole gli elementi di fondo che hanno giustificato la scelta editoriale.
Lei ha definito gli elzeviri di Prato un lungo «nastro narrativo» creato dall’autrice su Roma. La stessa definizione adottata per Giù la piazza non c’è nessuno e, in generale, per la scrittura dell’autrice. Sono più le differenze o le contiguità tra gli elzeviri di Prato, la visione che l’autrice dà di Roma e quella che dà di Treia, come emerge da Giù la piazza?
Non è lo stesso «spirito» che agisce nell’una e nell’altra situazione, nella rappresentazione che dell’una e dell’altra viene ad essere costruita. Mi sembra però che in tutti e due i casi ci sia la necessità di reperire un genius loci che si condensa in modalità diverse. In ambedue i casi c’è un’incidenza col nome, come se per nominare le cose bisognasse prima battezzarle: Roma è un nome falso, dice Dolores Prato, e non sapremo mai qual è il suo vero nome, confuso come è stato in diversi occultamenti spesso scaramantici. Vibra nelle frasi di Roma, non altro come un’ansietà mistica – una mistica non religiosa ma sicuramente misteriosofica, quasi una suggestione che farebbe sorgere l’ombra fervida di un Numa Pompilio e di una Ninfa Egeria. Parallelamente, Dolores Prato individua un problema con lo iòd di Treja che nessuno pronuncia più e vi lega qualcosa di profondamente sentimentale e rammaricato: ogni volta, l’incertezza di un qualcosa di strano che accorda dignità all’oggetto in analisi. Sempre sembra aleggiare un vago problema nel dire l’affetto che ci lega al nome del luogo in cui siamo nati o in cui viviamo, nel reperire l’incertezza di ogni origine, potente perché segnala una modalità dell’essere e dello spirito. C’è poi l’imponenza monumentale di Roma – c’è anche quando le vicende si svolgono in luoghi sotterranei – che traspare in quasi tutti i momenti evocati dall’autrice. Mentre per quel che riguarda Treja c’è un invasamento più sottile, più intimo, quasi una poetica dell’affetto e della dolcezza. C’è nelle evocazioni di Treja la meraviglia delle scoperte offerte dalla vita: la descrizione della grande piazza, la folgorazione del sole o di altri elementi naturali, la meraviglia delle rivelazioni infinite, c’è la costanza di una poetica dello stupore.
Negli elzeviri, scrive, emerge l’amore di Dolores Prato per il popolo, come in Giù la piazza, e la sua inimicizia per vulgate e retoriche in accordo con i tempi in cui l’autrice ha vissuto. Scrive anche che il suo sguardo pone problemi e temi per così dire ancora attuali. Quali sono?
La scrittura di Roma è sostanzialmente diversa da quella di Giù la piazza. Non che non si ritrovino gli stilemi specifici dell’autrice, il suo tono, la sua tonalità sono assolutamente inconfondibili – è come ritrovare Puccini o Verdi o Bellini in appena poche note, Leonardo o Michelangelo o Artemisia nel minimo dettaglio –, ma incalzante è la volontà di costruzione mentale – che qui sfiora non la ricostruzione di un mondo passato, ma piuttosto di un mondo che non ha mai cessato di essere presente negli animi dei viventi. E non si troveranno pagine di andamento «turistico», come una guida, no, qui vale il consustanziarsi del sentimento glorioso e amoroso, non tanto il racconto della «cosa», ma le diverse esistenze delle cose che conferiscono loro un’eterna attualità. Valga per tutto, il «racconto» della discesa nell’oltretomba gioioso delle catacombe ne Il mondo sottoterra, uno dei racconti più intensi eppure più leggeri. La scena comincia e si svolge in silenzio, le parole non valgono in quanto tali ma, come è detto, per lasciare «affiorare il ricordo a commuovere». E poi, come un commento: «Eppure è un’idea sbagliata che qui possa esserci un quartiere dove la Roma del passato sia assente». Si scende, sì, nel passato, ma questo passato è un presente di quello stesso passato, trasecolato dalle ombre e dalle luci fioche che accarezzano i muri, angelicato dalle voci che intonano canti con accenti singolari come a evocare una religione forse dimenticata in cui paganesimo e cristianesimo confondono i loro moti. È un racconto importante anche perché, proprio qui, sono significate le differenze che costituiscono i vari personaggi esibiti o trascritti: signori della villa di sopra, poi, giù, popolo, tante persone degne e umili e fiere che scendono in fondo a quest’animo segreto. E il popolo diventa mondo, bianchi, cinesi, neri cantano liturgie con voci esalanti de profundis, un mescolarsi di elementi, di sensibilità, di emozioni. Verrebbe qui da evocare l’altro splendido racconto, Incontro con Marchesi, con una semplice citazione: «Il giorno che Marchesi se ne andò a me pareva che buttasse a tutti una speranza e un invito all’unione e che la folla lo raccogliesse». In altre pagine, poi, le accuse rivolte ai poteri che non curano questo immenso sito risonante, Roma, un groviglio di vari motivi che tracciano la volontà intima di non voler abbruttire la città.
Il prossimo libro che Verdier pubblicherà è Educandato. Le chiedo in anteprima la sua impressione critica e di traduttore su questo testo.
Direi che Educandato per la materia stessa che lo compone, è assai più vicino a Giù la piazza di quanto lo sia Roma, non altro… La geografia nella quale la trascrizione prende vita è la stessa, Treja, essendo stata essa oramai svelata con Giù la piazza, il mondo si restringe – o si dilata diversamente – in Educandato. Educandato potrebbe essere la descrizione dello spazio del corpo e dell’animo confrontato a quell’altro spazio – esterno e interno – che è il collegio, la cui natura, o almeno i regolamenti che lo gestiscono, possono corrispondere a quelli dettati da una prigione qualsiasi. E questa sensazione di corpo imprigionato vien fuori fin dalla prima scena in cui la zia la lascia o l’abbandona davanti o dietro il portone. Che Dolores Prato abbia avuto un problema fondamentale con le porte non è un mistero: fin dalla prima pagina di Giù la piazza si percepisce la violenza di questo meccanismo apparentemente banale dell’entrare e dell’uscire – ma che nutrono il timore costante di essere abbandonata. Questo viene ribadito con termini differentemente cruciali dalla protagonista: parole di una bimbetta nel caso di Giù la piazza, termini di una ragazzetta in Educandato, una ragazzetta che viene preparata – senza che però si prepari veramente – ad affrontare la vita, perché lì dentro non è vita. A tal proposito, lavorando sul testo, sono rimasto stupito dal numero infinito di volte in cui il collegio è indicato con un banale, semplice e distante «lì dentro». C’è poi la presenza della Madrina che ridice, raddoppiandola, la figura sovente lontana della zia, che trascrive un certo astio e il desiderio che questa condizione o questo sentimento fanno nascere; la Madrina si erge così come figura da imitare iscrivendosi però nella distanza, inarrivabile ma inavvicinabile, una distanza critica. Si può evidentemente pensare a un panoptikon foucaultiano, l’occhio della Madrina che determina ogni movimento e ogni giudizio, con il desiderio e l’aspirazione a venirne fuori – come poi accadrà con la messa in atto di una clamorosa fuga. Ecco il quadro generale. Ma c’è poi dell’altro. C’è una elaborazione attentissima del sapere che non ha in queste pagine nulla di gratuito: trascrivere queste liste, tutte queste liste – di oggetti, gesti, architetture, persone –, dove niente succede, trascrivere questa necessità assoluta del vivere anche senza storia, è un modus vivendi che appartiene al positivismo, a un tardo positivismo, epoca della pura razionalità convinta che le soluzioni siano tutte possibili a condizione di non aver tralasciato di nominare tutto nella lista, di enumerare ogni dettaglio dove le parole si ammassano e si assommano e diventano vita: per ritrovare ancora una volta il passato come presente pulsante e vivido, forse ancora non del tutto trascorso né del tutto trascritto, con la scrittura che dice appunto questo: l’infinità della vita, l’infinità del pensiero scrivente.