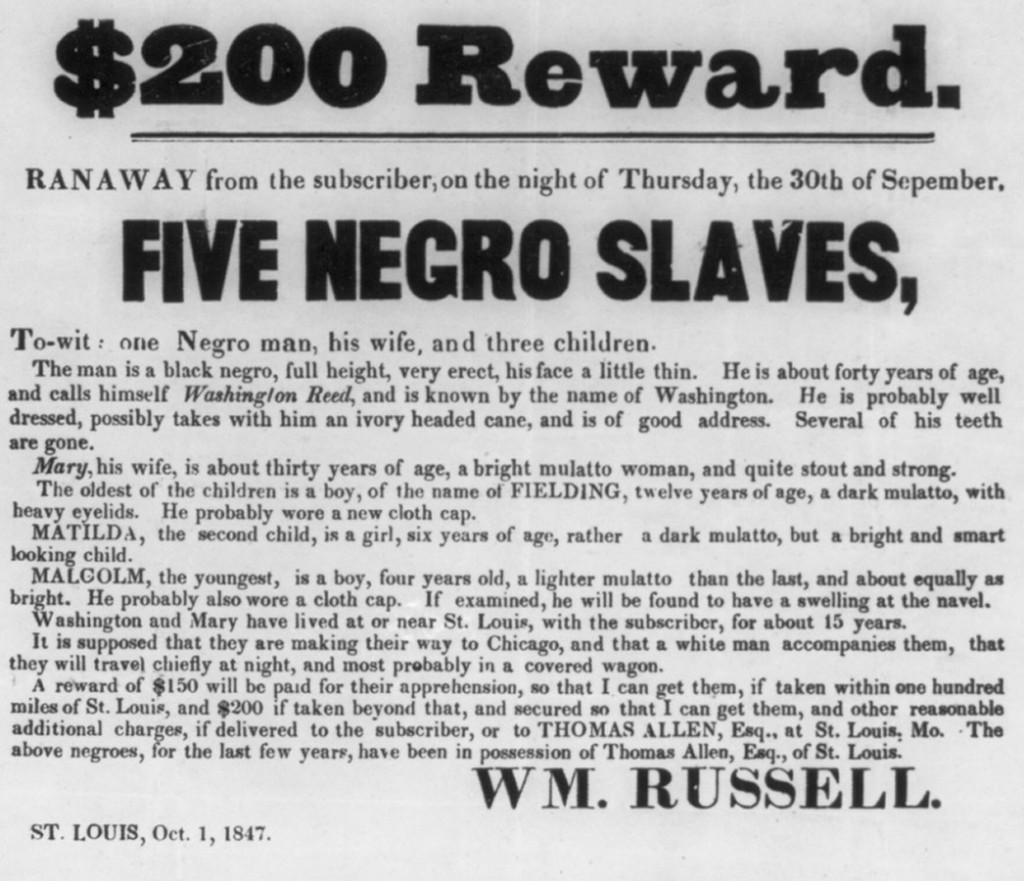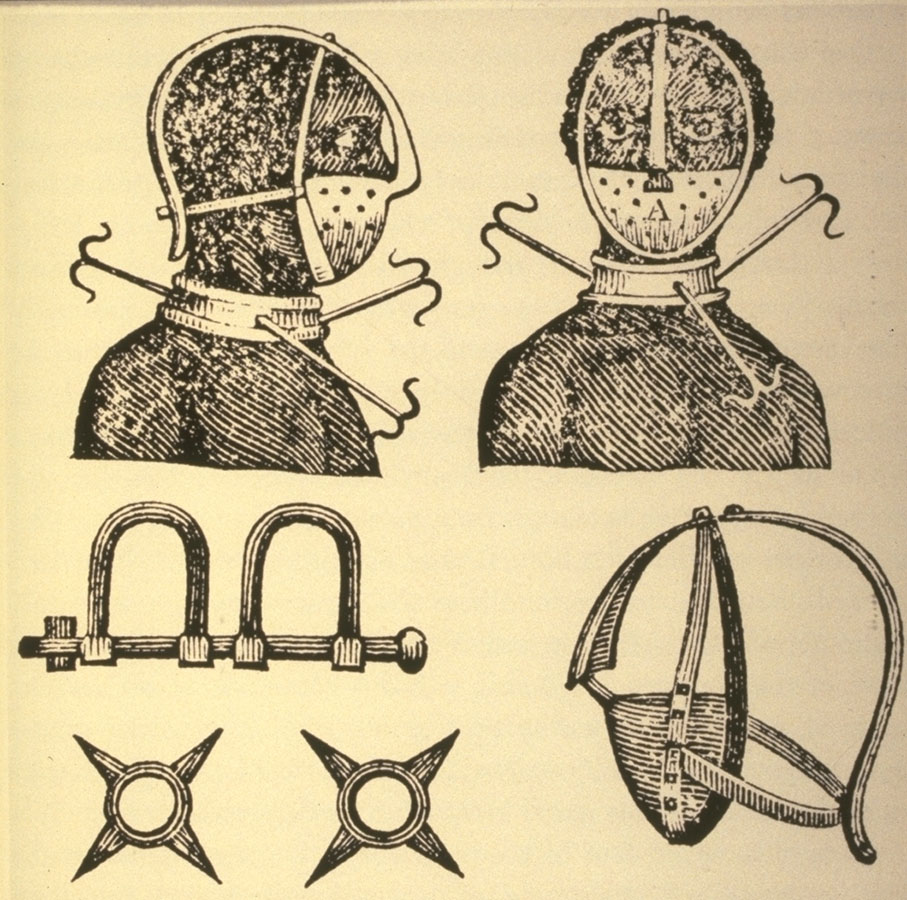di Andrew Zawacki
di Andrew Zawacki
traduzione di Andrea Raos
Corona
Un io balbettò e un io mutò
voce, un io provò
a legare una fune a un io che
se la slacciava.
Un io guardò un pescatore trainare a riva
dal frangente uno squalo tigre della sabbia,
mentre un altro io era già anni più tardi,
tornato là dove un abitante del posto
aveva messo l'esca per il persico ma abboccò uno squalo.
Un io si sedette sotto nuvole olivina,
nuvole rosso acceso, un cielo cortigiana,
e un io si stese al sole
da bambino, immaginando una canna da pesca
divenuta corona. Un io sventolò una sciarpa
fiordaliso, ascoltò il suono di una girandola
e il suono del vento,
salutò con la mano un imminente
amore passato. E un io andò in giro
a piedi nudi e scottato dal sole attraverso
le inibizioni nicheliche del pomeriggio,
scagliando bottiglie ambrate contro un sommacco selvatico,
il lago piombo, nuotando per raggiungere i suoi
sul molo mentre scendeva il crepuscolo,
mentre lo stesso ragazzo restava indietro
a guardarlo nuotare. Un io credette
che un padre potesse essere ucciso da uno smottare di roccia
e un io si svegliò per scoprire che aveva solo
sognato, benché suo padre fosse già morto,
e un io credette nella bellezza di una casa
non costruita da nessuna mano. Un io promise
che mai niente si sarebbe rotto – e niente si ruppe –
e un io vide rompersi ogni cosa
e non seppe dirlo.
*
Vertigine
Se il vento che si attarda tra i rami
sfugge da sé solo per finire in quarantena
per via di una bufera sbandata dal nord
e se l'aria si capovolge mimando
i resti dell'imbrunire sconvolta da una gelata precoce
e punita per quanto freddo è il suo freddo
tu, come un proiettile che si incastra nell'osso
e diventa parte del corpo,
non ti sveglierai partita via dal tuo nome.
E io non sarò parte di te.
§
Ci sono cose che vorrei mettere in chiaro
con me stesso. Perché, per esempio,
mentre l'autunno si dipana, non riesca a cementare
me con me stesso, solo luce del sole
sparsa in giro da qui fino al sole. Con “io”
voglio dire una finestra, punto di rosso che sfiora il lago
all'alba o un'eco spulata
lungo il muro, premuta a nascondersi
e sformata dalla voce da cui svanisce.
Voglio dire così tante finestre. Così tanto rosso.
§
Che non mi si fraintenda.
Quella donna che porta in sé
l'inverno, intirizzita da una neve
che mai si livella – vorrei dire
io la amo. Ma io è parola troppo forte
e amo non abbastanza.
*
Glassscape
Soffio di grigi in campo
fluido e ticchettio di pioggia
lo-fi – bleu pétrole –
un sole
a 60 watt svitato dal
cielo desolato: pietr-
ame e fanghiglia di carbone,
benna e loess, per quale fosforo
è un semaforo, setoso
nelle sue ombre acustiche
a slucernare, a restare
via quando mi sposto:
figure lontane dal mercurio
buio, non
infrangibile, non
otturabile,
da immagine rumore
ogni contorno stirato a
strass –
come se i margini fossero
invasi da centri o ceneri
– “Ecchoes
to the Eye” –
o la scarpetta di Cenerentola
soffiata in poli-
vinile butile
laminata a vetro.
*
Le forme gelate in familiare lontananza
Questi azzardi,
usciti da una neve speculare
più bella di quanto la sua scarna ed elastica grammatica
dovrebbe consentire, ma l’assiomatica dell’inverno
ristà – intarsiata, soffiata a vetro – sul fiume
spianato incolore, il suo moto
sospeso ormai da ore, anche solo alla vista,
come una cicatrice sutura una ferita,
da taglio, la frontiera tra febbre e fremito,
o una ripresa aerea dei quartieri
open- source della mente
– e allora cosa. Il terreno assalito saturato
da tutto tranne noi benché noi
stiamo qui, una buca nel campo già una tappa
verso la foresta, e perciò siamo trattenuti dai
boschi e dai prati nello stesso tempo, grati a entrambi,
corsivi lungo il nostro elaborato collasso verso l’alluvionale
disastro della storia. Come se il crepuscolo
fosse una forma di cortesia, antiquato, pittoresco
con quei suoi ninnoli, sbatacchiante contro un sottocoppa fragile che accoglie
il poco che è versato – eppure i Fahrenheit di una ricerca,
incisi e ribattuti a cercare
ciò che mai ci tocca
malgrado la nostra mancanza di sentimento, la nostra costante
incostanza nascosta agli occhi e così esposta al meglio,
impreparata alle stravaganze del sonno, la sua aragonite,
dei nomadi punti cardinali del sonno.
Quale flangiata o sfalangiata ipotesi
– qui, oppure qui – chiediamo del ghiaccio,
non poterono nascere, o gene- rarvisi, quali sovranità
del lago sono causa del vento – un’interruzione di chi siamo
e anche di sé – non svaniranno in quello stesso
bianco che le rende alla visione.
Che il fico fiorisca, ai margini
di preoccupazioni personali, il cipresso
come evento statico, i suoi rami vitrati in
cristallo saldato in acqua nel freddo,
di cui il centro è una cosa che nuota
che ingloba il panico presente nei suoi polmoni
sferici, cimmeri, e aspetta un concetto di superficie
per lasciare andare. Abbiamo forse fatto troppe storie
in merito all’impianto formale, rapide a sbiancare le sue mura,
quando la vacuità del contenuto è ciò che vuole
e ciò che è. Solfato di rame e più ramata
aria, tardiva in deviazione ottica:
così l’oro- genico, augurato cuore.
Una notte latente si annuncia
anonima da un hinterland, tagliata dal testo della cornea,
la sua luce spinta avanti in quanto analisi, lo gneiss
che un tempo solo e nel buio ammassò il buio:
tempra, con un carico termale, annullando
ogni icona venuta prima; ma a differenza di chi
la guarda, di chi ascolta entro la sua infernaledischiusa
cornice – e noi non facciamo eccezione – molto tristemente per
lei lei
non morirà mai.
***
Fermata
One of me stuttered and one
of me broke, and one of me tried
to fasten a line to one of
me untying it from me.
One of me watched a fisherman haul
a sand shark from the breaker,
while another was already years later,
returned to where a local man
baited for striper but landed a shark.
One of me sat under olivine clouds,
clouds of cerise, a courtesan sky,
and one of me sunned himself
as a child, imagining a fish-rod
turned fermata. One waved a sash
of cornflower blue, one heard
a windmill, one heard the wind,
one waved goodbye to an imminent
leftover love. And one strolled
barefoot and sunburnt across
the nickel inhibitions of afternoon,
tossing amber bottles at a smoke tree,
the gun lake, swimming toward
his family on the dock as twilight fell,
as the same boy stayed behind
to look at him swim. One believed
a father could be killed by falling rock,
and one woke up to find he’d only
dreamt, although his father was dead,
and one believed in a beautiful house
not built by any hand. One promised
nothing would break, and nothing did,
and one saw breaking everywhere
and could not say what he saw.
*
Vertigo
If wind that wastes its time among the trees
escapes itself, only to end up quarantined
by a derelict squall from the north,
and if the air turns somersaults, miming
the outtakes of dusk, scandaled by an early frost
and punished for its coldness by the cold—
then, like a bullet that lodges in bone,
becoming a piece of the body,
you will not awake apart from your name.
And I will not be not a part of you.
§
There are things I would settle
with myself. Why, for instance,
as autumn unravels, I cannot mortar
myself to myself, nothing but sunlight
littered from here to the sun. By I
I mean a window, redness grazing the lake
at dawn, or an echo winnowing out
along a wall, hard pressed to hide itself
and straining for the voice it vanished from.
I mean so many windows. So much red.
§
Please do not misunderstand.
That woman who carries winter
inside her, dizzied by snowfall
that won’t level off—I would say
I love her, but I is too strong a word
and love not strong enough.
*
Glassscape
Grayscale breath on a fluid
field, with lo-fi
rainpatter—bleu pétrole—,
a 60-watt
sun unscrewed from the
woebegone sky: rip-
rap & coal slurry,
dragline & loess, what phosphor
-us is a semaphore
for, silklike
in its acoustic shadows
louver away, or stay
when I move:
figures astray from the mercury
dark—shatterproofless,
shutterproofless,
image noise
stressing each contour to
strass—
as if the margins were
swarming with
centers, or cinders
—“Ecchoes
to the Eye”—
or Cinderella’s slipper
blown of poly-
vinyl butyral
& laminated glass
*
The Forms Frozen in Familiar Remoteness
These hazards,
out of a specular snow
prettier than its gaunt,
elastic grammar
ought to allow,
but winter’s axiomatics
hang—tessellated,
ashblown—on the river
matted colorless,
its movement
suspended for hours now,
if only to the eye,
as a cicatrix
sutures a jackknife
graze, the frontier between
fever & thaw,
or an aerial recon
photo of the mind
’s open-
source arrondissements
—and what of it.
The assailed ground saturated
with anything other
than us although we
stand there, a hole in the field
already a halt
to the forest, and are thereby
held by
woods and meadow at once,
beholden to both,
cursive along our labored
collapse toward history’s
alluvial havoc.
As if twilight
were some kind of courtesy,
antiquated, quaint
in its china, rattling against
a brittle saucer that catches
the little is spilled—and yet
the Fahrenheits of a research,
inlaystricken and outward
struck, to track
what is never not
touching us
despite our lack of
feeling, our constant
inconstancy hidden from view,
that being its proper display,
ill prepared for the vagaries
of sleep, its aragonite,
of language’s nomadic
cardinal points.
What flanged or unphalanxed
hypothesis
—here, or here—,
we ask of the ice,
could not be born, or borne
across, what sovereignties
of the lake effect wind—
an interruption to who we are
and even to itself
—won’t vanish into the very
white that gives them back
to vision.
That the fig tree
flower, at the outskirts
of private concern,
the cypress-pine
as a static event,
its branches glassed in
water soldered crystal under
the cold,
the center
of which is a swimming thing
that packs the current taut
within its globed,
Cimmerian lungs, and waits
for a concept of
surface to let it go. Have
we fussed too much
with the formal design, quick
to flaxen its walls,
when emptiness
of content’s what it wants
and what it is. Bluestone
and the bluer
air, late
thru an optic swerve:
so the oro
-genic, augured heart.
A latent night
announces itself
anonymous, from a hinterland,
cut from the cornea’s text,
its light rushing forth as
analysis, the gneiss
that once alone and in
the dark amassed the dark:
anneals, with a
thermal freight, annulling
every icon came before;
but unlike those who
look at it, who listen inside its
helllatched
frame—we being no
exception—sadly enough for
it it
cannot die.