di Eleonora Marangoni

Autrice di Piccole Donne, Louisa May Alcott nasce nel 1832 nell’impronunciabile Massachusetts. Sessant’anni dopo, nei pressi di Londra, Isabella Mackenzie Fairfield dà alla luce la sua terza e ultima figlia, Cicely Isabel Fairfield, che da signorina sceglierà come pseudonimo il nome di un’eroina di Ibsen, diventando così miss Rebecca West. Oltre all’oceano Atlantico, le separano cose come l’avvento dell’automobile, la scoperta del telefono, la costruzione della torre Eiffel, l’arrivo della Coca Cola dalla Georgia e quello di Jack lo squartatore nell’East End. Sessant’anni di distanza, per come e quanto girava il mondo a quei tempi, erano una piccola eternità.
Le due però si assomigliano, eccome. Oltre che autrici prolifiche, sono entrambe intellettuali engagées, suffragette tenaci, attiviste politiche, viaggiatrici solitarie. Diversamente dalle flappers, sono anticonformiste ma non provocatrici: niente capelli alla garçonne o foxtrot scalze sui tavoli, per intenderci; più che l’emancipazione cercano (trovandola) la libertà. Lo fanno in modo ostinato e mai chiassoso, alla larga da convenzioni ed etichette: «Io stessa non sono mai riuscita a capire che cosa significhi con precisione femminismo. So soltanto che mi definiscono femminista tutte le volte che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino o da una prostituta», scrive la West nel 1913.
Quando da ragazze moderne le due diventano signore mature, le loro strade sembrano disgiungersi. Una resta zitella (la Alcott), l’altra si sposa poi resta vedova. Una mette al mondo un figlio illegittimo (West, nato dalla storia d’amore con H.G. Wells), l’altra non lascia eredi. Una muore a cinquantacinque anni (Alcott), l’altra arriva a novanta. Ma nessuna delle due smetterà mai di scrivere, e tutte e due vivranno sole in case pieni di libri e di gente alla porta. Non saranno mai mogli operose, madri modello o nonne pazienti; finiranno, l’una e l’altra, col somigliare a quelle donne testarde, indomabili e leggendarie che ogni tanto si ha la fortuna di avere come zie.
Spesso le signore che si assomigliano sono state le stesse bambine, e in questo caso è andata proprio cosi. Sia la West che la Alcott erano nate in famiglie che la disparità fra status economico e livello culturale rendeva indefinibili da un punto di vista sociale: l’autrice di Piccole donne da bambina faceva i compiti in salotto con Nathaniel Hawtorne e Henri David Thoreau, poi vestiva i panni di sartina di provincia e correva a ricamare gli orli delle ricche signore di Concord. La signora Fairfield non esitava a separarsi dai “mobili buoni” per mantenere Cicely/Rebecca e le sue sorelle maggiori, ma nessuno venne mai a portarsi via il pianoforte, i sonetti di Shakespeare o i volumi intarsiati dell’Encyclopaedia Britannica.
Quelle due erano cresciute nelle stesse case grandi e un po’ malandate, col verde intorno, dove i pavimenti scricchiolavano allegri e in cucina c’era sempre una torta in forno. Nelle stanze fiorite, libri e spartiti seppellivano le cambiali, e qualcuno al piano di sotto si occupava di ravvivare il fuoco. Piccole donne e La famiglia Aubrey sono la storia di queste case. La prima diventerà una saga celeberrima in quattro volumi, l’altra resterà una trilogia incompiuta sconosciuta ai più.

Le sorelle Aubrey sono diverse dalle March per passaporto, vocazione e destino, per il modo che hanno di raccogliere i capelli. Ma, in fondo, sono tutte lì che dispongono fiori, suonano il piano, si preparano alla vita mentre imburrano tartine sopra e sotto. Le Aubrey sono tre, una in meno delle March. Ma c’è un fratellino, Richard Quin, illuminato e bianco come l’ultimogenita delle americane, Beth. La vita riserva a entrambi un destino struggente, e forse per questo fin dalle prime pagine i due sono sprovvisti di una vera fisicità: più che dei bambini, Beth e Richard Quin sono fragili oracoli, e aleggiano come teneri ologrammi. Ci sono la sorella ambiziosa (Cordelia, West; Amy, Alcott) e la sorella cauta (Mary, West; Meg, Alcott). C’è un padre che deve sempre “tornare”: dalla guerra (Alcott) e da non si sa dove (West). C’è una madre innamorata, paziente e stanca, che anni di rinunce e nostalgie non hanno privato della naturale eleganza verso le cose né della voglia di cantare al piano. E poi c’è Rosamund, la cugina preferita delle Aubrey, dorata e selvaggia come Jo.
C’è una domestica saggia, fedele e brusca (Kate, West; Hannah, Alcott). C’è “l’uomo da sposare” (Oliver, West; Laurie, March), e perfino un benefattore âgé dalle guance rotonde (Morpurgo, West; James Laurence, Alcott). Sarà perché “tutte le famiglie felici si assomigliano” ma qui sono tutti al loro posto, da entrambe le parti e in modo curiosamente simmetrico.
Né a Orchard House (casa March) né a Lovegrove (casa Aubrey) succede poi granché: è tutto una colazione, un’attesa, una corsa nei prati, una visita in città, un Natale povero ma allegro, una visita inaspettata, un pettinarsi i capelli, un battibecco appena sveglie. Certo, come in ogni romanzo che si rispetti, non mancano lutti, sacrifici, illusioni perdute e parenti nei guai. E c’è “la guerra”, poco importa quale essa sia (Secessione nel primo volume della Alcott, Grande Guerra nel terzo della West). Ma quello che ci si porta dietro leggendo sono soprattutto cose come lo zenzero e il pungitopo, le carrozze e i motori a scoppio, gli abiti rammendati e le pieghe delle tende.

Ora, non c’è tanto da chiedersi perché per decine di generazioni occidentali le avventure delle sorelle March siano state imposte a livello mondiale facendo di loro eroine se non indimenticabili quanto meno immancabili, mentre Amy, Rose, Cordelia e Richard Quin sono ancora lì su una barchetta a remi che cercano di attraversare la Manica; e neanche perché, sebbene il «Times» l’abbia definita nel 1947 «indiscutibilmente la migliore scrittrice al mondo», della West non parli più nessuno e le rare occasioni in cui ci si ricorda di lei è per il suo diario di viaggio in Iugoslavia, le sue cronache del processo di Norimberga per il «New Yorker» o per il suo flirt con Charlie Chaplin.
La domanda sarebbe piuttosto: perché, se già in tenera età ci siamo sorbiti Piccole donne e non siamo attualmente alunni di scuola media, dottorandi in letteratura vittoriana, femministe sentimentali e nemmeno zitelle del Sussex, dovremmo adesso sciropparci la loro apparente versione anglosassone?
Risposta: perché il salottino dei March una volta visitato lo riponiamo a cuor leggero sugli scaffali alti, accanto ai numeri della raccolta I grandi classici della letteratura in edicola, fra i libri “che tutti hanno letto e nessuno rilegge” e che un giorno, forse, regaleremo ai nostri figli. Le stanze degli Aubrey invece, una volta scoperte, non solo abbiamo difficoltà a spostarle dal comodino, ma vorremo spalancarle a tutti, e portarcele dietro sempre, come un amuleto, un antidoto alle sciatterie della realtà, alla miseria dei giornali e all’inconsistenza di certi romanzoni moderni. Se siete musicisti, musicologi o musicomani esiste poi una ragione ulteriore, più “tangibile” anche se in fondo incorporata e dissolta nella prima: la West scrive di musica e sulla musica e per la musica come pochi (e forse come nessuna) hanno fatto. Le pagine dedicate ai concerti di Rose e Mary, agli esercizi al violino di Cordelia, alle impressioni sui grandi compositori classici sono scritte come si scrivono i capolavori: con sobrietà, grazia, esattezza e magia.
Stare dietro alle sorelle inglesi è senza dubbio più difficile, e non perché non vi prendano per mano, ma perché non vi portano negli stessi posti. Le March rigano dritte dal punto A al punto B e così via, senza star lì a dilungarsi fra quel che c’è in mezzo, creando futuri prossimi e conseguenze orizzontali, comprando cappellini in tre righe e innamorandosi in sei. In casa Alcott è l’intreccio, in fondo, a farla da padrone, diretto dai buoni sentimenti e dalla poetica del vivere ammodo.
Al contrario gli “eventi” veri e propri del suo romanzo la West li liquida in fretta: una morte, un abbandono o un matrimonio stanno stretti in poche righe, e il vero protagonista è una sorta di presente dilatato, eterno e apparentemente inutile, fatto di cose piccolissime che non tendono mai in avanti ma si ripongono una dentro l’altra come bambole russe. Degli uccelli su un albero, un sottobosco di felci, una lezione di piano, il disporsi degli ovini in un campo, una storia di fantasmi: la famiglia Aubrey non si muove, ondeggia, in uno spazio a cui non siamo abituati e che è il fondo di un tempo liquido.
Forse questo accade perché Rebecca West ha iniziato a scrivere della famiglia Aubrey alla fine della sua vita, e per raccontare il mondo dell’adolescenza si è presa tutto il tempo della vecchiaia: ha preso “tempo” e l’ha messo lì dentro, anche dove non doveva essercene, maneggiandolo senza troppe cautele, con l’incoscienza, l’entusiasmo e quel pizzico d’irriverenza figli del modernismo inglese primi ’900. Lei comunque lo sa, e l’epigrafe che sceglie in apertura al primo volume è il suo modo (inglese) di scusarsi: «The cistern countains, the fountain overflows» (citazione dal Matrimonio del cielo e dell’inferno di William Blake). Ma ogni volta che lascia correre l’acqua la West ha ragione, perché ci porta dove certo nessun romanzo di marzapane e trecce bionde e compassione è stato in grado di fare, o forse ha semplicemente provato a fare.
In un certo senso, Piccole donne sta alla Famiglia Aubrey come Jingle Bells all’Oratorio di Natale di Bach. Teoricamente parlano della stessa cosa, il Natale, ma sono cose diverse, suonano inevitabilmente in un altro modo e, mentre la prima dà il meglio di sé anche nella versione per pianola, la seconda guarda più in alto, e assolverà il suo compito solo a condizione che le venga dedicato il giusto spazio, o almeno un impianto stereo decente. Cisterna e fontana, insomma. Nelle pagine della West, come in ogni vita che si rispetti e come in tutta la grande letteratura, quel che conta sono i momenti e il flusso in cui sono immersi, non quello che si impara o dove si va a finire. L’attesa della vita e la vita stessa sono una cosa sola; l’una senza l’altra non avrebbe lo stesso gusto, e men che meno lo stesso valore. Se c’è qualcosa che questo libro vi insegna è questo, e non è poco, e lo fa mentre vi parla di tutt’altro.
A un certo punto, a metà del terzo volume, Oliver (il musicista che sposerà Rose) è lì in salotto che mangia una torta alle ciliegie. Per dirla bene, Oliver ha mangiato tutte le ciliegie e lasciato un pezzettino di torta nel piatto. La gemella di Rose, Mary, gli propone di fare il bis, lui ringrazia e accetta. Mary ribatte: «Ma se ci togli le ciliegie la riduci in briciole. È un peccato, perché la torta è buonissima. Vado giù in cucina a chiedere alla cuoca di darmi delle ciliegie candite a parte, cosi potrai mangiarle senza rovinare la torta». Poi lei scende per le scale che scricchiolano e a quel punto Oliver si chiede, nel modo più naturale del mondo: «Com’è possibile che una ragazza sensibile come Mary non si renda conto che mangiare le ciliegie candite da sole non sarebbe la stessa cosa che mangiarle dopo averle levate da una torta?».
Insomma, è una storia di frutta candita, d’inglesine acerbe che suonano il piano e prendono il tè. Ma dentro ci trovate proprio tutto, basta accomodarsi in salotto.
[Questo articolo è stato pubblicato, con altro titolo, su Archivio Caltari]




 di Mirfet Piccolo
di Mirfet Piccolo 
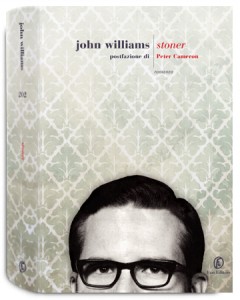

 di Andrea Carraro
di Andrea Carraro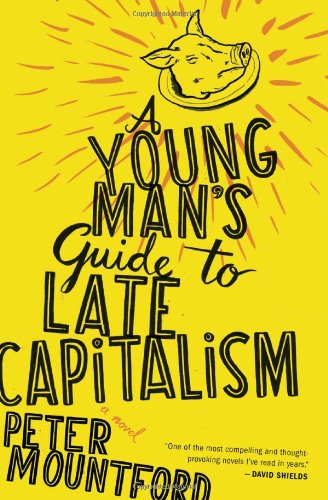





 (L’autore del divertente e surreale Polpette, uscito 2 anni fa per le edizioni Epika, ci regala 20 sue polpette inedite. Buon appetito. G.B.)
(L’autore del divertente e surreale Polpette, uscito 2 anni fa per le edizioni Epika, ci regala 20 sue polpette inedite. Buon appetito. G.B.)



