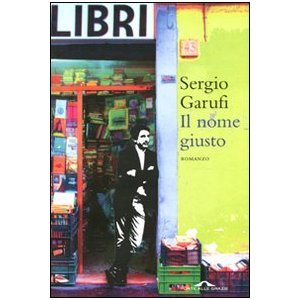di Franco Buffoni
“Io mi domando”, si chiede Céline nella lettera a M. Hindus del 15 maggio 1947, “in che cosa mi paragonino a Henry Miller, che è tradotto?, mentre invece tutto sta nell’intimità della lingua! per non parlare della resa emotiva dello stile…”.
Evidente, mi pare, già da questa breve citazione, la posizione teorica di Céline sul tradurre. Una posizione che noi italiani potremmo definire crociana, in quanto fa leva sul presupposto della unicità e irriproducibilità dell’opera d’arte per negare la traducibilità della poesia e della prosa “alta”. Tale concezione è l’espressione di un idealismo oggi particolarmente inattuale, contro il quale l’estetica italiana del secondo Novecento (Banfi, Anceschi, Formaggio, Mattioli) si è battuta, direi, vittoriosamente.
Nel 1975 George Steiner parlò della necessità – da parte del traduttore di poesia e prosa en artiste – di rivivere l’atto creativo che aveva informato la scrittura dell'”originale”. E negli ultimi trent’anni la traduttologia – ben conscia della lezione steineriana, ma anche di quelle non meno pregnanti di Gianfranco Folena e di Antoine Berman – ha cercato in ogni modo di suggerire come tradurre in realtà questa necessità di rivivere l’atto creativo. Anzitutto sfatando il luogo comune che tende a configurare la traduzione come un sottoprodotto letterario, invitando invece a considerarla come un Überleben, un afterlife del testo cosiddetto originale. Ma senza cadere nella comoda scappatoia della imitatio.