 di Giacomo Sartori
di Giacomo Sartori
In qualche modo sono riuscito a arrivare fino al piazzale della casa di mio fratello. Il peggio è fatto, mi dissi, tirando un sospiro di sollievo. Mentre uscivo dall’auto rimasi però impietrito: il male al cuore era di nuovo terribile. Avevo una gamba fuori dalla macchina e una dentro, ma non potevo muovermi, non potevo respirare, non potevo fare niente. L’aria fredda mi raschiava la gola, scendeva a frustare la zona del cuore giù nel torace. E erano ripresi i tonfi disordinati. Le stelle aspettavano verosimilmente che tirassi le cuoia, come quelle persone che assistono a un film fitto di ammazzamenti sanguinolenti leccando tranquillamente un gelato.
Quando all’ospedale avevano chiesto a mio fratello se qualcuno in famiglia avesse avuto dei problemi cardiaci, mi venne da pensare, lui aveva risposto risolutamente: no! Indossava una specie di spolverino azzurro in materiale sintetico da cui spuntavano i peli del petto e delle ascelle, ma la faccia era quella di uno che veste una giacca costosa e una bella cravatta. E anche mia sorella, pure lei presente, aveva risposto: no! Con la sua solita sicumera saccente, amplificata da un timbro insopportabilmente nasale: lavorando in un ospedale pensa di sapere le cose mediche molto meglio degli altri membri famigliari. Non è un medico, ma nei nostri confronti si atteggia a medico.
Nostro padre l’anno prima di morire aveva avuto un infarto, avevo allora fatto presente. È vero che aveva due cancri, e che lo stavano ammazzando con la chemio, ma aveva pur sempre avuto un bell’infarto. E questo nonostante il suo regime salutista di ascendenza mussoliniana, nonostante le quotidiane marce a piedi, nonostante non fumasse ormai da decenni. Poi non era morto per quello, ma l’infarto gli era venuto. Del resto anche il fratello pittore fallito era schiattato dopo un’operazione al cuore riuscita male. E il fratello più giovane aveva avuto un attacco molto grave prima ancora dei sessant’anni, e ci era quasi rimasto. Quanto al terzo e ultimo zio gli avevano fatto un’operazione al cuore di non so quante ore, e con non so quali prodezze idrauliche gli avevano permesso di tirare avanti ancora un po’.
Non me l’ero preparata, perché a dire la verità non ci avevo mai pensato nemmeno io. E forse era per puro spirito di contraddizione che avevo cominciato a parlare, come mi succede qualche volta con i miei deleteri famigliari. Quello che però era venuto fuori era assolutamente innegabile: quattro fratelli, quattro cardiopatici della madonna. La nuda realtà era quella: il medico assentiva gravemente con la testa, come a dire che si aspettava un quadretto del genere. Un caso da manuale, sembravano dire le sue labbra ben strette e le narici palpitanti.
I miei fratelli mi guardavano invece come si guarda un importuno saltato fuori da chissà dove con un feto in mano. Per loro faccio apposta a tirar fuori delle frasi che fanno stridere i denti. Me le preparo prima, pianifico i momenti più adatti per passare all’attacco. Ormai è diventato un inossidabile pregiudizio che sbandierano ai quattro venti. Però in questo caso non potevano accollarmi il ruolo dell’efferato terrorista, perché le cose stavano esattamente come le avevo esposte io. Dovevano anzi conoscere un mare di particolari che corroboravano la mia tesi, visto che a me le notizie riguardanti il parentame arrivavano sempre a spizzichi e bocconi.
E anche dalla parte di nostra madre le cose non erano poi così allegre, ho continuato, approfittando del mio temporaneo vantaggio: nostro cugino aveva avuto un primo infarto bello tosto a trentacinque anni, e poi un altro di media gravità qualche anno dopo. E un altro cugino un infarto intestinale a quarantanove. E la sorella di nostra madre era morta di un ictus cerebrale. Quanto al nostro nonno materno le cose non erano chiarissime, perché c’era ancora chi sosteneva che si fosse suicidato, ma verosimilmente oltre che sifilitico era anche cardiopatico, e era morto per quello. Era già tanto che qualcuno fosse ancora vivo, con il cuore di merda che avevamo, quella era la verità. Il medico mi ha guardato abbassando le palpebre, come a significare che poteva bastare.
Ero lì con una gamba fuori e una dentro nel piazzale della casa di mio fratello, ormai mezzo assiderato. Ero pronto a restarci anche subito, ma non volevo soffrire. Il mio cuore poteva anche scoppiare, dividendosi in pezzetti minuscoli come un proiettile a frammentazione, bastava che se la sbrigasse lui. È per quello che restavo immobile. Stavo cercando in realtà di scendere a patti con la morte. Chiedevo un minimo di garanzie. E non so perché avevo l’impressione di essere sul punto di spuntarle. Ero io stesso stupito della fermezza che mostravo nei confronti dell’assatanata falciatrice. Mi stavo comportando molto meglio di quanto avrei immaginato.
È mia madre che ci ha affamato per tutta l’infanzia, con il risultato che né io né mio fratello sappiamo fermarci di fronte al cibo, mi dicevo. Se smetto di mangiare è perché decido che ho mangiato abbastanza non certo perché provo una qualche sensazione di sazietà: mi riempio sempre di più, ma nessun segnale arriva al cervello. Lei lo sapeva bene, quando ha deciso di preparare l’enorme arrosto di maiale e la funesta torta al cioccolato: ha approfittato ancora una volta della mia debolezza. Solo che questa volta non è una semplice indigestione, è un infarto.
Sono poi riuscito a trascinarmi in qualche modo fino alla porta dell’appartamento di mio fratello. Mio nipote era lì con il suo amico. Stavano guardando la televisione. O meglio, tanto per cambiare stavano fumando uno spinello. Si capiva dall’inequivocabile odore di erba arrostita, e dai pezzetti di cartoncino sparsi un po’ dappertutto.
Mio nipote era contento di vedermi, non è questo, ma niente nel suo atteggiamento faceva pensare che avessimo un appuntamento. Come già era successo in altre occasioni si limitava a spazzolarmi dall’alto in basso con lo sguardo. Quelle occhiate che fanno il punto della situazione. Io lo ho salutato come se niente fosse, e anche lui mi ha salutato. Poi quando mi ha chiesto come andava gli ho detto che avevo appena avuto un infarto. Ma pacatamente, come se si trattasse di un raffreddore.
Lui mi ha guardato con la sua solita aria svagata. Infarto?, ha chiesto, con il tono con cui si chiede se davvero fuori pioviggina. Probabilmente con il suo amico avevano fumato per tutta la serata. Anzi, era sicuro, a giudicare dall’esagerato arrossamento degli occhi. Si permette di soppesare impunemente il grado alcolico dello zio, però lui fuma uno spinello dietro l’altro. Infarto!, ho confermato io.
Lui si è riseduto. Forse bisognerebbe fare qualcosa, ha mormorato, con la sua solita voce strascicata. Eh, già!, ho detto io, sedendomi anch’io sul divano. L’infarto è grave, ha confermato l’amico. Lui doveva averne fumati settanta spinelli, dalla lentezza con cui parlava. Alla televisione c’erano delle immagini di una barca a vela che affrontava enormi onde nell’Oceano Pacifico. Era impressionante, veniva il mal di mare anche solo stando seduti sul divano. Tutti e tre guardavamo la televisione.
Mi venne in mente la volta che mio fratello mi aveva parlato di un nuovo programma comico. Piangeva, da quanto lo facevano ridere certi sketch che mi stava raccontando. E anch’io ridevo molto, perché mi piacciono i programmi umoristici. Come dire, mi piace anche solo che me li descrivano. Il fatto è che non ho la televisione, perché per ragioni estetiche sono contrario alla televisione. E quindi sono come quelle persone che non bevono mai, e basta anche solo l’odore del vino per renderle alticce. Vedendo come sghignazzavo mio fratello ha detto che dovevo assolutamente vedere qualcosa: andava a prendere una cassetta registrata da suo figlio, che in quel momento non c’era. Tuo nipote registra ogni puntata!, mi ha detto, a titolo di garanzia.
È tornato con la cassetta, e l’ha messa. Il primo sketch era davvero esilarante. Sia io che mio fratello ridevamo moltissimo. Dopo una trentina di secondi è apparso però un uomo nudo, e subito dopo anche una donna, pure lei nuda. L’uomo nudo s’è messo a sodomizzare la donna nuda. Io davo per scontato che fosse un altro numero, e quindi un po’ ridevo, come si ride per inerzia. Mano a mano che la sodomizzazione procedeva era sempre più evidente che si trattava di un film pornografico. Un film davvero molto pornografico. Io guardavo il film molto pornografico, e anche mio fratello guardava il film molto pornografico. E pure mia cognata tirolese guardava il film molto pornografico. Era diventata un’intricata scena di sodomizzazione collettiva, perché erano apparsi anche altri personaggi. Per un bel po’ abbiamo continuato a seguire con la massima attenzione l’aggrovigliata sodomizzazione collettiva. Ora mio fratello non rideva più, e nemmeno io ridevo.
Poi mio fratello si è alzato, e ha tolto la cassetta. Senza alcun commento. Ma dalla faccia era chiaro che per lui era un qualche problema di fabbricazione della cassetta, senza alcun rapporto con il figlio quattordicenne. Lui le tensioni preferisce eliminarle alla radice, in modo che non abbiano opportunità di attecchire. Ha sempre fatto così. Ma a quanto pare anche mia cognata tirolese usava lo stesso metodo. Per tutta la serata nessuno ha più fatto allusione alla cassetta.
Quando verso mezzanotte me ne sono andato, l’avevo dimenticato il film pornografico mimetizzato da programma comico. E invece nel piazzale ci ho ripensato, e sono scoppiato a ridere. Non riuscivo nemmeno a stare in piedi, da quanto ridevo. Ridevo anche mentre guidavo, sghignazzavo da solo. Evidentemente il riso s’era incistato dentro di me, come una bomba a effetto ritardato.
Forse è meglio se ti sdrai, mi disse l’amico di mio nipote. Già, forse è meglio che ti distendi, ha confermato mio nipote, contento che un’idea qualsiasi avesse fatto capolino. Mi fecero allora sdraiare. Io li guardavo, e loro mi guardavano. Alla televisione c’era adesso una pubblicità di scatolette per gatti. Il gatto vaporoso della televisione sembrava chiedersi anche lui cosa diavolo sarebbe successo.
In effetti sei molto pallido, mi ha detto mio nipote, come quando si imbellisce la realtà per non spaventare qualcuno. Sembrava che il suo cervello avesse preso finalmente l’abbrivio, cosa che se avessimo davvero affrontato la ripetizione del programma di scienze, come era nei piani, non sarebbe certo successa. Io stesso a dir la verità mi sentivo molto pallido. Mi sembrava però che mi facesse bene stare sdraiato. Mi veniva quasi da dormire: all’improvviso mi sentivo molto stanco.
In fondo mia madre lo fa apposta a preparare dei cibi così pesanti e così indigesti, mi dicevo. Lei normalmente mangia solo insalatine scondite, ma tutte le sue cene sono a base di fritti e di grassi saturi. Altro che prepararci le cose che ci fanno più piacere, in realtà è da anni che tenta di farci fuori, non contenta di aver eliminato suo marito. Dopo innumerevoli tentativi – con il pretesto del Natale o appunto di questo o quel compleanno – andati buchi, è finalmente riuscita nel suo intento. Quella torta untissima non era un dolce in mio onore, non era il mio dessert preferito, era una bomba a scoppio ritardato.
Forse bisognerebbe andare subito all’ospedale, ha detto l’amico di mio nipote, facendomi sussultare. Mi ero davvero appisolato. E a quanto pare loro si erano spaventati: pensavano che fossi svenuto, o peggio ancora. Mio nipote aveva abbandonato i suoi gesti strascicati da adolescente, si stava infilando la giacca a vento. E anche il suo compare si muoveva con molta più celerità del solito.
Io non voglio andare all’ospedale!, ho protestato. In realtà adesso non sto malissimo, ho corretto il tiro, accorgendomi io stesso del tono poco consono al mio ruolo di zio e di studioso scientifico. Non era che un piccolo malore, ora sta passando, ho detto, cercando di fare quello che nella vita ne ha già viste di tutti i colori, e che non ha paura di restarci. Loro però hanno ribadito che non c’era da star lì a discutere tre ore. Prima arrivavamo al pronto soccorso meglio era. Mi parlavano come i proprietari dei bar parlano agli ubriachi quando la sera vogliono chiudere. Mi alzavano di peso. Erano un po’ ridicoli a fare gli adulti, con i loro vestiti quattro misure troppo grandi da adolescenti. Grotteschi.
Mi hanno sdraiato sul sedile dietro della mia macchina, proprio come un vero moribondo. Nessuno dei due aveva ancora la patente, ma l’amico di mio nipote poteva guidare senza nessun problema, secondo le rassicurazioni di entrambi. Io non obiettai nulla. In fondo ero contento che avessero preso in mano la situazione.
Non stavo malissimo: nel complesso il dolore al petto era diminuito notevolmente. E anche le irregolarità sembravano essere sparite. Eppure il mio cuore doveva ormai essere nelle condizioni di un pallone bucato. Vedevo le lave nere delle Eolie, quando pensavo alle necrosi del mio cuore. Le lave tutte screpolate, cupe e orribili.
Attraverso il finestrino di fronte scorgevo le stelle che continuavano a ostentare il loro falso interessamento alle sorti dell’umanità. Prima ancora di pensarci gli tirai la lingua. In fondo le colate di lava non erano poi così brutte, erano solo molto brulle, mi dicevo. Erano senz’altro meglio delle patate pesanti di grasso, delle tasche adipose dell’arrosto di maiale. Avevo quasi voglia di dormire di nuovo.
Deve aver bevuto un po’ troppo, forse è per quello che gli è venuto l’infarto, ha sussurrato l’amico di mio nipote, accendendosi una sigaretta. Si direbbe proprio, ha risposto mio nipote, sottintendendo che me l’ero cercata. Pensavano che dormissi. Avrebbero fatto meglio a pensare ai loro spinelli, mi dissi. E a non fumare nella mia macchina. Appena mi fossi ripreso ne avremmo riparlato, mi dissi.
Arrivati all’ospedale mi hanno fatto passare davanti a tutti. Una volta mi ero presentato con il naso tutto spiaccicato, ma per loro non era tanto grave, e mi avevano fatto marcire mezza giornata seduto su una sedia di plastica. Adesso invece era chiaro che il caso più urgente ero io. Ebbi un brivido lungo la schiena, mentre mi applicavano sulla faccia la maschera dell’ossigeno, e nel contempo mi facevano un’iniezione: forse me l’ero dipinta un po’ troppo in rosa. Avevo di nuovo molta paura, mi accorsi.
Un infermiere ha appeso sulla maniglia del lettino un cartellino sostenuto da un grosso elastico di gomma. Un cartellino rosso. Avevo visto bene, era proprio rosso. Anche a mio fratello avevano dato il cartellino rosso, che vuole dire pericolo imminente di decesso. Loro non potevano immaginare che lo sapevo, ma io lo sapevo benissimo. Per via appunto di mio fratello.
A prima vista il reparto sembrava davvero ben organizzato. Si davano tutti un gran da fare, cominciavano già a farmi le prime cure. Quindi non dovevo aver paura: sarebbe successo quello che era destino che succedesse. Dovevo pur sempre essere contento che per una volta qualcuno prendesse il mio stato di salute seriamente, e si occupasse in modo efficiente di me.
Avrei voluto che mi spiegassero quello che mi facevano, ma quando chiedevo delle informazioni mi rispondevano appena. O anche mi dicevano che non dovevo togliermi continuamente la maschera dell’ossigeno. Erano un po’ bruschi. Ma si poteva capire, erano tutti presi dallo sforzo di salvarmi. Io sentivo che parlare mi avrebbe fatto bene, ma loro volevano che facessi il malato e basta. Era così che si faceva.
Chiudevo allora gli occhi e tornavo mentalmente al solito dilemma: sarei morto o no? Un po’ mi dispiaceva schiattare, perché una delle infermiere era proprio carina. Forse un po’ troppo seriosetta, ma certo in un frangente diverso sarebbe stata più sciolta, avrebbe sorriso. Le sarebbe venuta una rughetta verticale sulla fronte, se continuava a essere così seriosa. Sono proprio incorreggibile, mi dicevo, constatando la mia vacuità perfino in un momento del genere.
Era perfettamente coerente da parte di mia madre ammazzarmi, mi dicevo. Non era che l’ultimo atto di un lungo processo, un processo cominciato con la mia nascita. La conclusione obbligata, per così dire. Mi aveva messo al mondo per quello, per farmi fuori. Ecco perché negli ultimi tempi insisteva sempre così tanto perché partecipassi ai deleteri ritrovi di famiglia, ecco il perché. Ecco perché quella sera aveva continuato a mettermi nel piatto della calamitosa torta al cioccolato con il suo letale corollario di panna. Prima di morire lei stessa voleva essere sicura di avere eliminato me. Il suo anticonformismo era in fondo una forma di copertura come un’altra: tutti gli assassini hanno un subdolo alibi. Con la scusa del compleanno mi aveva dato il colpo di grazia.
Non si trattava affatto di un infarto, mi dissero prima ancora che fosse finito l’elettroencefalogramma. Il tracciato non rivelava niente di anormale. E comunque in nessun caso l’infarto dava quei dolori che avevo descritto. Senza contare che il cuore non era affatto dove indicavo io, era molto più in basso. Doveva quindi essere un dolore intercostale. Probabilmente ero caduto, e non me ne ricordavo, dicevano, sottintendendo che poteva esserci una relazione con il mio tasso alcolico. In ogni caso mi avrebbero misurato la troponina, e mi avrebbero tenuto lì fino al mattino in osservazione.
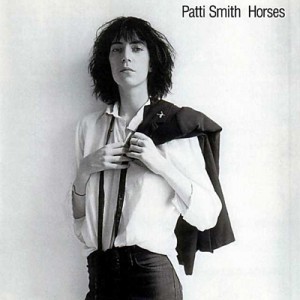
















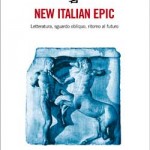


 di Giacomo Sartori
di Giacomo Sartori

 di Giacomo Sartori
di Giacomo Sartori




