
La prima e unica indagine del Prof. Salvo Perricone
ANTEFATTO
30 marzo 1947
“Andrea Raia di Casteldaccia, sindacalista, ucciso dai mafiosi locali mandati dai grossi proprietari terrieri fascisti e separatisti nell’agosto del ’44. Agostino D’Alessandria, di Ficarazzi, segretario della camera del lavoro, ucciso a settembre del ’46 per la sua lotta contro la mafia che controlla i pozzi per l’irrigazione. Gaetano Guarino, sindaco socialista di Favara, ucciso a maggio del ’46 dopo appena sessantacinque giorni dalla sua elezione; la sua unica colpa: chiedere a gran voce l’attuazione dei decreti Gullo per la ridistribuzione delle terre incolte. Pino Camilleri, sindaco socialista di Naro. E di recente, negli ultimi mesi, i nostri compagni e amici Accursio Miraglia, a Sciacca, e Pietro Macchiarella, a Ficarazzi, Leonardo Salvia, a Partinico…”.
In trentamila stavano ascoltando, senza fiatare, quel lungo elenco di nomi. Uomini, donne in rigoroso silenzio. Anche i bambini non fiatavano: i neonati erano stati attaccati al seno dalle madri per non farli piangere, i più grandicelli zitti per paura di prendere qualche scappellotto dai padri. Trentamila contadini giunti a Palermo da tutti i paesi della Sicilia occidentale, volti scavati dalla fame, coppole e vestiti logori. Molti di loro con gli occhi pieni di lacrime: i nomi che Li Causi, dal podio, stava elencando, erano stati compagni di tante lotte.
“È a loro che dobbiamo la vittoria di oggi. Al loro sacrificio”.
Un applauso scrosciante sostituì il silenzio.
Salvatore sentì il fragore di quel battere di mani quando era già arrivato al centro dei Quattro Canti. Camminava cercando di non pestare la distesa di merde di cavallo e di mulo che riempiva via Maqueda. La protesta era arrivata in città a dorso di scecco e aveva lasciato un palmo di concime lungo le strade, fin sopra i marciapiedi. Un percorso insidioso, soprattutto per le sue scarpe nuove, comprate, con tanti sacrifici, qualche giorno prima.
Stava tornando alla stazione centrale per prendere l’ultima corriera, quella delle 18, che l’avrebbe riportato a casa. Non vedeva l’ora di raccontare a sua moglie Giovanna, per filo e per segno, tutti i momenti di quella eroica giornata: l’incontro, all’alba, con i compagni davanti alla Casa del Popolo nella piazza del paese, poi il viaggio di andata in corriera in un misto di speranza e di paura per le sorti della manifestazione che da settimane stavano organizzando, l’arrivo a Palermo, il raduno a piazza Indipendenza con i rappresentanti delle centinaia di leghe cooperative nate negli ultimi tre anni, gli stendardi che riempivano l’area, la marcia verso la sede dell’Alto Commissario per la Sicilia, le bandiere rosse dei Fasci Siciliani che, tirate fuori dai loro nascondigli, di nuovo tornavano a sventolare, la delegazione, guidata da Mommo Li Causi che entrava dentro il palazzo, ore e ore di composta attesa e poi infine l’esplosione di applausi quando Li Causi, uscito dall’incontro con l’Alto Commissario, salito su un podio costruito alla buona durante l’attesa, aveva dichiarato vittoria.
Sulla corriera, seduto in disparte, mentre i suoi compagni ridevano e festeggiavano, Salvatore Perricone stava in silenzio, si godeva il paesaggio e la sensazione di soddisfazione che gli riempiva l’anima. La stanchezza per l’interminabile marcia era svanita. Così come erano svanite anche la paura per il futuro incerto e la rabbia contro il gabellotto mafioso al soldo del barone che l’aveva minacciato fino a pochi giorni prima. La gioia per il risultato raggiunto in quella giornata di vittoria del movimento contadino aveva annullato anche il dolore ai piedi per le scarpe nuove.
Sorrideva pensando alle tonnellate di letame che ingombravano le strade di Palermo. E, pieno di letame, oltre alle strade, c’era anche l’Alto Commissario per la Sicilia che adesso doveva per forza applicare i decreti Gullo dopo tre anni dalla loro emanazione. Tre anni in cui il blocco formato da politici, latifondisti e mafiosi aveva spadroneggiato infischiandosene della riforma agraria proposta dal Comitato di Liberazione Nazionale.
Giovanna ci avrebbe creduto? Avrebbe creduto che finalmente, dopo anni di lotte, avrebbero avuto anche loro diritto alla terra?
Sceso dalla corriera si mise a correre verso casa, veloce, incurante dei compaesani che lo chiamavano per avere notizie della marcia. Aprendo la porta trovò un gran casino: i pochi mobili erano riversi a terra, le sedie a gambe all’aria, il tavolo addossato a una parete. Si diresse verso l’unica altra stanza e trovò la moglie in lacrime, sul letto, mezza nuda, con la veste a brandelli.
Salvo non disse niente, le si sedette accanto e la strinse a sé.
“Don Calò fu, con suo figlio e suo compare”.
Furono queste le uniche parole, intervallate da lunghi singhiozzi, che udì da lei per molti e molti giorni.
*
11 maggio 2024
Questa terra, questa sconfinata solitudine schiacciata dal sole, è la Sicilia, che non è soltanto il ridente giardino di aranci, ulivi, fiori che voi conoscete, o credete di conoscere, ma è anche terra nuda e bruciata, muri calcinati di un biancore accecante, uomini ermetici dagli antichi costumi che il forestiero non comprende. Un mondo misterioso e splendido di una tragica ed aspra bellezza…
“Ivan, per favore, metti in pausa”.
La voce fuori campo si interruppe, Salvo accese la luce, un paio dei suoi studenti strinsero gli occhi che ormai si erano abituati al buio della sala.
“Ecco, adesso guardate le prossime scene del film. Immaginate i personaggi con cappelli e vestiti da cowboy. Questo di Pietro Germi è indubbiamente il primo western italiano. Ivan, premi play”.
Le scene di In nome della legge si susseguirono proiettate sullo schermo: i banditi mascherati, l’agguato e l’esecuzione del carrettiere, il furto dei muli. L’antesignano degli spaghetti western di Sergio Leone.
“Ivan, metti di nuovo in pausa. Ecco, state attenti adesso a quello che succede: questa è una delle prime pellicole in cui si comincia a trattare il tema del rapporto tra mafia e latifondismo. Tra un po’ il barone Lo Vasto lo dirà chiaramente che i notabili del tempo facevano affari con i campieri e con i gabellotti che rappresentavano la mafia di allora”.
“Prof, ma così ci sta spoilerando tutto il film”.
La voce arrivò dal centro della sala provocando una risata collettiva.
“Avete ragione! Dai, Ivan, attacca, proverò a non interrompere più”.
Salvo Perricone amava alla follia tutto il cinema neorealista, in particolare adorava i film e i documentari che raccontavano il mondo contadino. E In nome della legge, capolavoro del 1947 di Germi, era uno dei suoi preferiti.
Ci aveva pure scritto un libro su quell’opera.
Poca cosa, comunque, in confronto alle dozzine di saggi che invece aveva dedicato alla storia del movimento contadino e alle lotte popolari dell’Ottocento e del Novecento italiano.
Salvo ci aveva costruito tutto il suo percorso accademico su quel periodo storico: prima da studente, poi da dottorando, dopo da ricercatore. E ora, da professore associato dell’Università di Palermo.
Anni e anni di studi e di meticolosa ricerca storica gli avevano permesso di ingraziarsi il professore Vinciguerra, il titolare della cattedra di Storia contemporanea della sua facoltà. Vinciguerra lo aveva voluto prima come assistente e in seguito come associato, affibbiandogli tutto il lavoro: le lezioni, gli esami, i ricevimenti con gli studenti. Ma Salvo non percepiva tutto questo come sfruttamento, anzi, al contrario, era felice del suo ruolo: amava trasmettere le proprie conoscenze, lo faceva con passione, con dedizione. E gli studenti, a loro volta, lo amavano. Era un giovane professore dai modi poco convenzionali che riusciva a catturare l’attenzione di tutta l’aula, soprattutto l’attenzione delle studentesse e in particolare quella di Agnese, ricercatrice fresca fresca di incarico che lo seguiva in tutte le attività didattiche da lui proposte: gruppi di ricerca, organizzazioni di mostre, rassegne cinematografiche a tema, convegni, lezioni di approfondimento. Agnese aveva una cotta stratosferica per Salvo.
Anche Ivan, l’altro ricercatore, l’aveva. Ma, a differenza di Agnese, Ivan, pigro com’era, non aveva voglia di impegnarsi di più nella sua ricerca per poter trascorrere più tempo con il suo amato professore.
I titoli di coda cominciarono a scorrere sullo schermo dopo la cavalcata del mafioso Don Turi, interpretato da Charles Vanel, e dei suoi uomini.
Salvo Perricone accese le luci in sala. “Allora, che ne pensate? Commenti?”.
Agnese intervenne immediatamente, scatenando la gelosia di Ivan: “È emblematica nel film la figura del giovane magistrato Guido Schiavi. La sua insistente lotta contro l’ingiustizia fa quasi tenerezza. Io la trovo mielosa…”.
L’intervento dal tono cinico di Agnese venne interrotto sul nascere dallo squillo di uno smartphone.
Salvo si guardò attorno irritato: “Per favore! Vi ho sempre chiesto di tenere i cellulari spenti in aula…”.
Si interruppe vedendo Ivan, accanto al proiettore, che gesticolava per attirare la sua attenzione. Il ragazzo indicava con insistenza la valigetta in pelle che il professore teneva sulla cattedra.
Salvo, rosso di vergogna, si scusò con la platea e tirò fuori dalla borsa lo smartphone.
Sullo schermo lesse un nome che lo incupì: Mario Sinna.
*
Salvo chiuse la porta dell’aula alle sue spalle lasciando dentro Agnese che aveva ripreso il suo intervento.
Rispose al telefono con tono infastidito: “Mario, dimmi, che c’è? Sono a lezione. È urgente?”.
“Certo che è urgente. Altrimenti non ti avrei chiamato. Lo so che a quest’ora sei all’università, sono dieci anni che sei sempre lì”.
“Che fa sfotti?”.
“No, assolutamente!”.
Salvo percepì il tono sarcastico dell’amico.
“Dai, non farmi perdere tempo, ho gli studenti che mi aspettano”.
“E mi sa che devono aspettare un po’. Ho bisogno di te. Stamattina abbiamo trovato il cadavere di una persona di novant’anni”.
“E io che c’entro, Mario? Le persone a novant’anni muoiono. È così che va la vita”.
“Sì, solo che questo non è morto per cause naturali. È stato ucciso nel letto mentre dormiva”.
“Oh, cazzo! A quell’età? È stata una rapina?”
“Dentro casa sembra non manchi niente. C’è tutto: soldi, gioielli… No, non si tratta di una rapina”.
“E quindi?”.
Silenzio.
“Mario, scusami, devo continuare a farti io le domande o vuoi finalmente svelarmi il motivo di questa telefonata?”.
Silenzio.
“Ohi, Mario, ci sei ancora? Pronto. Mario?”.
Ancora silenzio.
“Pronto. Ma che fa, è caduta la linea? Mario?”
“Scusa, è che sono rientrato nella stanza da letto. Qui la scena del delitto è assurda. Sembra il set di un film horror. C’è sangue ovunque. Ti ricordi quando eravamo bambini e abbiamo assistito all’omicidio di Nino ’U Summaccu? Ti ricordi quanto sangue c’era sul muro della sala biliardo? Qui ce n’è molto, molto di più! Credimi”.
Salvo si perse nei ricordi: Nino ’U Summaccu era stato il primo della catena di morti ammazzati a Belmonte Mezzagno durante la seconda guerra di mafia dall’81 all’84. Gli avevano sparato in faccia in pieno giorno mentre ancora aveva la stecca in mano dopo un tiro a carambola. Il killer mandato dai corleonesi era fuggito via nello stesso istante in cui Salvo e Mario stavano entrando nella sala. La scena terrificante che si era svelata ai loro occhi non l’avrebbero più scordata.
“Sì, certo che lo ricordo. Hanno sparato in faccia pure a questo novantenne?”.
“L’hanno sgozzato come un animale e con il sangue l’assassino ha scritto una frase sul muro. È per questo motivo che ti ho chiamato. Ho bisogno del tuo aiuto per decifrare la frase”.
“Scusami, Mario, ma non ho capito. E perché telefoni a me? Cos’è, mi hai fatto un contratto da consulente e io non me ne sono accorto? Io mica sono della polizia scientifica!”.
La porta alle sue spalle si aprì, e via via gli studenti cominciarono a uscire. Agnese per ultima.
La ragazza si fermò a pochi passi da lui “Prof, tutto bene? È successo qualcosa di grave?”.
Salvo con un cenno della mano la tranquillizzò: “Tutto bene, grazie. Sono al telefono con un amico”.
Quando Agnese si fu allontanata, riprese la conversazione telefonica: “Mario, scusa, i miei studenti sono appena andati via, li ho salutati”.
“Scusami tu per avere interrotto il tuo lavoro. Mi sei venuto in mente e ti ho chiamato senza pensarci su. Ho bisogno che mi aiuti a capirci qualcosa. In vent’anni di servizio non avevo mai visto niente di simile”.
Il tono del maresciallo Mario Sinna non era spavaldo come al solito. La sua era davvero una richiesta di aiuto.
Salvo si mise in modalità ascolto.
“Con il sangue schizzato dalla giugulare l’assassino ha scritto: …è del sistema e l’ha scritto su un foglio di carta attaccato con lo scotch alla parete. Aspetta che ti leggo il resto: Persuadevo dolcemente i lavoratori morenti di fame che la colpa non è di alcuno… E poi ci sono decine di volantini ciclostilati attaccati in giro per la stanza, volantini comunisti che inneggiano al movimento contadino, alla distribuzione delle terre. Che significa, Salvo?”.
“La frase che mi hai letto è di Nicola Barbato, capopopolo dei Fasci Siciliani dei Lavoratori. È un pezzo del suo discorso al processo dell’aprile 1894 dopo la messa al bando del movimento…”.
“Hai visto che avevo ragione a chiamarti? Lo sapevo che avresti decifrato la frase. È il tuo mondo, questo. A che ora torni in paese? Vorrei mostrarti le foto degli altri reperti trovati a casa del morto”.
“Rientro alle 18. Dove ti raggiungo? Chi è il morto?”.
“È Don Ciccio Passalacqua, il vecchio capomafia in pensione ormai da vent’anni”.
“Cazzo, Don Ciccio? Ma perché non me lo dicevi prima?”.
“Perché se lo avessi fatto, non mi avresti aiutato”.
Filippo Pistoia (Palermo, 1975) da più di vent’anni è manager di progetti culturali in Sicilia. Negli ultimi anni ha concentrato le sue energie sul processo di rivitalizzazione dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo In Terra colta, il suo primo romanzo, ha provato a fondere le sue due principali passioni: le lotte contadine del Novecento e il noir mediterraneo.
 Gianni Biondillo intervista Leonardo Colombati
Gianni Biondillo intervista Leonardo Colombati










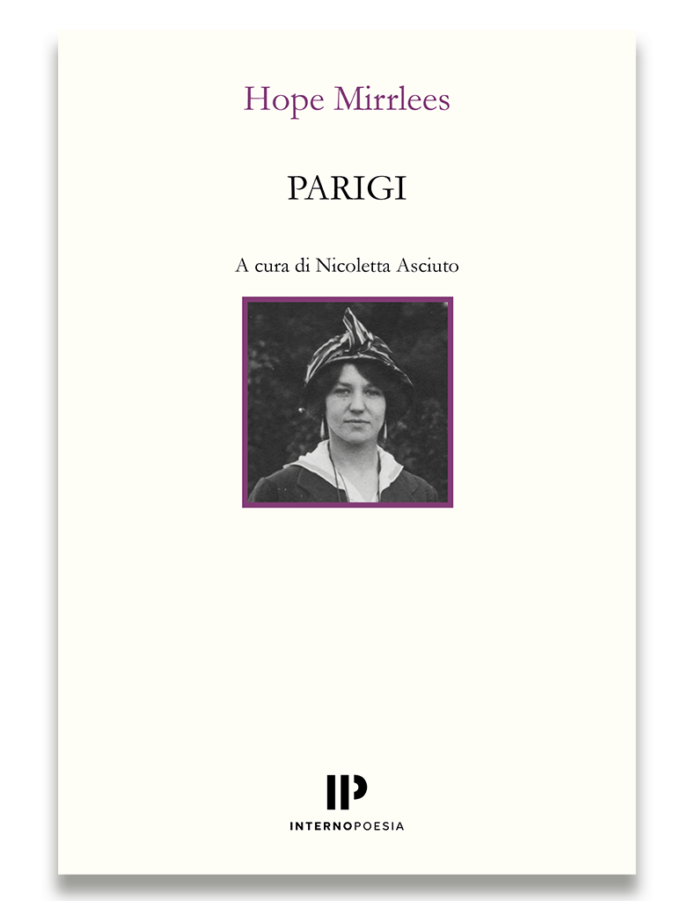
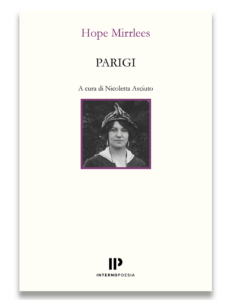




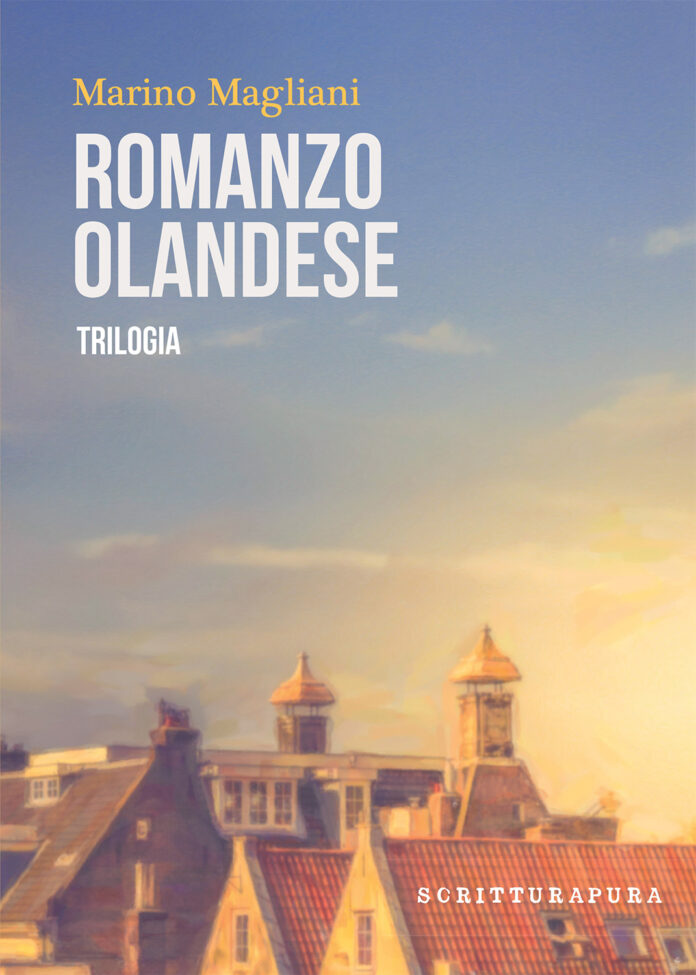
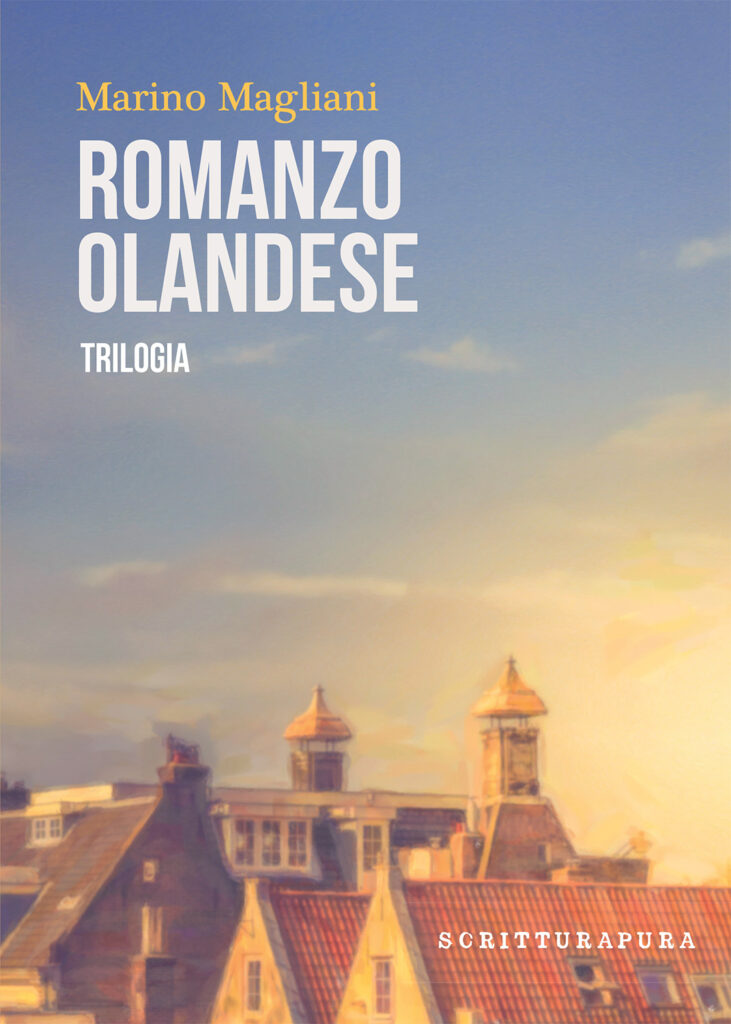
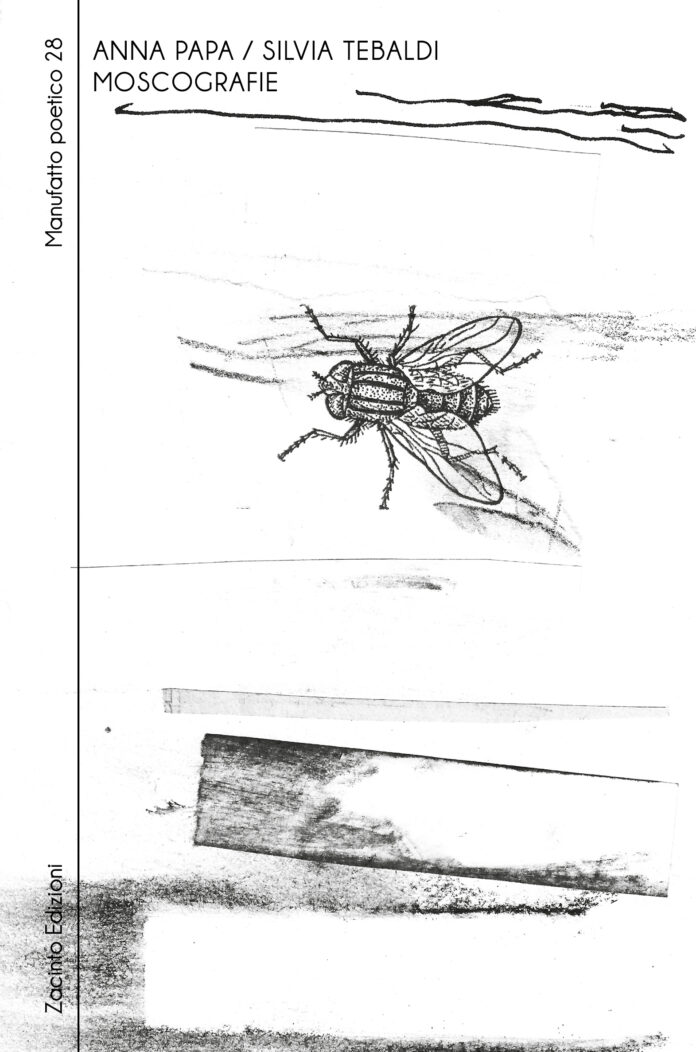
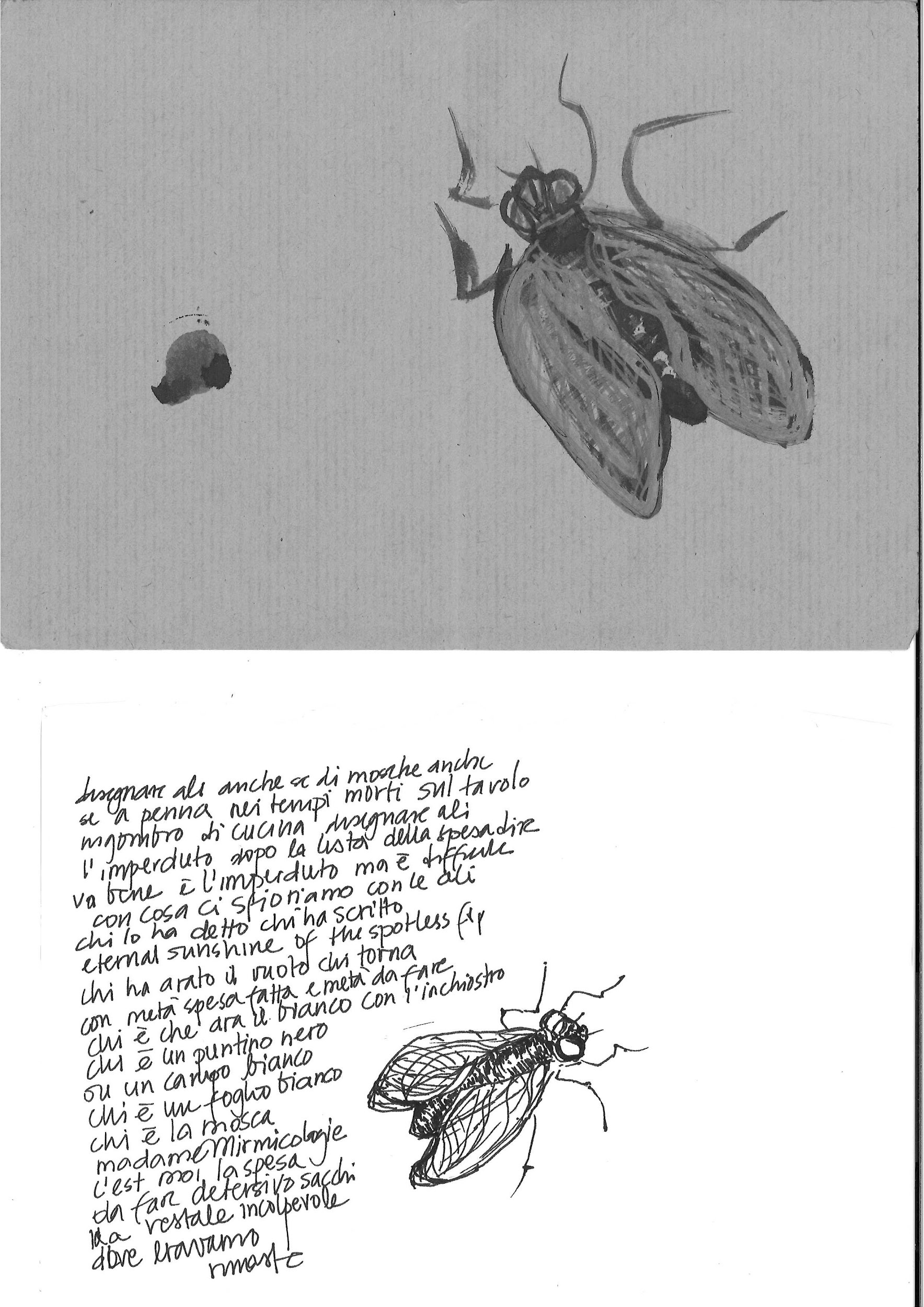


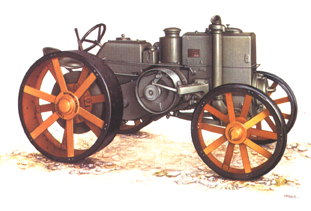







 di Gianluca Veltri
di Gianluca Veltri

