 di
di
Francesco Forlani
Di lui mi ritorna in mente il viaggio fatto in macchina da Napoli al cuore degli Abruzzi, dal Molo Beverello a Torricella Peligna. Quattro parole magiche che se pronunciate una dopo l’altra, articolando bene le sillabe, ti suggeriscono quell’altra che è destino. Quasi un moto d’emigrazione, il nostro, ma di ritorno. Del resto il sogno “sospeso” di Francesco è sempre stato quello: far sorgere poco distante dal luogo del nostro appuntamento, all’Immacolatella vecchia, un museo dell’Emigrazione in grado di raccogliere oggetti, testimonianze scritte e orali, una memoria viva del viaggio non solo fisico ma anche linguistico di intere popolazioni delle nostre regioni catapultate nel mondo. Un luogo in cui raccogliersi. Perché lui era dalla loro parte, da vero aristocratico nutriva una stima profonda per i penultimi, un profondo affetto per quelli che avrebbero potuto “non farcela”. Chi altri, del resto, se non lui, pioniere delle lettere, rigoroso e sperimentale, poteva far rivivere i destini di un centinaio di esploratori italiani del vasto campo della lingua e della vita americana, attraverso il magnifico progetto di Italoamericana, opera in due volumi dedicata proprio a nostri illustri o per nulla compaesani.
Di quel viaggio agile, danzante, mi ritornano in mente le canzoni ascoltate, evocate e perfino cantate, ma anche la tratta in cui mi ritrovai a fargli da audiolibro. In quell’edizione 2010 del festival John Fante di Torricella Peligna, Francesco avrebbe infatti dialogato con Jonas Hassen Khemiri a proposito del romanzo Una tigre molto speciale e poiché aveva bisogno di rivedere alcuni passaggi del secondo capitolo mi chiese di leggerglielo strada facendo. Cosa che naturalmente feci con piacere adoperandomi, con vocine ed effetti speciali a seconda dei personaggi e delle scene, a che la narrazione fosse quanto più avvincente possibile. Ridemmo molto.
Di lui mi viene in mente la sua arte della conversazione e del cazzeggio, l’idea di letteratura e della vita come una grande recita in cui è appunto il gioco dell’attore a fare la differenza, la purezza del giocatore a rendere ogni partita degna di essere giocata, a prescindere dal risultato. Tante sono state le testimonianze di stima, di vero affetto nei suoi confronti, in questi giorni. Particolarmente toccanti sono state quelle di Giovanna Di Lello, direttrice artistica del Fante, di Titti Marrone sul Mattino e di Antonio D’Orrico sul Corriere. Ho chiesto proprio a Titti, curatrice del bel volume collettivo dedicato a Pino Daniele, Ho sete ancora, di rendere disponibile per i lettori di Nazione Indiana, blog che ha sempre seguito da fiancheggiatore, il racconto e la canzone che Francesco Durante aveva scelto. Ho pensato che questo sentire la sua voce d’autore fosse il modo migliore per ricordarlo, insieme alla nota che Marco Petrillo, suo storico amico friulano, ha redatto per noi. Mi raccomando, leggetelo ad alta voce, fatelo rivivere anche solo per un po’, perché la musica possa farci da compagna per il resto del viaggio. Ciao Fra. On the road again.

Quanno chiove
Ascoltare Pino Daniele sul raccordo autostradale Pordenone-Portogruaro
di Francesco Durante
Alla fine dell’estate 1979 scambiai il mio meraviglioso spider Triumph con una Citroen CX vasta e lunga come un piroscafo. Ne era stato proprietario
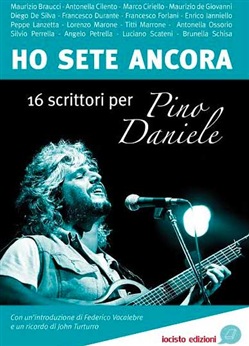 il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.
il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.
Le ragazze straniere non avevano pregiudizi nei confronti della Triumph. Anzi: si divertivano. Con le italiane era diverso. Il mio statuto di “young professional”, però di sinistra, pareva a loro in aperta contraddizione con un’autovettura dall’aria un po’ troppo fighetta. Ebbi una contrastata relazione con una studentessa di Trento che su quella mia macchina ci saliva soltanto in incognito, e non riuscii a farle accettare l’idea che guidare uno spider non era di necessità un gesto antiproletario, bensì, prima di tutto, una cosa molto divertente. Con la CX era tutto un altro discorso. Era enorme ma a suo modo più sobria. Aveva questa cosa bellissima che, quando la mettevi in moto, dovevi prima aspettare che si sollevasse sulle ruote. Munita di alzacristalli elettrici (una rarità all’epoca), era silenziosissima, spaziosissima, comodissima anche in occasione di utilizzi un po’ più informali. In più, era dotata di un formidabile impianto stereo Pioneer, di quelli che, come si diceva una volta, spaccavano il culo ai passeri.
Lavoravo come cronista al quotidiano “Il Piccolo” di Trieste. Mi avevano incaricato di curarne le pagine friulane, e dunque facevo la spola tra Udine e Pordenone. Erano tempi in cui la giornata di lavoro non finiva praticamente mai: fino a oltre la mezzanotte ci si doveva dar dentro, magari per andare a far le foto di un incendio. Poi, però, c’era per l’appunto la notte, e passarla sostanzialmente in bianco era quasi un dovere.
Piripicchio una sera venne a trovarmi in redazione accompagnato da Kramer, il cantante di blues soprannominato “il negro bianco”. Vennero col Triumph che gli avevo ceduto e ricordo che mi fecero notare un problema di carburazione di cui, al momento dello scambio, non avevo fatto menzione (e del quale, probabilmente, non m’ero mai accorto). Non fu una recriminazione, tutt’altro. Piripicchio si rendeva perfettamente conto della mia totale ignoranza in fatto di motori, dunque non metteva in dubbio la mia buona fede. Gli dissi che nello scambio ero stato certamente io quello che c’era andato meglio, perché lui, invece, di motori ne capiva, e la CX era assolutamente perfetta in ogni dettaglio. Quella notte la usammo per tirar mattina tutti e tre insieme.

“Ho una nuova cassetta che voglio farvi ascoltare”, annunciai. E verso l’una partimmo.
Sul sedile posteriore, Piripicchio rollava canne, Kramer e io parlavamo del più e del meno, lui soprattutto di quella stronza per la quale aveva perso la testa, tanto da inviarle anche sei lettere d’amore al giorno senza che mai lei si fosse degnata di rispondergli. In cinque minuti fummo all’imbocco dell’autostrada Pordenone-Portogruaro, 26 kilometri molto rettilinei e soprattutto (a quell’ora) sostanzialmente deserti. Fu allora che inserii la cassetta nello stereo, alzai il volume al massimo, sigillai i finestrini e feci partire il secondo album di Pino Daniele. Nel silenzio raccolto dell’attesa, esplose Je sto vicino a te. L’auto era arrivata all’altezza di Azzano Decimo quando Piripicchio rilasciò il primo commento. Disse: “Non capisco una minchia, ma il sound è proprio buono. Mi acchiappa. Sembra George Benson”.
(A beneficio di quanti potrebbero ritenere impossibile tanta ignoranza di Pino Daniele a quel tempo, debbo chiarire che noi, in fatto di gusti musicali, si era ancora fieramente anti-italiani. Non ci pareva possibile che in Italia si facesse della musica accettabile, anche se qualche eccezione ormai c’era: la Premiata Forneria, il Banco, poco altro tra cui qualche cantautore, ma in dosi omeopatiche. Sapevamo invece tutto delle band americane o inglesi, e perfino del rock elettronico tedesco.)
A Portogruaro uscimmo dall’autostrada per riprenderla in senso inverso mentre partiva Chillo è nu buono guaglione. Il negro bianco si entusiasmò poco dopo all’ascolto di Ue’ man (che a me per la verità ha sempre detto poco), e poi – più o meno all’altezza del casello di Chions – tutti concordammo sul fatto che la canzone che ora stavamo ascoltando, vale a dire Donna Cuncetta, era semplicemente strepitosa. Talmente strepitosa che, giunti a Pordenone, riprendemmo la via per Portogruaro, per poi tornarcene e ripartire e rifare il tragitto ancora un altro paio di volte, tutti e tre ormai preda di una esilarante sensazione di straordinaria lucidità mentale dentro il fumosissimo, musicalissimo, ritmatissimo abitacolo: benandanti felici nel pieno di una magica notte stellata in mezzo alla pianura del Friuli occidentale.
Piripicchio e Kramer venivano da Sacile (“il giardino della Serenissima”) e non avevano la benché minima idea del dialetto napoletano. Così mi misi a spiegargli le parole di Donna Cuncetta.
“C’è questa vecchia che si chiama Concetta, una che rimpiange i bei tempi andati, e dice che il tempo delle ciliegie è già finito.”
“Ti credo: è autunno.”
“Ma no, il tempo delle ciliegie nel senso di un’età benedetta e ormai lontana. Ed è come se nella massa nera dei suoi capelli raccolti fossero racchiuse tutte le paure di un popolo che cammina rasente il muro.”
“I napoletani? Rasente il muro?”
“È una metafora. Come dire che il popolo napoletano – il popolo basso, il popolino – da sempre è stato abituato a sopportare, a tenersi tutto dentro, a dissimulare, dunque a non esporsi. E poi considera che nei vicoli, anche se non vuoi, finisce che cammini sempre rasente il muro, perché altrimenti ti mettono sotto coi motorini. Ma insomma, ecco che poi Pino esorta Donna Concetta. Le dà del voi, come si fa a Napoli, e le dice: tirate fuori tutti i ricordi dal cuore, e mettetevi finalmente a gridare come mai avete avuto il coraggio di fare nella vita.”
“Una cosa rivoluzionaria?”
“Direi di sì. Poi però arriva questo pezzo così dolce, così sognante. Donna Concetta è come se avesse una visione: se volesse Dio, se lui volesse dare una mano a questa mia fantasia, getterei tutto a mare. Però sono vecchia, posso soltanto dormire, mi sento come uno straccio in mano alle gente e posso soltanto stare a guardare. Ma se fossi un ragazzo, se avessi l’energia di un ragazzo, di sicuro sarei un caporione, e quando soffia il vento – il vento della ribellione? ma sì – allora senza paura direi la mia. Ah, se soltanto lo volesse Dio!”
Ci fu un momento di pausa. Poi, e sia pure impastando un poco le parole, Kramer ci consegnò una perla di adamantina acutezza.
 “Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”
“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”
“Guarda Kramer, sono già un bel po’ di anni che a Napoli si fa una musica nuova piuttosto interessante. Gli Osanna, il Balletto di Bronzo. Per non parlare della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Ma che te lo dico a fare? Tu non hai mai avuto la pazienza di ascoltarti tutta la Gatta Cenerentola. A Padova, all’università, abbiamo fatto le notti con Jesus Christ Superstar, ne conosciamo ogni virgola, e invece quel capolavoro piaceva solo a me. Sai che ti dico? Napoli, e non solo per evidenti ragioni geografiche, è la nostra West Coast.”
“Comunque la mia teoria è che noi italiani, per fare qualcosa di buono in campo musicale, dobbiamo cercarci una lingua che sia sì italiana, ma in modo diverso. Meno condizionata dalla tradizione.”
Piripicchio ascoltava nel frattempo, per l’ennesima volta, Je sto vicino a te, e menando fendenti con le braccia e con le mani sottolineava il ritmo delle anticipate nell’inciso “ma che parlammo a ffà”. Siccome era un bassista, gli piaceva particolarmente il ricco corredo ritmico, il complesso e intrecciato lavoro di basso e batteria. “Pompa che è una meraviglia. Ma chi se ne fotte delle parole? Io dico che se non c’è la musica, se non ci sono i musicisti con i controcazzi, il resto non conta niente”.
Parole sante, a modo loro.
***
In quei mesi del 1979 non potevo neanche lontanamente immaginare che di lì a poco la mia vita sarebbe radicalmente cambiata: che dal “Piccolo” sarei passato al “Mattino”, e da Trieste a Napoli. Benché vi transitassi ogni estate per andare a Capri, Napoli era per me soltanto la Stazione Centrale, via Marina ancora coi segni dei bombardamenti, e il Molo Beverello. Poteva starci al massimo una rapida sosta da Pizzicato, in piazza Municipio, e poi era il ponte di un traghetto o il pozzetto di un aliscafo da cui assistere allo squadernarsi della bellezza man mano che si prendeva il largo.
A Napoli ci arrivai nella primavera del 1980 a bordo della mia formidabile CX. Coi miei nuovi colleghi facemmo in tempo a usarla poche volte. Per esempio, un giorno che, al termine di un’assemblea, era stato proclamato uno sciopero dei giornalisti, partimmo issofatto per Positano. Per il resto, tragitti brevi e brevissimi, in città. Scendevamo dal Casale di Posillipo, dove si coabitava in tre, e andavamo al giornale dove, all’epoca, si faceva sempre molto tardi.
Insomma, potevano essere passati quindici o venti giorni da quando ero arrivato, una notte esco dal giornale e la macchina non c’è più. La cerco per un’ora o due, conscio del fatto che non mi ricordavo mai bene dove l’avevo parcheggiata. Poi ritorno su in preda all’agitazione e un collega della nera prova a telefonare a due o tre “scassi” per vedere se per caso qualcuno gliel’aveva portata. Alla fine realizzo che me l’hanno proprio, e definitivamente, rubata. Soprattutto, il giorno dopo, chiamando l’assicuratore in Friuli, apprendo che non l’avevo mai assicurata contro il furto. Entro insomma in una nuova fase più francescana dell’esistenza, caratterizzata da una serie di Maggioloni Volkswagen, tutti rigorosamente usati e provvisti di una deliziosa aria un po’ vintage. I miei cinque anni successivi, da questo punto di vista, sarebbero stati tutti tedeschi, a parte un vespino che credo mi venne trafugato non più di quattro o cinque ore dopo l’acquisto.
Tutto sommato, andava bene così. L’esperienza mi insegnava che una delle più evidenti differenze tra il vivere a Napoli e il vivere nel Friuli-Venezia Giulia consiste nel diverso grado d’importanza del mezzo di trasporto. A Napoli il macchinone non mi serviva proprio, anzi: sarebbe stato una condanna. Vuoi mettere una macchina al di sotto di ogni tentazione, che puoi parcheggiare dove ti pare, con la quale puoi farti largo nei viluppi del traffico senza tema di rigarla, di strisciarla, di esporla a ogni forma di usura? Il mio collega Antonio Fiore, da questo punto di vista, faceva scuola: la sua arcaica 124 coupé era talmente malmessa che nelle commessure del cofano ci cresceva l’erba. Carlo Nicotera, un altro collega, aveva un trabiccolo da cui ogni tanto, soprattutto in salita, si staccava una ruota che rotolava a valle e tutti noi dovevamo precipitarci a rincorrerla. Quanto a Michele Bonuomo, quando fece il gran salto e dalla Vespa passò all’automobile, ne comprò una di color grigio metallizzato con certe inspiegabili venature auree: pacchianissima. L’architetto Giannì, suo storico sodale noto per il rigore un po’ snobistico dei gusti estetici, la liquidò senza pietà: “Pare la macchina di un grossista di mozzarelle di San Sebastiano al Vesuvio”. Al confronto, i miei Maggioloni, per quanto scassati e comunque sempre efficienti come quello del “Dormiglione” di Woody Allen, andavano che era una bellezza.
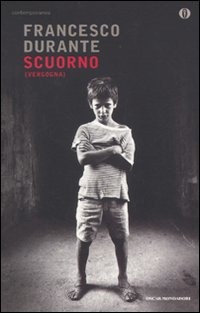 Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi.
Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi.
Tornando a Quanno chiove, la prima cosa che mi piacque di quella canzone fu la sua sostanza tendenzialmente infinita, come il celebre assolo di sax di James Senese che la impreziosisce. Mi spiego: è un meccanismo musicale perfetto, con dentro un’armonia complessa e molto varia (un gruppo come gli Oasis, per dire, se si fosse imbattuto in questa sola canzone, ne avrebbe potuto trarre materiale per almeno un paio di album), che nel segno di Pino fonde insieme tutte le settime del blues e tutte le accensioni liriche della tradizione napoletana, facendone una mescola inimitabile. Specialmente l’inciso, che trovo bellissimo, compie il miracolo di staccarsi nettissimamente, eppure con una morbida naturalezza, dalla strofa che lo precede, mutando completamente il piano musicale, e attingendo un ritmo dolcissimo e sognante, la cui aderenza al reale andavo scoprendo proprio in quell’autunno piovoso: “E aspietta che chiove / l’acqua te ‘nfonne e va / tanto l’aria s’adda cagna’”, parole sostenute da una musica così urgente e necessaria da dover essere ribadite sopra una ulteriore costruzione armonica gemmata dalla precedente: “ma po’ quanno chiove / l’acqua te ‘nfonne e va / tanto l’aria s’adda cagna’”.
Ora dovrei dire che cosa mi ritorna in mente quando ascolto quella canzone, giacché si sa che le canzoni hanno questa fondamentale caratteristica, di essere la colonna sonora della nostra vita, dei momenti più memorabili che abbiamo vissuto. Ma il problema è che talora le canzoni – le belle canzoni – scelgono la nostra vita per sottolinearne certi snodi anche a posteriori; e il resto lo fa la nostra memoria selettiva, capace com’è di essere del tutto arbitraria, e di scegliere, poniamo, che mentre Pino cantava Quanno chiove ci eravamo innamorati di quella ragazza lì, di quella e non di un’altra. Ma io non posso sostenere seriamente un’ipotesi del genere. Di fatto, questa canzone non mi rimanda un singolo episodio o una situazione particolare. Col tempo, posso dire di averla eletta al rango di una specie di inno che sa far rivivere per un momento tutta una stagione felice, e che a mano a mano che quella stagione si allontana nel tempo è capace di eccitare ancora la mia commozione, perfino di farmi spuntare una lacrima.
Curioso effetto: perché poi in Quanno chiove vibra anche un notevole dinamismo: c’è qualcuno che scende le scale di corsa “senza guarda’”, e c’è chi ridendo va al lavoro. Ma è come se a ogni fuga vitalistica facesse da correlativo una pausa intimistica e francamente malinconica. Tu corri, ridi, vai al lavoro, ma tutta la tua vita se ne va lontano, tanto che cerchi di conservarla (di “astipartela”) per non morire… E poi per l’appunto quell’inciso che assomiglia a un “adda passa’ ‘a nuttata” rivisitato quarant’anni dopo. C’è del fatalismo, sì, nell’aspettare che piova, e che un’acqua lustrale ci inzuppi, animati da quella piccola fede elementare secondo cui, dopo lo scroscio, l’aria dovrà cambiare e, chissà, qualcos’altro prima o poi succederà.
 A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.
A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.
Quando stavo ancora in Friuli, un paio d’anni prima di trasferirmi a Napoli, mi capitò di leggere il romanzo di Nicola Pugliese Malacqua. Era una cosa nuova, garantita da Calvino in una collana di scritture sperimentali. In quel periodo leggevo soltanto quella roba lì, oppure classici o semiclassici. Malacqua mi colpì perché ribaltava l’immagine consueta di Napoli. Anni dopo avrei imparato che l’immagine piovorna della città era tutt’altro che abusiva, e, per esempio, m’imbattei in titoli di opere letterarie come Prologo alle tenebre di Carlo Bernari, o Una spirale di nebbia di Michele Prisco, per non dire de La morte della bellezza di Giuseppe Patroni Griffi, le quali rinviavano un’idea radicalmente diversa a proposito di un luogo che tutta Italia è abituata ad associare al sole, alla luce piena, persino impietosa e sferzante, veicolata dalle canzoni, o da molta letteratura di successo (penso a Giuseppe Marotta). Ecco: Quanno chiove – e a Napoli, ormai lo sapevo, chiove spesso e in modo abbondante – mi diceva la stessa cosa, che cioè la luce, il sole, l’esibito e impudico pulsare della vita possono anche essere illusori e nascondere più segreti corrispettivi. Inoltre, mi suggeriva un’altra caratteristica che avrei imparato a cogliere soltanto vivendoci, perché standone fuori se ne ha un’idea del tutto opposta. Che, cioè, Napoli è un luogo di profonde malinconie, e la malinconia – e perfino l’umor nero, l’ipocondria – è il tratto saliente del carattere dei napoletani, e ciò che di molti di loro fa degli artisti.
È per tutti questi motivi che Pino Daniele, fin da quella remota e limpida notte sotto il cielo stellato del Friuli – andando con Pasolini “viers Pordenon e il mont”, verso Pordenone e il mondo: cioè seguendo docili e pazienti l’unico destino possibile per i vecchi contadini di Casarsa, quello dell’emigrazione – mi è rimasto caro sempre, anche quando per alcuni il suo estro s’era ormai piegato a sensi più commerciali e magari un po’ troppo edulcorati. Quell’uomo dalla debordante fisicità, in così palese contrasto con quel filo di voce afona, aveva un modo speciale di dire le cose, e di farle diventare condivise, universali, buone per essere cantate in coro con un’emozione che ancor oggi, dopo tanti anni, appartiene a tutti.

 Frank
Frank
di
Marco Petrillo
“Onnisciente”, mi piaceva definirlo così, ma quando glielo dicevo, lui glissava sorridendo e scuoteva la testa con un “Ma figurati!” a seguire.
Su argomenti del genere era schivo, non ne voleva proprio sapere.
Eppure è la verità, fidatevi, lo conoscevo ormai da più di cinquant’anni, quando già disegnava mappe geografiche dettagliatissime di paesi e città inesistenti, perché l’atlante ufficiale non gli bastava più.
Ora dopo lo scippo ingiustificabile di chi per me era un fratello, una vigliaccata della vita quando ti viene a scovare a tradimento, aggiungo anche “amatissimo”.
Gli volevamo tutti un grandissimo bene, per quel suo sorriso che gli illuminava gli occhi e che poi si apriva in una gran risata, che fosse con gli amici davanti a un gin tonic o sul palco di un teatro a cantare le sue belle cose intinte nel repertorio napoletano che tanto amava.
Quello stesso sorriso con cui cantava “Reginella” alla sensibile professoressa di lettere del liceo.
Era fatto così, voleva la leggerezza attorno a sé, dispensandola a piene mani, amava giocare con un’eleganza che non tutti hanno, pur preso da mille impegni che sapeva affrontare e controllare con precisione svizzera.
Parlare di tutto quello che è riuscito a fare nel suo campo è superfluo, gli articoli tutti sinceri si sono affollati in questi giorni e chi l’ha conosciuto e ci ha lavorato assieme non è riuscito a nascondere la domanda sottintesa “Ma dove trovava il tempo per fare tutto?”.
Risposta mia: “Non aveva bisogno del tempo indispensabile per gli altri, era un fulmine d’inventiva e di capacità critica con un patrimonio culturale inesauribile e di pronto impiego”. Tutto qua.
Era in grado di affrontare qualsiasi argomento letterario, una traduzione, una lettura con la sua bella voce, un’intervista o una recensione, che fluivano con una naturalezza incantatrice, senza esagerare, senza che trasparisse il minimo autocompiacimento.
In mezzo a tutto questo aveva anche modo di fare lo scrittore.
Ora che non c’è più, mi mancherà quella sua capacità di comparire all’improvviso con un messaggio o una telefonata, facendomi delle offerte che secondo lui non avrei potuto rifiutare, a volte matte e a volte sensate, venate da una goliardia mai sopita, ma comunque sempre sue.
Mi mancheranno i suoi bei modi napoletani che mi parlavano di sogni e di imprese, di musica e storie vere o inventate lì per lì, di voglia di vivere e di ricordi belli.
Mi mancherà il suo abbraccio.
Come scriveva Mauro Marè alla fine della sua poesia “Er cinematofrego”:
…..La luce in sala, s’apreno le porte.
Aspetti er bibitaro
e arriva quella stronza della morte.



 di
di
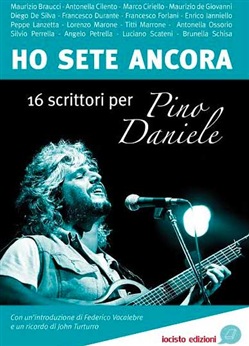 il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.
il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.
 “Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”
“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”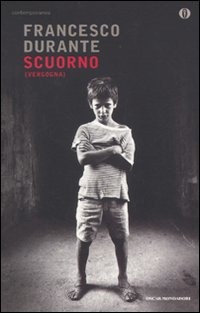 Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi.
Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi. A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.
A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.
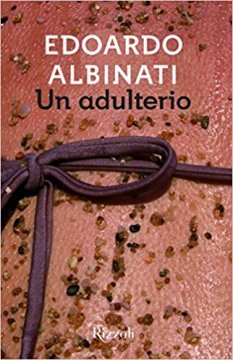

 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese





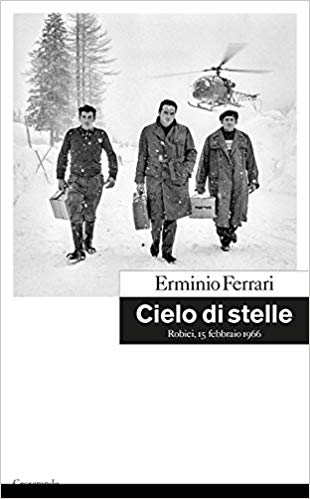

 La sala prove era alla fine di una strada bianca, in un casolare, fra i canneti che, come la casina di Yoda, emergeva dalla mota millenaria di quelle terre, aggrappato all’argine del canale in mezzo ai campi, dove la figlia zoppa e suo padre, il Martini, camminano eternamente scontrosi. Vanno da Cioni Mario, l’unico marito possibile per questa figlia sciancata; – …tanto son di famiglia moritura – le dice il padre, così che quando il povero Cioni ci rimarrà secco fiammifero durante l’amplesso, potranno riunire i poderi e andare in culo al mondo. Ma lei non ne vuol sapere. Mario è brutto. Il Martini la minaccia: – O chi vòi? Marlon Brando? …Sta’ zitta! Ti do uno schiaffo ti spoglio.
La sala prove era alla fine di una strada bianca, in un casolare, fra i canneti che, come la casina di Yoda, emergeva dalla mota millenaria di quelle terre, aggrappato all’argine del canale in mezzo ai campi, dove la figlia zoppa e suo padre, il Martini, camminano eternamente scontrosi. Vanno da Cioni Mario, l’unico marito possibile per questa figlia sciancata; – …tanto son di famiglia moritura – le dice il padre, così che quando il povero Cioni ci rimarrà secco fiammifero durante l’amplesso, potranno riunire i poderi e andare in culo al mondo. Ma lei non ne vuol sapere. Mario è brutto. Il Martini la minaccia: – O chi vòi? Marlon Brando? …Sta’ zitta! Ti do uno schiaffo ti spoglio.


