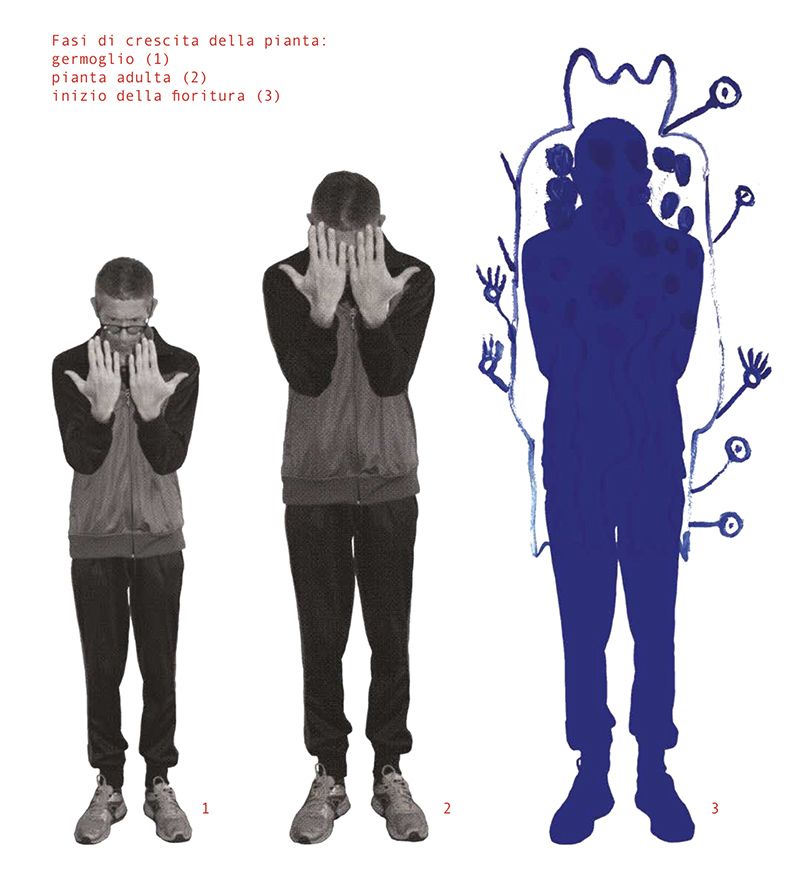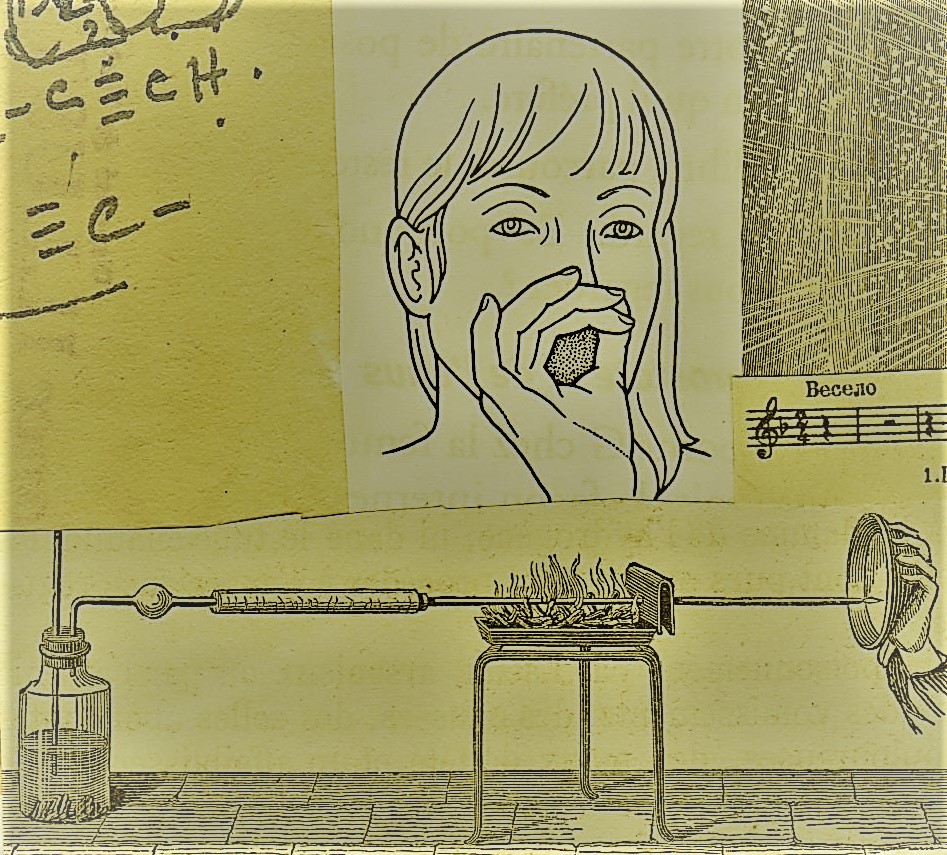“”Dall’interno del veicolo un carabiniere – identificato come Mario Placanica secondo le sue stesse dichiarazioni – dopo aver estratto e puntato la pistola verso i manifestanti intimandogli di andarsene, spara due colpi. Un colpo raggiunge allo zigomo sinistro Carlo Giuliani che morirà nei minuti successivi. Il fuoristrada, nel tentativo di fuggire rapidamente dai manifestanti, riprende la manovra passando sul corpo del ragazzo due volte (una prima in retromarcia, la seconda a marcia avanti). Sono le 17:27 del 20 luglio 2001. Tutta la sequenza è registrata nei filmati degli operatori presenti sul posto.””
20 luglio 2001, Genova, Carlo Giuliani
Glossario dei tempi
di Giorgio Mascitelli
Con la fine del secolo breve e della guerra fredda ossia dell’ordine nato dalla seconda guerra mondiale, l’epiteto ‘nazista’, usato espressamente oppure richiamato per allusione, ha conosciuto una seconda giovinezza in ragione direttamente proporzionale alla crescita della depoliticizzazione nella società. Sdoganato all’inizio degli anni novanta dall’apparato mediatico con la funzione di propaganda bellica ( all’epoca della prima guerra del Golfo era Saddam Hussein a essere il nuovo Hitler), essa è ormai diventato una componente essenziale di qualsiasi comunicazione tesa a stigmatizzare un comportamento considerato a vario titolo inaccettabile e irrappresentabile. In questo senso l’aspetto significativo di questo fenomeno non è tanto l’accusa di nazismo in situazioni per così dire codificate e classiche di polemica politica, per esempio l’accusa rivolta a Putin e ai separatisti russi durante la guerra civile in Ucraina verosimilmente per nascondere la presenza predominante dell’estrema destra nei ‘rivoluzionari’ ucraini o la lunga serie di scambi di accuse reciproche nel conflitto israelo-palestinese, ma il suo passaggio alla dimensione quotidiana. Ne ha fornito un esempio autorevole alcune settimane or sono il Santo Padre quando ha definito espressamente l’aborto selettivo una forma di nazismo in guanti bianchi.
E’ chiaro che la generalizzazione dell’uso del termine da parte degli operatori mediatici è stata possibile solo nel quadro di una fondamentale depoliticizzazione che consente di evitare di prendere quelle misure cautelative che un giudizio politico del genere imporrebbe a chi lo formulasse: ecco allora che diventa credibile, come è successo nei mesi scorsi, denunciare come fondatore di lager il precedente ministro degli interni Minniti e contestualmente chiedergli provvedimenti contro organizzazioni in odore di neofascismo.
Il passaggio decisivo si ha quando questa modalità viene ripresa sui social in rete da parte di utenti comuni e diventa un fenomeno di massa, assumendo un carattere fortemente aggressivo. Allora veramente ognuno può diventare il nazista di qualcun altro in qualsiasi momento per qualsiasi motivo. Tale trasformazione è connessa con quella che il filosofo Byung-Chul Han ha chiamato la società dell’indignazione, tipica dell’epoca della rete, ossia una società in cui dominano insistenza, isteria e riottosità che “non ammettono nessuna comunicazione discreta, obiettiva, nessun dialogo, nessun discorso” ( Nello sciame trad.it 2015 p.18). Ma l’allusione al nazismo può trovare posto anche in una discussione pacata, ce ne sono perfino sui social, non contrassegnata da quello che i tedeschi chiamano shitstorm, ossia la tipica aggressione verbale nella rete, a segnalare una sua trasformazione in un repertorio argomentativo naturale e ovvio, una sorta di seconda natura ideologica. Per esempio un paio di mesi fa, nel commentare uno stato di politica su facebook, uso l’espressione ‘scelte delle èlite finanziarie’ e mi viene risposto inopinatamente se sono convinto che le èlite finanziarie siano composte da ebrei. Il ragionamento è interessante, il mio interlocutore, che è democratico di sinistra antirazzista ed è una persona colta, teme che io sia un antisemita perché nella sua convinzione per parlare di élite finanziarie si deve essere per forza antisemiti, in quanto va da sé che esse siano composte da ebrei e chiunque non sia un antisemita non parlerà mai di èlite finanziarie. Qui vediamo come addirittura un tipico stereotipo antisemita ( l’alta finanza è costituita da ebrei) riviva in una forma antirazzista nella persuasione che chiunque parli di élite finanziarie non possa farlo che per esternare i propri sentimenti antisemiti e pertanto un sincero democratico non debba parlarne mai. Eloquente in proposito la reazione di smarrimento e di incomprensione del mio interlocutore quando finalmente si è convinto che avevo citato le èlite finanziarie non per motivi complottistici antisemiti, ma per parlare effettivamente di queste.
Questo episodio, che testimonia di una mentalità diffusa, non è spiegabile senza quello che Jonathan Friedman ha chiamato associazionismo, ossia la tendenza a valutare una tesi non per quello che sostiene effettivamente ma per il modo in cui si colloca in un determinato immaginario sociale, di modo che diventa pressoché naturale associare a una certa affermazione tutta una serie di altre affermazioni, anche se la prima non le implica affatto logicamente. Questo tipo di logica è praticata non soltanto nelle conversazioni private, ma anche in una dimensione pubblica, essendo caratteristica del politicamente corretto, ed è sicuramente uno dei meccanismi alla base della rapida moltiplicazione delle accuse di nazismo.
La più ovvia delle conseguenze di questo fenomeno, ma non per questo la meno grave, è che il concetto di nazista e anche quello di fascista, per il quale valgono considerazioni analoghe, sono quasi completamente inutilizzabili per l’inflazionamento e la torsione semantica a cui sono state sottoposte le parole che li indicano. Visto che purtroppo viviamo in un’epoca in cui qualche segnale oggettivo e pericoloso di fascinazioni nostalgiche c’è, questo è un motivo di preoccupazione in più.
In secondo luogo esso finisce con il creare un sacco di interdetti ossia di argomenti su cui non è possibile discutere perché bollati come sicuro sintomo di nazismo: non è un caso infatti che questa tendenza non sia un fenomeno spontaneo, nato in rete, ma sia l’imitazione di una pratica mediatica della società dello spettacolo, dove è stato introdotta con finalità di propaganda. Il fatto che la pratica dell’interdetto venga replicata a livello di massa rende molto difficile la nascita di un reale discorso di controinformazione e di critica dello stato di cose presenti, in quanto la funzione critica trova uno degli elementi fondamentali nello smascherare ciò che vi è dietro ogni interdetto anziché metterne di nuovi.
Infine, la perdita del valore specificamente politico dell’accusa favorisce una commistione tra una dimensione morale, una politica e quella emotiva che produce confusione e smarrimento, del tutto funzionali ai processi di depoliticizzazione. Che questa commistione sia una caratteristica sia del politicamente corretto sia del linguaggio mediatico, è una considerazione pertinente, che non posso però sviluppare qui, ma che va in ogni caso tenuta a mente.
Viviamo in tempi la misura dei quali ci è stata offerta da un politicante austriaco che ha rispolverato l’espressione asse tra Roma, Berlino e Vienna: e poco importa che quest’asse non si realizzerà mai per l’evidente inconciliabilità geopolitica degli interessi dei contraenti, la misura dei tempi ci è offerta dal fatto che abbia potuto permettersi di usare un’espressione simile, cosa fino al 2001 impensabile. Viviamo in una società in cui la macchina mitologica ha ripreso a funzionare e a offrire le sue vittime sacrificali per nascondere i problemi che non si possono o si vogliono affrontare. In questo contesto l’uso rigoroso di alcuni concetti e termini connotati storicamente non è una questione filologica, ma politica. Infatti, la ragion politica, per quanto parziale e fragile, man mano che passo ci incamminiamo nella nottata del mito è l’unico strumento che ci resta ( e lo affermo in polemica con tutta una temperie culturale che ha affermato l’importanza dei sentimenti in politica come unica garanzia di autenticità) per provare a orientarci e a non essere del tutto passivi nel buio che ci circonda..
Edoardo Sanguineti e Andrea Zanzotto: storia di un tributo intermittente
 di Chiara Portesine
di Chiara Portesine
Il dibattito con il Gruppo 63 affiora come un basso continuo nella maggior parte degli articoli letterari di Andrea Zanzotto, un idolo polemico che proietta la sua ombra su materiali di discorso eterogenei, che spesso non implicherebbero un confronto diretto con la Neoavanguardia. Che si parli di Luzi, Pasolini, della Science Fiction o di Leiris, attraverso trattazioni esplicite o allusioni mai troppo velate, la nemesi privilegiata della riflessione zanzottiana rimane il Gruppo 63 (quantomeno a partire da 1962, anno di pubblicazione dell’articolo dedicato ai «Novissimi» [PPS 1107-1113] (1), e fino a quando, negli anni Ottanta, il dibattito si sposta progressivamente sul territorio dei nuovi Media e della televisione) (2).
Per riassumere sinteticamente i capi d’accusa, Zanzotto taccia lo sperimentalismo neoavanguardista di «disimpegno» [FA 109], di ostentare una trasgressione meramente di facciata, quando, nel concreto, le premesse e l’operazione stessa del Gruppo non si contagiano mai con il nucleo traumatico del mondo contemporaneo (il «terrore assoluto» [ivi, p. 275]), ma si muovono entro il territorio protetto e non belligerante della forma, in cui «ogni rischio è puramente convenzionale, endoletterario» [ivi, p. 109]. Di fronte alla disgregazione moderna del ‘senso’ («il trauma incombente sulla lingua» [FA 359]), la Neoavanguardia non propone altro che un macabro divertissement (il «frigido artificio» [ivi, p. 62]), una ridda per aristocratici annoiati sulle rovine del linguaggio; come scrive Raffaele Donnarumma nel suo Tracciato del modernismo italiano, «l’atteggiamento dell’avanguardia è eroico e patetico […]. Rovesciare gli idoli tardo romantici e spazzar via il ciarpame piccolo borghese vuol dire rinnovare la vita in una festa sanguinaria» (3). Affidandosi alla deriva infinita dei significanti, si pone di fronte alla realtà con un gesto ludico-regressivo, mentre per Zanzotto la letteratura ha ancora la possibilità e anzi l’obbligo di veicolare un’ipotesi di autenticità (per quanto pericolante e minimale). La parola poetica, infatti, è «la figura che rimane sui muri dopo una deflagrazione atomica» [AD 358], la radiazione fossile che sopravvive nel mondo a testimoniare la sopravvivenza del senso, «le frange di una vitalità sulle rovine» [PPS 1088-1089].
Zanzotto licenzia la Neoavanguardia con il sigillo infamante di «fenomeno, tutto sommato, d’ingenuità-irriverenza in relazione a cose note» [PPS 1109]. In realtà, la laboriosa digestione dell’esperienza del Gruppo 63 emerge dal costante bisogno di rintracciare modelli alternativi, autori-exempla pure situati in un generico côté sperimentale ma variamente schierati in nome dell’istanza affermativa e della persistenza del dire poetico (da Emilio Villa a Amelia Rosselli). Lo scopo dell’atto artistico consiste nell’«arrivare ad un’altra poesia piegando questo annichilimento assoluto, e pur rimanendo in un certo modo nell’annichilimento» [AD 345] (4).
Più ambiguo e possibilistico si configura il rapporto con l’odiosamato Edoardo Sanguineti, di cui Zanzotto non perde occasione per rimarcare velleità e vizi di forma, ma che considera un referente d’elezione per testare la propria poetica riformata, sorta come presa di coscienza del «chaosmos» contemporaneo [FA 208] e accelerata proprio dalla provocazione terroristica della Neoavanguardia. Si potrebbe dire, per usare una metafora, che il Gruppo 63 è stato la leva obbligatoria (5) della letteratura italiana secondo-novecentesca, la brusca chiamata alle armi che costringeva a schierarsi (anche in qualità di disertori). Zanzotto vuole, però, scegliere il suo avversario e riconosce a Sanguineti l’onore delle armi (nonché i germi potenziali di uno sperimentalismo più persuasivo rispetto alla combriccola «sessantatré-ese»), «pur con tutto il male che merita gli si dica in faccia per gli equivoci di cui si è fatto furioso portabandiera» [PPS 1130]. Per Zanzotto, le intuizioni tecniche del poeta genovese e la sua grammatica dell’eversione mantengono un alto grado di interesse fino a quando non travalicano il piano letterario-linguistico in nome di una poco convincente vocazione politico-sociale. L’errore di Sanguineti consiste nel rifiutare un’intera tradizione letteraria in nome di un’utopica fuoriuscita dal circuito della convenzione/storia, trovandosi di fronte a uno scacco preliminare (la convenzione è insuperabile) e all’interrogazione su un falso problema (l’unica sfida autentica della letteratura contemporanea è quella di tornare a una significazione –anche minima– attraverso la crisi, per «coordinare sia pure minimamente ciò che sfugge da tutte le parti come sabbia» [AD 198]).
Da un punto di vista tecnico, le risoluzioni retoriche e sintattiche di Sanguineti seducono Zanzotto, che vorrebbe adoperare gli strumenti della grammatica laborintica pur tenendo saldo un controcanto costruttivo. Ad esempio, loda «l’asintattismo di fondo» delle poesie sanguinetiane, visto come la figura retorica più adeguata a mimare il presente, ma ne mitiga e irreggimenta gli esiti formali inserendo subito un segno di valore più, una tensione alla ristrutturazione etico-linguistico, in nome di quella che Guglielminetti ha definito «resistenza della sintassi poetica» (6), grazie alla quale «da questo asintattismo, nei suoi minimi tessuti, nelle sue microstrutture, si lascerà intravvedere una indicazione sintattica» [PPS 1112]. Ogni volta che si accosta a singoli espedienti artigianali del laboratorio sanguinetiano, Zanzotto sembra prendere appunti per assimilare in veste normalizzata le competenze artigianali di Sanguineti, addomesticando il «babelismo smitragliato» [PPS 1130] in una nozione operativa e ancora civile/civilizzatrice. Simili riconoscimenti di valore (parziali e quasi malgré soi) ricorrono spesso nella riflessione zanzottiana; ad esempio, parlando di Vocativo, rammenta l’esperienza di Laborintus per «la comprensione della funzione che può assumere l’intarsio latino per uno che scriva in italiano» [ibidem].
L’attestazione di un sotterraneo influsso esercitato dalle sperimentazioni sanguinetiane viene tematizzata addirittura in modo esplicito, in un’intervista del 1969 Su «la Beltà», dove, incalzato dall’intervistatore sui futuri lavori in via di pubblicazione, Zanzotto allude agli Sguardi i Fatti e Senhal con queste parole sibilline:
Come tutti ho quantità di appunti e di fiches nei cassetti […]. Forse il commento in versi al test di Rorschach, un mio Rorschach in versi, che sto rimuginando da anni? In ogni caso arriverà in ritardo; certo qualcun altro avrà avuto la stessa idea, o mi precederà Sanguineti (come è avvenuto per altri temi), pubblicando tutto il suo TAT o qualcosa del genere [PPS 1148].
Tale allusione a un’affinità elettiva di risorse formali (una consonanza addirittura preventiva, aurorale) appartiene al generale «tributo intermittente» a Sanguineti, che Zanzotto formula e dissimula di soppiatto nei suoi interventi critici, oppure è spia di un rimando effettivo e circostanziato a una realtà testuale della raccolta Gli Sguardi i Fatti e Senhal? L’ispezione degli autografi svela una situazione genetica molto più complessa, che porterebbe a considerare l’intera raccolta zanzottiana come un «contrasto» poetico (per usare le parole dell’autore stesso) [PPS 373] il cui interlocutore iniziale doveva essere proprio Edoardo Sanguineti.
Gli Sguardi, i Fatti e Senhal: un contrasto camuffato con Edoardo Sanguineti
Pubblicato nel 1969 (a un anno di distanza dalla Beltà) in edizione privata a limitatissima tiratura e ristampato solo nel 1990 da Mondadori (con un intervento di Stefano Agosti e alcune note supplementari del poeta), il poemetto Gli Sguardi i Fatti e Senhal rimane in una nicchia “cautelare” per volontà dello stesso autore, che escluderà la raccolta anche dall’antologia Poesie 1938-1986, in una sospetta quarantena editoriale. Stefano Agosti parla di «una vera e propria enclave nel percorso espressivo di Zanzotto, o di una vera e propria isola, che solo il presente volume [Le poesie e le prose scelte] ha consentito di esibire insieme al continente di cui comunque fa parte» [PPS XXXIII]. Lo studioso accosta la ritrosia divulgativa degli Sguardi alla pubblicazione in sordina di Filò (edito nel 1976 per le edizioni veneziane del Ruzante e ristampato solo nel 1988 da Mondadori), ma per quest’ultima Agosti rintraccia una possibile strategia autoriale, vale a dire che «si tratti di un’anticipazione (o della prova) di un esperimento che verrà funzionalizzato solo successivamente» [ibidem] –ossia l’assunzione del dialetto nella sezione centrale di Idioma–. Ma quali motivazioni potrebbero aver condotto Zanzotto a proteggere il poemetto dalla fruizione su scala nazionale?
Da un punto di vista strettamente formale, gli Sguardi non inaugurano né anticipano alcuna direzione stilistica, proseguendo la sperimentazione in bilico tra «un certo filo logico e il puro non-senso» [PPS 1530] avviata all’altezza della Beltà e confluita, con variazioni e aggiornamenti, in Pasque (che, come suggerisce Stefano Dal Bianco nelle note critiche in appendice al Meridiano, «si sarebbe tentati di leggere come una ‘seconda puntata’ o una lunga appendice della Beltà» [PPS 1538]).
Alla base di questa procrastinazione editoriale risiede forse un contenuto rimosso, che Zanzotto si è premurato di occultare nell’affastellamento stratigrafico delle fasi redazionali, attraverso una proliferazione di varianti di depistaggio, volte a cancellare (o, come direbbe Derrida, «barrare») il movente originario.
Consideriamo le note dell’autore stesso alla raccolta e le osservazioni in risposta all’intervento di Agosti, posposte all’edizione mondadoriana del 1990: oltre ai temi già rilevati da diversi studiosi (7) (e suggeriti dall’autore stesso), come il riferimento al mito di Diana, l’impresa americana dell’allunaggio, la prima tavola del test di Rorschach (nel cui dettaglio centrale è ravvisabile un’allusione alla figura femminile), le numerose interferenze con il lessico fumettistico-favolistico, l’impianto cinematografico della visione (8), è interessante notare come Zanzotto rimarchi più volte il carattere intertestuale e dialogico del poemetto. In Alcune osservazioni dell’autore, in calce all’intervento di Stefano Agosti, Zanzotto insiste sul carattere citazionistico e sui numerosi “copia e incolla d’autore” di cui sarebbero disseminati gli Sguardi, ricollegandosi ai versi di Mallarmè evocati dallo studioso (che pure Zanzotto confida di non aver mai letto):
Nello stesso tempo arriva da quei versi una confortante, dolce sensazione di unità che, quasi appartenente, inerente ad un sincronico “inconscio” poetico ed anche letterario, si ritesse avanti e indietro in un tempo che non è quello dei giorni e degli orologi. Così, tutti coloro che abbiano avuto certe esperienze poetiche, grandi o piccoli, precedenti o successivi, si trovano entro una sola corrente profonda, rientrante in se stessa come l’omerico fiume Oceano, rapiti in essa, testimoni di essa, più o meno consapevolmente non importa. Né importano “plagi”, imitazioni, o altri tipi di contatti tra autori, che non sono mai casuali, mentre importa che vi sia questa communio, questa circolazione, questo dare e ricevere, questo rubacchiare in una specie di ipnotica cleptomania, od arrivare a punti che possono essere contemporaneamente d’incontro e di scontro. Di tutto questo, ne Gli Sguardi i Fatti e Senhal v’è addirittura uno spreco, se si pensa alla brevità del testo, una ridda di minimi furti, in cui la “cosa rubata”, la refurtiva è (vedi vv. 291-2) di scarso conto, o a tal punto ridotta per dispersione, perdita. In questa consapevolezza (non sempre emergente, però) quando ho inviato a qualche amico il poemetto, al posto del © del copyright ho aggiunto a mano “Nessun diritto è riservato: magari da me si copiasse/ tanto quanto dagli altri ho copiato” [PPS 1530].
La schermaglia prudenziale, come vedremo, non è così retorica come potrebbe sembrare. A quali furti testuali allude questo passaggio? Anche nella Beltà Zanzotto aveva ammonticchiato una serie di citazioni più o meno dichiarate (9), eppure non aveva sentito il bisogno compulsivo di giustificarsi e scagionarsi in anticipo come in questa nota. Excusatio non petita, accusatio manifesta?
A questo proposito, è opportuno rievocare il nome di Edoardo Sanguineti, a partire da un piccolo foglio di block notes che si può consultare presso il Centro Manoscritti di Pavia, all’interno della cartellina DS5 che, oltre a un dattiloscritto con correzioni autografe, contiene due fogli di carta velina (f. VI, 42, solo recto, e f. VI, 43, sia recto che verso) con appunti a mano dell’autore. Queste tre pagine di piccolo formato (mm. 211 x 141 e 212 x 142), raccolte come materiali di lavoro relativi alla correzione del dattiloscritto DS5, in realtà sarebbero da leggersi parallelamente al dattiloscritto DS3 (che, ad una comparazione biunivoca delle varianti, si rivela precedente a DS5 –a partire dal titolo I fatti di Diana e Senhal, cancellato con una barratura orizzontale e modificato nel titolo corrente, già emendato in DS5–). A livello di DS3, infatti, si verifica il processo macroscopico di emendatio che viene a coinvolgere i frammenti sbozzati in ff. VI, 42 e 43. Il contenuto di queste tre facciate è riassumibile in un breviario di citazioni sanguinetiane (f. VI, 42), in cui Zanzotto annota i versi che più gli sono piaciuti di Laborintus ed Erotopaegnia, appuntando diligentemente la pagina di riferimento o il numero della poesia da cui ha estrapolato il sintagma, e in una tabella di riconversione “sanguinetiano-zanzottiano” (f. VI, 43), che consta di una colonna sinistra deputata a raccogliere un elenco di citazioni sanguinetiane (alcune si ripetono rispetto a f. 42) – sempre corredate di precisazioni bibliografiche– e a destra la corrispondente “traduzione”, ristrutturata e camuffata da Zanzotto per essere accolta negli Sguardi:
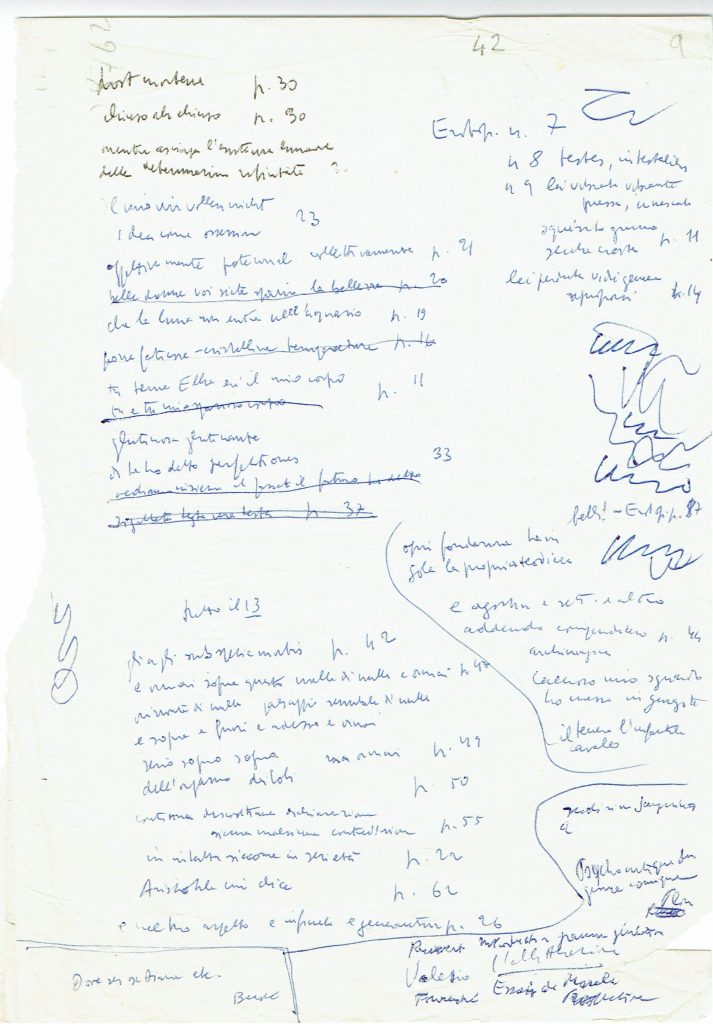
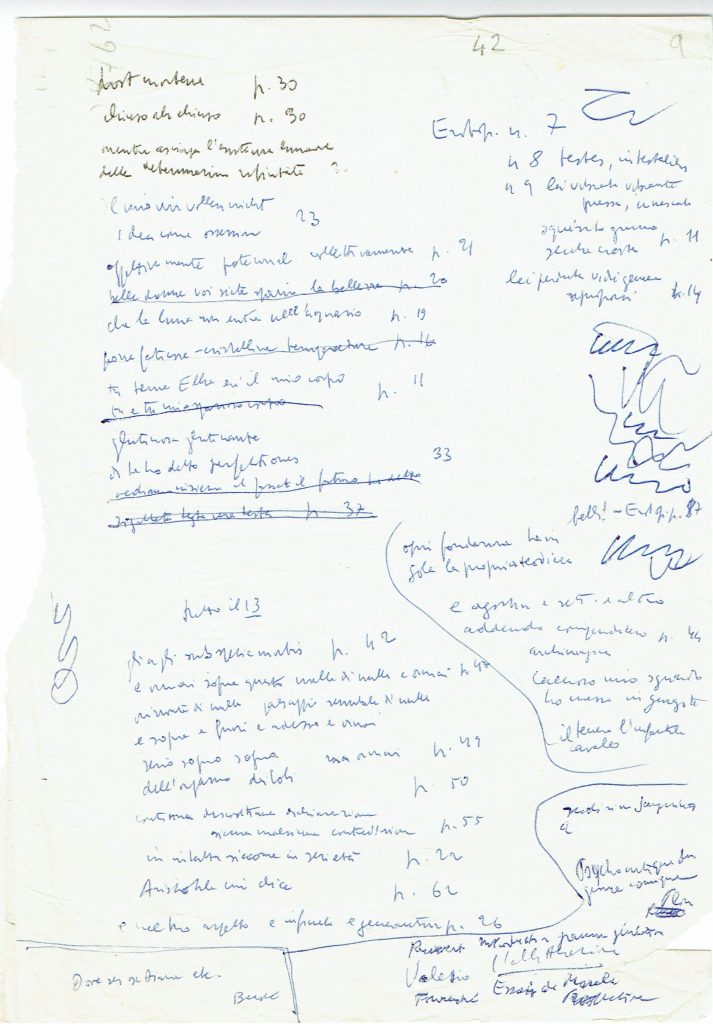
A una lettura della tabella, risulta chiaro il confronto serrato con le soluzioni linguistiche del novissimo, in un tentativo di auto-aggiornamento a partire da materiali formali del “nemico”. L’operazione del poeta veneto rivela, pertanto, un’interconnessione inaspettata e una lettura accanita (ai limiti del freudiano) di quella stessa opera che, nel 1956, aveva denigratoriamente bollato come «sincera trascrizione di un esaurimento nervoso». In questi appunti di destinazione privata Zanzotto si sbilancia addirittura in esclamazioni di ammirazione incondizionata («belli! Erotop.» [f. VI 42]; «tutto il 13» [ibidem]), senza le avversative e i cauti distanziamenti che avrebbero costellato un eventuale posizionamento pubblico nei confronti del Gruppo 63.
In sintesi, la volontà generale di Zanzotto è quella di assimilare in forma variata e positiva quella che considera la vera (e unica) rivoluzione di Sanguineti, ossia quella che si registra a livello di assemblaggio formale e strutturazione della pagina poetica. Proporrei di parlare del rapporto Zanzotto-Sanguineti secondo la categoria bloomiana del «poeta rivale» (10), coniata a proposito di quello che potremmo definire un “assorbimento agonistico” della poetica marlowiana all’interno dell’opera di Shakespeare. Lo sperimentalismo moderato di Zanzotto sembra generarsi a partire da un’originaria assimilazione parassitaria dell’altro laborintico, secondo un’azione prospettica che ricorda le modalità mediche della vaccinazione: attraverso l’inoculazione di una parte del virus si ottiene un’immunizzazione definitiva.
Curioso, a questo proposito, l’atteggiamento della critica, che finora non mai approfondito un’eventuale connessione tra i due autori, nonostante alcune palesi emergenze sanguinetiane nella Beltà, facendosi forse depistare dal rifiuto della Neoavanguardia ostentato programmaticamente da Zanzotto («il grande rivale di Sanguineti, nel match finisecolare (e oltre)», secondo la definizione di Cortellessa (11). La tendenza interpretativa è anzi quella di suggerire una partizione epistemologica, un aut aut tra poetiche alternative e non assimilabili: una linea di sperimentalismo ideologico e distruttivo (Sanguineti) e uno sperimentalismo formale e costruttivo (Zanzotto), in lotta per una possibile egemonia generazionale. Negando a priori l’ipotesi di una convergenza liminare (nonostante alcuni temi affini –primo fra tutti la ripresa in chiave contemporanea del topos lunare–), si è insistito troppo su una presunta ed esteriore separatezza esistenziale.
Significativo, a questo proposito, l’articolo di Fausto Curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, il cui incipit recita: «ora che la morte, e solo la morte, li ha ricongiunti, sembra più doverosa qualche riflessione su di loro, collocandoli uno di fronte all’altro» (12). L’articolo continua nel solco di questa incomunicabilità costitutiva, per cui «nessuno dei due si era sforzato di capire le ragioni dell’altro» [ivi, p. 448] e Zanzotto «era rimasto fermo al parere negativo espresso sui Novissimi nel suo articolo del 1962» [ibidem]. Sarebbe curioso sottoporre a Curi la tabella preparatoria per gli Sguardi, in cui emerge invece lo sforzo di misurarsi a ogni verso con le «ragioni dell’altro», con un’acribia filologica che forse non aveva lo stesso Sanguineti (autore dalle «scarse varianti» (13) nel correggere il suo Laborintus.
Anche Fernando Bandini, pur avendo intuito un’affinità complessiva per quanto riguarda certi espedienti formali, sembra subito sconfessare una tale illazione; le convergenze tematiche e sintattiche sono interamente giustificabili a livello di fonti comuni, come due intertestualità autonome che si parlano soltanto in differita, attraverso i rispettivi modelli letterari:
Di questo manierismo [contemporaneo], Costanzo ha offerto, in tavole sinottiche, degli «esemplari autenticanti», ed è singolare la somiglianza tra certi stilemi di Zanzotto e Sanguineti. Non si pone naturalmente nessuna questione di presunte relazioni tra i due poeti. Sono le fonti ad essere comuni (Novalis, Morgensterm, certo Landolfi, ecc.) a creare quel linguaggio di riporto che fonde immagini su acque e alfabeti vegetali (14).
Naturalmente, è doveroso e raccomandabile conservare la specificità teorica dei due autori, le cui poetiche hanno generato filiazioni di «nipoti e nipotini», adepti diretti e scuole critiche assai differenti. Tuttavia, mentre Sanguineti può essere tranquillamente studiato prescindendo dal percorso di Zanzotto, ritengo che non valga altrettanto per il poeta di Pieve di Soligo, la cui parabola poetica a partire dalla Beltà non può essere compresa e contestualizzata senza un marcato riferimento alle sperimentazioni del Gruppo 63. Senza il «terrorismo verbale» (15) della Neoavanguardia forse, parafrasando una citazione di Silvio Ramat (16), l’arcadia zanzottiana non sarebbe mai stata travolta.
NOTE
(1) Segnalo in apertura alcune sigle citate nel testo: AD = Aure e disincanti nel Novecento italiano, Mondadori, Milano, 1994; FA = Fantasie di avvicinamento. Le letture di un poeta, Mondadori, Milano, 1991; PPS = Le poesie e le prose scelte, a cura di S. Dal Bianco, G. M. Villalta, Mondadori, Milano, 1999.
(2) Cfr. ad esempio il saggio del 1989 intitolato Poesia e televisione [PPS 1320-1331]; già nell’Intervento del 1981 Zanzotto dichiarava che «tutti gli apparecchietti della civiltà tecnologica hanno ormai condizionato la nostra quotidianità, ma possono anche fornirci delle chiavi di espressione più complete» [PPS 1284].
(3) raffaele donnarumma, Tracciato del modernismo italiano, in Sul modernismo italiano, a cura di Romano Luperini, Massimiliano Tortora, Napoli, Liguori, 2012, pp. 35-38 (36).
(4) In termini quasi analoghi, Zanzotto parla della sua stessa operazione poetica, in un’intervista dal titolo Il mestiere del poeta: «A proposito dell’informale, direi che io ho tentato di afferrare qualcosa dello scontro tra l’idea di una massima strutturazione (a carattere sistolico, come si suol dire) e le tensioni della non-struttura che oggi sono nell’aria» [PPS 1133].
(5) Come scrive Maria Corti nel suo Viaggio testuale, «da un lato ci sono i Novissimi, fenomeno letterario in senso stretto […], fenomeno di rottura, di eversione delle codificazioni del sistema letterario; i Novissimi, e il nome stesso in metafora lo suggerisce, hanno marcato, per dirla con Lotman, la categoria ‘fine’ dei modelli letterari vigenti a livello tematico e formale» [maria corti, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 115].
(6) marziano guglielminetti, Zanzotto e la resistenza della sintassi poetica, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, Milano, Marzorati, 1979, pp. 9765-9771 (9765).
(7) Cfr. stefano agosti, L’esperienza di linguaggio di Andrea Zanzotto, in PPS IX-XLIX (XXXII-XXXV); fernando bandini, Zanzotto dalla Heimat al mondo, in PPS LIII-XCIV (LXXX-LXXXIII); clelia martignoni – Daniele occhi, Gli Sguardi i Fatti e Senhal: di alcuni percorsi genetici tra gli autografi, «Autografo», XLVI, 2, Novara, Interlinea, 2011, pp. 21-33; luigi metropoli, Il nulla maiestatico e i senhal, «Quaderni veneti», Ravenna, Longo, 2004. Segnalo, inoltre, la tesi magistrale di Daniele Occhi, Per “Gli sguardi i Fatti e Senhal”. La genesi del testo sulle carte autografe (Università di Pavia, aa 2009-2019, relatore prof. Martignoni, correlatore prof. Stefanelli); sebbene non abbia ancora avuto modo di prendere visione di questa ricerca, si tratta del primo compiuto tentativo di censimento integrale e descrizione archivistica degli intricati materiali della raccolta, con ipotesi sulla progressione genetica degli inediti.
(8) Cfr. john p. welle, Zanzotto: il poeta del cosmorama, «Cinema & cinema», 49, 1987.
(9) Come viene dimostrato esaurientemente in luca stefanelli, Attraverso la Beltà di Andrea Zanzotto : macrotesto, intertestualità, ragioni genetiche, Pisa, ETS, 2011.
(10) arold bloom, Il poeta rivale, in Anatomia dell’influenza. La letteratura come stile di vita, Milano, Rizzoli, pp. 67-83.
(11) andrea cortellessa, Petrarca è di nuovo in vista, in Un’altra storia: Petrarca nel Novecento italiano, atti del convegno di Roma, 4-6 ottobre 2001, Roma, Bulzoni, 2004, pp. I-XXXI (XIII).
(12) fausto curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, «Poetiche», 13, 2/3, 2011, pp. 447-453 (447).
(13) erminio risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti, San Casario di Lecce, Manni, 2006, p. 11.
(14) fernando bandini, Zanzotto tra norma e disordine, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, op. cit., pp. 9756-9765 (9759-9760).
(15) fausto curi, Struttura del risveglio. Sade, Benjamin, Sanguineti. Teoria e modi della modernità letteraria, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2013, p. 226.
(16) silvio ramat, Andrea Zanzotto. Dalla purezza lirica dell’idillio all’arcadia travolta, dalla parola poetica all’oggettivazione della lingua: la grammatica emozionale e la resistenza delle parole assolute, della fede nella poesia, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, op. cit., pp. 9730-9753.
Juke-box: Gianni Maroccolo
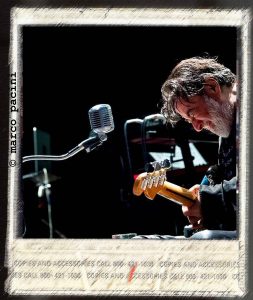 Come fanno i larici d’autunno
Come fanno i larici d’autunno
di Mirco Salvadori
Un’altra volta forse si prenderà
le mosse da un punto più
alto
fin qui è stato risalire a colpi
d’orgoglio confuso con l’idea
da proporre
quella volta non ci sarà bisogno
di voltarsi indietro e nemmeno
di guardare troppo avanti
ciò che ci sarà –la cura
nel fare, l’intuizione
del propizio, l’abbraccio
o la parola secca- basteranno
e basterà la pioggia se pioverà
e il sole se farà caldo
la strada deserta
o il rombo della gomma sull’asfalto
(Biagio Cepollaro – Le Qualità – La Camera Verde, 2012 )
È tutto racchiuso nel breve istante della morte, nell’altrettanto fulmineo sbocciare della nuova vita. “Rinasce chi sa tornare, rinasce chi sa cadere, rinasce chi sa morire, rinasce chi sa cambiare colore come fanno i larici d’autunno” canta Cristina Donà in ‘Vdb23/Nulla è Andato Perso’, album firmato da Gianni Maroccolo con Claudio Rocchi. Rocchi, colui che comprese il segreto per rendere la vita tale, accettando la morte e la successiva rinascita. Il magico viandante volante, l’artista coerente e coraggioso, l’amico inseparabile tutt’ora presente quando il verso annienta e il suono colpisce. È da lui che prende il via questa storia di indipendenza e rinnovamento.
La sera scende lieve in questo angolo di Toscana. In lontananza si percepisce l’urlo costante del traffico impazzito che avvolge Firenze ma qui è il silenzio che regola i movimenti. Sono seduto sull’antica pietra del Teatro Romano, l’orecchio teso nell’ascolto del suono che appartiene al presente, armonia che mi porta indenne la voce di chi ci ha lasciato, di chi ha dovuto abbandonare i suoi dischi le sue corde, i panni stesi ad asciugare lasciando sul cuscino l’impronta dei suoi sogni. Claudio Rocchi è scomparso nel 2013 dopo aver collaborato con Gianni Maroccolo alla realizzazione di ‘Nulla é Andato Perso’, disco che rappresenta una sorta di suo testamento pubblico giunto a noi grazie all’opera divulgativa del bassista e compositore grossetano, figura centrale del suono indipendente italiano, raro musicista a cui sembra inevitabile la necessità di allontanarsi in fretta dalla melma della conformità come scrive Battiato nel testo della lunga suite che rappresenta l’asse portante di questo splendido lavoro corale.
Scomodamente seduto sull’antica scalinata cerco di mettere ordine in un passato che ha lasciato dietro di sé memorie e passi d’altri ch’io calpesto, come recita Giovanni Lindo Ferretti interpretando l’inquieto valzer che ancora imperversa nella balera sempre aperta del mio cuore. Mi perdo nella musica e i ricordi iniziano a pulsare, si materializzano sul palco assumendo fattezze umane, quelle di Simone Filippi, Antonio Aiazzi, Andrea Chimenti e Gianni ‘Marok’ Maroccolo. Musicisti un tempo attivi in formazioni che appartengono alla storia del rock indipendente italiano, esponenenti di una cultura non solo musicale che individuava Firenze come città simbolo dell’esplosivo movimento new-wave degli anni ‘80. Sono riuniti qui a Fiesole per celebrare l’ultimo concerto dedicato a Claudio Rocchi e allo spirito di autonomia che lo distingueva, un concerto che nel corso di due anni ha riempito decine di teatri in tutta Italia, un live dal quale é stato tratto un triplo album di incomparabile valenza artistica, un vero manifesto poetico di indipendenza culturale.
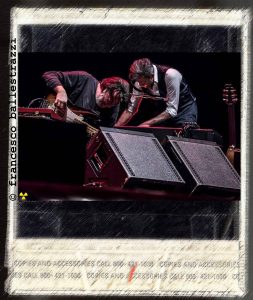 Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.
Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.
Sovrasta il piacere dell’ascolto, questo enorme specchio che si erge lungo i confini della notte fiesolana, una superficie che riflette il nostro passato, la storia collettiva dei sopravvissuti ad un’era di tempeste e mareggiate di cui ora rimane solo un borbottio di tuono e la volontà indomita dei pochi che insistono nel bisogno di cambiamento.
Di morte e rinascita é intessuta la lirica poeticamente interpretata da Andrea Chimenti mentre Simone Filippi filtra la violenza del battito, Antonio Aiazzi colora il cielo sintetizzandolo di passione e Gianni Maroccolo disegna movimenti di irresistibile danza alternandosi tra l’elettronica e le corde del suo amato strumento pensando a quella sua vecchia produzione discografica il cui titolo recitava: ‘Solo Un Folle Può Sfidare Le Sue Molle’.
Quanti sono rimasti indietro, ancorati a ricordi e celebrazioni, quanti non hanno retto il passaggio delle stagioni, abbarbicati sopra fragili troni di cartapesta. Quanti hanno rinunciato al rischio della follia, sbriciolandosi nelle trite e antiche movenze del rock’n roll.
Gli occhi chiusi, raggomitolato nel suono del basso, Marok sta forse pensando al momento nel quale ci saremmo ritrovati quarant’anni più tardi, ancora una volta decisi a cambiare colore, proprio come fanno i larici d’autunno, proprio come raccontava Claudio, convinto che ciò che ci sarà –la cura nel fare, l’intuizione del propizio, l’abbraccio o la parola secca- basteranno.
Nè acqua per le voci
di Marina Massenz
( i due testi qui presentati sono tratti da Nè acqua per le voci, Dot Com Press, 2018, ultima raccolta poetica di Marina Massenz,g.m.)
Siamo usciti dalla scatola proprio stamattina
Siamo usciti dalla scatola proprio
stamattina giunture e riflessi crac
crac arrugginiti messa in moto
lenta ma efficace infine attivi
Le armate spettrali di Bergamo
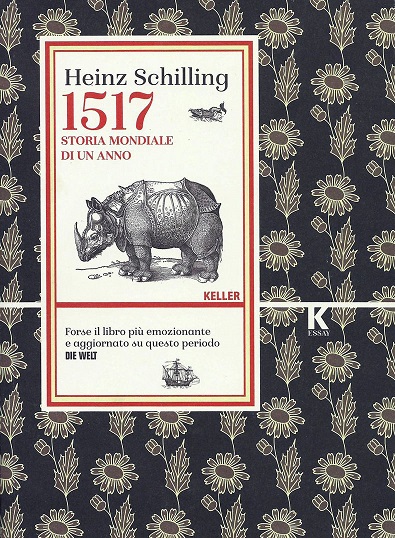 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi
Heinz Schilling, 1517. Storia mondiale in un anno, Keller editore, 2017.
Heinz Schilling è professore di Storia moderna. Per quanto tedesco, il suo libro di ben 383 pagine si apre con la cronaca di una strana battaglia combattuta nel dicembre 1517 a Verdello, frazione di Bergamo. Davanti a un boschetto, due armate guidate dai reciproci sovrani con tanto di vessilli, trombe, tamburi, e composte di fanti, cavalieri, artiglieria, si scontrano sino all’ultimo sangue. Poi spariscono. Sono spettri. E come tutti gli spettri sono un presagio di ciò che sta per accadere: eventi celesti, intemperie, rincari, carestie, epidemie, guerre. Non è così solo per quei pochi che vanno oltre la superstizione del popolo non istruito e sanno leggere la realtà per quello che è: l’esalazione di mucchi di letame che l’inverno rigido fa volteggiare nell’aria. Eppure, all’epoca, gli spettri servirono a materializzare prima le paure dei contadini, poi quelle degli abitanti della città, poi addirittura quelle del Papa e dei cardinali riuniti in Concistoro. A Schilling servono invece per materializzare lo spirito del 1517.
La battaglia spettrale di Verdello non è l’unico punto di riferimento di questa monografia dedicata a un solo anno della storia dell’umanità. Altri tre eventi lo caratterizzano: l’invasione dello Yucatàn da parte dei conquistadores spagnoli; l’incontro di un’ambasciata portoghese presso il delta del Fiume delle Perle (Zhujiang) con il segretario provinciale di Canton, in quello che allora si chiamava il Regno di Mezzo; le novantacinque tesi contro le indulgenze affisse sul portale di una chiesa di Wittenberg da parte di un misconosciuto monaco agostiniano che passerà alla storia con il nome di Martin Lutero.
Schilling, incastrando tra questi quattro elementi tutta una serie di fatti e di approfondimenti storici, sia antecedenti sia successivi ma comunque determinanti per una comprensione a tutto tondo dell’anno in questione, fornisce le chiavi di lettura dell’attuale compagine mondiale. Perché fu proprio allora, nel 1517, che prese il via la cosiddetta globalizzazione. Certo, con la Riforma di Lutero al centro di tutto la visione diventa un po’ germanocentrica. Fin dai banchi di scuola ci è stato insegnato che la Storia moderna inizia con il 1492, la fatidica data della scoperta dell’America, e non dall’affissione delle novantacinque tesi di Lutero. Ma è anche vero, dal punto di vista dell’evoluzione del pensiero, che il gesto del monaco di Wuttenberg liberò la capacità del mondo cristiano “di apprezzare in modo critico le Sacre Scritture e quindi di sottrarsi all’immutabilità numinosa della comprensione”. La Riforma, proprio in quanto figlia dell’Umanesimo e del Rinascimento italiani portati all’estero, non fu quindi solo un enorme passo verso il pluralismo confessionale ma anche una spinta formidabile verso il libero pensiero che condurrà all’Illuminismo.
È un bel testo, questo di Schilling. Non trattandosi di un libro di Storia in senso stretto, riesce a spaziare attraverso gli eventi universali passando per la Querela pacis (Il lamento della pace) di Erasmo da Rotterdam, I quattro cavalieri dell’Apocalisse di Albrecht Dürer, la teoria monetaria di Copernico, le donne del Rinascimento, le trame di potere dei Medici. O addirittura curiosità emblematiche come l’elefante indiano Annone, donato dal re portoghese Manuele a Leone X, che ne fa il suo beniamino (tanto che Pietro l’Aretino coglierà il pretesto per scrivere una feroce satira contro di lui e contro la Curia romana, Le ultime volontà e testamento di Annone, l’elefante).
Le stesse tesi di Lutero, per quanto punto di convergenza di tutte tematiche trattate nel libro, sono presentate nella loro obiettiva verità storica: una semplice raccolta di critiche costruttive che il monaco agostiniano rivolse alla Chiesa romana nella speranza di ottenere un ritorno alla spiritualità. Furono dunque il momento favorevole, l’indifferenza di Roma, ma soprattutto l’incredibile diffusione della stampa a trasformare uno spunto di riflessione in una riforma vera e propria. Sì, perché a soli cinquant’anni dalla rivoluzione di Gutenberg l’informazione non circolava più attraverso la limitata corrispondenza privata degli umanisti ma in forma di libri, opuscoli, volantini, immagini stampate, tutto materiale che moltiplicava la diffusione della conoscenza. Compresa quella dei mondi esotici, come dimostra l’incredibile popolarità della xilografia di Dürer dedicata al rinoceronte indiano Ulisse, ospitato nel recinto reale di Lisbona e dono del governatore delle Indie Albuquerque al re del Portogallo.
Il 1517 è anche l’anno in cui fanno comparsa due grandi potenze straniere: gli Ottomani da una parte e l’Impero moscovita zarista dall’altra. Roma, Bisanzio, Mosca, ecco dunque la “terza Roma”. Sarà Sigmund von Herberstein, una sorta di Marco Polo tedesco, che in qualità di legato dell’imperatore Massimiliano farà un resoconto dettagliato dei territori immensi del nuovo Cesare. Il suo Rerum Moscoviticarum Commentarii quadruplicherà l’elenco dei fiumi e delle località note tanto da permettere il primo vero aggiornamento delle conoscenze geografiche. Herberstein saprà inoltre riportare anche un’analisi attenta del carattere del popolo russo che metterà in risalto il servilismo dei sudditi rispetto ai superiori, la smania di potere e il dispotismo dei potenti. Aspetti sociali che in cinquecento anni non sembrano molto cambiati.
1517. Storia mondiale di un anno, diciamolo, è anche un bel libro dal punto di vista grafico-editoriale, a cominciare dalla suggestiva copertina con la riproduzione del rinoceronte di Dürer. Ma anche per la scelta dei caratteri tipografici e per l’impaginazione impeccabile e ariosa, che dà respiro alla lettura. Conta anche questo, in editoria, specie in tempi di omologazione e di sensazionalismo a tutti i costi. Lo so, dell’editore Roberto Keller ho già parlato altrove, sempre qui su NI. Merita comunque l’ennesimo applauso.
Un’ultima nota. Il Medioevo è stato archiviato eppure ancora oggi ci sono pubblicazioni, riviste e blog che trattano della battaglia degli spettri di Verdello come di un fenomeno paranormale realmente accaduto. Questo fa pensare che mezzo millennio non è ancora bastato per sconfiggere le nostre paure.
Bloomsday: italiani in trappola nella scacchiera di Joyce

di Bianca Battilocchi
Ma lo ‘sbaglio’ non sarebbe che del tutto carente senza il ‘vagabondaggio’,
cioè senza il labirinto, ma, sia chiaro, un labirinto incoerente,
cioè un labirinto che non ha fine, non ha uscite, non ha entrate
(si entra dove si vuole, anzi si è già dentro) un labirinto che genera labirinto.
(Giorgio Manganelli, Discorso dell’ombra e dello stemma, 1982)
In occasione dei recenti eventi organizzati a Dublino per celebrare Bloomsday – che cade il 16 giugno, il giorno in cui è ambientato l’Ulisse di Joyce, di cui Leopold Bloom è il protagonista principale – si sono realizzate fertili congiunzioni nate all’insegna di un felice caso.
Come perpetuando il gioco infinito dell’errare nella lingua (e nel mondo), avviato fatalmente dall’iperscrittore irlandese, i due indomiti traduttori italiani del Finnegans Wake hanno deciso di brindare a questo nella sua amata-odiata città, seminando nuove tracce delle loro sudate ma divertite scoperte e intrecciandole con quelle di nuovi potenziali lettori. Sono Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni i primi pezzi mossi in questa narrazione aperta da cui si sono sviluppate manganellianamente storie parallele. Nella veglia di Bloomsday presso la National Library of Ireland e grazie alla collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano di Dublino, hanno intrattenuto un vasto pubblico conversando e divagando con il giornalista Edoardo Camurri e l’attore Alessandro Bergonzoni, entrambi già ben addentrati nel labirinto joyciano.
Da principio è stato necessario avvertire il lettore-giocatore del suolo friabile e instabile della scacchiera sulla quale Joyce ci invita a giocare, della sintonia dell’errare con l’errore e quindi dei fenomeni di “errorismo”, delle geometrie non euclidee, come ipertesto prescelto dal creatore di Bloom, autotradottosi in italiano come Giacomo Giocondo. Un’ulteriore istruzione per l’uso è stato l’invito al non riconoscersi, ad abbandonare i sentieri a noi familiari, per permettere di perderci liberamente nei percorsi labirintici di JJ e approdare all’impensabile, a nuove forme di conoscenza. Va rammentato che l’autore irlandese non ha composto opere enigmistiche e, in maniera evidente, nel Wake dove non esiste un codice unico soggiacente per “scioglierne” le allusioni e i misteri. Al vagabondare joyciano nel linguaggio non c’è antidoto, si tratta anzi di un “infinire”, non si inizia né si finisce, le categorie di Spazio e Tempo non esistono più, in obbedienza al nodo scorrevole del “riverrun”, figura di un serpente che si morde la coda.
Si può tradurre allora l’opera matura di JJ come un “libro di vento/ libro divento” dove si possono continuamente compiere trasformazioni, metamorfosi alchemiche di natura simile a quelle dei Tarocchi di Emilio Villa o ad alcuni versi di Carmelo Bene (“Non dico niente.Soffio di vento. Divento soffio”), due autori che ammirarono profondamente le innovazioni linguistiche e anarchiche del collega irlandese. In aderenza alla logica eraclitea dell’eterno scorrere, Bergonzoni conclude con una fulminante interpretazione del gesticolare dei vigili urbani, che subito si fa appello: “Circolare, c’è un mondo da vedere!”
Rispondendo all’attore bolognese e soffiati dal vento d’Irlanda, i due “straduttori” hanno girovagato nei giorni seguenti in un pellegrinaggio laico per Dublino e dintorni per riannusare i portoni joyciani e i luoghi emblema come fossero carte universali da leggere e rileggere per penetrare sempre più a fondo nelle stratificazioni escogitate dal Giocondo. Nella giornata di Bloom, mentre alla National Library musicisti eseguivano le canzoni italiane citate nell’Ulisse, i due joyciani non hanno potuto declinare l’invito alla festa nel giardino del presidente Michael Higgins, in compagnia di Camurri e di altri colorati stregatti e cappellai matti.
L’indomani, a loro insaputa, si festeggerà il buon non compleanno di Bloom, che li troverà circondati da nuovi improvvisati ma entusiasti giocatori, alla vecchia farmacia (ora libreria) Sweny citata nell’Ulisse e ancora profumata dalle saponette al limone. In questo luogo preservato da volontari e riempito di memorabilia joyciane e musica irlandese, si viene accolti calorosamente da PJ in camice, da anni il principale orchestratore di continui incontri e sessioni di lettura da opere di Joyce proposte in molteplici traduzioni, tra cui non mancano mai quelle in italiano (ora lette alla domenica pomeriggio). Il convegno del giorno dopo Bloomsday ha visto come partecipanti alcuni studenti di Cosenza capitanati da una fata professoressa (e poetessa) che dopo averli introdotti a Joyce, ha ritagliato del tempo nella loro visita a Dublino per portarli alla celebre farmacia. E così sono state lette pagine dell’Ulisse, una dopo l’altra, dall’episodio di Circe, le voci dei traduttori alternate a quelle degli studenti e quella di un nuovo personaggio attratto dall’orbita del gioco, Massimiliano Bianchi, neuroscienziato nella vita e autore di Odysseus, opera poetica in inseguimento spontaneo della prosa joyciana. Vengono lasciati messaggi preziosi a questo giovane pubblico dagli occhi sbarrati, leggere Joyce il prima possibile – JJ è per tutti, non solo per accademici – e non dimenticare la libertà del lettore nell’interpretare i testi, “i libri sono di chi li legge”. Rifocillandosi al Kennedy’s (il pub di fronte) i nostri protagonisti si accorgono di nuovi pezzi sulla scacchiera, tre membri di un book club di Roma venuti appositamente per il festival e catturati dalle malie dello stregone plurilingue PJ, che li fa accomodare al tavolo (da gioco). La dimostrazione, forse, che il caso, sotto un segno “giocondo” apre le strade più sorprendenti?
Nota
L’immagine si riferisce a Enrico Terrinoni e Massimiliano Bianchi al reading dell’Ulisse presso la vecchia farmacia Sweny di Dublino.
Iconoclastia artistica e concetto di littéralité
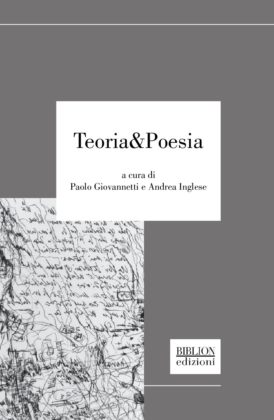 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese
(Questo testo è incluso nel volume Teoria e poesia, curato da Paolo Giovannetti e me, per le edizioni Biblion di Milano. Il volume raccoglie 11 testi di altrettanti autori che su invito dei curatori hanno realizzato una giornata di studio, con interventi e discussioni, alla Libreria Claudiana di Milano il 16 settembre 2017. Gli autori sono Giulio Marzaioli, Florinda Fusco, Vincenzo Frungillo, Stefano Ghidinelli, Italo Testa, Mariangela Guatteri (responsabile anche dell’immagine di copertina), Lorenzo Cardilli, Luigi Severi, Stefano Versace, Simona Menicocci.)
Ideologie del testo
Nel regime moderno delle letteratura, così come in quello delle arti, lo statuto di un testo, la sua appartenenza all’universo letterario, o a un genere specifico, nonché il suo funzionamento, e i suoi eventuali meriti e demeriti, non sono determinabili in modo esclusivamente consuetudinario, ma esigono periodicamente delle nuove forme di legittimazione.
Pensieri sparsi a poche ore dalla partenza per Lisbona
di Cristiano Denanni
(Pubblichiamo un estratto dal romanzo d’esordio di Cristiano Denanni («L’atlante dei destini», Autori Riuniti 2018). Si può disegnare una mappa del mondo attraverso le storie delle persone che lo hanno attraversato, che hanno amato sofferto e gioito? Stefano Solinas, il protagonista di questo romanzo, credeva di sì)

Torino, 16 settembre
So che sei in città e prima che io riparta ho bisogno di raggiungerti. Getto sul tavolo la mappa e la apro, dove sei? Ho camminato partendo da Sud, da Mirafiori; ho camminato ma ora voglio disegnare la ricerca sulla mappa davanti a me, voglio puntare col dito ciò che sto facendo. La sala della Biblioteca Nazionale è piena di una strana luce, le vetrate rettangolari incorniciano Piazza Carlo Alberto battuta da quel sole che viene dopo la pioggia, contraddittorio e miserevole eppure bello, amaro ma bello.
Mi riparo qui perché sono marcio, gli ombrelli mi infastidiscono e poi li perdo.
Inizio da questo posto. Punto gli occhi, punto un dito, perché ti sto cercando. Come ho fatto a piedi, parto dai bordi, dalle periferie, da dove forse sta ancora piovendo, o deve ancora cominciare.
Parto da quei palazzi rossi e marroni di Corso Giambone che erano l’accoglienza dei più poveri molti anni fa, tra fabbriche e ghetto, fra i campi sportivi e i cortili pacificati. Dove sei? Probabilmente molto prima del dito, forse molto più a sinistra dello sguardo, indubbiamente molto più lontana dell’intenzione di trovarti, ma non si sa mai, non è detto.
Torino batte, ribatte e rumoreggia. Mirafiori un tempo era erbacce e fabbrica, ora è locali e vialoni e il pensiero di essere stati inutili, ma nulla è stato inutile, è che il passato da solo non basta.
Ti sto cercando e so già che non ti troverò, ma voglio sapere dove hai camminato, dove un passante ti ha notata, dove un muto condominio ti ha distratta. Sulla mappa corro ancora, da Sud a Nord, e mi accorgo che devi aver osservato anche tu questi momenti. Lo sguardo si tiene saldo al dito, la carta è liscia, la legenda sul bordo, lontana.
Come si fa a pensare alla legenda di una città? Come si pensa di nominare vite senza raccontarle, come si esclude il tutto da un contenitore: la rabbia da una lotta, il suono da una parola?
Cammini diversamente da come ho sempre camminato io, ma cammini ugualmente.
Sei disperatamente bella nel tuo cercare un mondo che ti corrisponda, siamo maledettamente buffi a cercare sempre, a cercare ancora, a salire anziché accomodarci, a percorrere scalinate, a puntare il naso alla cima.
Il dito svolta e arriva ai piedi della collina: questa è la casa di Salgari, che aveva moglie figli e sigarette come alberi in tempesta, e parole e atlanti per raccontare storie. Corso Casale è traffico e fiume, eppure in certi pomeriggi ricorda mondi lontanissimi, quei pirati e quelle germinazioni. E ci sono giorni in cui l’amore è un tutt’uno con il lontano, e il fiume ti ricorda che per quel lontano si parte da qui.
Non finire di correre, non rispondere, non ti azzardare, io ti troverò. Anche se non ti trovassi lo farò, perché cercarti è diverso dal pensare a quanto sarebbe bello, a quanto potremmo fare e a quanto si potrebbe condividere. Cercare è prendere possesso di uno spazio e non vivacchiare, cercarti è un altro modo di dire il tuo nome e, in certi momenti, l’unica forma del mio esserti accanto.
Quando abbiamo smesso di tentare quello che vogliamo?
INTATTI FANTASMI CHIEDONO IL REALISMO: JACK SPICER
UN’INTERVISTA A NATHALIE QUINTANE
a cura di Andrea Franzoni
In occasione della prima pubblicazione in italiano di After Lorca, di Jack Spicer, presso Gwinplaine edizioni, ho chiesto a Nathalie Quintane ― scrittrice, intellettuale di rilievo e autrice della prefazione all’edizione francese delle opere complete di Spicer ― di tornare su alcuni dei punti più rilevanti, a mio avviso, della poetica spiceriana e della parabola che ha attraversato nella poesia americana ed europea.
Ho provato a portarti lontano ( cinque poesie)
di Antonio Merola
Ho provato a portarti lontano,
ma il mostro ci ha seguito ovunque
come a spaziare l’alberata in una grillaia:
sentiva l’odore del sole, tu piangevi
dietro a ogni angolo. Una lubricità
non bastava a nascondere la sfogliatura,
a scivolare altrove: avevamo paura
delle grandezze
come l’acqua dentro una fontana.
***
l’unicità si dipanava lungo la steppa
come soli freddi o rovine
nella pioggia: la notte durava una volta
sola come di fronte a un nemico
che voleva mutilare l’origine comune
prima della disparità delle losanghe:
e allora chi giocava ancora per non essere scoperto
cercava la musica del mare
come una speciale isola di bianchezza o schianto.
***
Nemmeno una scogliera di bianco
rugava la pesca
come la nostra immobilità che seguiva la pioggia
nelle montagne: si abboccava all’ardiglione
perché bisognava mangiare come una resipiscenza
ti sentivo lontano una strada
che forse vuoi percorrere da solo
mentre sulla collina una voce suonava il motivo
dell’abbandono: la binarietà era il nostro destino.
Avevamo commesso l’errore dei dinosauri:
essere troppo grandi per camminare.
***
c’erano solo i mostri che attraversavano la brina
come una piorrea dell’infinito oppure accecati
dalla stella polare: era l’estinzione della strada
contro il muro recintato di caligine
che riserenava la città… bisognava passare oltre
la vita: ho imparato che tutto si destina.
***
E così vengo imbestiato dentro il vagone spoglio di rifugio:
è ora di ritornare a casa attraverso l’oscuramento
negli occhi di uno sconosciuto oggi che tutto rimane uguale
a una pietraia come l’orientarsi della mia abitudine
allo scoliasta che rintraccia in uno spicilegio la favola a margine
della gigantessa slanciata senza patema sopra le stelle
cadute oltre lo strapiombo: amareggiare la città
non serve a niente davanti allo squadrare del treno.
Voglio essere come un forestiero nel mondo
degli uomini: fuori rintrona ancora l’ultima migrazione.
da In che luce cadranno / Gabriele Galloni
I morti tentano di consolarci
ma il loro tentativo è incomprensibile:
sono i lapsus, gli inciampi, l’indicibile
della conversazione. Sanno amarci
con una mano – e l’altra all’Invisibile
***
Ai morti si assottiglia il naso. Quando
li sogni se lo coprono. È normale
vederli a volto coperto passare
dal corridoio al bagno alla cucina.
***
Si parlava dei morti. Sulla tavola
i resti sparsi della cena – quelle
bistecche appena cotte. Il frigorifero
in dialogo amoroso con le stelle.
***
I morti vanno in cerca di riposo
l’uno dell’altro facendosi carico
inutilmente; ché nel continente
si va un giorno in avanti e due a ritroso.
***
I morti hanno fiducia nella sorte.
A notte fonda salgono sugli alberi
del tuo giardino; li trovi che all’alba
non sanno come scendere dai rami.
Li vedi; non ti vedono. Li chiami
e non ti sentono. Li aiuti – scendono.
Ogni notte ritornano e dimenticano.
***
I morti seguono un apprendistato
severo. Per sei mesi sono semplici
ematomi; poi superfici lisce.
E se divengono quel che già sono
è solo merito loro (non scivolano).
***
I morti continuano a porsi
le stesse domande dei vivi:
rimangono i corsi e i ricorsi
del vivere identici sulle
due rive. In che luce cadranno
tornati alle cellule.
***
La pornografia dei morti
è un vuoto di finestra, un passo
tra la veranda e il giardino. È quello
che noi sogniamo tutto il pomeriggio.
***
Le catacombe
delle case bianchissime;
due morti fra i tanti,
due fratelli,
ci porgono le offerte che in virtù
di trapasso donarono gli amici.
In che luce cadranno / Gabriele Galloni. RPlibri, 2018
apparso nella collana L’anello di Möbius, sezione diretta da Antonio Bux
Minima Oralia : Luigi Cinque

Oral Poetry e Identità Selvaggia *
di
Luigi Cinque
Oral Poetry. Se ne parla molto spesso senza cognizione. Qualcuno crede ancora all’equazione che fu dell’America degli anni Cinquanta e Sessanta, diventata da noi sottoequazione e farsa di provincia, di colonia, ovvero: il passaggio semiautomatico da medio poeta beat&freak a rockstar, e pure con significato politico. Da lì deriva probabilmente quell’auto referenzialità – quella speciale sindrome Bruce Springsteen, Patty Smith quando non Kathy Berberian o Demetrio – che oggi consuma i nostri poeti performer/lettori di poesie con musica. Quell’analogia era, in buona dose, dovuta al forte imperialismo americano postbellico, al suo potenziale di esportazione della lingua e il conseguente mercato che si produceva a scapito, si capisce, delle singolarità culturali colonizzate. C’era posto per quasi tutti i white americans. In un certo senso facevano un’azione di pulizia. Il furore mercantile dello zio Sam induceva, procurava e giustificava, a sua immagine e somiglianza, nei giovani readers&poets americani, una subliminale disposizione al saccheggio dei «negri», dei «colored bluesmen», degli hobos, dei dropout, del folk dei workers «with Grape of wrath» alla Steinbeck o «with bound for glory» alla Guthrie ma anche degli indiani, dei pakistani, degli aborigeni non americans del mondo. Li derubavano dei loro versi, dei loro racconti, dei loro modi di comunicare, delle loro ripetizioni. I nostri eroi beats erano assetati, famelici. Mescolavano il tutto in salsa Pound, Whitman, Baudelaire, T.S. Eliot, Rimbaud e rimodellavano a suon di black bebop in neorealismo on the road, in american way un po’ maledetta, leggendo in quei reading (che noi un paio di decenni dopo credemmo mitici) nei College in subbuglio, nelle strade e soprattutto nelle cantine dei bianchi new left, degli ebrei, dei siciliani, degli irlandesi, dei wasp.
Avete mai visto un nero in quel folto gruppo di beat/suca/parole? Pochissimi. LeRoy Jones (che non era ancora Amiri Baraka, sia chiaro) fu una delle poche eccezioni. Il procedimento era semplice: i nostri eroi riprendevano cinquant’anni dopo le avanguardie europee e, in un’America che si preparava all’hamburgerizzazione del mondo, a forza di droghe e di malinteso buddismo zen, teorizzavano che meno si pensa e più si è geniali; che tutti siamo geni e non lo sappiamo; che per diventarlo basta liberare se stessi «fino in fondo», anzi (e non è poco) liberarsi di se stessi e, visto che siamo tutti geni, ne conseguiva, guarda guarda, che tutti possiamo diventare senza problemi geni del consumo: 1950, nascono i primi veri consumantes della storia umana. Tornando all’arte, i nostri eroi contribuirono (ma non furono i soli, mettiamoci le varie avanguardie!) anche alla nascita di una essenziale figura del Novecento: il genio artistico cretino come ci dice Alfonso Belardinelli.
Gli editori accorrevano spavaldi, li coccolavano, li spompinavano, promuovevano i loro eccessi infantili. I discografici fiutavano l’affare e fu così che molti di loro passarono al più remunerativo mercato musicale e il Ministero dell’Immagine Americana nel Mondo approvava. Dopotutto un certo antagonismo libertario faceva molto bene all’export, ma con la giusta dose di sovversione funzionale, si capisce, senza mai trasformarsi in eversione, altrimenti la questione si sarebbe complicata e il Sistema sarebbe poi stato costretto a usare metodi forti: vedi le morti eccellenti del rock fino a Lennon, per intenderci.
Tra questi poeti e cantori ci sono state schiere di esempi luminosi, certo, da Jim Morrison a Patty Smith passando per lo stesso Dylan. Da bravi inconsapevoli coloni siamo cresciuti con loro. Li abbiamo imitati come potevamo e, per anni (o forse ormai per sempre, perché hanno popolato i nostri vent’anni) li abbiamo molto amati.
Ma se torniamo al presente e restiamo in argomento, vediamo che l’oral poetry di casa nostra non fa che ribadire davanti al pubblico del primo quarto del terzo millennio fenomenologie ormai comico/mistiche del genio cretino.
Facciamo allora un po’ di chiarezza: l’oral poetry non ha niente a che fare con l’esercito dei poeti sordi, dei performer neostonati e postavanguardistici; non si collega alla nobile tradizione della poesia sonora europea; non è, come rischia di apparire, l’ennesima estrinsecazione del narciso celibe; non è una rivoluzione mirata a liberare il verso poetico dalla pagina angusta e librarlo nell’aere; non si tratta di mettersi davanti a un microfono e telefonare le proprie poesie leggendole con della musica di sottofondo. La «poesia detta» – chiamatela pure spoken poetry –, la parola-verbo, arriva da molto lontano. Essa si basa essenzialmente sull’ascolto, sulla pratica religiosa dell’ascoltare, del sentire. L’oral poet – diciamo così – che potremmo chiamare tranquillamente electric shaman – ascolta gli ascoltatori prima ancora di parlare, instaura un feedback e quando infine parla racconta quanto sta ascoltando in quel momento.
Non c’è voce poetica (suono) senza ascolto del mondo. Né può esserci alcuna forma di poesia orale senza quel piccolo teatro che è l’orecchio nel quale l’essere rimette in scena il «reale» e lo rappresenta nella forma alta di intrattenimento; non esiste oral poetry senza quell’attività di leghein (ascoltare, conservare, raccogliere, riflettere silenziosamente) che si è «smarrita» ci dice Heidegger «in favore dell’affermazione di un logos», di un io narciso, «tutto preoccupato di dire, affermare, discorrere».
Solo in questo modo si arriva alla «parola-suono» (che è la casa dell’essere), a una parola transitiva che è in grado di mostrare, manifestare al di fuori di se stessa, qualcosa che senza di essa rimarrebbe nascosta, o perlomeno invisibile.
«Il verso cantato deve cominciare sempre con il suono della vostra pelle» diceva uno dei Dagar brothers, cantante di Dhrupad, a proposito dell’inizio dell’esposizione. Nel suo caso i versi dei poemi vedici si tengono come riferimento e si improvvisano, si abbelliscono e all’istante vengono inventate tutte le possibili varianti ritmo-melodiche, ma dentro la tradizione. Via via la sua parola cantata diventa solo significante, suono, e perde lentamente il significato, che deve essere tuttavia percepito nella forma di una sparizione, come un frullare di ali ma senza vedere neppure il volo di qualcuno, uccello o demone che sia.
L’oral poetry viene comunemente definita come poesia composta e trasmessa senza l’ausilio della scrittura. Dunque siamo alla sintesi orale, non epica; alle formule che hanno il potere, se dette, pronunciate, cantate nel modo giusto, di mediare con l’altrove, con gli dèi, ognuno dei quali oltretutto ha una sua vibrazione su cui sintonizzarsi. La poesia orale esiste solo quando diventa e produce suono, realtà altra, parallela.
Le parole devono mantenere certamente un senso percepibile che si dissolve in altro, in una sorta di Identità Selvaggia, proprio nel momento in cui si pronunciano. Tutto questo non ha niente a che fare con l’idea, spesso sentimentale, che abbiamo di poesia. La poesia orale è suono. Suono che magicamente non esprime ma lascia sparire il poeta o, in certi casi (pochissimi) l’attore-medium che coscientemente fa risuonare versi di altri.
Chi ha avuto l’esperienza di vedere Carmelo Bene in azione, in scena, o chi con lui ha collaborato, come mi è capitato brevemente di fare, lo vedeva davvero sparire dietro il suono dei versi. Carmelo non esprimeva o comunicava niente. Tracciava traiettorie che disegnavano figure sonore e quelle figure (qui sto citando Alessandro Baricco) erano icone dell’umano. La poesia in questo modo smetteva di essere una telefonata fatta per comunicare e diventava un’entità di pietra.
Senza dimenticare l’attenzione ossessiva, obliqua e malvagia, che Carmelo poneva sull’uso del microfono. Quanti infiniti microgesti egli studiava tra i mille gradi di vicinanza alla bocca. Così il microfono diventava, come per i cantanti di rango, uno strumento che si suona come la coulisse di un trombone. Per fare questo serviva tecnica, esperienza, capacità di sintonizzare il proprio orecchio con il feedback che arrivava dai monitor di palco. Il microfono era l’amplificazione della voce, era la maschera greca, era la laringe e la corda vocale che proiettava l’io nel cosmo, era la capsula spaziale, era il nuovo capitolo della «presenza della voce».
Eccoci alla voce, alla sua presenza nel mondo, all’esercizio fonico che, dice Paul Zumthor, si manifesta preminentemente nell’uso del linguaggio. Zumthor fa una dichiarazione chiarificatrice: «Una voce senza linguaggio non è abbastanza differenziata da far passare la complessità di forze del desiderio che la animano, mentre la stessa impotenza colpisce la lingua senza voce che è la scrittura. Dunque le nostre voci richiedono il linguaggio e nello stesso tempo godono nei suoi confronti di una libertà d’uso pressoché totale e che ha al suo culmine il canto».[1]
Ma c’è qualcosa di più, ed è la relazione antropologica tra parola e musica. Eviterei la linea di fuga del folklore, ma lo stesso mi consento un richiamo al mondo tradizionale.
La parola poetica di tradizione si avvale di una precisa tecnologia dell’organo vocale. È di per sé significato e significante. Il poeta di tradizione orale controlla e suona «quell’eccesso di connotazioni che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. Dal rumore più insolito al canto più squisito, essa crea una gamma molto vasta di associazioni culturali, musicali, quotidiane, emotive, fisiologiche» diceva Luciano Berio.
C’è dunque un’identità tra suono e significato che è da sempre la base della poesia di tradizione orale. Il poeta, il cantore, il cuntista modella la materia sonora per spettacolarizzare il frammento poetico o l’epica, e in tal modo il racconto che in esso si realizza non è propriamente quello che tende a ricostruire un passato secondo una prospettiva temporale ma diventa Onniscienza di carattere divinatorio.
Se ricerchiamo, per quel che ci è possibile, nella classicità mediterranea, troviamo che tra parola poetica e suono-musica esiste una vera e propria Identità Selvaggia: permane il senso che la parola è di per sé, innanzitutto, suono, mentre il rumore/suono/musica non è solo significante, ma, per via simbolica, verbo primario, radice, suggestione e significato esso stesso. Il ritmo, già possessione metrico-poetica, diventa infine il luogo elettivo di quell’identità: il luogo vero della convivenza. Questo i tragici greci lo sapevano bene, e infatti elaboravano una partitura-tessitura di testo ritmico e suono: erano, insomma, autori-compositori a tutto campo, non semplici librettisti.
L’unità narrante di suono e parola è da considerare oggi, insieme alla microfonia e alle nuove tecnologie, come una vera possibilità di evoluzione contemporanea del teatro di poesia. L’Identità Selvaggia è la sospensione del significato e del significante in uno stato di reciproco ascolto; è l’essenza stessa della poesia di tradizione orale; è un’azione scenico-sonora tesa a cogliere e restituire la risonanza altra – terza – tra musica e parola, considerando quest’ultima come anticipatrice di suono, e la musica come paesaggio della parola.
Se assistiamo, oggi, a reading che si spacciano come performance di oral poetry, ci accorgiamo, molto spesso, che i poeti portatori sono vittime di un insanabile equivoco. Leggendo le loro poesie davanti a un foglio scritto e accompagnati alla meglio da un ensemble musicale acustico o elettronico che sia, pensano di compiere il gesto forte e di approdare negli «orti saraceni» della «nuova Poesia liquida». Non è così. Intanto un’azione del genere presuppone in prima istanza – ma lo stesso non basta – la memoria del testo scritto. E poi mancano tutti quei fondamentali che ritroviamo nei residui di poesia orale tradizionale ancora vivi sia nelle fasce folkloriche europee, come i cuntisti, sia nelle grandi tradizioni dei griot africani, degli sciamani nordici, ma anche in molti infiniti studi realizzati in ambito di musica contemporanea. Rendiamo omaggio ai tanti vocalisti moderni che hanno sperimentato in questo senso.
In tutti i casi, pur lasciando al testo le sue prerogative grammaticali e fonematiche, la voce deve rispettare (o contraddire consapevolmente) i parametri dell’intonazione, del timbro, della durata, dell’espressione.
Da qui si passa al secondo punto. Al salto vero. Serve l’interplay. Il rito dell’oral poetry si compie solamente se in scena prende forma una nuova identità sciamanica. Il poeta deve ascoltare, giocare con gli altri aspetti della musica prodotta in scena poi costruire, inventando in tempo reale il poema. Questo è il salto: comporre nel tempo del rito scenico. Le parole non sono più «pre-visione» ma devono essere «in-visione»; devono essere possessione e improvvisazione, ovvero, elaborazione della parola metrica e del senso in tempo reale. Anche qui le tecniche oltre che i fondamentali sono decisive. Esse prescindono dal talento, si capisce, ma servono tuttavia alla forma, all’intrattenimento. Valgono soprattutto per esplorare l’immediato, alleggeriscono l’istinto. Servono a sospendere il tempo reale della performance e consentono all’esecutore di entrare nel tempo molecolare della comunicazione. Senza una tecnica acquisita è molto difficile proporre alcuna forma di relazione con la musica e con l’ascoltatore.
Vanno dunque considerati bagagli indispensabili per un «teatro poetico della visione» i parametri di ritmo, metrica, armonia, radice, significato, significante, comunicazione, ascolto, intonazione, microfonia, tempo reale, vocalità, elettroacustica, vibrazione, gesto/corpo, respiro, sguardo, silenzio, memoria/testo, bagaglio narrativo.
Se guardiamo alla tradizione, l’aedo, il rapsode, il griot, lo sciamano, il cuntista, ma anche i moderni poeti di strada metropolitani e molti performer di area classica/contemporanea, avevano e hanno padronanza di tecniche precise e studi preparatori a carattere ritmico/mnemonico/informativo. Procedono con un sistema di formule collegate le une alle altre secondo rapporti abbastanza complessi di equivalenza, di complementarità, di opposizione, sia semantici, sia funzionali. Così in scena, nel tempo di richiamo della memoria (quasi un pilota automatico), nella citazione della formula preparata, pur continuando a ritmare e dire, (o ripetere: la ripetizione è un elemento tecnico/formale decisivo) riescono a sdoppiarsi, permettendosi una sorta di sonnambulismo creativo e visionario che è quello che produce la forza «poetica e politica» del poeta medium; che gli fa tendere la mano dentro di sé a raccogliere informazioni extrasensoriali. Per questo il poeta performer contemporaneo deve costituirsi, anche all’interno della propria produzione, un bagaglio di memoria, lavorare in scena per strutture modulari a collegamento istantaneo, essere attore della composizione immediata.
Dopotutto, i ragazzi del rap americano, quelli della inner city, ovvero la città profonda e nascosta, quelli certo più veri e interessanti dei nostri eroi della beat generation, che oltretutto i fondamentali li hanno imparato dalla strada, usano le tecniche del dozens, un gioco verbale diffuso e memorizzato che permette di improvvisare su norme retoriche e metriche complesse e rigorose; che permette di picchiare con le parole come quel maestro di pugni e insulti verbali ritualizzati – dice Sandro Portelli – che risponde al nome di Muhammad Alì.
Penso davvero che oggi, nell’era della replica delle repliche, nel terzo e forse ultimo tempo della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, nel secolo della globalizzazione degli oggetti e della tribalizzazione dei soggetti, un’improvvisazione consapevole, sapiente, che si prenda in scena i tempi – irrinunciabili – della composizione di suono e senso sia l’unica vera prova di forza che possiamo operare. L’oral poetry deve riferire da altre dimensioni e determinare eventi non replicabili. Take cinematografici unici.
Sarà bene che le schiere di narcisi con pretesa di oral poetry escano dal povero surrealismo di massa con le loro paginette appoggiate su leggii defunti e provino a fare il salto nell’Identità Selvaggia della parola stabilendo finalmente una connessione accelerazionista e postumana tra arcaico tradizionale e terzo millennio. Questa sarebbe musica per le nostre orecchie. E se, poi, vogliono perpetuare la lettura, si convincano almeno che leggere in scena deve essere un modo di dimenticare. Una non forma dell’oblio. Un modo, come dicevamo citando Carmelo Bene, di scomparire e rendere nuovamente bianca la pagina appena letta.
In quanto poi alla canzone, essa è una singolarità differenziata. Gioca in un campionato diverso. E la pagina scritta di un libro di poesie è ancora altro. La questione è semplice e già ampiamente dibattuta. La confusione fa male.
[1] Paul Zumthor, La presenza della voce, Il Mulino, Bologna 1984.
* Oral Poetry e Identità Selvaggia è un capitolo di Kunzertu 77 18 . Memorie di bordo per una musica del futuro. in uscita a fine Giugno 2018 per le Edizioni Hypertext O’rchestra e Zona Music Books
Storia di Abdelali migrante
di Marco Rovelli
(Nazione Indiana ha compiuto quindici anni a marzo, da allora molte persone e molte cose sono cambiate; testimonianza molto importante, e talvolta emozionante, di questa lunga storia è il suo archivio, del quale abbiamo deciso di ripubblicare alcuni post, che riteniamo significativi. Oggi proseguiamo con un brano di Marco Rovelli, in passato redattore di nazione indiana. La redazione) Questo articolo è statp pubblicato su Nazione Indiana da Sergio Baratto l’8 settembre 2004.
 Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.
Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.
In Marocco quegli anni non c’erano ancora. Abdelali se li è venuti a prendere in Italia. Ha raggiunto il padre, che si è messo in regola. Anche lui può stare qui, adesso.
Abdelali fa amicizia, s’impara presto a stare nelle strade di una città nuova che ti nutre. Abdelali impara a stare nei carruggi di Genova. E’ un ragazzo come gli altri, agli altri è legato dall’età, il confine di stato si fa presto a dimenticarlo. Basta un gesto per abbatterlo, e Abdelali ne fa tanti di gesti che lo accomunano agli altri. Come quello di arrotolarsi una sigaretta di hashish, come quello di comprare un po’ di più di fumo per rivenderlo e potersi permettere qualche piccolo piacere. Tanto più che il corpo di Abdelali comincia a prendersi anni troppo velocemente: lo stomaco a volte si piega dal dolore, e vomita sangue. In ospedale lo trattengono, e per un po’ quella è la sua dimora. Lo operano in fretta, gli aprono la pancia, poi lo sottopongono a sedute interminabili.
Chemioterapia. Dolore. Fatica. Abdelali esce dall’ospedale senza sapere bene cos’abbia, non si può credere di morire a diciott’anni. Intanto dimentica il dolore con i suoi piaceri.
Ma la legge non conosce piacere né dolore. E non le piace essere ignorata. Si presenta in divisa, e gli rovescia le tasche.
E rovesciano anche lui, con lo stesso gesto, anche se ancora Abdelali non lo sa. Glielo dicono dopo pochi mesi, ed è una catena di parole in rapidissima sequenza che gli sbattono in faccia, e gli chiudono la bocca: permesso di soggiorno revocato, ed espulsione. Tutto in un solo gesto rovesciato, tutto in fretta, più in fretta dell’operazione che lo ha aperto all’ospedale.
Si ritrova in una stanza fredda della Questura di Genova, quarantott’ore a pane e acqua, senza sapere cosa gli accadrà. Sa solo che ci sono delle persone delle quali adesso è in pieno potere, che possono disporre di lui come vogliono. Aspetta, e intanto vomita sangue.
Ma il suo sangue è uno spiacevole incidente per la legge, se la legge avesse vene non ci passerebbe sangue, ma la legge non ha vene, solo corde e funi. Così qualcuno pulisce il sangue di Abdelali, e in fondo gli va bene che non sia lui a dover pulire là dove ha sporcato, come sarebbe giusto.
Alla fine vengono a prenderlo, lo caricano su una camionetta dai vetri oscurati, nessuno sa se ad Abdelali siano venuti in mente i vagoni piombati che portavano nei campi gli indesiderabili, forse no, Abdelali è ancora troppo giovane, pensa solo al suo dolore, e al piacere che adesso non potrà più avere per far fronte a quel dolore.
Il viaggio è lungo, e non si può nemmeno guardar fuori. Ci sono solo le voci forti e scandite degli uomini in divisa, la voce di marmo della legge che riporta le cose al proprio posto, come nel cosmo dei greci ogni cosa ha il suo luogo proprio, e quello di Abdelali è fuori di qui, anche per il suo sangue non c’è posto, è stato già pulito, e anche quello vomitato nella camionetta verrà pulito al più presto.
Il luogo di passaggio tra il dentro e il fuori è il nulla di un campo. C.P.T., si chiama, centro di permanenza temporanea, ma Abdelali non conosce ancora così bene l’italiano da far notare l’incongruenza dell’espressione alla legge che lo custodisce. Che importa, adesso è a Brindisi, e tra poco sarà rimesso al suo posto, appena passato il mare. Il mare nostrum, non lo si scordi.
Per venti giorni Abdelali non merita l’ospedale. Vomita sangue, e gli danno Valium e Tavor. Tanto lo stomaco è già andato, che stia tranquillo per questo tempo che gli resta. Lo va a trovare un avvocato genovese, una ragazza dal sorriso amoroso. Prova a spiegare che il suo corpo cede, che lì non può stare, lo porta davanti al giudice, alzati la maglia, gli dice, il giudice vede lo squarcio nella pancia, e non solo la magrezza del corpo. Sono un giudice, non un dottore. Sono un giudice, così ha detto il giudice. E’ la legge.
Poi, quando il suo dolore grida troppo, lo portano all’ospedale. Abdelali ormai sa che lì lo cureranno quanto basta per alleviargli il dolore, e poi lo rimanderanno al campo, e di lì in Marocco. Abdelali scappa. Riesce a uscire senza farsi notare, e arriva alla stazione. Telefona all’avvocato dal sorriso amoroso. Vieni da me, gli dice lei. Lui arriva a casa sua, e l’avvocato dal sorriso amoroso quando gli apre la porta si spaventa, sotto l’azzurro degli occhi non c’è più quasi nulla. Andiamo in ospedale, gli dice. Aspetta, risponde Abdelali. Ho dei debiti, prima li voglio pagare. Dopo qualche ora Abdelali ritorna. Andiamo, dice. L’avvocato lo porta in ospedale, poi avverte il padre.
Voglio vedere la mamma, chiede Abdelali, non la vedo da quattro anni. Voglio vedere anche la mia sorellina che ho visto appena nata. Ma l’ambasciata italiana in Marocco non lo vede, quello sguardo, quell’azzurro che diventa sempre più azzurro su quel corpo che sta finendo di sostenerlo. I visti per la madre e le sorelle non arrivano, e Abdelali continua a vomitare sangue, a perdere peso e parola. Bisogna insistere. Bisogna gridare. L’avvocato lancia un appello su internet e sui giornali – pochi, solo quelli che riescono a dar voce al dolore senza farne trofeo. Mandate fax all’ambasciata, fate i visti alle donne di Abdelali. Nell’attesa, è l’avvocato la madre di Abdelali. E’ lei che passa i giorni all’ospedale con Abdelali, è lei che chiameranno in caso di morte. Abdelali si sta spegnendo, non si alza più dal letto, è un corpo chiuso, rinserrato. E’ solo dopo due settimane – alla fine del mese di febbraio – che Abdelali ha le sue donne. E le sue donne si fanno canali di un miracolo: Abdelali si fa trovare in piedi, e pare sano. Abdelali resta sano per una settimana, nell’incredulità dei medici.
Il padre ha rimesso il figlio alla Volontà di Dio. La morte – il suo quando, il suo come – è stabilita da Dio in un momento preciso quando il bambino è ancora nella pancia. Non si può che accogliere la Volontà, che arriverà quando Dio l’avrà deciso. Il medico non è d’accordo, Abdelali dovrebbe sapere che ha ancora non più di dieci giorni di vita, e regolare i suoi conti, se ne ha da regolare. Non si preoccupi, risponde il padre. Tu sei nelle mani di Dio, dice al figlio, che si accorge di un’altra verità. Mi stai mentendo, dice al padre, mi nascondi qualcosa. Ma le due verità non stanno insieme, quella del dottore e quella del padre, il padre non gli stava mentendo, gli diceva la sua verità, Abdelali capisce e accoglie la verità del padre. E accoglie il suo dolore, e il suo amore, e il dolore e l’amore della madre. E accoglie la sua morte.
E pure, ha ancora una richiesta. Voglio morire in regola, dice. Voglio il permesso di soggiorno. L’avvocato supplica la legge, Abdelali sta morendo, non soggiornerà a lungo ormai. Riesce a ottenere il permesso. Glielo portano in ospedale il 12 marzo, e Abdelali riesce ancora a immaginarsi un avvenire.
Il 17 marzo, di notte, Abdelali muore.
Un nuovo ruolo per il soggetto all’inizio del Novecento: anche intorno alla relatività #1
di Antonio Sparzani
“Poiché lo stile non è certo qualcosa di limitato all’architettura o all’arte plastica, lo stile è qualcosa che penetra
in ugual misura tutte le espressioni vitali di un’epoca. Sarebbe assurdo considerare l’artista un essere d’eccezione,
uno che conduce quasi una vita appartata, nell’ambito dello stile ch’egli crea, mentre gli altri ne restano esclusi”
[Hermann Broch, Huguenau o il realismo]
Non c’è dubbio che i venticinque anni che aprono il secolo XX° possono ben venir ripercorsi e descritti come un susseguirsi di radicali trasformazioni che hanno interessato i settori più diversi dell’attività intellettuale dell’Europa, dall’arte alla scienza, dalla musica alla linguistica, dalla letteratura alla filosofia e alla psicoanalisi.
Nel tentativo di parlare di un’epoca, alla ricerca di qualche denominatore comune nelle evoluzioni di diverse discipline, vi citerò un passo di un illustre storico delle idee, Carl E. Schorske, che, nell’introduzione alla sua lucida analisi dell’ambiente della Vienna fin–de–siècle, così si esprime:
“Ciò cui ora lo storico è chiamato ad abiurare, e più che mai al cospetto del problema della modernità, è la tendenza a enunciare aprioristicamente un comune denominatore astratto e categorico: ciò che Hegel chiamava lo Zeitgeist, e che Mill definiva “la peculiarità dell’era”. Scontato l’intuitivo discernimento di valori unitari, dobbiamo ora impegnarci nella ricerca empirica di pluralità, quale condizione preliminare per individuare schemi unitari nel contesto della cultura. Se peraltro ricostruiamo il corso dei mutamenti intervenuti nelle singole branche della produzione culturale, possiamo assicurarci una base più solida per definire i loro punti di affinità e di dissomiglianza. A sua volta un siffatto metodo ci porterà a discernere i comuni elementi d’interesse, i comuni criteri di raffronto di contrapposte esperienze che uniscono gli uomini, nella loro qualità di produttori di beni culturali, in un medesimo spazio culturale e sociale.”
(Carl E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna, Alfred A. Knopf, New York, 1980; trad. it di Riccardo Mainardi, Vienna fin de siècle, Bompiani, Milano 2004², p. XVI).
Anche se l’idea di Zeitgeist ha conosciuto nel ventesimo secolo alcune versioni non banali – citerei per tutti Hermann Broch. vedi anche il brano posto qui in esergo – queste parole mi sembrano fornire un’indicazione metodologica largamente condivisibile.
Mi piacerebbe tentare di darvi un’idea di una delle più importanti rivoluzioni verificatesi nella fisica di quel periodo, la cosiddetta teoria della relatività, sotto un profilo che permetterà di inquadrarla, in un modo che mi pare plausibile, in un più generale atteggiamento che è comune per vari aspetti a quelli presenti negli analoghi rivolgimenti accaduti in altri settori della vita culturale dell’epoca.
Per rendersi conto di come i risultati ottenuti dai maggiori fisici del periodo, Lorentz, Poincaré, Einstein siano inscrivibili in un’analisi che converga sul ruolo del soggetto conoscente, occorre ripercorrere schematicamente la storia dell’idea di relatività, avendo riguardo al senso più elementare che questa parola assume nella teoria della conoscenza.
Comincerò dunque con l’affermazione quasi ovvia che, essendo ogni conoscenza descrivibile come un’interazione tra un soggetto cosciente e qualcosa di altro da sé, che chiameremo per comodità oggetto della conoscenza, il prodotto finale di tale conoscenza, cioè di tale interazione, ovunque esso si ritenga localizzato, sarà inevitabilmente costituito da contributi provenienti dall’oggetto e da contributi provenienti dal soggetto conoscente. Non occorre certo scomodare le moderne acquisizioni della fisica quantistica per corroborare una tesi del genere, quando basta ripercorrere gli aspetti gnoseologici già delle filosofie più antiche. Se fissiamo la nostra attenzione per il momento sulla conoscenza di oggetti materiali, appare evidente un primo modo in cui il prodotto della conoscenza – l’immagine retinica, o su lastra fotografica, dell’oggetto, o il corrispettivo mentale di una tale immagine – dipenda fortemente quantomeno dalla posizione e dall’orientamento dell’oggetto: lo stesso oggetto, visto di profilo o visto di fronte fornirà normalmente (salvo casi speciali, tipo quello di una sfera) immagini marcatamente differenti; o ancora, lo stesso oggetto, visto da vicino o da lontano, fornirà immagini differenti – più grandi. più piccole; il che permette di concludere subito che quel che appare rilevante a questo riguardo è la posizione relativa dell’oggetto rispetto al soggetto. Questa analisi del tutto elementare deve condurre a valutare come e in che misura diverse immagini possano riferirsi allo stesso oggetto, nel senso che, solo se le immagini differiscono l’una dall’altra secondo ben precise regole, si pensi nelle arti figurative alla dottrina della prospettiva, esse possono essere ricondotte a un qualche comune denominatore che viene indicato come “lo stesso oggetto”.
Questa locuzione identificatrice di un unico riferimento costituisce un’acquisizione – o forse una comoda convenzione linguistica – che Homo Sapiens compie nei suoi primi sei mesi di vita cosciente e che non è a quanto sembra propria di ogni organismo vivente (non, ad es., del moscerino della frutta, cfr. Marcus Dill, Reinhard Wolf and Martin Heisenberg, Visual pattern recognition in `drosophila’ involves retinotipic matching, Nature, vol. 365, (1993), p. 751).
Anche Ireneo Funes, l’uomo dalla memoria totale, protagonista del racconto Funes el memorioso di Jorge Luis Borges, non capisce perché si debba dare lo stesso nome al ‹‹cane delle tre e quattordici (visto di profilo) … e al cane delle tre e un quarto (visto di fronte)›› (Jorge Luis Borges, Funes, el memorioso, in Ficciones, Buenos Aires 1944; trad. it. Funes o della memoria, in Tutte le Opere, vol. 1, a cura di D. Porzio, Mondadori, Milano 1984, p. 712).
Questa basilare capacità di riconoscimento dell’identità indipendentemente dalla posizione relativa di soggetto e oggetto è la forma più fondamentale di relatività, quella detta Euclidea; la ragione del nome è da ricercare nel fatto che Euclidee vengono dette le trasformazioni che spostano un sistema di riferimento nello spazio e/o lo ruotano in un modo qualsiasi. Se guardo un parallelepipedo da una certa posizione e mi sposto attorno ad esso, so che l’immagine che percepisco nella mia retina cambierà seguendo il mio spostamento e so anche con buona approssimazione come cambierà; se cambiasse in modo diverso da come mi aspetto, comincerei a pensare che si tratta di un oggetto strano, che cambia inaspettatamente forma, o che comunque presenta qualche anomalia.
Dunque in un primo stadio vi è una separazione tra parte oggettiva e parte soggettiva nel prodotto della conoscenza che sembra del tutto ovvia e invariabile, e infatti così si è pensato per molti millenni. Qualcosa è cominciato a cambiare all’inizio di quella che chiamiamo era moderna, nel contesto di quel complesso di rivolgimenti culturali che va sotto il nome di prima rivoluzione scientifica. Per comprendere questo cambiamento, occorre cominciare a rendersi conto che tra gli oggetti di osservazione privilegiati per chi vuole indagare la natura vi sono non solo gli oggetti materiali, ma i loro comportamenti, le regolarità cui tali comportamenti sembrano obbedire, le leggi di natura. L’elaborazione di tali leggi è stata naturalmente un’operazione che ha richiesto secoli di tentativi, di proposte, di prove, di verifiche, di false partenze, che riempiono i volumi della storia della scienza. Ora, nella elaborazione che iniziò con Copernico per concludersi, in buona sostanza, con Newton, cominciò a prendere consistenza un’idea nuova, connessa con la cosiddetta legge di Galileo, o legge d’inerzia – formulata per la prima volta correttamente da Christiaan Huygens nel 1656. Secondo questa nuova proposta, frutto in verità di una riflessione secolare, cominciata agli inizi del Medioevo, se un corpo non interagisce con altri corpi, allora può sì stare fermo ma può altresì muoversi di moto rettilineo uniforme. Si capisce facilmente che questa è una novità forte rispetto al pensare che un corpo che non interagisce con altri corpi (‘sul quale non agiscono forze’) sta fermo; è un allargamento notevole. Ma un allargamento di cosa esattamente? Un po’ di riflessione conduce a notare che, se cominciamo a dare una vera rilevanza ai comportamenti degli oggetti più che agli oggetti stessi, ovvero alla loro forma, osservare un oggetto fermo, oppure osservarlo in moto rettilineo uniforme è da tutti i punti di vista che giudichiamo interessanti, la stessa cosa: in entrambi i casi si tratta dello stesso oggetto che non interagisce con alcunché d’altro; e allora il fatto di osservarlo fermo oppure in moto rettilineo uniforme diventa puramente contingente, dipende da circostanze che non vogliamo ritenere importanti per la conoscenza dell’oggetto, quindi circostanze che non appartengono veramente all’oggetto, dipendono piuttosto dal punto di vista dal quale lo si osserva, dipendono dal soggetto conoscente. Se guardo da riva una barca che scivola lenta sull’acqua la vedo muoversi di moto rettilineo uniforme, ma se la guardo dalla barca stessa la vedo ferma e se la guardo da una barca che analogamente scivola nello stesso specchio d’acqua la vedo muoversi in modo ancora diverso, ma sempre si tratta dello stesso oggetto che interagisce nello stesso modo con tutto quanto lo circonda. E allora ciò che si è allargato è in verità la parte di conoscenza che dipende dal soggetto conoscente, quella separazione di cui si parlava all’inizio si è spostata.
La parte dell’oggetto si è un po’ ritratta.
Fatemi concludere questo primo accenno al nostro tema con un passo tratto dalla Cena delle Ceneri di Giordano Bruno, scritto in quella sua prosa un po’ ostica e sgraziata, ma così penetrante e sottile che vale la pena di gustare lentamente. Si parla di una nave e di due mani, accostate, che lasciano ognuna cadere una pietra. Eccolo:
“. . . se dunque saranno dui, de’ quali l’uno si trova dentro la nave che corre, e l’altro fuori di quella, de’ quali tanto l’uno quanto l’altro abbia la mano circa il medesmo punto de l’aria, e da quel medesmo loco nel medesmo tempo ancora l’uno lascie scorrere una pietra e l’altro un’altra, senza che gli donino spinta alcuna, quella del primo, senza perdere punto né deviar da la sua linea, verrà al prefisso loco, e quella del secondo si trovarrà tralasciata a dietro. Il che non procede da altro, eccetto che la pietra, che esce dalla mano de l’uno che è sustentato da la nave, e per consequenza si muove secondo il moto di quella, ha tal virtù impressa, quale non ha l’altra, che procede da la mano di quello che n’è di fuora; benché le pietre abbino medesma gravità, medesmo aria tramezzante, si partano (e possibil fia) dal medesmo punto, e patiscano la medesma spinta. Della qual diversità non possiamo apportar altra raggione, eccetto che le cose, che hanno fissione [l’esser fissate] o simili appartinenze nella nave, si muoveno con quella; e la una pietra porta seco la virtù del motore il quale si muove con la nave, l’altra di quello che non ha detta participazione. Da questo manifestamente si vede, che non dal termine del moto onde si parte, né dal termine dove va, né dal mezzo per cui si move, prende la virtù d’andar rettamente; ma da l’efficacia de la virtù primieramente impressa dalla quale dipende la differenza tutta.”
(Giordano Bruno, La cena delle ceneri, a c. di A. Guzzo, Mondadori, Verona 1995.)
Les nouveaux réalistes: Alexandra Petrova

tratto dal romanzo Appendix (NLO, 2016).
di
Alexandra Petrova
Alex me fecit Mario
A tutti gli scomparsi nelle acque
del Mar Mediterraneo e in quelle
dell’oblio questo libro è dedicato
La nuova leggerezza di Mercurio
(traduzione di Valentina Parisi)
No, non mi sarei dovuta abbuffare. Ma si erano abbuffati tutti! Gli ospiti, mia madre, mia sorella, la nonna e la zia.
“Mamma”, una voce strozzata mi uscì finalmente dalla gola secca, “là, per favore”. E con lo sguardo tentai di indicare la direzione. “Prometti di seppellirmi sotto quella betulla”. Gli alberi si chinavano su di me e frusciavano, la penombra mi rinfrescava la pelle.
I miei occhi misero a fuoco una macchia, mia sorella che si stava avvicinando. Con lo yo-yo in mano andò alla finestra, la spalancò e guardò in basso, nel nostro cortile-pozzo sempre un po’ torbido. Si sedette di lato sul davanzale e cominciò a giocare con lo yo-yo. I suoi calzettoni bianchi si confondevano con i tronchi delle betulle.
“Qui non ci sono betulle”, disse.
Provai ad alzarmi, ma fui assalita da un altro conato. I tentacoli appiccicosi e le lame ricurve da pirata che quella notte qualcuno mi aveva cucito nella pancia stavano cercando di uscirmi dalla gola. La bambina che avrebbe trovato la forza di ribattere alla vena polemica della sorella ormai era trapassata.
Il giorno prima, quando mi ero svegliata, era ancora buio, e sotto le mie palpebre si era intrufolata l’ombra mattutina di un enorme vaso di tulipani. Possibile che quel momento fosse davvero arrivato? Con cautela avevo lasciato penzolare una mano per tastare i regali. Ne avevo afferrato uno e lo avevo avvicinato a me, tentando di indovinarne il contenuto, ma mi ero addormentata di nuovo.
Alle nove ormai il sole si configgeva nei vetri delle finestre lavate da poco, riflettendosi nelle larghe assi del parquet tirato a lucido per la festa, e fissava insieme a me i pacchi e pacchetti scartati, sparsi sul pavimento. Alle dieci stavamo già preparando un antipasto dietro l’altro, mia madre batteva la carne e la infilava a pezzetti nel tritacarne, facendo uscire dai buchi pallidi vermiciattoli rossastri.
Nella mia pancia erano finiti parecchi morti ammazzati. Parti di maiale e di mucca, di aringa e di gallina, e poi l’oca dal cui fegato ingrossato si otteneva un prelibato patè. Galleggiavano in mezzo al purè, alla panna, alla gelatina, al pan di Spagna ammollato, ai succhi gastrici e anche a quello di mela, versato dal grosso barattolo da tre litri, con il coperchio di latta e l’elastico che odorava di acido.
Gli ospiti se ne erano andati, eppure restava ancora un’intera montagna di insalata russa, un po’ di quella di barbabietole e qualche fetta di torta. Dopo aver svuotato le insalatiere, finii anche il dolce, continuando a sparecchiare.
La fine di una festa è sempre ripugnante. Com’era stato bello invece quel mattino, e ancora più bella la notte prima, al chiaro di luna, con la carta da regalo che mi balenava di continuo davanti agli occhi.
L’impressione era che a inventare la vita fosse stato un essere del tutto privo d’immaginazione: inizio-fine, mangiare-cacare, bere-pisciare, giocare-dormire, mamma-papà. Oppure per esempio le case, che crescevano tutte in altezza, come tanti cubetti. Quando riuscivo a individuare delle eccezioni, anche minime, mi ci affezionavo subito come ai miei amici prediletti, e capivo che in realtà le possibilità erano molte di più. Ma fermarsi di colpo, quando uno sta già rotolando giù, richiede uno sforzo troppo grande, e molto spesso non ha neanche senso farlo.
La tovaglia cosparsa di macchie di vino e di barbabietola fu tolta e il pesante tavolo di quercia ripiegato da braccia femminili. La stanza divenne all’improvviso più grande e vuota. L’angoscia prese ad avvicinarsi sotto forma di ruttini rancidi.
Mia sorella accese la radio. Come sempre, attese l’inno dell’Unione Sovietica e poi andò a dormire. L’inno le dava una certa sicurezza. Io invece non ero sicura di niente, né dell’inno, né dell’asino di peluche che mio padre mi aveva regalato prima dell’inizio della scuola e che abbracciavo mentre dormivo, forse perché era l’ultimo regalo di mio padre. Non ero neppure certa del fatto che un bel giorno il nostro palazzo, e insieme a lui anche il resto del mondo, non sarebbe fragorosamente crollato. Ero scesa apposta dalla vicina del piano di sotto a vedere dove sarei finita se a un tratto fosse venuto giù il pavimento e, per ogni evenienza, avevo spostato il mio letto in modo tale da ritrovarmi direttamente nel suo. Non riuscivo mai a ricordare cosa dicessero alla radio, né a cogliere il senso dei discorsi degli adulti. Finito di leggere un libro, non ero in grado di dire di che cosa parlasse. Il succo delle cose, la logica della banalità mi sfuggivano, come se il mio organismo non fosse capace di assimilarli e li rigettasse, proprio come faceva adesso con i piselli, i cetrioli e i pezzetti di prosciutto che schizzavano fuori dal mio stomaco e che, chissà perché, non potevano più ricomporsi in un maiale o in una gallina, e neppure ridiventare una meravigliosa insalata nella sua insalatiera di vetro, ornata da mazzetti di aneto. Perché ero proprio io a soffrire questi dolori schifosi? Proprio io, mentre mia sorella, con i suoi calzettoni bianchi, se ne stava seduta sul fresco davanzale a giocare.
Non temevo affatto la morte, anzi in quel momento mi sembrava perfino rinfrescante, come l’acqua.
Quando finalmente mi trascinai giù per la nostra interminabile scala fino al cortile eternamente in ombra e mi misero sulla barella dell’ambulanza, prima che chiudessero di colpo lo sportello vidi per la prima volta che la porta della nostra casa era dipinta di grigio e che la vernice screpolata lasciava intravedere un altro colore, più chiaro.
E checché ne dicessero, nel cortile che credevo di lasciare per sempre si levavano i tronchi sparsi di alcuni alberi bianchi, sormontati da una rete di rami su cui si erano impigliate le prime foglioline primaverili. E anche se qualcuno non li vedeva, non significava affatto che non potessero esserci, benché fino ad allora non avessero trovato nemmeno una manciata di terra nell’asfalto.
La scala dell’ospedale, invece, la salii orizzontalmente. Ero pesante, il giorno prima avevo compiuto pur sempre dodici anni.
La pancia non mi faceva più male. Indossavo la camicia appena ricevuta in regalo da zia Ljalja, che mia madre chiamava “sottoveste”. Verde malachite, trasparente, con i pizzi – una cosa così non ce l’avevano né mia madre né mia sorella. Mia madre, con l’aria lievemente sprezzante e distaccata che aveva sempre quando parlava della famiglia di mio padre, aveva osservato che quella “sottoveste” non era adatta per la mia età, ma io avevo deciso di tenerla anche per la notte, perché mi conferiva particolari poteri magici.
In ospedale nessuno pensò a togliermela, in compenso, ahimè, i medici-assassini mi avevano sfilato le mutandine e adesso un dottorino dalle guance rosee mi stava trasportando premurosamente in braccio, con la passera all’aria su cui spuntava già una peluria scura, appena visibile. Mi trasportò così fino al quarto piano, l’ascensore non funzionava e io non dovevo assolutamente camminare, sennò dentro di me si sarebbe potuto rompere qualcosa.
Nella sala dei riflessi, tutta vetri e metallo, mi deposero su un catafalco gelido, sempre con la sottoveste indosso. Solo a quel punto venne fuori che non potevo nemmeno muovermi. I medici si affaccendavano intorno a me e, prima che riuscissi ad aprire bocca, mi misero una mascherina-museruola. Sospirando, mi accorsi che già al secondo respiro le voci volavano via chissà dove, lontano, in alto, sempre più in alto, finché non si fusero in un unico brusio, nel vuoto.
Da lì a un attimo riaprii gli occhi. Ero in una grande corsia, la pancia mi bruciava e mi faceva male, molto male. Urlai.
I medici accorsero e, fingendo di tastarmi, mi fecero un’iniezione. Quando mi risvegliai, mia madre, di nuovo china su di me, mi disse che avevo dormito molto a lungo, che l’operazione era durata quattro ore e che mi avevano ripulito tutto l’intestino. Avevo un’appendice enorme – diciotto centimetri, una cosa incredibile per la mia età. Sebbene fosse scoppiata, l’avevano messa in un barattolo pieno d’alcol e da quel momento in poi sarebbe rimasta lì, in mostra nel museo dell’ospedale. Avevo sempre indosso la mia “sottoveste”, che adesso era tutta sporca di qualcosa di marrone sulla pancia e, per colpa di questo schifo, aveva certamente perso gran parte della sua magia.
Ma, ancora di più, mi spiaceva per l’appendice. Eppure me l’avevano sempre detto: “Non mandare giù i noccioli, togli la buccia dei semi di girasole prima di infilarteli in bocca, altrimenti ti verrà l’appendicite”. Io però, di nascosto, inghiottivo non solo i noccioli delle ciliegie, ma anche le pagine dei miei libri preferiti (non a caso dicevano che li “divoravo”), oltre a perline colorate e manciate di terra – in generale tutto ciò che era meraviglioso e non pericoloso. Mi piaceva l’idea che tutto sarebbe rimasto dentro di me, in un sacchetto nascosto.
Una volta al cervo di Münchhausen era spuntato un albero in testa da un nocciolo di ciliegia. Per cui era assolutamente possibile che anche dentro di me si celassero i germogli di arbusti che potevano spuntar fuori in ogni momento, spandendo il loro profumo nel bel mezzo delle occupazioni quotidiane. I passaggi più spaventosi delle fiabe o quelli che mi piacevano di più rimanevano dentro di me per poi, un bel giorno, venir fuori del tutto inaspettatamente. Il luccichio delle perline di vetro levigate rischiarava l’oscurità delle mie viscere.
Un tempo i nostri antenati si nutrivano esclusivamente di erba e radici, per questo il loro intestino era molto più lungo. L’appendice era la testimonianza materiale di quell’epoca. Poi gli esseri umani avevano preso gusto a bere il sangue e a masticare la carne di esseri quasi uguali a loro e un tubo così lungo per la digestione dell’erba era diventato inutile, ma per qualche strano motivo, forse per rammentare l’innaturalezza del mangiar carne, l’appendice aveva continuato ostinata a spuntare a tutti. La definivano un atavismo. La vergogna può trasformarsi senza nessuno sforzo in un atavismo. Una volta la scuola ci aveva portati a visitare un campo di concentramento. La gente abitava lì vicino, armeggiava in cucina, faceva la fila per il pane, più o meno come allora, quando l’aria era irrespirabile per l’odore penetrante delle carne ebrea e rom bruciata. Forse a qualcuno veniva un po’ di nausea, ma già non ci si interrogava più sulla causa di quella reazione.
Anche se grazie all’evoluzione l’appendice non mi serviva più, avevano pur sempre tagliato via un pezzo di me. O meglio, pensavano che non servisse più, ma io sapevo già da tempo che, mettendosi dietro gli striscioni con gli slogan, si potevano leggere cose inimmaginabili. La gente guardava il mondo senza notare la sua multisfericità. Appena usciti dall’infanzia, iniziavamo ad assomigliare sempre di più l’uno all’altro . Si riusciva quasi sempre a indovinare come finivano le frasi degli adulti alla terza o addirittura alla seconda parola. In un universo simile bisognava per forza inventarsi un trampolino, un dirigibile, un bunker o un nido, o anche solo imparare a correre velocemente. Più veloce dei motorini e della luce. Nella borsetta-appendice erano custoditi tutti i materiali indispensabili per costruire macchine volanti, quella era la mia dote. Grazie agli oggetti che conteneva avevo capito, come per magia, che a mezzanotte non doveva per forza risuonare l’inno, che non era sempre necessario chiedere il permesso di alzarsi da tavola o limitare l’estate a soli tre mesi – un’estate relativa, per di più. In realtà, al mondo non esistevano nemmeno i mesi, oppure, se alle volte proprio ne capitava uno, allora poteva essere maprile, maggggio o serpentario. Ma ecco che il mio sancta sanctorum, il mio trampolino, il mio lanternino era finito in un barattolo, esposto alla curiosità generale. Da quel momento in poi la mia forza sarebbe rimasta lì, nascosta in un museo anonimo, non mi apparteneva più. L’appendice era mia, le perline e le pagine delle fiabe dei fratelli Grimm al suo interno erano mie, eppure non potevo più vantare alcun diritto su di loro. La mia vita precedente mi era stata tolta per sempre, con un taglio netto.
In quella nuova, successiva all’amputazione, cominciò a farmi male come un arto fantasma tutto ciò su cui avevo potuto contare fino a quel momento – la sicurezza del giocatore d’azzardo al pensiero del suo conto svizzero o quella del criceto mentre fa provviste di semi nella guancia. Allo stesso tempo iniziai a sperimentare un’ignota leggerezza. Perdere i bagagli fa spuntare le ali dietro la schiena o sui sandali, come accadde a Mercurio.
Insomma, bisognava rinunciare all’accumulazione diretta (che poteva sempre interrompersi tragicamente) e ricominciare da capo, contando solo su me stessa.
Il messaggio è democratico
 [Questo testo è apparso in una versione un po’ differente sul n° 4 del 2017 della rivista “Trivio” (Oèdipus editore). L’intero numero, intitolato Polesìa, è stato curato da Ferdinando Tricarico, che partendo da questa crasi di Polis e Poiesis ha invitato un ampio numero di poeti (51) a scrivere sulla nozione di “democrazia”, lasciando massima libertà nelle forme e nella lunghezza. Il numero contiene anche interventi del curatore, del direttore Antonio Pietropaoli e due saggi (Per una poesia democratica, di Francesco Muzzioli e Dopo la democrazia. La parole dei corpi ribelli di Giso Amendola).]
[Questo testo è apparso in una versione un po’ differente sul n° 4 del 2017 della rivista “Trivio” (Oèdipus editore). L’intero numero, intitolato Polesìa, è stato curato da Ferdinando Tricarico, che partendo da questa crasi di Polis e Poiesis ha invitato un ampio numero di poeti (51) a scrivere sulla nozione di “democrazia”, lasciando massima libertà nelle forme e nella lunghezza. Il numero contiene anche interventi del curatore, del direttore Antonio Pietropaoli e due saggi (Per una poesia democratica, di Francesco Muzzioli e Dopo la democrazia. La parole dei corpi ribelli di Giso Amendola).]
di Andrea Inglese
In ogni suo punto il messaggio è complesso, stratificato, rilevante a perdita d’occhio, ma nel suo insieme è liscio, flessibile, omogeneo.