 di Federico Betta
di Federico Betta
A vederlo così era come se stesse affogando. Si muoveva tutto veloce, saltava di qua e di là, dal suo manuale al video, e poi dal video ai suoi appunti e poi si fermava, tirava un respiro, guardava lo schermo e ricominciava a sbracciare coi suoi stupidi fogli. Lo so, è impossibile, ma sembrava come se venisse risucchiato dentro quel coso.
Da quando ha cambiato lavoro non ha smesso di nominarlo. Fino al Natale scorso, ha continuato a ripetere che in America ce l’hanno tutti e qui, invece, siamo ancora mezzi contadini per colpa dei russi.
Era la cosa che voleva di più al mondo, l’unica che gli avrebbe cambiato la vita, che avrebbe cambiato la vita a tutti noi. Ma la mamma non era d’accordo: diceva che con le assicurazioni non aveva ancora ingranato e prima o poi dovevamo cambiare la macchina. Quando lei tirava fuori quella storia lui spariva dalla stanza e urlava “La macchina va benissimo!”
Questa volta, però, non voleva solo comprarlo, non voleva solo far crepare d’invidia lo zio Giorgio. Questa volta voleva proprio convincerci che era la cosa giusta da fare: “Senza di lui mi passano tutti avanti.”, diceva sempre.
Alla fine, la botta giusta gliel’ha data la storia del muro e per quasi due mesi, da quel nove novembre fin sotto Natale, è diventato insopportabile. Continuava a stressarci che finalmente potevamo fare il grande salto anche noi, che lui quella cosa l’aveva aspettata tutta la vita. È arrivato a dire che non comprarlo era come se i rossi avessero perso con tutti, a parte che contro di noi: “Se non cavalchiamo le macerie, per noi è la fine!”.
A quel punto anche mamma non ce l’ha fatta più e gli ha attaccato un messaggio sullo specchio del bagno: “se proprio ci tieni, è giusto che tu lo prenda.”
Era il 22 dicembre, sabato: io stavo facendo colazione, pronto all’ultimo giorno di scuola, e mamma, al solito, passava la pezzetta sulle maniglie della cucina.
Ho sentito un toc toc, strano, leggerissimo, e ho alzato la testa vedendo mamma che si era fermata anche lei. La porta della cucina, lentamente, si è aperta e, dopo qualche secondo, è spuntata la faccia di papà, con un gran sorrisone e quel bigliettino appiccicato sul naso. Ci ha guardati, prima mamma e poi me, e come una tigre pronta all’assalto si è avvicinato a bere il suo caffè. Appena la tazzina ha toccato di nuovo il tavolo, mi ha guardato e ha detto: “chi mi accompagna al negozio invece di andare a scuola!?”.
Mamma l’ha puntato e senza dire una parola gli ha lanciato lo straccio. Papà l’ha schivato e si è tuffato dietro me, con il foglietto ancora sul naso: “Roooarr”, ha fatto. Mamma, asciugandosi le mani nel grembiule, ha raccolto la pezza e, alzando gli occhi al cielo, ha detto: “va be’ va, a Natale siamo tutti più scemi.”
Ci siamo preparati come per andare in spedizione: acqua, frutta, due Mars e Polo a tutto spiano. Mamma ci ha guardati salire in auto dalla porta di casa e, quando mi sono voltato perché papà ha grattato incastrando la terza, lei era ancora lì.
“Siamo indietro, Fra! Il mondo è nel futuro e noi giochiamo ancora col fax.”
La storia del muro per lui è stata fondamentale, come se una cosa che succede a mille chilometri potesse cambiare le cose anche da noi: “le brigate rosse, la p2, la Dc, ma ti sembra un Stato normale? Se non ci fossero loro, secondo te, avremmo tutti ‘sti casini?” Per lui, il muro di Berlino è sempre stato il simbolo del potere dei russi e adesso, che finalmente è caduto, tutto il mondo si darà una regolata. E anche qui da noi, secondo lui, sarà tutto diverso, perché non avremo più quella cosa a farci ombra. Di questo è proprio convinto: “da quando hanno tirato giù quell’obbrobbrio – così dice sempre lui, obbrobbrio con quattro b – finalmente anche noi possiamo diventare un paese normale. Siamo già in ritardo, Fra! Se non stiamo al passo, ci asfaltano!”
A me, in fondo, non sembra che sia successo chissà che. I russi, sì, se la sono presa in quel posto, ma non scherziamo, quelli sono i russi: mica sono tutti idioti come tispiezzoindue. E poi, anche se non tornano i russi, arriveranno i cinesi. Sicuro! Mi ricordo ancora quella scena, con quel tipo davanti alla fila dei carri armati; l’hanno fatta vedere centomila volte. “Un ragazzo! Un ragazzo da solo, vedi cosa può fare?” Papà si esaltava come ai film di Rambo, ma io ho sempre pensato sì, un ragazzo da solo lo fanno vedere alla tv, ma quello è uno, uno solo, e gli altri morti ammazzati? Eh? Non contano niente?
“Quelli sono cinesi, Fra! Non si capiscono neanche tra di loro. Ma sai quanti sono? Ora che si mettono tutti d’accordo, qui, ne facciamo uno grande come una casa!”.
Ecco, da quando aveva mollato la fabbrica per lanciarsi con le assicurazioni – “Fra, questo è il mio piano americano!” – il mondo girava attorno a quel coso. “Basta imparare due tasti e fai tutto più veloce. I miei capi, in America, ne hanno due a testa. Altro che russi, Fra! Questo, questo è il futuro.”
Quel giorno, sabato 22 dicembre, il piano americano di papà doveva fare, finalmente, il grande salto: quel coso, dopo averci rotto le palle per un anno, stava arrivando. Grazie al magico presepe e alla faccia della Ritmo scassata, infatti, stavamo per comprare il nostro primo computer.
Era gasatissimo, come i bambini che aspettano il gelato. Ma, secondo me, non aveva fatto bene i calcoli. Era sabato, ultimo giorno prima della chiusura natalizia, in giro c’era un casino allucinante e cercare quel coso è stato una specie d’incubo. Mamma gli aveva detto “Ma perché non lo prendi su Postal Market?” ma lui non ha voluto sentire storie: “comprare cose serie per corrispondenza? Ma va’, non lo fanno neanche in America!” E così abbiamo girato tutti i negozi e i negozietti della nostra bella città sotto il dirupo e, a ogni ora che passava, mi sembrava sempre più di cadere in fondo a un buco, come nella trappola di quegli insetti assurdi. Quand’ero bambino ce n’erano tantissimi a casa del nonno, si chiamano Formicaleone, ma non so perché li ho sempre chiamati Ragno Tigre. Forse perché mi facevano paura, nascosti in fondo al loro buco, con le pareti così ripide che le formiche, appena ce le buttavo dentro, erano quasi sicuro spacciate.
Con i primi due tipi è stato tranquillo. Loro hanno detto: “mi dispiace, è tardi, bisognava ordinarlo”, e lui, come niente fosse, ha fatto finta di guardare le macchine fotografiche e ha detto: “Be’, certo, il 22 dicembre, ovvio”. Dal quarto negozio in poi, però, aveva la pelata bagnata come i vetri quando piove. E dopo il centro commerciale, quello nuovo attaccato all’autostrada, quasi quasi finiva male. Erano le quattro e mezza e il tizio con la targhetta sulla camicia sorrideva da dietro il bancone: papà aveva gli occhi pieni di fuoco e io mi sono messo in mezzo per portarlo via. Altro che Ivan Drago.
Era praticamente buio e il fondo del fosso ci stava aspettando. Sentivo il respiro feroce di un mostro pronto a saltare fuori per inghiottirci, ogni persona in mezzo alle scale era un artiglio del nemico e seguivo papà che gli spintonava a destra e sinistra per arrivare prima alla macchina. Nel piazzale ha grattato due volte per incastrare la prima e poi è partito facendo un salto. Io ho chiuso gli occhi e ho gridato: “attento!” Lui ha inchiodato e ha urlato contro una vecchia che non si muoveva. Lei si è girata e senza capire cosa stava succedendo ci ha salutato con la mano.
Annegare, cadere in un buco, farsi mangiare le gambe da un Ragno Tigre, volevo dirgli di andare a casa, che l’avremmo comprato dopo Natale, ma lui, come tutte le formiche disperate che ho lanciato in quelle trappole, era pronto a tutto.
E, infatti, ha avuto l’ultimo scatto: è partito facendo fischiare le gomme e abbiamo infilato il casello.
Anche le formiche facevano così. Arrivate sul fondo del buco, era come se impazzivano: cominciavano a muoversi di qua e di là, saltando sui granelli di sabbia come per volarci sopra, come quando al mare stai annegando e, anche se sei distrutto, dai le ultime bracciate, ancora più potenti delle altre. A vedere la scena ti verrebbe voglia di dare una manata e salvarle, vorresti sentire l’abbraccio di mamma che ti alza, ma invece stai fermo, perché sei attirato anche tu in qualche cavolo di modo magnetico, da quel mostro che può schizzare fuori e tirarti sotto.
Aggrappato al volante non c’era verso di fargli prendere un pezzo di Mars. “C’è un giorno nell’anno, Fra, no grazie, un giorno solo, ho detto no grazie, uno tra tutti gli altri trecentosessantaquattro giorni, che deve andare come si deve, com’è sempre andato.”
Saltando nella corsia di sorpasso, guardavo la luce dei fanali scassati della Ritmo, e pensavo che la cosa bella delle formiche nel fosso è che alcune, quelle che ce la mettevano davvero tutta, riuscivano a salvarsi.
“Lo sai perché nel presepe mettiamo anche quel tizio che dorme, eh? E quegli altri… quello che fa le castagne, eh? Per esempio? Cosa c’entra?”
Papà era schizzato a centotrenta e mi chiedevo se avremmo sfasciato la Ritmo o ci saremmo salvati anche noi. Per mantenere la calma distruggevo una Polo dopo l’altra, ipnotizzato dalla lancetta del contachilometri che tremava terrorizzata anche lei. “Perché così, quando a mezzanotte mettiamo il bambinello, tutte quelle cose, quelle persone normali, diventano magiche!” Senza staccare gli occhi dalla strada, ha suonato a una Mercedes che non lo faceva passare e ha rubato dal cruscotto l’ultimo pezzo di Mars.
“E io, eh? Me lo spiega quel cretino con la targhetta, cosa scarto io a Natale?”
Erano ormai quasi le sei e papà ritardava a rallentare per mettersi in coda al casello di uscita. Passando in fianco alle macchine, ha fatto i fari e suonato a un furgoncino col telone strappato: con una finta uno-due che sembrava Rocky, l’ha fatto fermare e si è infilato al suo posto.
Quando la stanga si è alzata – stavamo volando sui granelli di sabbia – e il tipo del furgoncino ci malediceva – come sbracciamo per la paura di affogare – ho chiuso gli occhi inghiottito da un mostro – cammini tranquillo e poi cadi in un fosso – e quella vanga che ha spaccato tutto mi ha invaso la testa – il buco in un vetro è come nella sabbia.
Era quasi Natale anche lì, io avrò avuto dodici o tredici anni. Stavamo caricando, proprio in quella Ritmo appena comprata, gli attrezzi da portare al nonno: dovevamo aiutarlo a piantare un grosso pino che voleva addobbare in mezzo al giardino. Avevamo la terra, un piccone, un vaso gigante e una vanga, molto lunga. Era tutto sistemato, e papà, per ridere, mi ha sollevato facendo finta di mettere nel baule anche me. Io ridevo, come al solito quando fa lo scemo: “Dai, mettimi giù, dai, il nonno ci aspetta.” Ma lui continuava a farmi girare e con una mano, da dietro, ha sbattuto il portellone della macchina.
Bum!
Tenendomi sollevato, dopo un momento, si è voltato e, quando mi ha lasciato andare, ho capito cos’era successo: il manico della pala avanzava fuori dal vetro sfondato della Ritmo nuova.
A me si è aperta la bocca e ho fatto un passo indietro. L’ho detto io, che era lunga. Lui è rimasto immobile, come ipnotizzato da quella pala che aveva distrutto la macchina. In tutto quel silenzio mi ha spaventato un rumore: era stato come un urlo, ma un urlo basso, come tappato, e veniva dal secondo piano. Mamma si era affacciata alla finestra e ci guardava con una mano davanti alla bocca.
Lui si è voltato verso di me, poi ha guardato lei, e con la faccia grigia è rimasto lì fermo, tra la mano di mamma, la mia bocca aperta e la macchina bucata. Io guardavo tutto e non sapevo cosa dire.
Al telefono col nonno cercavo di non farmi scappare quella storia – “Ma cos’è successo? Dove siete?” – e mi passava in testa un sacco di roba: c’era il presepe, c’era papà, il nonno, l’albero di Natale, la mamma, la vanga, l’orsetto di peluche – “Digli di sbrigarsi, se viene buio non si fa più niente!” – e tutte quelle cose si distruggevano una sull’altra, come le palle di sabbia schiacciate su una montagna sempre più alta.
Se ce la metti tutta il mostro non ti prende: se ti muovi, se fai ancora due bracciate, non annegherai mai, così mi diceva, così mi ha sempre detto, devi dare sempre altre due bracciate. E lui se ne stava lì, davanti alla pala nel vetro della Ritmo nuova, con il nonno che urlava per fare il buco dell’albero.
Era una buca grande, talmente grande che sembrava la trappola gigante di un Ragno Tigre. Era un fosso enorme che s’ingrandiva sempre di più, un buco nell’acqua è come nella sabbia, un buco nel vetro che diventa infinito e risucchia tutto, compreso me, il nonno al telefono e anche il tipo del furgoncino dietro di noi, anche se tutto era successo quattro anni prima.
È strano come le cose di tanti anni fa sono sempre qui. Come quel muro caduto a Berlino, che ci ha fatto fare il grande salto, come me, adesso, davanti alla porta del sua stanzetta. Lo guardo, chiuso là dentro da mesi, davanti a quel coso che gli fa la faccia più grigia del buco nella Ritmo. E vorrei entrare e dirgli no, dai, lascia stare, non serve a niente. Vorrei dirgli che è lo stesso, anche se hai distrutto il vetro della macchina nuova, vorrei dirgli chissenefraga di tutto, fai ancora due bracciate papà!
E invece non faccio niente, rimango fermo, zitto, e lo guardo che piano piano smette di agitarsi. Sembra attaccato a un attrezzo che non gli da più energia. O forse i grandi capi, quelli in America, quelli che ne hanno due, proprio quelli che non sbagliano niente, gli stavano succhiando via tutta la vita. E lui se ne sta fermo immobile, senza sapere cosa fare, tra i miei occhi e il computer, come me, quella volta della vanga, tra i suoi occhi fissi e la mano di mamma.
Ivan Drago, la caramella intorno al buco e il tipo con la targhetta. La tigre, i cinesi, la donna nel parcheggio, il telone strappato e le formiche che non sono mai spacciate fino alla fine. Dai, ancora due bracciate, dai papà, ancora due.
Ci sono i pastori, la capanna, Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello, e quando a mezzanotte arriva il bambino, tutto diventa magico. Anche la stella, lassù nel cielo, la stella magica con la coda, ferma immobile a brillare. Ancora due bracciate, volando sui granelli, ancora due, ancora due, se no diventi grigio, sempre più grigio, ancora due papà, se no cadi giù, ancora due, ti prego papà, vola, vola impazzito su quei maledetti granelli, se no sparisci, perché il muro è caduto, la fabbrica è chiusa, abbiamo il computer, sparisci, sparisci assieme a tutto il resto, come le formiche, quelle spacciate che non ce la fanno più.
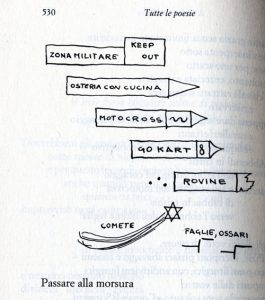

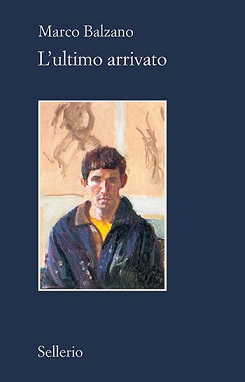 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo

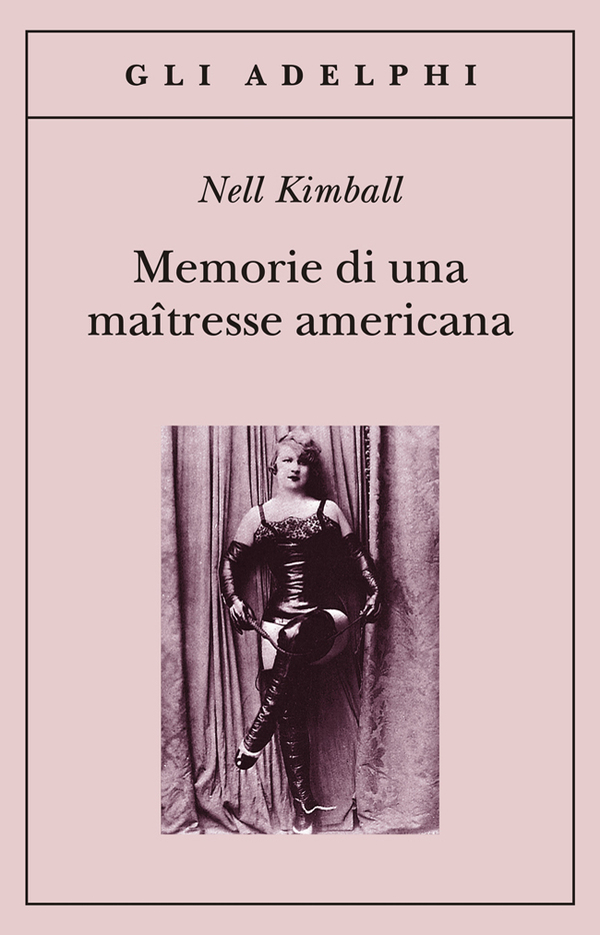 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot
 L’uomo, mettendosi in macchina a Ferragosto- benché avesse programmato con largo anticipo una partenza a un orario cosiddetto “intelligente”-, sapeva che sarebbe stato vittima di un evento ineluttabile: la coda per raggiungere il mare. Gli era già capitato un migliaio di volte di restare imbottigliato, eppure sul suo volto si dipinse uno stupore infantile mentre scalava le marce dalla quarta alla prima. Subito dette la colpa a tutta una serie di circostanze nefaste: la seconda colazione al bar, il rifornimento superfluo di giornali all’edicola, il lavavetri che si era avventato sul parabrezza con il semaforo verde…
L’uomo, mettendosi in macchina a Ferragosto- benché avesse programmato con largo anticipo una partenza a un orario cosiddetto “intelligente”-, sapeva che sarebbe stato vittima di un evento ineluttabile: la coda per raggiungere il mare. Gli era già capitato un migliaio di volte di restare imbottigliato, eppure sul suo volto si dipinse uno stupore infantile mentre scalava le marce dalla quarta alla prima. Subito dette la colpa a tutta una serie di circostanze nefaste: la seconda colazione al bar, il rifornimento superfluo di giornali all’edicola, il lavavetri che si era avventato sul parabrezza con il semaforo verde… 

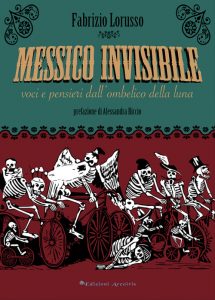

 A dire la verità questo fotografo, Alija Akšamija, non era uno qualunque, era un vero maestro. Il suo sogno di fare una foto che diventasse un simbolo si è avverato. È proprio lui l’autore della famosa foto del premio Nobel Ivo Andrić, ritratto accanto al protagonista del suo romanzo, il ponte di Mehmed Pasha Sokolović a Višegrad.
A dire la verità questo fotografo, Alija Akšamija, non era uno qualunque, era un vero maestro. Il suo sogno di fare una foto che diventasse un simbolo si è avverato. È proprio lui l’autore della famosa foto del premio Nobel Ivo Andrić, ritratto accanto al protagonista del suo romanzo, il ponte di Mehmed Pasha Sokolović a Višegrad. Per esempio le fotografie della strage di 22 persone in fila per il pane a Sarajevo nel 1992, dove tutto è bagnato di sangue, hanno avuto molto meno impatto sull’opinione pubblica della foto del violoncellista di Sarajevo, Vedran Smajlović. Vestito in smoking, noncurante dei bombardamenti e dei cecchini nella Sarajevo assediata, Vedran aveva suonato l’Adagio in sol minore di Tommaso Albinoni per ventidue giorni, un giorno per ogni vittima uccisa in fila per il pane. L’immagine del violoncellista è stata molto più esplicita, e descrittiva di quanto stava succedendo in Bosnia, rispetto a molte fotografie di orrori, morte, distruzione o sofferenze. “Un popolo sotto il fuoco d’artiglieria riesce a mantenere l’umanità”, con queste parole il “New York Times” aveva pubblicato la foto del violoncellista.
Per esempio le fotografie della strage di 22 persone in fila per il pane a Sarajevo nel 1992, dove tutto è bagnato di sangue, hanno avuto molto meno impatto sull’opinione pubblica della foto del violoncellista di Sarajevo, Vedran Smajlović. Vestito in smoking, noncurante dei bombardamenti e dei cecchini nella Sarajevo assediata, Vedran aveva suonato l’Adagio in sol minore di Tommaso Albinoni per ventidue giorni, un giorno per ogni vittima uccisa in fila per il pane. L’immagine del violoncellista è stata molto più esplicita, e descrittiva di quanto stava succedendo in Bosnia, rispetto a molte fotografie di orrori, morte, distruzione o sofferenze. “Un popolo sotto il fuoco d’artiglieria riesce a mantenere l’umanità”, con queste parole il “New York Times” aveva pubblicato la foto del violoncellista.




 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta
 di Federico Betta
di Federico Betta