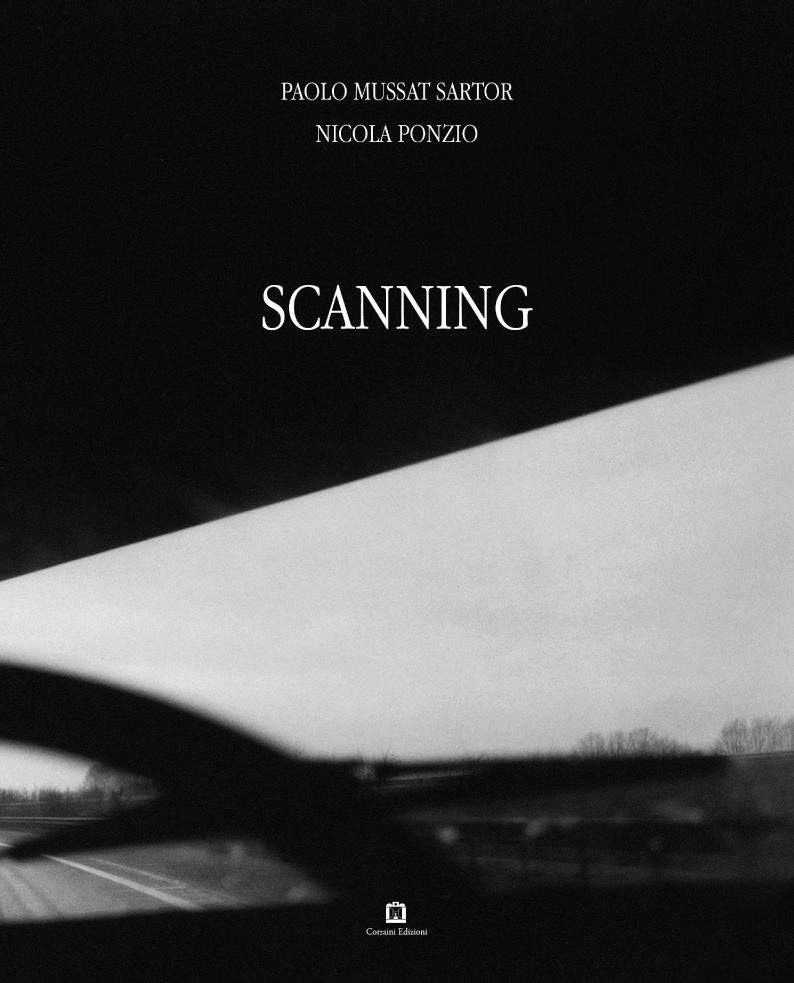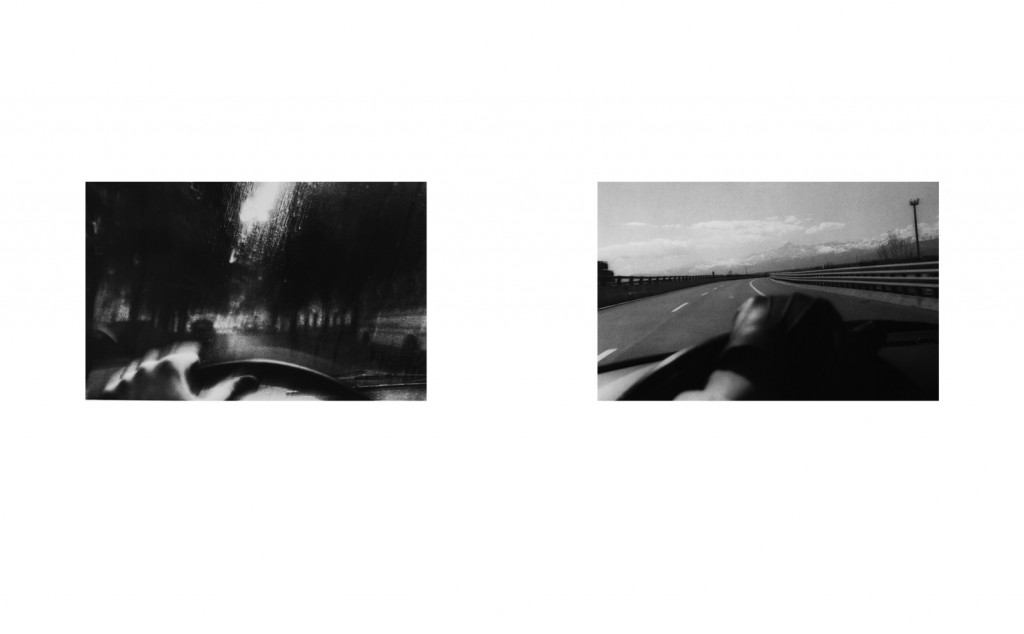“Mi piacevano le belle ragazze”, dice Luigi. “Mica volevo andare a combattere”. Il ragazzo che è seduto accanto a me, con una maglietta rossa e un foulard al collo, ascolta e sorride. Per lui Luigi Fiori è un eroe, non ci piove. La sua volontà di combattere è fuori discussione. Ha comandato centinaia di uomini, ha visto la morte in faccia, ha sofferto. Dire che non voleva combattere, è un understatement che lo rende ancora più grande. E sia. Uomini come Luigi sono grandi. Ma sono uomini.
“Mi piacevano le belle ragazze”, dice Luigi. “Mica volevo andare a combattere”. Il ragazzo che è seduto accanto a me, con una maglietta rossa e un foulard al collo, ascolta e sorride. Per lui Luigi Fiori è un eroe, non ci piove. La sua volontà di combattere è fuori discussione. Ha comandato centinaia di uomini, ha visto la morte in faccia, ha sofferto. Dire che non voleva combattere, è un understatement che lo rende ancora più grande. E sia. Uomini come Luigi sono grandi. Ma sono uomini.
(Così si apre l’introduzione di Eravamo come voi di Marco Rovelli. Un libro “fuori tempo massimo” in una società che ha dimenticato tutto. Che ha dimenticato persino perché può permettersi di dimenticare. Ma lavori di scavo vivo e presente come quelli di Marco sanno restituirci quella dimensione etica della società che appare perduta. Solo così riusciamo a comprendere perché dobbiamo dire grazie alle ragazze e ai ragazzi che hanno combattuto per noi. E che erano come noi, allora. Marco ci regala un capitolo del suo libro e noi per questo lo ringraziamo di cuore. G.B.)
di Marco Rovelli
Poi c’era Topolino. Che è stato uno dei partigiani più giovani tra tutti i partigiani. E che infatti dopo la guerra gli hanno dato pure la medaglia d’argento al valor militare. L’ho conosciuto a casa di Franco, perché dopo la guerra anche Topolino è stato un gran contrabbandiere. Che se ne andava per le montagne tutto da solo, e portava indietro tabacco e sigarette.
Luigi Fovanna ha solo 86 anni, quando ci vediamo da Franco davanti a un caffè corretto alla grappa. E ne dimostra molti di meno. Imponente, due gran baffi, lo definirei un montanaro distinto, tenuto in ottima forma e tempra dall’aria di montagna. Che chissà com’era quando aveva quattordici anni, pensi.
Ecco, mentre ci parlavo mi immaginavo di avere davanti il Pin, quello dei nidi di ragno.
A quattordici anni Luigi scappa di casa per andare con i partigiani. Era come un western, dice. Anche se allora gli western non li vedeva mica. Li vede adesso, e allora resta sveglio anche fino a mezzanotte. Altrimenti alle nove e mezzo è già a letto, fa così da sempre, in montagna ci si alza all’alba.
Guarda gli western, adesso, perché è la sua vita che era un western, si combatteva sulla frontiera della fame.
Se gli chiedi se andava a scuola, ti guarda come venissi da un altro mondo (e in effetti, è da un altro mondo che vieni). “Ho fatto la prima, dice, a sette anni era già finita. Andavo a fa’ l pastur, sopra Trasquera. Adesso mandi i figlioli a Rimini, di qua, di là, una volta ti mandavano a far da servitore a un contadino che poi ti dava niente, solo da mangiare e basta, ed era già manna!
Ti facevano la minestra, la polenta, ma col latte scremato, perché col resto ci facevano il burro. Pasta e riso tutto assieme, un miscuglio così. Si mangiava ul strutt! Era così in montagna, il contadino mangiava sempre gli scarti, la roba fresca doveva venderla!”.
Che poi siccome alla frontiera della fame ci si stava in tanti, e un ricordo tira l’altro, Franco ricorda: “Quando eri all’alpe con le mucche, il latte lo mettevi in una padella e lo lasciavi un giorno o due per togliere la crema per fare il burro, magari ci finiva dentro qualche topo? prima di tirarlo via lo leccavamo, il topo, che aveva la crema!”
“Eh, la gente oggi non è temprata per la vita”, chiosa Luigi. Per quella vita, no di certo.
Luigi era piccolino che venne via da Montecrestese. Prima a Varzo, dove ha fatto l’unico anno di scuola, poi verso i dodici anni a Vogogna, con quattro fratelli. Luigi è uno che vuole farlo capire che il suo era proprio un altro mondo, e che lui in quel mondo ci sapeva stare, e lo reggeva bene. Reggeva bene anche il vino. “Mia mamma mi raccontava che un giorno mi aveva lasciato a casa da solo, e quando è tornata mi ha trovato che ghignavo, ghignavo, ridevo… Mi metteva sullo sgabello da una parte e cadevo dall’altra… Poi ag vegn in ment da vardà ul fiasc da vin sul taul, ne mancava un bel po’! Hai capito, ero ciuc, a dui agn!”.
Temprato dalla vita, con il padre che non trovava un lavoro (ma Luigi capirà solo dopo il perchè), da ragazzino faceva i mille lavori della montagna. Portava su e giù la legna dal monte, e alla sera dormiva nel bosco da solo. Andava ad aiutare chi doveva far starnu, il letto di foglie delle mucche. Andava ad aiutare a fare il cemento. Quel che c’era da fare, lo si faceva. “E mi cercavano, perché rendevo cume ‘n om!”.
E quando a dieci anni sei in grado di dormire nel bosco da solo, affrontando gli spiriti della notte, e le streghe di quel folto, ché in Ossola è pieno di streghe, allora sei in grado di fare qualunque cosa. Come scappare di casa per andare coi partigiani, anche se non sai mica bene chi sono.
“Gh’era il Beldì, il Corani che era mio coscritto… sì, il fratello piccolo di Malombra…Gh’era l’Aldo Marta… era un po’ più grande di me, ma a quei tempi mica pensavi hai un an pussée che mi, un an meno da mi, eravamo tutti ragazzi che si giocava assieme… A un certo punto il Marta è sparito, duv’è andà… E ti dicono, con i partigiani, con Superti. E poi ci va il Corani. C’è andà lu, ci vo anca mi. Alura mi sun scapà di cà e son andà coi partigiani. Sono andato a Rumianca, sapevo che lì c’erano dei partigiani. Appena sotto la centrale, nella casa di uno che si chiamava Terzi, li ho trovati lì, c’era un tenente che si chiamava Franz, e subito m’han preso. Eran forestè, però han visto che ero un bocia deciso e mi han tenuto là. Che dopo venivano giù delle belle ragazze che mi baciavan sulla bocca, eh, mi ero un bocia… Però mia mamma e mio papà han saputo e son venuti a vedere per portà a cà el fiol. Portatelo pure a casa, ma guardate che se questo vuol star qui ci torna! E infatti mia mamma, conoscendomi, Lassumal lì, almeno sappiamo dov’è…”.
E’ il febbraio del ’44, Luigi è con la Di Dio, divisione Valtoce. E diventa Topolino. “Sì, il cartone animato c’era già, ma Topolino perché ero un ragazzino”.
Alla sera Topolino dorme in una cascina sopra Rumianca, e alla mattina scende allo stabilimento, va al deposito biciclette, ne prende una e gira per la valle. Guarda cosa succede in giro nei paesi, e riferisce. Relaziona sui movimenti dei fascisti, come quando vede che hanno catturato un partigiano e lo fanno camminare in testa a un plotone per andare a recuperare una mitragliatrice nascosta sotto il ponte del Migiandone.
Una volta porta una busta al battaglione di georgiani arruolati coi tedeschi, erano accampati a Mergozzo, c’erano stati dei contatti per farli disertare e passare coi partigiani, lui ne vede uno alla stazione, un po’ a caso, che se non era il georgiano giusto poi, ma non ci pensa due volte, il georgiano lo porta fuori dalla stazione, scende in un campo di mais, legge la busta, e gli risponde Noi andiamo a Borgomanero, facciamo fuori il comandante e poi veniamo da voi. Poi il bocia ciapa la bici e torna a Rumianca.
A volte c’è da recuperare cibo per dei partigiani nascosti, e allora lui, con i “biglietti” dei partigiani, che è come cartamoneta sulla fiducia, si fa dare farina, riso, formaggio, latte. Il negozio del Beldì a Vogogna, per esempio, lui gliene dà sempre, o il Ripamonti al mulino. E se non glielo danno, come al dopolavoro di Pieve Vergonte, entra nello scantinato di nascosto e fa provviste da solo.
Anche se non porta armi è un partigiano, e gli fanno una divisa. E’ in telatenda, come si diceva, non l’ideale per un guerriero, ma Topolino ne va orgoglioso. Un giorno si va fino a Nonio a ritirare un lancio degli americani. A Topolino tocca uno zaino bucato. Ma il carico è lo strutto, e la strada è lunga e faticosa. Lo strutto comincia a colare giù per la schiena. Quando si arriva a Rumianca, la divisa è da buttare. E questa fu una delle grande delusioni della guerra per il bocia partigiano.
Che poi i partigiani, la prima volta, li aveva visti a Villadossola, l’8 novembre, il giorno dell’insurrezione, che il giorno dopo arrivarono perfino gli aerei a bombardare, e il Redimisto Fabbri lo torturarono e fucilarono a Pallanzeno con altri cinque. Luigi, che ancora non era Topolino, aveva sentito che c’erano dei tumulti ed era andato a vedere, perché lui era mica uno che c’aveva paura di qualcosa, lui, e aveva visto un tedesco moribondo su un carrettino per portare le verdure, tremava smodatamente come un epilettico, e anche se Luigi non sapeva cos’era un epilettico aveva gli occhi per vedere quella cosa schifosa che è la morte.
Il giorno dopo aveva seguito l’onda, quando tutti erano dovuti scappare da Villadossola, ed era andato verso la centrale di Pallanzeno che c’erano già i tedeschi che giravano, e un tizio che scappava con lui gli aveva dato una Beretta calibro nove, “tienila poi me la ridai quando ci vediamo”, l’aveva presa disarmando i carabinieri ma adesso era più prudente non averla dietro, quello era un bocia e non correva rischi, che poi insomma anche per il bocia non era il caso di averla, ma col suo curai dela madona se la lega in mezzo alle gambe e torna verso casa, che al ponte di Pallanzeno incontra una di quelle macchine scoperte che chiamano scim-sciam, insomma una Fiat con la capotta, sono tedeschi, lo vedono a distanza e gli fanno segno di avvicinarsi, che lui avvicinandosi correndo si accorge di avere le pallottole nel taschino e pensa Adesso mi cadono, e invece non gli cadono e i tedeschi quando vedono che è un bocia lo lasciano andare, e allora lui via verso casa, e nasconde la pistola nel casale diroccato vicino casa, proprio vicino al ponte di Dresio, e adesso ce l’ha lì una pistola, e sai come ci si sente forti con quella, che già non hai paura di niente, e con quella sei fortissimo, di cosa puoi aver paura con quella, va nel casale di tanto in tanto a tirarla fuori dal nascondiglio e se la guarda, se la strofina, è sua, non sa cosa può farci e contro chi e perché ma è sua come sue sono le braccia e le gambe, e forse ci ha perfino guardato dentro il buco della canna come Pin nella pistola del tedesco, fatto sta che il papà si accorge che va troppo spesso in quel casale come a un santuario, e scopre la Beretta, caccia degli urli che non ti dico, se la prende, la dà a degli amici, che la diano ai partigiani.
“Per me andare coi partigiani era un’avventura. Come un western, capìo?”.
(La colonna sonora di quel western era anche per Topolino Marciar marciare – e chissà come gli risuonava alle orecchie quel verso, Mamma non piangere).
“Se mi avessero detto chi sono i fascisti? Gente come noi che mangian pussée ben, gh’en ben vestiti e stanno meglio di noi”.
“Non ho fatto il partigiano come il patriota convinto… Sbarcavo il lunario, poi mi son trovato che stavo peggio che prima. E poi una volta che sei lì non puoi venire via quando vuoi…”
“Ho cominciato a capire quando mi dicevano vai qui vai là passa a vedere… Una volta capito a Anzola, c’erano tedeschi e fascisti, e sottolineo fascisti. A un certo punto sento sparare raffiche, davanti alla cooperativa, c’erano 22 o 23 mitragliatori messi giù, e in una roggia c’erano quattro o cinque ragazzi, distesi per terra, uno aveva una tuta da ginnastica blu, con la barba. Me lo ricorderò sempre”.
Ecco, questo ti dice Topolino, se gli chiedi quando ha cominciato a capire.
I grandi lo proteggevano dalla morte, però. Il comandante Ugo, in particolare, aveva dato disposizione che lui non vedesse mai qualcuno che muore. Come quella volta che è in una stalla a dormire tra i cavalli, sente degli spari, allora esce per vedere che succede. Arriva e vede un uomo per terra, che grida “Vigliacchi, avete ucciso vostro fratello”… Saprà il giorno dopo che era una spia che aveva fatto prendere due partigiani a Pallanzeno, era stato preso e, pensando che lo avrebbero ucciso, era scappato: per quello gli avevano sparato. Ma non assiste all’agonia dell’uomo: un partigiano gli grida: Vai a dormire!
Quando arriva la Repubblica, Topolino fa il bocia, molla la Di Dio e se ne va a Domodossola. “Ero il bocia partigiano, chi mi baciava, chi mi prendeva in spalla, chi mi dava da mangiare, insomma tutti mi volevano vicino, specialmente magari quelli che avevano timore perché magari avevano fatto qualcosa contro i partigiani e allora si ingraziavano un ragazzino, perché gli altri erano pussée dritti e mica si lasciavano infinocchiare come un bocia!”. Prende dimora a Villa Tibaldi, dove prima erano i tedeschi, e dove anche Arialdo aveva fatto la guardia: “stavo bene lì, mangiavo e bevevo! Poi passa qualche giorno, entrano i miei della Di Dio, Hai abbandonato la squadra, ti fusilan sicur! Scherzavano, ma m’ero preso una paura… Insomma sono tornato a Ornavasso con loro, facevamo il servizio di guardia al passaggio a livello. E le pallottole che fischiavano quando sono arrivati i tedeschi!”.
A Ornavasso Topolino incontra il padre. Anche lui era con la Valtoce, ma mica si erano mai incrociati, Topolino non sapeva che fosse pure lui un partigiano. Si vedono allo spaccio dove davano le sigarette. A quattordici anni mica si fumava. Suo padre lo vede con un pacchetto di tabacco. Glielo prende, gli dà le sigarette in cambio: “Piglia queste che ti fanno meno male”. E poi se ne va con la sua squadra.
Il padre di Luigi era elettricista, lo avevano cacciato da due stabilimenti perché non aveva la tessera del fascio. Tanto che i primi anni di guerra aveva dovuto andare nel bergamasco, a lavorare la terra.
E adesso che lo vede partigiano, Luigi capisce. Non era solo per la povertà che lui non aveva la divisa dei balilla, e piangeva perché non ce l’aveva, e il massimo che avevano potuto fare i suoi era comprargli i calzettoni verdi con la riga nera che solo con quelli Luigi si sentiva chissà chi; capisce che anche se qualcuno gliel’avesse comprata, la divisa, non gli avrebbero permesso di metterla.
Eh sì, i fascisti erano quelli che mangiavano e erano vestiti bene. “Che da Fontana dovevo andare a piedi fino a Bertogno, che adesso è un passo, ma a quei tempi era una distanza enorme, con la neve, gli zoccoli ai piedi, un freddo bestia e senza mangiare, arrivavi a casa e non trovavi niente da mangiare. Quelli invece eran tutti bei rotondi e mangiavano, mi avevo una fam dela madona…”
Poi arrivano i fascisti, che al ponte dov’erano di guardia il Ghiringhelli viene sbalzato via da una cannonata ma neanche un graffio, ed era bianco come se l’avessero messo in un sacco di farina, e più in su una cannonata porta via un angolo della casa dove adesso c’è il museo della resistenza, e Topolino prende una scheggia nella gamba che non ci fa caso ma la scheggia c’è e poi comincia a gonfiare e far male, e quando arriva a Crodo dopo tanti di quei chilometri di andirivieni che non sa come ha fatto si butta su un mucchio di segatura per riposarsi, e lì è la seconda e ultima volta che vede suo padre durante la guerra, che lui guidava un camion per portare in salvo chissà cosa e poi alla cascata del Toce i tedeschi lo catturano, il papà, e decidono di fucilarlo, ma un istante prima della fucilazione altri partigiani tirano una bomba a mano ai fucilieri e il papà di Topolino se ne fugge in salvo con gli stivali dei tedeschi, e intanto anche Topolino riesce ad arrivare in val Formazza per scappare, e ci arriva in moto perché non poteva più camminare, e poi giù in teleferica verso la Svizzera, e siamo salvi.
Topolino è di quelli che tornano in Italia. Arriva alla casa di Vogogna, ma gli dicono che i fascisti lo cercano, e allora torna in montagna: ma la Valtoce non c’è più, e così trova la Redi, brigata Garibaldi, e va con loro. Si becca anche un rallestramento il 25 marzo che devono scappare e mentre scappano su un sentiero cade una gavetta, il rumore segnala la posizione dei fuggiaschi, i tedeschi sparano, centrano Topolino al piede.
Lo caricano in spalla, lo mettono in una coperta e lo portano giù al paese di Ponte, a una specie di infermeria. Ma qualcuno fa la spia: “sento un casino, non capivo, tra il freddo la fame e il sangue perso mi sembravano i ragazzi che escono di scuola quando corrono. E invece era la gente che gli bruciavano il paese. I fascisti cercavano il ferito. Hanno ammazzato una donna incinta, col mitra, e poi uno che veniva dall’ospedale di Omegna che aveva in tasca una preghiera dei partigiani che gli aveva dato una suora. Lo hanno legnato negli stinchi finché si sono spezzate le gambe, poi lo hanno ammazzato”. Doveva essere la preghiera del garibaldino che aveva voluto il comandante della Garibaldi della Valsesia, Cino Moscatelli, corredata con tanto di icona di San Michele Arcangelo che trafiggeva il demonio. E questo indemoniava i fascisti ancora di più.
Entrano anche nella casa dov’è Topolino, i fascisti, lui sta rinserrato in un buco dove si entra per un passaggio segreto dietro la credenza, ma gli va bene, ché quando i fascisti se ne sono andati riescono a spegnere l’incendio e lo mettono in salvo. Passerà il resto del tempo prima della Liberazione prima in un buco di una grotta e poi su una cengia, sotto un larice, dove lo calavano giù la mattina e lo tornavano a prendere la sera, che almeno la notte era meglio dormisse in una baita.
Finita la guerra, Luigi si mette a lavorare. E il suo lavoro sarà il contrabbandiere. Poi, ereditando il sapere paterno, diventerà un bravo elettricista, e per molti anni girerà il mondo per i cantieri dove costruiscono centrali elettriche. Ma sempre con la nostalgia per il contrabbando, per la solitudine della montagna, quell’intimità con la smisuratezza delle cime. Per quel passare le frontiere in silenzio, di nascosto da tutto e da tutti.
“Il mondo è nato senza frontiere, le frontiere le ha fatte l’uomo. La legge dell’uomo ti condanna, la legge di Cristo non ti condanna mica. Però la questione è che se ti mettono in galera, non viene mica, Gesù Cristo!”.


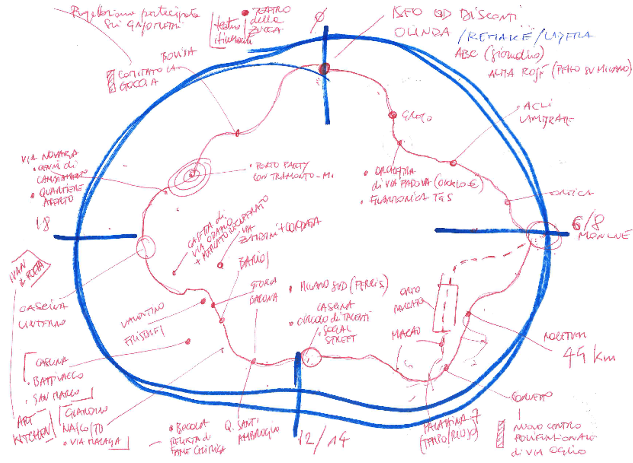

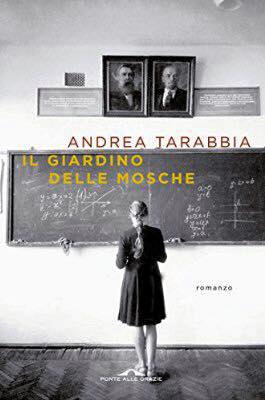
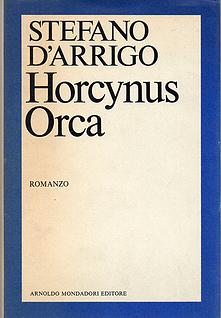
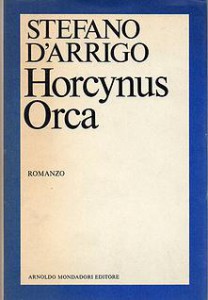
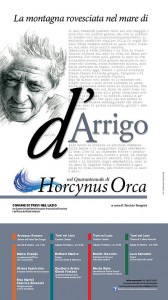





 Anche la seconda poesia, scritta l’11 gennaio 1872, vede protagoniste le sorelle Drury, stavolta nella veste un po’ insolita di piccole mascalzone; al pari della prima, anche questa è la dedica contenuta in uno dei libri di Carroll, una copia di Attraverso lo specchio, che come si vede è citato giocosamente nei versi.
Anche la seconda poesia, scritta l’11 gennaio 1872, vede protagoniste le sorelle Drury, stavolta nella veste un po’ insolita di piccole mascalzone; al pari della prima, anche questa è la dedica contenuta in uno dei libri di Carroll, una copia di Attraverso lo specchio, che come si vede è citato giocosamente nei versi.