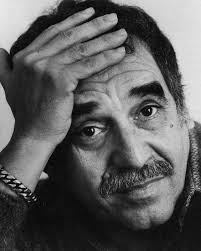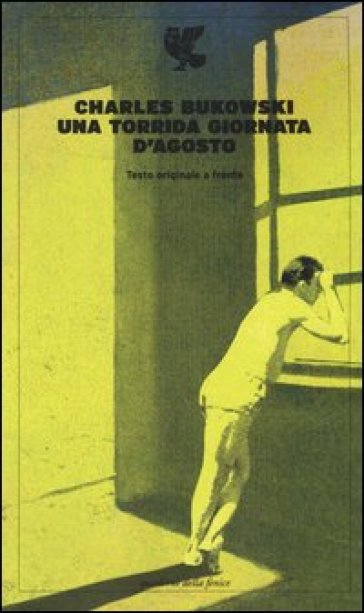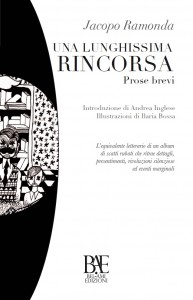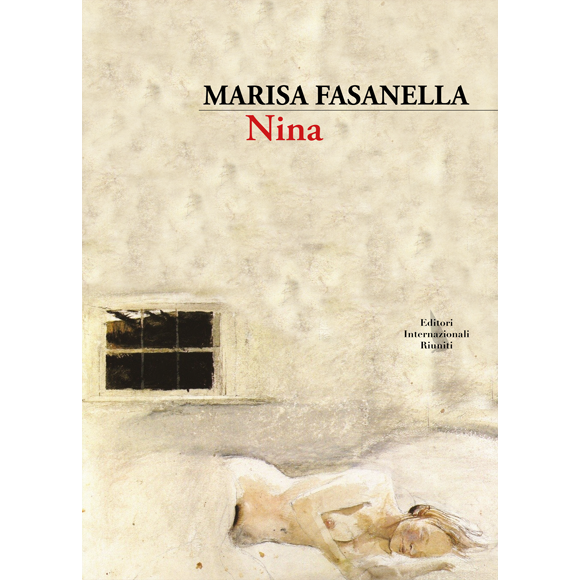Gery Geddes
(trad. Angela D’Ambra)
A mio modo li ho amati, al punto
da pagare il fucile in moneta sonante,
studiare la strategia l’intera notte.
Non mi lamentai per il vento freddo
o l’estenuante ascesa alla torre;
neanche la lunga attesa e il rancido afrore
dei piccioni fiaccarono la mia pazienza.
Quando, dopo un po’, apparvero,
nel fulgido sole d’inverno, a mezzogiorno
non lesinai sforzi per calibrare il fucile,
posizionare la delicata croce del mirino
in linea con le loro tempie o i petti.
E quando si misero a correre, dopo che il primo
crollò stecchito nella neve molle,
mai persi la calma, ma li presi
uno a uno, come un gatto coi gattini.
Quando andai a esplorare il paese
portai parastinchi, maschera antigas,
gomme da neve con borchie in metallo,
radar, bazooka, aerei da ricognizione,
borotalco, filo interdentale, fucili
FN, passaporto falso, tessera sanitaria
e un sospensorio con coppa di metallo.
Nel viaggio d’esplorazione del paese
mi procurai fumetti di Batman, walkie-talkie,
bombe a mano e baionette, uno yoyo,
il ricordo d’una madre che sventola calzini
e biancheria pulita, assicurazioni sulla vita,
l’Enciclopedia Britannica, la benedizione
di Mosè, una cassetta, un quarto di whisky,
antistaminici, alcuni indirizzi,
tamburi bongo, Playboy, congegni
per intercettazioni, sacchi da rifiuti verdi,
Kleenex, lassativo, gommone gonfiabile,
pemmican, razzi, cerotti anticallo,
biglietti di ritorno, batterie di ricambio,
contraccettivi, un atlante.
Sapevo che questo era il posto giusto:
smerciai l’intero lotto il primo giorno.
Mi feci carne;
Nuotai, impaziente,
in acque placentali.
Guanti di gomma
diressero il mio cranio letale
nella breccia, mi lanciarono
in mari più sottili.
Un quarto di buon champagne
mi schizzò lungo i fianchi,
un motore minuto
mi sospinse avanti.
Navi affondarono, una dopo
l’altra, le urla degli uomini
non valsero a nulla.
Cantai nell’aria,
il mio canto
infranse un pensiero di bambino.
Mi piantarono nei campi,
sotto ponti, nessuno
raccolse i pezzi.
Mi lanciarono su città;
la carne bruciata mi s’impuntò
in gola.
Mi svecchiarono, mi resero
slanciato, bello.
Divenni vanesio. Inesausta
era la mia brama.
Li osteggiai.
Menzionarono dio, l’onore.
Mi pulii la bocca
sulla manica.
Ci reputiamo
stabili, concrete.
Nessuna rilevante caducità,
pure avemmo la nostra quota
di arrampicatori sociali.
Fummo ciò che fummo,
su noi si poteva sempre contare
per restare ferme
a produrre, o riprodurci.
Conservatrici in politica:
né avide né ribelli,
solo noiose. Che accadde?
Fu ambizione o vanità,
volare troppo vicino al sole
quasi a scrollarci di dosso
questo dedalo di radici,
lo stigma del posto?
Sia come sia, ci bruciammo.
Ci fu un’esplosione,
una luce accecante.
Saltarono i trasmettitori
si sciolsero. Uno squarcio
s’aprì nel firmamento
e con noi sparì
tutto ciò che esiste.
Marlon Mendizabel accende la TV
dopo un duro giorno di trattative. I bambini
giocano ai suoi piedi, la partita di football in onda
sul canale americano. Tutta la mattina
incontri coi dirigenti alla fabbrica di Coca-Cola
per risolvere lo sciopero. La Società
ne ha assunti tre nuovi, ufficiali dell’esercito,
a dirigere stoccaggio, risorse umane, sicurezza.
Sei occhi lo vogliono morto, sei nuovi occhi laser
negoziano la sua scomparsa pezzo a
pezzo. Prima a svanire è la voce che tenta
con passione, con logica, ma nulla di quel che
dice sembra avere il minimo effetto.
Poi le mani, riprendendo la discussione,
in sostegno alla voce, vacillano,
sconfitte a un soffio dalla meta.
Presto le sole braccia che possiede per arrendersi,
quelle pure svaniscono. S’adagia sullo schienale, uomo
invisibile, un desaparecido, ma la famiglia
non lo nota. Niente di quanto fatto o detto
gli farebbe perdere la faccia, ma quella pure
svanisce insieme col resto. Non è il solo.
Ventisette leader sindacali
della Confederazione Nazionale del Lavoro
sono stati sequestrati; due mesi dopo
altri diciassette, omicidi confermati
dalla Conferenza dei Vescovi del Guatemala.
Marlon vuole vivere per i suoi figli,
ma è troppo tardi. Delle 208 ossa nel suo corpo,
metà sono tornate in casse da imballaggio.
La dieta di paura gli contrae lo stomaco.
I figli guardano lo spot della bibita analcolica
in TV, tifando per il camion della Coca
se quello rivale lo distanzia. Vorrebbe
dir loro che non si tratta di gusto, ma di etica,
che il camion contiene le ossa di 100.000
guatemaltechi ammazzati, trucidati da squadroni
della morte al soldo del governo e di grandi compagnie.
Invece, stende una mano invisibile sulle loro teste
e offre una muta preghiera per la loro salvezza.
Il cuore di Marlon si allarga tanto da colmare la stanza
finché anche quelli alla TV se ne accorgono
e interrompono l’attività per guardare e ascoltare
il messaggio di quel cuore in comunione
con Dio. I giocatori di football si tolgono i caschi
e restano in piedi a testa china; gli speaker,
per una volta, sono a corto di parole. Fuori
Dallas, il camion della Coca accosta, luci
lampeggianti. Si apre una portiera e quelle ossa
formano un ampio ponte che si stende fino
a Città del Guatemala. Bambini lo attraversano,
mani unite, cantando. Niente li può fermare.
È difficile, adesso, parlare di queste cose.
Descriverei invece come la luce piove
nei cortili, al mattino, su panni
stesi ad asciugare.
Quel bimbo nel vano della porta
che si volge al suono delle persiane,
fra il ridente e il corrucciato.
E i capelli di Carmen
che colmano il finestrino di dietro
della Peugeot.
Quindici finestre nel poster di Lonquen,
un volto in tutti, tranne uno.
Campesinos dall’Isola di Maupu
torturati e sepolti vivi
nella calce. Padre
e tre figli.
Riquadri di testimonianza
dell’agente Valenzuela:
un gruppo ucciso alla base aerea,
altri gettati in mare
da elicotteri, stomachi squarciati.
Ogni affisso un micro-condominio,
inquilini che fissano giù in strada
qualche fatto, un corteo,
un tramonto. Altri otto a Valparaiso
che avrebbero dovuto guardare il mare.
Ho visto una buganvillea
nella vetrina di un ristorante
vicino al luogo dell’agguato;
e una vetrina con un cactus spinoso
in fiore, un maiale di coccio
e una sfilza d’uccelli in vimini
che con grazia roteano nel vento.
Perch・sorridono, queste facce in cornice
sanno qualcosa che noi ignoriamo?
Dietro loro bianco perpetuo,
luce brillante
al termine del tunnel.
Forse siamo noi i perduti
e loro vegliano su noi
da qualche mondo perfetto,
chiedendosi la ragione di tanto
scompiglio, perché
queste maschere di sofferenza.
Quando le rompono gli occhi
le immagini restano.
Il suono d’elicottero
si perde. Il mare lecca
il rosso dal suo stomaco.
***
I loved them, in my own way,
enough to pay hard cash for the rifle,
to plan my strategy long into the night.
I did not complain about the cold wind
or the exhausting climb to the tower;
even the long wait and the rank-smelling
pigeons never taxed my patience.
When they emerged, after a time,
into the bright winter sun at mid-day,
I spared no effort to steady the rifle,
to bring the delicate cross of the gun-sights
into line with their temples or breasts.
And when they began to run, after the first
had settled to rest in the soft snow,
I never lost my cool, but took them
one by one, like a cat collecting kittens.
When I went to spy out the land
I took shin pads, gas mask,
snow tires with metal studs, radar,
bazookas, reconnaissance planes,
foot powder, dental floss, FN
rifles, forged passport, hospital insurance
and a jock-strap with a metal cup.
On my way to case the land
I took Batman comics, walkie-talkie,
hand-grenades and bayonets, a yoyo,
the memory of mother waving clean socks
and underwear, life insurance,
the Encyclopaedia Britannica, Moses’
blessing, a cassette, a mickey of rye,
anti-histamine, a few addresses,
bongo drums, Playboy, equipment
for wire-taps, green garbage bags,
Kleenex, laxative, an inflatable raft,
pemmican, flares, corn-plasters,
return tickets, spare batteries,
contraceptives, an atlas.
I knew this was the right place,
I sold the whole lot the first day.
I became flesh;
I swam, impatient,
in placental waters.
Rubber gloves
guided my lethal skull
into the breach, launched me
into thinner seas.
A quart of good champagne
splashed down my sides,
a tiny motor
propelled me forward.
Ship after ship went
down, the screams
of men meant nothing.
I sang in the air,
my song
shattered a child’s thought.
They planted me in fields,
under bridges, no one
collected the pieces.
They dropped me on cities;
the charred flesh stuck
in my throat.
They updated me, made me
Streamlined, beautiful.
I grew vain. My lust
could not be glutted.
I turned on them.
They spoke of god, of honour.
I wiped my mouth
on my sleeve.
We considered ourselves
stable, down-to-earth.
No appreciable transience,
though we had our share
of social climbers.
We were what we were,
could always be counted on
to stay in one spot
and produce, or reproduce.
Our politics were conservative:
neither greedy nor revolting,
only dull. What happened?
Was it ambition or vanity,
flying too near the sun
as if to shake off
this labyrinth of roots,
the stigma of place?
Anyway, we got burned.
There was an explosion,
a blinding light.
Our transmitters fritzed,
then melted. A rift
opened in the firmament
and with us went
everything that is.
Marlon Mendizabel turns on the TV
after a hard day of bargaining. Children
play at his feet, a football match in progress
on the American channel. All morning
he has met with officials at the Coca-Cola
plant, trying to resolve the strike. The Company
has hired three new army officers to direct
warehousing, personnel and security.
Six eyes want him gone, six new laser eyes
negotiate his disappearance piece
by piece. First his voice, venturing out
passionately, logically, vanishes, as
nothing he says makes the least impression.
Then his hands, picking up the argument,
running interference for his voice, falter,
are brought down short of the goal.
Soon the only arms he has to surrender
are gone too. He leans back, an invisible
man, a desaparecido, but the family
hasn’t noticed. Nothing done or said
could make him lose face, but that went too
along with the rest. He’s not alone.
Twenty-seven union leaders
from the National Confederation of Labour
have been kidnapped; two months later
another seventeen, murders confirmed
by the Conference of Guatemalan Bishops.
Marlon wants to live for the sake of his kids,
but it’s too late. Of the 208 bones in his body,
half have returned to the packing-crates.
His abdomen shrinks from its diet of fear.
His children watch the soft drink commercial
on television, cheering on the Coke truck
as it falls behind that of its rival. He wants
to tell them it’s a matter of ethics, not taste,
that the truck contains the bones of 100,000
murdered Guatemalans, killed by death-squads
in the pay of government and large corporations.
Instead, he lays an invisible hand on their heads
and offers up a silent prayer for their safety.
Marlon’s heart grows so large it fills the room
until even those on television notice
and stop what they’re doing to watch and listen
to the message of that heart as it communes
with God. Football players take off helmets
and stand with heads bowed; the announcers,
for once, are at a loss for words. Outside
Dallas, the Coke truck pulls over, lights
flashing. A door opens and those bones
form a vast bridge that stretches all the way
to Guatemala City. Children are crossing, hands
joined, singing. Nothing can stop them.
It’s difficult now to speak of these things.
I’d rather describe the way light falls
in morning courtyards, on clothes
hung out to dry.
That child in the doorway
turning to the sound of the shutter,
half smiling, half indignant.
And Carmen’s hair
filling the entire back window
of the Peugeot.
Fifteen square windows in the Lonquen
poster, a face in all but one.
Campesinos from Isla de Maupu
tortured and buried alive
in lime. Father
and three sons.
Windows of agent
Valenzuela’s testimony:
a number killed at the air-base,
others thrown into the sea
from helicopters, stomachs opened.
Each poster a small apartment building,
tenants gazing into the street
at some event, a demonstration,
a sunset. Eight more in Valparaiso
who should have looked out on the sea.
I saw bougainvillea
in a restaurant window
near the place of ambush;
and a window with a spiky cactus
in full bloom, a pottery pig
and a string of wicker birds
turning gently in the wind.
Why do they smile, these framed faces,
do they know something we don’t?
Behind them perpetual white,
bright light
at the tunnel’s end.
Perhaps it is we who are lost
and they looking out at us
from some perfect world,
wondering what all the fuss
is about, why
these masks of suffering.
When they break her eyes
images remain.
Sound of the helicopter
recedes. Sea is a window
above him, water tongues
the red from his stomach.
*
Gary Geddes, nato nel 1940 a Vancouver, Columbia Britannica, è poeta, critico, autore di teatro, scrittore di viaggio e nature writer, curatore di antologie ed editore. Tra le sue opere di poesia ricordiamo: Poems (1971), Rivers Inlet (1972), Snakeroot (1973), Letter of the Master of Horse (1973), War & other measures (1976), The Acid Test (1980), The Terracotta Army (1984; 2007); Hong Kong (1987), No Easy Exit (1989), Light of Burning Towers (1990), Girl by the Water (1994), The Perfect Cold Warrior (1995), Active Trading: Selected Poems 1970-1995 (1996), Flying Blind (1998), Skaldance (2004), Falsework (2007); Swimming Ginger (2010). I testi qui inclusi sono tratti dall’antologia inedita Being Dead in Venice.