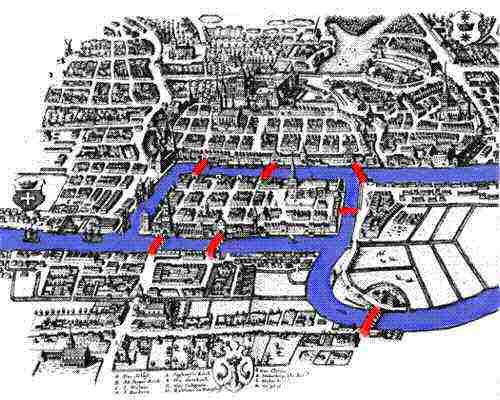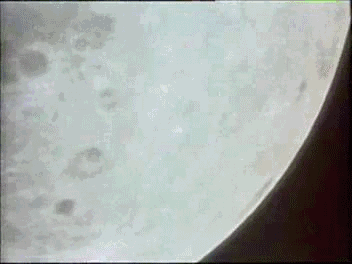di Franz Krauspenhaar
Call-center. Tutt’altro che una parola magica, che una formula per la scoperta di qualcosa di utile. Un solo significato pregnante, che ne nasconde qualsiasi altro: sfruttamento elettronico.
“Operai telefonici, ecco quello che siamo”, mi dice un ragazzo che forse non è più un ragazzo, a guardarlo con attenzione. Indossa una maglietta nera con su stampato il nome di una rock band degli anni Ottanta. Ecco, mi trovo davanti a un esemplare non raro di essere umano di sesso maschile fuori tempo massimo. Una specie di pugile suonato del mondo del lavoro, di reperto funzionante.
I turni sono serrati, giovani e meno giovani si pigiano alle loro postazioni. Uomini e donne, più o meno in parti uguali. C’è di tutto: dallo studente di buona famiglia che raggranella i soldi per la vacanze in Spagna allo studente che viene da fuori – spesso da molto fuori – e lavora al call center per pagarsi l’esoso affitto. E poi il disoccupato, di età indefinita, di indefiniti gusti e inclinazioni, che le ha provate tutte, e alla fine è arrivato qui, all’ultima stazione, un luogo teoricamente di transito che alla fine è diventato definitivo, o quasi. C’è l’ex manager licenziato che non riesce a ricollocarsi e in attesa di una chiamata propizia sconta la sua pena al call center. E c’è la pensionata, che distribuisce caramelle ai giovani per ingraziarseli, che parla con spiccato accento milanese e ha vissuto la sua vita lavorativa in fabbrica e ora è qui perché i soldi non bastano mai.