di
Pasquale Panella e Lucio Saviani e
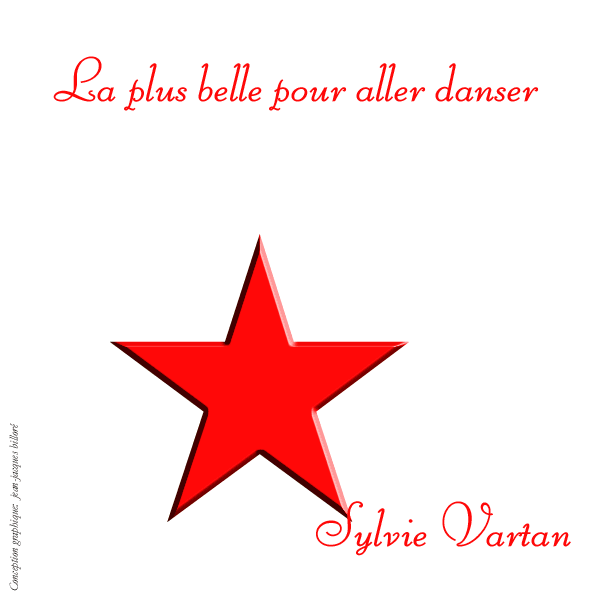
2
… ho gli occhi abbacinati dal tramonto…
invasi da un superbo verdazzurro…
1
… un’ottima risposta della retina…
2
… un po’ come…
un’idea fissa…
Filippo La Porta to Christian Raimo
Caro Christian, ho appena fatto una recensione al libro da te curato (Il corpo e il sangue d’Italia), però la tua introduzione mi ha lasciato perplesso. In che senso? A prima vista ineccepibile, ultracorretta. ll valore semantico della parola “verità” (che una volta Freccero disse trattarsi di citazione dagli anni ’60), e poi il principio di realtà e perfino la “provocazione etica”! Ma sei sicuro che queste cose ti appassionino? Mi sono perso forse qualche passaggio. In un dialogo con Cortellessa non ricordo che tu opponessi una resistenza memorabile al suo negare il valore semantico dei concetti di “verità” e “autenticità”…
Dopo aver letto la tua introduzione ho pensato di avere di fronte un ircocervo: che so, il corpo di Cortellessa ma la testa socratica di Fofi, il nichilismo un po’ cinico di Scarpa e lo sdegno che dà sul vernacolo di Giacopini… Mi permetto di dirtelo proprio perché tu stesso inviti a mettersi in gioco. Visto un po’ dall’esterno il tuo atteggiamento sembra una variante all’interno del gioco italianissimo dei travestimenti. Ma: pronto a ricredermi, naturalmente. L’etica? Sì, vabbè, ma su cosa la appoggiamo? Una tradizione? Il passato? Il futuro? L’amore per qualcosa o qualcuno? Una fede appunto nella “realtà”? Tutte cose che, credo, abbiamo urgente bisogno di ri-motivare di nuovo. Non ti pare?

di Sergio Soda Star
a gucci
sono preda delle particelle
che sono belle
vedo le luci colorate
l’intermittenza ci fa qualcosa
nel sogno (pure) è innamorata
cadono le comete e tutti gli astri
quando mi ricordi
capita di rado
sono venuto a dirti che me ne vado
***
In assenza di.
Se ciò che è riflesso somiglia
occorre che il vetro sia rotto
perché con le schegge si tagli.
La pelle (l’immagine sotto).
Riportare notizie in merito ad un percorso proprio implica la necessità di un’osservazione attenta ed attendibile. Poiché, tuttavia, un percorso in fieri è per definizione in continuo movimento, una fotografia dello stesso non potrebbe che risultare mossa. Inoltre, riferire di un’esperienza necessaria continuamente rinnovata (quale la scrittura per chi, qui, ne scrive) sarebbe come segnare i punti cardinali del proprio mangiare o dormire etc.. Infine, il miglior modo che un autore può scegliere per veicolare il proprio percorso è, per l’appunto, la propria opera e più rivolto a questa sarà lo sguardo più la focale risulterà esatta. Una prima forma di assenza è quindi mancare rispetto al compito assegnato. Ecco che di fronte all’invito a tracciare una traiettoria relativamente al proprio “fare versi”, chi scrive in questa sede tenta impropriamente di seguire la traiettoria che un verso, il verso di qualunque autore di poesia, fa o può fare.
di Cristina Babino
Monsanto è un lembo sperduto e antico del Portogallo centrale, nella regione interna di Beira Baixa. Nel 1938 il regime fascista, col suo vacuo primatismo da propaganda, coniò per esso la definizione di villaggio più portoghese del Portogallo, motto che occhieggia tutt’ora nei dépliant turistici e sui cartelli stradali. Dall’aeroporto di Lisbona occorrono circa tre ore di macchina per giungere qui, nel distretto di Castelo Branco, a sud-est della catena montuosa della Serra de Estrela. Il confine spagnolo è a un passo, si avverte nei nomi delle cose, e nell’aria calda e calma che pervade le vallate anche in inverno. Dalla capitale si punta in autostrada al cuore di roccia del Paese, per due buone ore e mezzo, poi ci si inerpica per strade più o meno impervie tra i diciassette villaggi del comprensorio di Idanha-a-Nova, di cui Monsanto è un municipio – una freguesia, secondo il termine locale usato ai tempi dei remoti splendori dell’Impero portoghese.

Un’orchestra che non agonizza, un singolare caso di lotta per il lavoro
di
Cristian Raimo
Tempo fa sempre qui scrivevo questo, che c’era un’orchestra che moriva.
Oggi ci sono delle novità, che non sono novità. Il tavolo con la Regione, due incontri, è chiuso. La Fondazione ha promesso di rispettare il contratto nazionale sottoscritto l’anno scorso (9 mesi di programmazione) ma a scapito della densità di concerti, presentando cinque mesi di programmazione. Dopo uno stop di sei mesi non retribuiti. I bilanci, promessi, non sono stati presentati. La ridotta attività comporta una ulteriore riduzione dei finanziamenti pubblici. Regione e comune latitano. L’Orchestra ha deciso l’agitazione permanente, cioè tutti i concerti in Auditorium saltano fino alla riapertura delle trattative. Pare che il vero capo della Fondazione sia un uomo solo (dimissionario in teoria, ma ancora in carica), arroccato a Segni, che ha rifiutato diverse offerte di direttori stabili, inviti a festival stranieri, ecc. forse per mantenere l’egemonia. Oggi l’ANSA dà notizia della petizione. Altre iniziative programmate: manifestazione a Segni (venerdì), concerto gratuito domenica, probabile occupazione della Sala Sinopoli, manifestazione in Campidoglio. Politici in soccorso: zero.
C’è una petizione da firmare
di Giampiero Neri
Di quella fontana stile novecento
che doveva durare
oltre le nostre vite
si è persa la traccia
morta con la sua epoca breve.
Era ridente nella sua rotondità
spensierata all´apparenza,
finita chissà dove.
di
Francesco Forlani


di Gianluca Morozzi
[A Bologna, domenica 24 Febbraio alle 19,30, XoMeGaP presenta il libro di racconti Mutazioni (LAB – Giulio Perrone Editore), al salotto post litteram dell’Arterìa (Vicolo Broglio 1/E). XoMeGaP è un un progetto letterario nato nel 2005: un “gruppo di affinità”, tra amici scrittori, in rete come sito e come blog. Da qui è nato Mutazioni, dodici racconti di dodici autori: Ivano Bariani, Sara Bosi, Simone Covili, Eliselle, Michele Governatori, Ettore Malacarne, Gianluca Morozzi, Massimiliano Prandini, Cecilia Randazzo, Giuseppe Sofo, Gabriele Sorrentino, Fulvio Tosi. Di seguito, il racconto di Morozzi.]
1.
Questo è quello che è successo all’inizio.
Un demone si era annidato nel cervello di suo padre.
E gli aveva ordinato di uccidere tutti.
di Franz Krauspenhaar
Un paio di giorni di malessere generale causato dall’insonnia. Riemergo in qualche modo, faccio una lunga passeggiata nella sera di fine inverno, attorniato da poca umidità. Passanti che trottano assieme ai loro cani, il dopolavoro del bravo borghese.
Vicino a un bar tabaccheria – l’unico aperto nel mio quartiere dopo le otto di sera, un posto che negli anni si è lentamente ripulito ma che è rimasto comunque abbastanza malfamato – vedo una Mercedes 320 blu scuro parcheggiata con le ruote verso l’esterno. A bordo un uomo robusto, dalla faccia quadrata, che parla concitatamente al microfono del suo cellulare. La sua bocca esprime dentatura e sforzo, tensione. Ho appena visto un uomo baconiano e l’ho riconosciuto. Il cellulare è quest’arnese di invadente comunicazione che, previa le cuffie, rende un sacco di passanti degli zombi che muovono le bocche come pesci in un acquario, o barboni ripuliti e imborghesiti che parlano da soli per le strade della città, ma più assorti, barboni di successo.
[dedico questo video ai miei due amici Tashtego e Valter Binaghi (ma anche a tutti gli altri indiani e lettori indiani) G.B.]
di Nicola Ponzio
Esiti, – dove si ostinano parole
e resistenza.
Rotoli in preda al silicio,
tra segni elettronici persi
nel vuoto del web.
Ora insisti
sui versi, – ti avviti
sugli input, desisti…
Se nel monitor vibrano impulsi vitali
o già morti, – dati al ritmo di bit

Scheletri della Cappella San Severo
I critici, soprattutto in Francia, sono fin troppo vanitosi per non parlare mai di null’altro che non sia il loro magnifico se stesso. Mai del tema. Tanto per cominciare, sono troppo coglioni. Non sanno nemmeno di che cosa si tratti. E’ uno spettacolo di grande vigliaccheria vederli, questi stomachevoli, sbattersi, offrirsi una stretta di mano subdola alla vostra buona salute, approfittare della vostra povera opera, per fare gli splendidi, pavoneggiarsi per l’uditorio, camuffati, sedicenti “critici”.
Louis Ferdinad Céline, Bagatelles pour un massacre
Perché introdurre con queste parole di Monsieur Destouches la lettura che sto per proporvi? Perché aver tradotto un brano del genere tratto dal più odioso libro mai scritto, dalla voce tra le più autentiche del Novecento, per parlare di Acqua Storta, di L.R.Carrino? Forse per alludere al marcio del sistema delle lettere italiche, tutto cronometrato sui rinvii d’ascensore dei critici / autori, autori /critici?
Di cosa parliamo, quando parliamo di cibo?
Sappiamo, lo abbiamo sempre saputo, che il mondo è fatto non di atomi, ma di parole, e il cibo è uno dei principali mediatori nella nostra relazione con il mondo e nella rappresentazione di noi stessi in relazione agli altri. Il cibo è logos, è simbolo, è espressione, è conquista o rifiuto, è luogo di cittadinanza o misura di assenza (“Il mio cuore è in Oriente e io sono nell’Occidente più remoto”, cantava il poeta Judah Halevi. “Come posso gustare il cibo che mangio?”) La portata e il senso delle nostre vite si misurano sulla base delle storie cui siamo disposti a cedere ascolto e di quelle che ricordiamo per poterle raccontare. Non si può allora parlare del cibo senza parlare delle storie che lo compongono come e più degli ingredienti, e delle vite che di quelle storie sono il sapore turbinoso o agro. Il quarto numero di Buràn (www.buran.it) prosegue la collaborazione con il British Council di Londra per i giovani scrittori africani (Uganda, Zimbabwe e Malawi), con il mondo dei magazine letterari delle università anglofone (come Harvard, Chicago, Wellington in Nuova Zelanda e molte altre) e con realtà geograficamente più vicine ma del tutto irraccontate, come la Lituania e l’Estonia. In questo numero di Buràn c’è tutto il mondo in rigoroso disordine alfabetico: 53 voci e sguardi da 26 Paesi diversi e da ciascuno dei continenti.
(la foto di copertina è di carlessolis)
Colonna di ciechi
una strada che si guarda di giorno e di notte,
di cui si beve ogni spostamento d’ombre,
in ogni stagione, con lampi di segnaletiche
e fari, figure sbandate lungo i cancelli, bambini
che cercano il sasso e il petto tenero dell’animale,
quelli chinati nelle poltiglie di foglie, quelli veloci
che chiudono con mani di fata silenziose portiere,
nei colpi continui della luce a illuminare le gole,
le gengive nude, e le teste molli in quella fiamma
che cercano riparo, assorbendo nei pensieri l’asfalto

di Silvio Mignano
18 agosto 2007
Ognuno porta con sé il paesaggio che sa, che ricorda, rimpiange o paventa. A me sembra un tratto della costiera tra Sperlonga e Gaeta, con meno alberi e senza gli ombrelli protettori dei pini marittimi. Graziano propende per la Riviera ligure, Marco oscilla tra il Lago di Garda e il Salento di Santa Maria di Leuca. Tutti siamo comunque vittime del miraggio interiore, prede della metamorfosi che vive in ogni luogo.
Chi conosce il D’Orrico style, recensore optimo e maximo che sulle patinate pagine del “Magazine” del Corriere della Sera stronca (max. 25 parole) o beatifica (max. 2 paginate), sa quanto la medietas a lui paia virtù desueta e repulsiva, estranea comunque all’irrefrenabile bizzosità che contraddistingue le sue scelte. Per cui non si prova nessun particolare trasalimento quando leggiamo che, per lui, questo L’ingegnere in blu, miscellanea di Arbasino dedicata a Gadda, è un libro che lo ha divertito ed incantato fino alla commozione. Maggiore è lo stupore e la perplessità che ci coglie invece quando il Critico per antonomasia del Corriere aggiunge: “…viene voglia di chiedere un bis, un libro simile ma scritto questa volta sullo stesso Arbasino. Ma c’è qualcuno capace di raccontarcelo come lui racconta Gadda?”. In realtà, quel libro è già stato scritto. Anzi a pensarci bene, è proprio quello che D’Orrico ha recensito con quei toni enfatici, quasi da epinicio, sopra ricordati.
Nel caldo borro dell’adolescenza tutta sofferenze e delizie nuove, in un nucleo di formazione che epitomava ogni esistenza a venire, nella rovente ferita di me ragazzino aperto in feritoie e sbreghi, corporalmente deprivato di carni e muscolatura e con giunture sloganti e con nervi friabili, in quegli anni che inglobavano infanzia e prosciugavano il futuro, in quella fetenzìa di età in cui il sudore è splendido e il catarro luminescente, opalescente, non nutrivo dubbi sulla poesia e sulla mia consustanzialità ad essa, anzi credevo più cattolico nella transustanziazione della poesia in me. Certamente penso pure adesso che un fanciullo che s’attrezza spiritualmente riassume in sé ogni esperienza possibile, ogni poesia possibile, ogni mito possibile, stato e futuro, in un ragazzino che cresce storto nella vita artistica viene conflata ogni esperienza estetica, un aleph, insomma. Tuttavia adesso non ho più fiducia nella poesia. O meglio, ne ho una fiducia pietrificata, ecco.
Mercoledì 20 febbraio 2008
Fondazione Adriano Olivetti
via Zanardelli 34
00186 Roma
Alle ore 18:00
Nadia Fusini e Alberto Abruzzese
presenteranno
Prime. Poesie scelte 1977-2007(Sossella, 2007)
di Gabriele Frasca
che per l’occasione leggerà alcuni suoi testi inediti
di Antonio Sparzani

d u c h a m p d e i f i o r i (cortesia di effeffe)
Il 20 gennaio 1600 Ippolito Aldobrandini, eletto papa della chiesa di Roma dal conclave del gennaio 1592 col nome, che poco gli convenne, di Clemente VIII, ordinò che l’imputato eretico “impenitente”, “pertinace” e “ostinato”, Giordano Bruno, nativo di Nola, fosse consegnato al braccio secolare. Frase che indicava il delizioso escamotage con il quale la suddetta chiesa si lavava le mani (la formula era “Ecclesia abhorret a sanguine”) dalla necessità di eseguire la sentenza già pronunciata su un condannato, affidandone invece l’esecuzione materiale al “braccio secolare”, cioè alle istituzioni dello stato che prevedevano appunto il reato di eresia.
Il giorno 8 febbraio dello stesso anno Giordano Bruno ascoltò la pubblica lettura della sentenza, alla presenza dei testimoni e della congregazione del S. Uffizio, nella casa del cardinale Madruzzi.
Giovedì 17 febbraio esattamente 408 anni fa, Giordano Bruno venne arso vivo in piazza Campo dei Fiori, con l’ovvia precauzione della “lingua in giova”, bavaglio o blocco, dato che diceva “bruttissime parole”, e invano gli porsero da guardare l’immagine del Crocefisso, dalla quale “volse fieramente lo sguardo.”