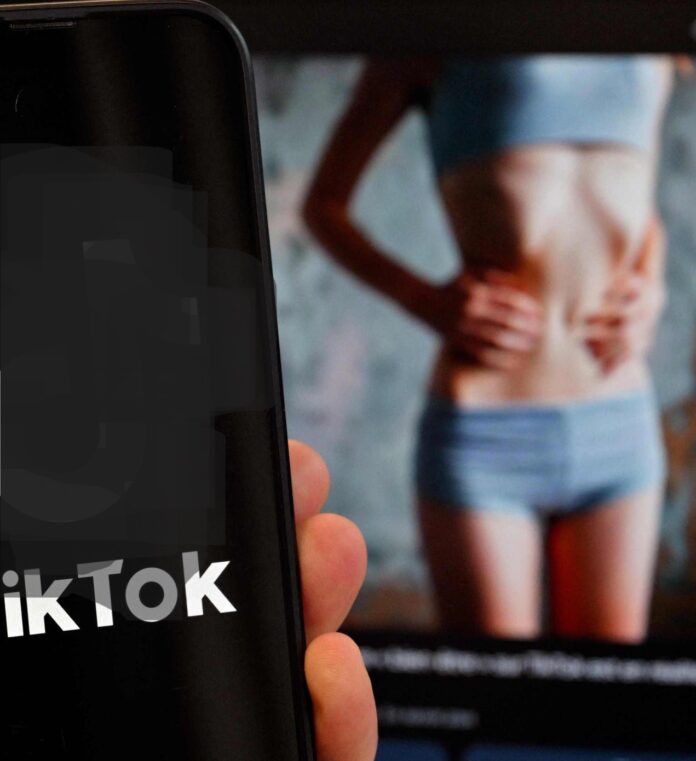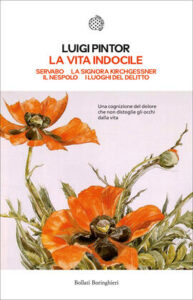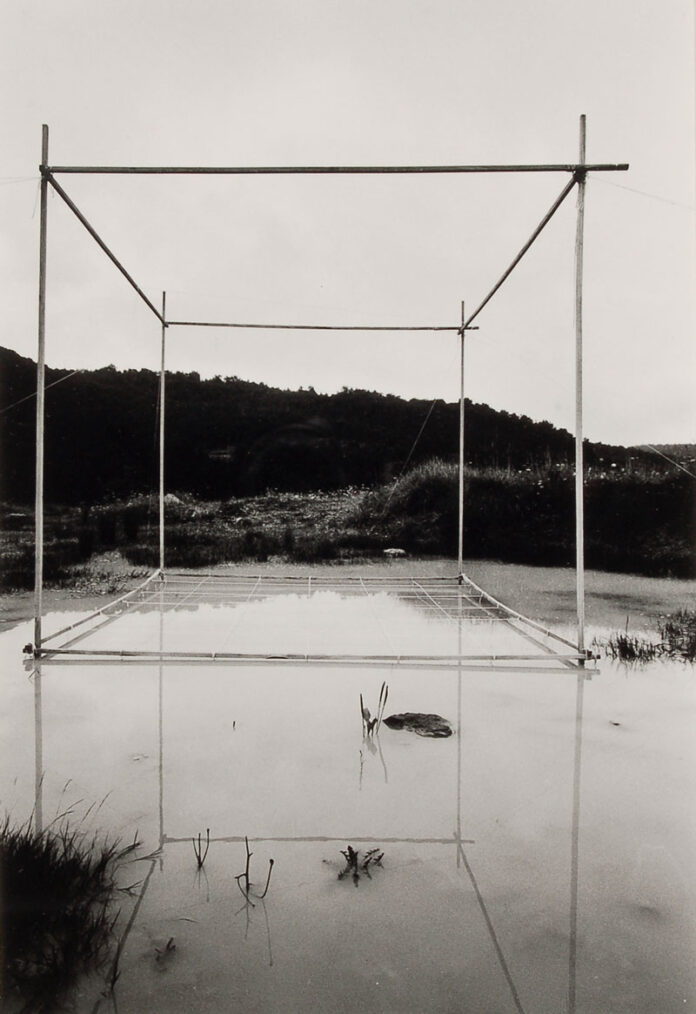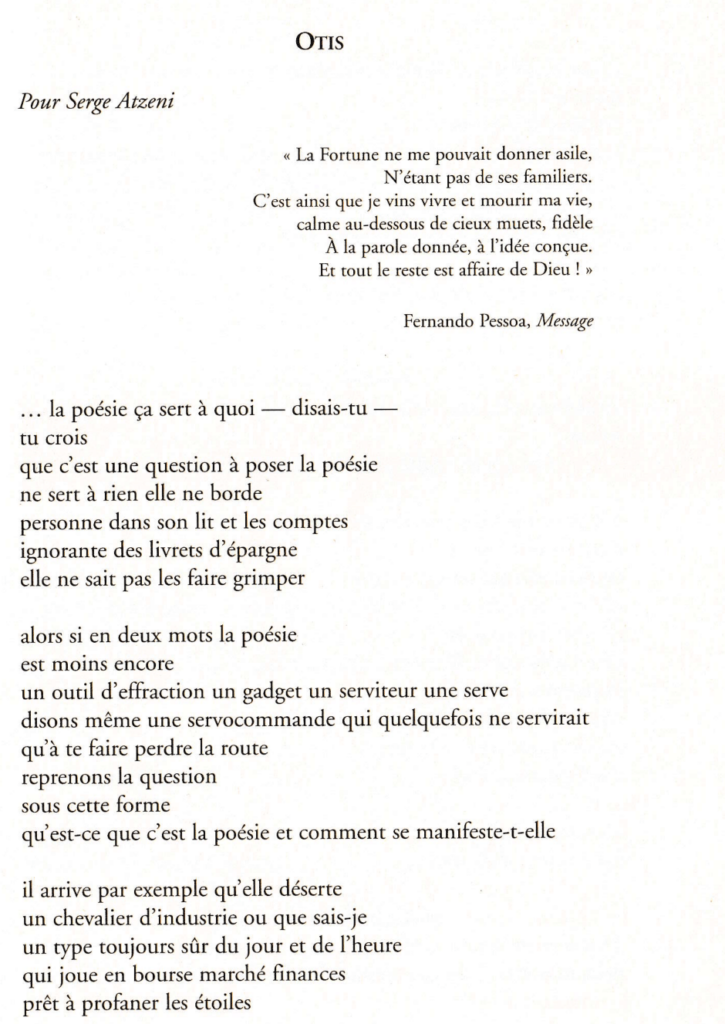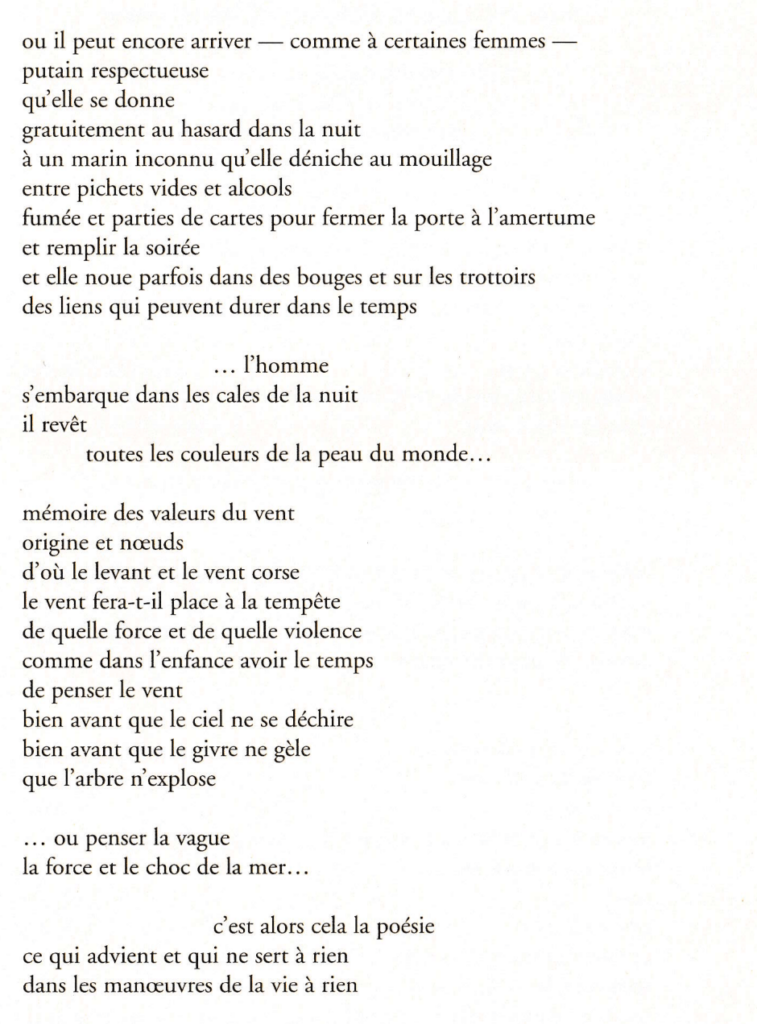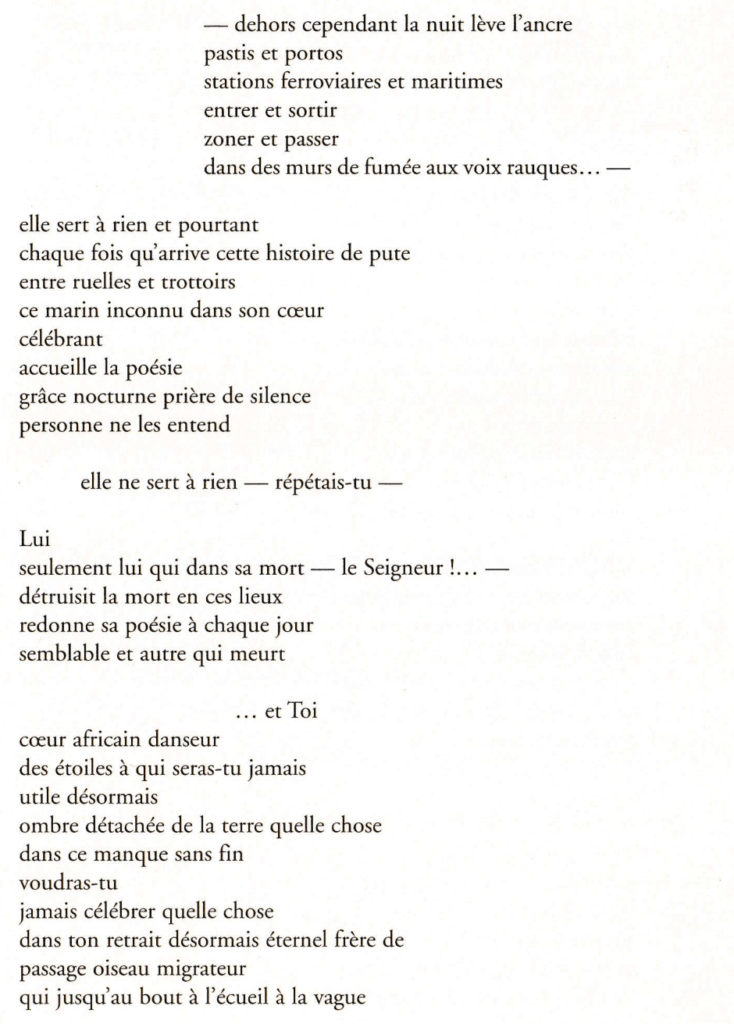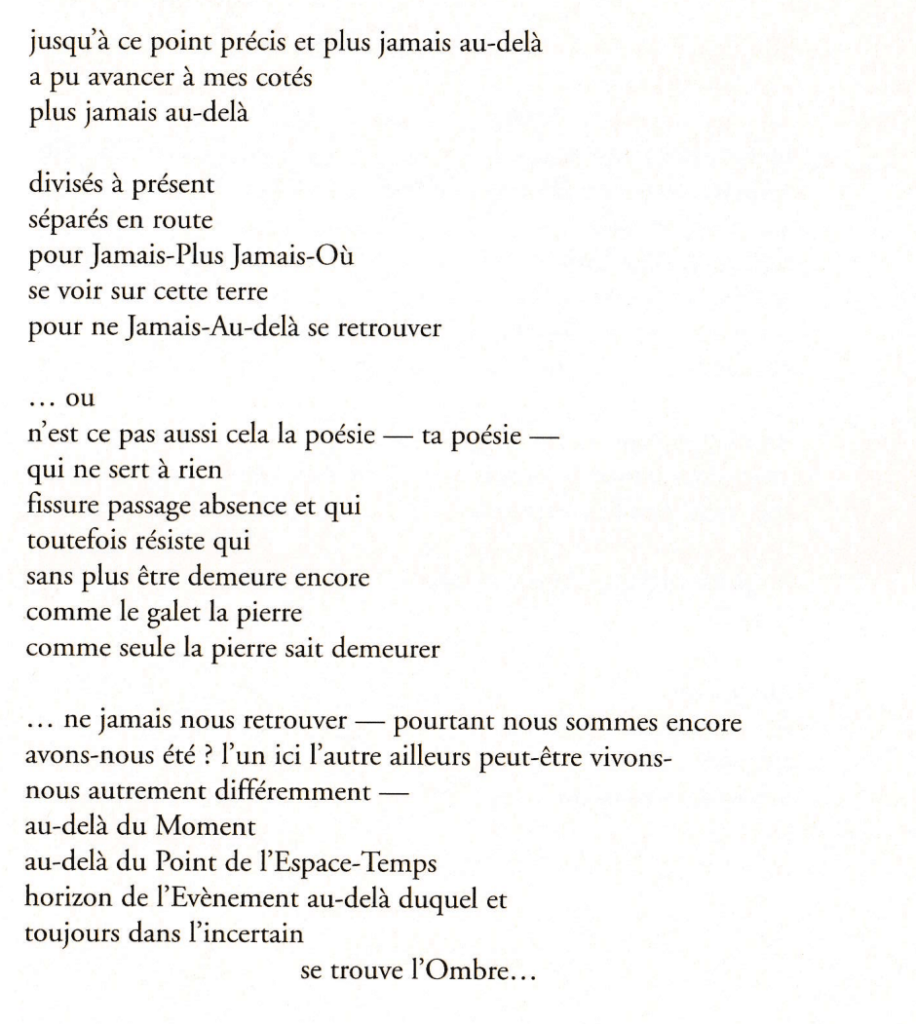di Francesco Segoni
Alle dieci e quarantacinque tutto era finito. La città era occupata, i difensori abbattuti e la guerra conclusa. L’invasore s’era preparato per questa campagna con la stessa cura che per altre di maggior ampiezza.[1] In cima alla facciata bruciacchiata di Palazzo Tursi sventolava già il Nuovo Tricolore. Mentre ancora i militari bonificavano il municipio da trappole e ordigni piazzati dalla resistenza poco prima della caduta, negli uffici si sostituiva la carta intestata del Comune con quella della Nuova Repubblica dell’Italia Sovrana.
Questo, almeno, è quanto si raccontava nei vicoli del centro storico.
Alla stessa ora di quella mattina, un tizio al bancone della Compagnia del Calice sbottò: «Questa città non si riconosce più». Gli rispose il bar in coro: «Belìn, Ringo, smettila». Genova infatti era riconoscibile anche coi blindati per strada; proprio in quel momento ne videro uno manovrare impacciato in piazza delle Erbe, un militare fece capolino dal portello per chiedere indicazioni a un anziano che portava a spasso il cane.
Ringo era facile alle iperboli e questo era il suo difetto. Ma non fu il solo che aveva continuato a bere mentre le sirene strillavano e la sindaca Salis ordinava agli abitanti di correre a prendere un’arma presso la sede della polizia municipale per difendere la città.
«Non hanno retto a Firenze e Bologna», diceva la gente, «vuoi reggere qui?»
La Nuova Informazione scrisse che da Voltri a Nervi, gli unici colpi sparati all’arrivo dell’esercito italiano erano stati di festa, intervistò qualche genovese. «Ormai avevo paura a uscire da sola», diceva un’insegnante di Albaro. «Mi hanno rapinato due volte quest’anno», faceva un negoziante di via XX settembre. «Se ci vogliono i militari per ridare sicurezza alle città italiane, ben vengano», concludevano entrambi. Era propaganda stravagante: ma di certo, durante la caduta di Genova, nella Compagnia del Calice la musica non aveva smesso di suonare.
Le voci correvano per i caruggi: Tizia resiste, Caio collabora, Sempronio è indeciso. Non ti potevi più fidare della persona che ti aveva sempre offerto da bere. Ringo era prudente, si limitava a dire «un biancamaro, grazie» (con Ada, invece, era lui a offrire). La scelta, per lui, la fece uno sgabello: quello all’estremità del bancone, riservatogli fin dal giorno in cui aveva aiutato il povero Manciafugassa a rimettere in piedi il suo bar dopo un incendio, vent’anni prima – guadagnandosi una lombalgia immortale e biancamaro gratis fino alla tomba. Da quello sgabello, Ringo raccoglieva le poche parole che rotolavano fino a lui da un tavolino in fondo al locale, dove una mezza dozzina di facce forestiere aveva preso l’abitudine di riunirsi sul tardi, intorno a baccalà fritto e farinata.
«… se gira la voce che paghiamo…»
«… se gli facciamo credere che anche la sindaca collabora…»
Una sera, Ringo notò un paio di occhi verdi che lo invitavano al tavolo: uniforme militare, capelli rossi legati in uno chignon basso, qualche lentiggine. Quando la donna gli parlò, Ringo sentì abbassarsi il volume delle voci nel locale.
«Cosa ti posso offrire?»
«Un biancamaro, grazie» rispose lui.
«Hai l’aria del cliente abituale. Non ti spiace se passiamo subito al tu? Da fuori non gli dai due lire, a questo bar, ma la farinata è eccezionale.» Si presentò: capitano Renata Vesperi, primo reggimento dei Granatieri di Sardegna. «Sto scoprendo Genova. Da piccola andavo in vacanza a Varazze ma non ci fermavamo mai in città.»
Ringo aveva già scolato il biancamaro. Lei gliene ordinò un altro.
«Mi hanno detto che sai come gira il fumo da queste parti.»
Ringo alzò le spalle, lei proseguì.
«Volevo combattere i russi in Ucraina, non i miei connazionali. Ma il nostro lavoro è fatto, Genova è tornata vivibile, è ora di riappacificarci. Voglio essere franca: la resistenza non ha scampo, sta prolungando il dolore per tutti. Puoi fare un favore alla città. Non tocchiamo le persone, il tempo della violenza è finito. Sappiamo muoverci in maniera meno frontale».
Ci vollero un paio di altri incontri e qualche biancamaro in più, Ringo aveva bisogno di pensarci e di essere rassicurato, ma rimandare la scelta era solo un modo per abituarsi all’idea, la sua carriera da collaborazionista era decisa. Iniziò un venerdì sera con la rivelazione dell’indirizzo di un nascondiglio di armi. Il capitano Vesperi ascoltò, annuì, si alzò.
«Hai fatto bene. Questo è per il conto.»
Si allontanò con un sorriso appena sfiorato. Lui non ebbe bisogno di contare i soldi per capire che sarebbero bastati per il conto suo e quello di tutti i clienti della giornata. Rimase a canticchiare a bocca chiusa With A Little Help From My Friends, come faceva quando aveva dei pensieri: è per questo che lo chiamavano Ringo.
Con la prima ricompensa comprò al mercato nero un cellulare criptato per sé e uno per Ada, regalo utile: un gioiello gli pareva troppo frontale, come avrebbe detto il capitano. Ada accettò con onesta gratitudine. Il primo messaggio che ricevette, il giorno dopo, era di Ringo.
«Ti va un tè da Bellucci?»
Accettò subito. Si videro un’ora più tardi, entrando nella pasticceria lei gli indicò un tavolino di fronte a una grande vetrata che dava su Piazza Fossatello.
«C’era bisogno di criptare l’invito per un tè?»
«Volevo provare il telefono», le rispose spianando la tovaglia bianca con la mano.
Il capitano Vesperi gli dava appuntamento alla Compagnia del Calice senza orari fissi. C’era in lei la semplicità della persona modesta che si è ritrovata per caso a fare cose importanti. Friulana, vegetariana, Ariete e divorziata senza figli. Appassionata di sci e letteratura francese.
«Sto rileggendo tutto Zolaper la terza volta, ma non ho tempo», gli disse senza un’ombra di ostentazione; facevano colazione con cappuccino e farinata.
Il Manciafugassa spolverava il bancone, si era avvicinato al loro tavolo.
«Oh belìn, Ringo, guarda che ‘sto anno il Doria o torna in Serie A, vedrai.»
Rimase lì a fissarli, Ringo capì che non sarebbe andato via senza una risposta.
«Per carità, fammi toccà i ballin.»
Ringo si chiese se i clienti del bar origliassero le sue chiacchiere col capitano. La donna aveva tatto, lui si sentiva libero di accettare o rifiutare, quindi finiva per accettare sempre: un nome, un orario, un numero di targa. Ogni volta lei lasciava sul tavolo una busta marrone.
Le ricompense si fecero più consistenti. Ringo portò Ada a vedere la Sampdoria in tribuna d’onore. Dopo la partita cenarono al San Giorgio con pesce crudo e capesante, provarono il piccione arrosto e bevvero champagne.
«Ti piace?»
«Il pesce sì», rispose Ada, «ma non credo che rimangerò il piccione in vita mia.»
Risero debolmente.
«Però è bello provare un posto così, quando puoi permettertelo», disse lui, pentendosi subito dell’allusione ai soldi.
«Riempimi il bicchiere, devo dimenticare la partita. La prossima volta andiamo al cinema.»
L’aveva detto con un sorriso, ma Ringo arrossì. Le luci erano basse, la sala era piena ma non rumorosa. I clienti avevano l’aria degli habitué, c’era qualche faccia da ufficiale della Nuova Repubblica Sovrana.
«Sei sicuro di voler stare con questa gente, Ringo?»
Nessuno l’aveva più chiamato per nome dopo sua madre. Neanche Ada.
«Fa’ piano. Non stiamo con loro», le disse, fissando il piatto sporco di sugo. «Sono tutti egoisti in questo momento.»
Il cameriere tornò con la lista dei dessert, Ada disse che era stanca. Abitava a Pegli, Ringo l’accompagnò in taxi. Gli mancò il coraggio per chiederle di salire da lei, ma ebbe l’impressione di avere superato una soglia psicologica anche più importante. Aspettò che Ada sparisse dietro il portone e rientrò a piedi, ci mise quasi tre ore. Passando vicino alla stazione di Principe trovò un camion-friggitoria aperto e comprò un cartone di verdure in pastella perché il ristorante l’aveva lasciato affamato.
I rettori delle università italiane si giravano fra le mani la lista dei termini proscritti nella ricerca, i giornalisti imparavano un’altra maniera di raccontare le cose, i magistrati si aggiornavano sulla riforma del diritto penale: la Nuova Repubblica Sovrana era una realtà. Un pomeriggio di ottobre Ringo guardava un documentario sui geyser, il capitano Vesperi chiamò.
«Puoi venire adesso?»
Al solito tavolo, accanto al capitano sedeva un giovane abbronzato, elegante, rasatura fresca: lei glielo presentò solo come Ermes, li lasciò dopo un caffè. L’uomo sbirciò il pataccone che portava al polso, piantò gli occhi in quelli di Ringo: sguardo deciso ma affabile, forse provato davanti allo specchio.
«Facciamo due passi?»
Finirono al Porto Antico a godersi il tepore del primo autunno. Fumavano una sigaretta dietro l’altra lanciando i mozziconi in mare. Fu Ermes a parlare.
«Renata dice che ci sai fare. Io posso aiutarti a fare anche meglio.»
Gli parlò di un mondo fatto di lusso vero e passaporti falsi, champagne a casse, cocaina a domicilio come ordinare la pizza. Ermes aveva creato una rete di collaborazione fra Torino e Cuneo, ora toccava alla Liguria.
«Hai capito di cosa sto parlando?»
«Credo di sì.»
«Moltiplicatori. Far fare ad altri quello che stai facendo tu. Smettere di fare il postino che consegna le lettere sotto la pioggia e iniziare a dirigere l’ufficio postale.»
«Ci devo pensare» rispose Ringo.
«Pensaci in fretta, questi si muovono rapidi.»
Ringo andò a zonzo tutta la notte per i caruggi canticchiando With A Little Help From My Friends. Per esserne capace, ne era capace: contatti ne aveva, da Levanto a Savona. L’idea di fare di meno e gestire di più non era malvagia. Quella sera, lavandosi i denti, s’immaginò in un bagno tutto marmo e cristallo, forse quello di una suite a Manhattan: un weekend con Ada a New York, una partita della Nba seduti accanto a Spike Lee (questa, allora, era la portata della sua immaginazione). L’indomani chiamò Ermes.
Le sue riunioni non si tennero più alla Compagnia del Calice: una volta alla settimana, Ringo passava sotto la bandiera della Nuova Repubblica Sovrana che sventolava all’ingresso di Palazzo Tursi per raggiungere l’ufficio del colonnello Vesperi nella sede del Comune commissariato: erano stati promossi entrambi.
I giorni a dicembre si fecero freddi e lividi come un cadavere. Una sera, uscendo dal Carlo Felice, Ringo aiutò Ada a infilare il cappotto di cashmere che le aveva regalato per i quarant’anni. Alzò il braccio verso un taxi, lei lo fermò: «Per una volta che non piove, camminiamo un po’.»
«Martedì sono a Chiavari», le disse mentre scendevano verso il Porto Antico.
Le montagne di cocaina e le casse di champagne non erano comparse, Ringo praticava l’arte della prudenza, si concedeva i lussi della gente normale: scarpe di marca, un gioello per Ada, una sera a teatro. Aveva scelto L’elisir d’amore perché Il Secolo XIX l’aveva definito «imperdibile», ma si era annoiato. Ada aveva lodato i costumi e le voci, ma Ringo l’aveva vista sbadigliare.
«Quanto bisogna andare avanti?» gli chiese lei.
«Non volevi camminare? Possiamo prendere un taxi in Caricamento.»
«Quanto bisogna andare avanti con questa gente.»
«Ci trattano bene.»
«Un giorno arriverà il conto.»
«Li abbiamo giudicati in fretta, Ada.»
«Ah! E invece?»
«La Vesperi è onesta.»
«Non è una questione di morale, Ringo, questa gente non la conosci.»
«Genova è migliorata. Io vedo questo.»
Lei accelerò il passo, non disse altro.
Verso Natale Ringo fu invitato a cena da Renata Vesperi. Il colonnello viveva nell’attico di un palazzo elegante, ma era evidente che non aveva il tempo di pensare a mobili e piante. Gli offrì del vino, Ringo chiese una birra.
«La prossima volta» gli rispose. «È già tanto se ho una bottiglia di vermentino in frigo.»
«Finché è vino ligure ed è fresco…» sorrise lui.
«Sono riuscita a finire Teresa Raquin. Forse è il mio preferito, di Zola.»
«Non l’ho letto.»
«Te lo presterò», disse. E poi, come a proseguire lo stesso pensiero: «Non sei stanco di vivere delle paghette dall’esercito come un adolescente, Ringo? Scusa, io non giro intorno alle parole.»
Lui guardò la distesa di stuzzichini sul tavolino. Notò che non c’era un televisore nella sala.
«Ora che ci conosciamo meglio, vorrei offrirti qualcosa di serio.»
«Belìn… scusami, colonnello, io mi accontento, non cerco roba seria.»
«Non ti chiederei una cosa per cui non sei tagliato. Non sarebbe nel mio interesse.»
Gli parlò di un laboratorio chimico-farmaceutico sopra Sestri Levante. Ringo lo conosceva: il prestanome per la struttura l’aveva trovato lui.
«E chi lo sapeva che il nome era prestato alla Nuova Repubblica», rise, forzando il tono leggero. «Cosa ci fate con una roba del genere?»
«Non è un banale laboratorio, Ringo, è un’avanguardia: ricerca, sperimentazione. Ha un valore strategico.»
«La chimica non è il mio genere.»
«Lo so qual è il tuo genere. Mi serve qualcuno per gestire la sicurezza.»
«Tipo ditta di vigilanza?»
«Non voglio Rambo, voglio una persona discreta. Uno sveglio e con le orecchie tese, non coi muscoli e le armi. È un’opportunità.»
Aveva avuto paura che il colonnello gli chiedesse di dirigere il laboratorio, o peggio, di fare da cavia per le ricerche. La vigilanza era alla sua portata. Soprattutto con l’esercito alle spalle. Accettò con sollievo.
Dopo la cena, Ringo andò alla Compagnia del Calice a pensare. Sempre più legato a quella gente, avrebbe detto Ada. Lei faticava ad accettare la sporcizia sotto il tappeto nella loro vita comoda, ma per lui non era una questione di vile denaro. Non solo. Renata Vesperi era di parola e a Genova si stava davvero meglio. L’esercito era venuto per soffocare caos e criminalità e l’aveva fatto. Per come la vedeva lui, non era collaborazionismo, era partecipare alla costruzione di una nuova Italia. Andò a sedersi al suo sgabello.
«Oh», gli fece il Manciafugassa, «ci vai a Marassi domenica?»
«Dammi un biancamaro, dai. Anzi, dammi un whisky scozzese di quello buono.»
L’altro lo guardò strano.
«Buono? Ti darò l’unico che ho, se ne rimane.»
«Di’, Mancia, tu rimpiangi la Salis?»
«Chi?»
«Il sindaco.»
Il barista fece una smorfia.
«E chi se ne ricorda.»
Lo servì, uscì a fumare. Ringo annusò il suo drink, sapeva di dolce e di legno bruciato. Si mise a giocare con il blocco-sblocco dello schermo del telefono, vide due chiamate perse di Ada, un messaggio: «Non dovevi passare dopo cena?»
«Cazzo.»
«Opportunità», aveva detto il colonnello. Per i media era «un’emergenza socio-sanitaria». Fin dal primo giorno, Ringo si rese conto di esserci finito in mezzo. Il Fentanyl era solo uno degli oppioidi sfornati dal laboratorio, dove «ricerca e sperimentazione» erano accompagnate da una generosa produzione. Il governo della Nuova Repubblica Sovrana parlava della crisi degli oppioidi come si parlava dell’aids quando Ringo era ragazzino: una storia di degenerati che si risolve da sé, basta darle tempo. Sapevano, a Palazzo Chigi, del laboratorio? Eravamo di nuovo all’eroina di Stato? Era un’iniziativa clandestina del colonnello o di qualche dirigente locale? Ringo si perdeva nei pensieri. Fino a poco tempo prima, il suo tradimento si era consumato all’interno dello scontro fra due belligeranti: per lui era uguale, esercito e resistenza a modo loro avevano entrambi a cuore Genova. Ora s’immaginava come un globulo rosso in un sistema circolatorio con diramazioni in tutta Italia. Pensò di tirarsi indietro, si diede del tempo per decidere.
Arrivarono ancora più soldi. Comprò casa con un prestito agevolato grazie all’interessamento del colonnello. Non una casa lussuosa, ma in centro e abbastanza grande da accogliere una cucina con isola centrale, un salotto con un caminetto inutile e un secondo bagno: il minimo, per proporre ad Ada di andare a vivere insieme.
«Un passo alla volta», disse lei. «Cominciamo con qualche weekend, vediamo».
La convinse a lasciare da lui qualche ricambio e il necessario per l’igiene.
Per la prima cena con Ada nella casa nuova si era fatto recapitare sushi dal miglior giapponese in città, ce n’era per cinque persone. In mezzo a loro, qualche candela e una bottiglia di Moët & Chandon nel secchiello del ghiaccio. Un’altra bottiglia era in frigo. Il cibo era ottimo, Ringo aveva comprato uno speaker Bose per ascoltare un po’ di musica, ma Ada non diceva niente, mangiava senza gusto.
«Cosa c’è?», le chiese. «Non c’è nessun obbligo, ho capito che dobbiamo fare le cose con calma.»
«Non è quello.»
Lui faceva sparire bocconi di sushi dopo averli inzuppati nel misto grigiastro di soya e wasabi.
«Non sono scema, Ringo. Quanto ti possono pagare al laboratorio? Non abbastanza per quello che spendi. Mi vuoi dire?»
Lui deglutì, bevve, sospirò.
«Cosa cambia?»
«Niente, appunto: prima o poi me lo dirai, quindi fallo subito.»
Ringo sbuffò di nuovo.
«Il sistema è semplice, non ci vuole un genio, anche perché altrimenti io non ce la farei», disse, senza riuscire a farla ridere. «In teoria, gli scarti di produzione sono distrutti. In realtà li rivendiamo in nero attraverso dei prestanome.»
«Siete pazzi.»
«Sono le nostre stock option.»
«E la Vesperi?»
«Non sa dei traffici, ovvio. Sono io la sua security.»
«Prima ti affidi a lei, poi la fotti.»
«Prima ero in serie B», disse lui stappando la seconda bottiglia. «Ora gioco in Champions».
Gli incontri a Palazzo Tursi proseguivano cordiali, ma in presenza del colonnello Ringo provava ora lo stesso disagio che aveva avvertito alla Compagnia del Calice, all’inizio della sua collaborazione. Nell’aria si sentiva ormai il profumo della primavera, ma infuriavano le mareggiate, il rumore arrivava fino a Bolzaneto. Ada si svegliò a casa di Ringo un lunedì mattina dopo una notte insonne, lui le portò una spremuta a letto, le fece compagnia mentre bevve.
«Oggi ho una riunione con la Vesperi al laboratorio, c’è anche un generale da Roma.»
«Lo so, me l’hai detto l’altro giorno. Vai piano, fammi sapere quando sei arrivato. Prevedono una bufera su tutto il Levante.»
«Sta’ tranquilla.»
«Sul serio, chiama quando sei arrivato. Dammi un bacio.»
Scendendo in garage, Ringo ripensò al giorno in cui le aveva regalato il telefonino criptato. Lei gli aveva detto ridendo che non sapeva cosa farsene, lui aveva risposto che avrebbero potuto inventarsi una doppia vita per renderlo utile.
Su Genova cadeva una pioggia ventosa, il sole era sorto ma sembrava notte fonda. Le strade erano intasate, i pedoni stringevano l’ombrello con due mani. Ringo accese la radio, regolò la temperatura, si dispose a ignorare la rabbia del traffico. Fece i primi chilometri senza quasi vedere la strada, ma passato il promontorio di Portofino il cielo si schiarì, i tergicristalli si ritrovarono a stridere sul parabrezza asciutto.
Uscì dall’autostrada a Sestri Levante, puntò verso l’interno. Poco più tardi vide il grigio del muro dell’impianto affacciarsi fra gli alberi. Entrò nel parcheggio degli ufficiali, privilegio dovuto alla riunione col colonnello e il generale, era proprio sotto gli uffici e la sala riunioni. Spento il motore, stava per scendere dall’auto quando si ricordò: prese il telefonino, chiamò.
«Come va? Sì, sono arrivato. Dopo Portofino il tempo è migliorato. Sì. Sì, sono qui, ti dico. Devo andare, dai. Mangiamo al San Giorgio stasera? Bacio.»
Si guardò nello specchietto, imprecando fra sé per essersi dimenticato di radersi. Nessuno può sapere se Ringo avesse fatto in tempo a sentire il clic che precedette l’esplosione, che lo colse mezzo dentro e mezzo fuori dell’auto, né se avesse avvertito il peso diverso del veicolo, dovuto alla carica che portava inconsapevolmente nel vano motore: fece saltare per aria l’intera ala della palazzina dove gli ufficiali stavano bevendo un caffè in attesa della riunione. Oltre a Ringo, rimasero uccisi il colonnello Renata Vesperi e il generale Scagni, venuto da Roma.
Quella sera Ada andò alla Compagnia del Calice, prese lo sgabello che era di Ringo.
«Avevi ragione che veniva giù tutto», le disse il Manciafugassa.
«Con tutte le volte che Ringo mi ha descritto quel posto», disse lei.
«Hai fatto sparire il tuo telefono?»
«Mille pezzi. E il tuo?» «Idem. Il biancamaro lo offre la casa.»
[1] È l’incipit di La luna è tramontata, di John Steinbeck.








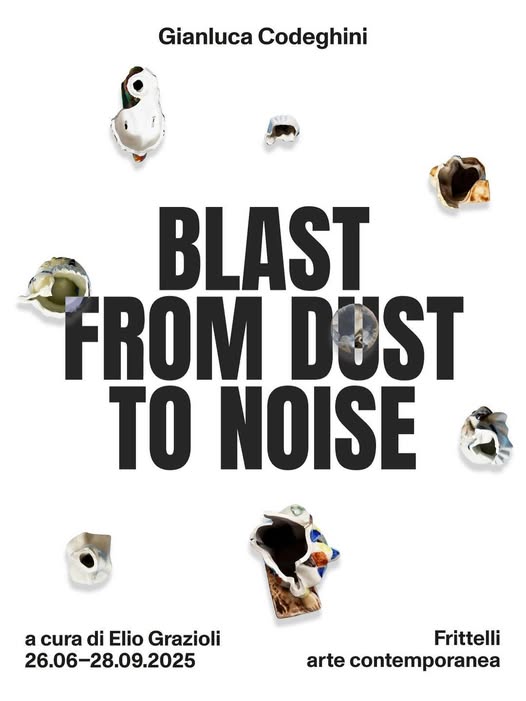



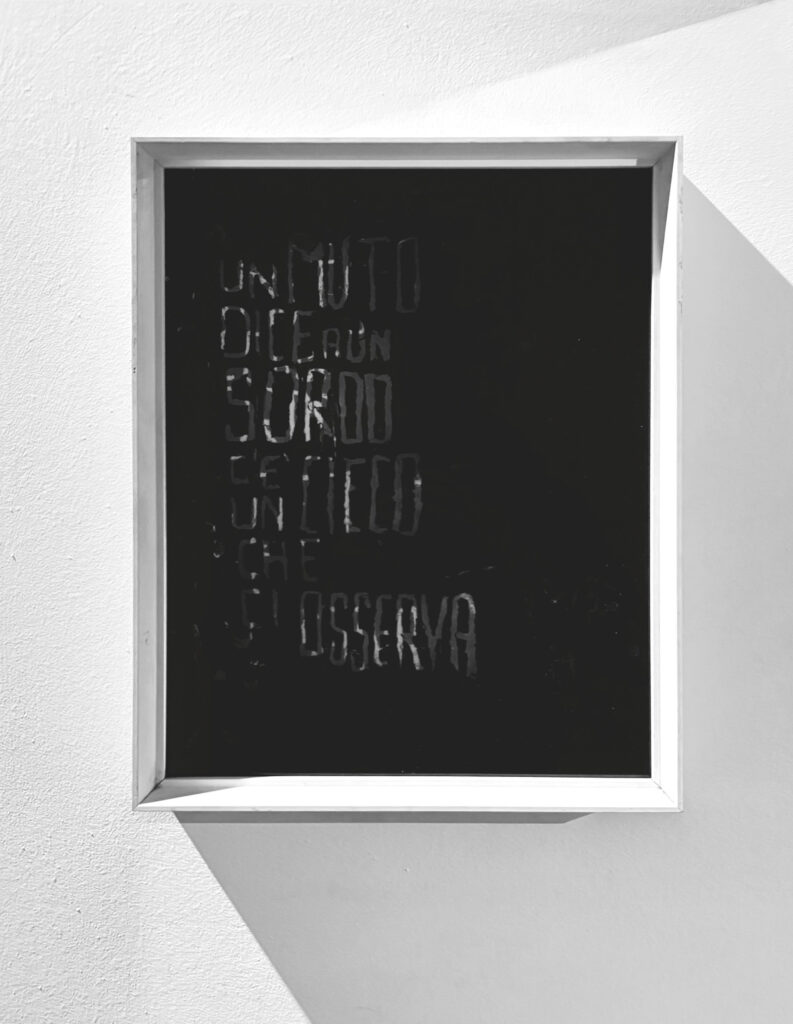



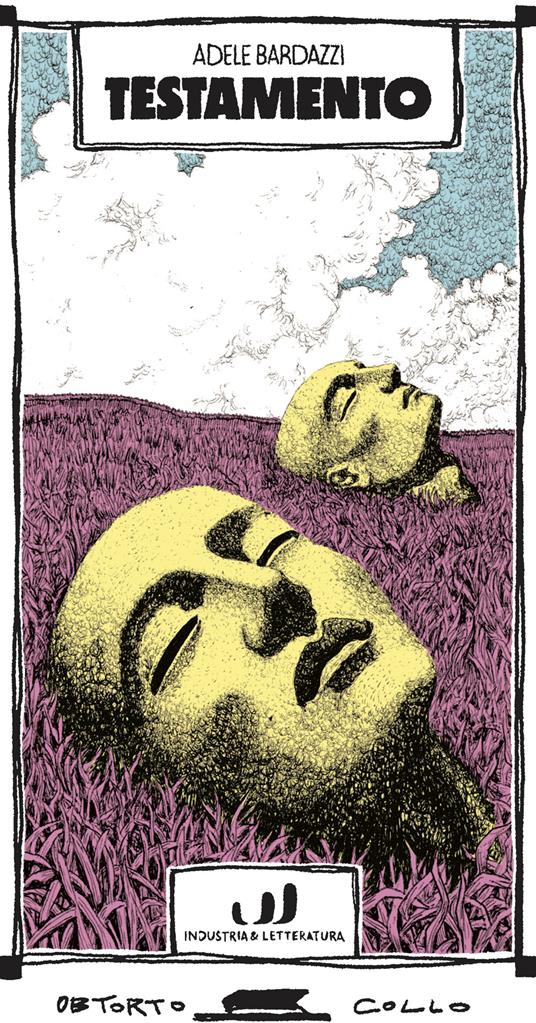


 Gianni Biondillo intervista Paolo Nori
Gianni Biondillo intervista Paolo Nori