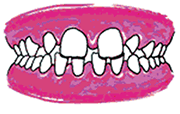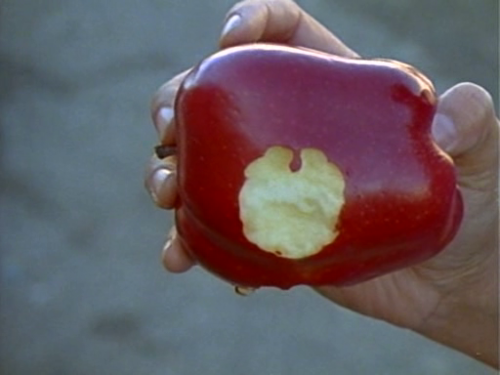di
di
Francesco Forlani
Qui di seguito i primi dieci capitoli del nuovo romanzo a cui sto lavorando. Tutto è cominciato qui su NI e tutto finirà, come condivisione libera, con questa prima parte. Spero di annunciare in giugno la fine della stesura e magari entro l’anno la sua pubblicazione. Dedico a Giovanni Lamanna questa mia azione per il lavoro che stiamo facendo insieme. Buona lettura. effeffe
*
Le tournant (romanzo, in preparazione) Corsica. Un’edicola votiva, memoriale di un automobilista morto in un incidente. Ma nella realtà non c’era stato nessun incidente e tanto meno il morto, inventato di sana pianta dal sindaco per indurre chiunque passasse di lì alla prudenza. Un’invenzione. Una fantasticheria che però aveva salvato un mucchio di persone. Così alla morte del geniale sindaco la giunta vuole commemorare l’uno, lo storico primo cittadino, e il secondo, il morto che non c’è, premiando quest’ultimo con una nuova vita, anzi vita tout court visto che non era nato nemmeno una volta. E lo fa ingaggiando uno scrittore per scrivere una storia; vitto e alloggio pagato in Corsica, per un anno. Il protagonista si chiama Franck, d’origine italiana ma in Francia da una mezza vita, fisarmonicista e scrittore; comincia a raccontare la saga familiare del morto, inventandosela dalla dominazione genovese, ai moti rivoluzionari dell’Ottocento e all’occupazione fascista degli anni Quaranta dopo la resa della Francia. Lo scrittore se la gode alla grande, come Ulisse da Calypso. Beve e mangia da dio, s’innamora, ma la vera notizia è che i suoi testi man mano pubblicati sulla gazzetta regionale riscuotono un successo che nessuno dei suoi libri aveva mai ottenuto. Tout baigne, direbbero in Francia. Solo che, a un certo punto, riceve un chiaro invito a fermarsi, quando scopre che sotto l’altarino c’erano davvero delle ossa…
Ouverture
Ci sono due modi per arrivare in Place des Vosges. Uno è percorrendo da Bastille il boulevard Beaumarchais prima di imboccare la rue du Pas-de-la-Mule; ben altra cosa però è raggiungere la meta sfilando lungo la rue des Rosiers, trecento metri di strada, rue des oubliés, des émigrés, des retrouvailles. In un angolo di giardino che precede la piazza, Franck osserva le panchine di legno disposte ad arco e le persone che se ne stanno sedute durante la pausa pranzo. Franck ne distingue i profili e ne indovina le conversazioni nonostante si trovi a una certa distanza e alle spalle. Ad attirare la sua attenzione è la panca di sinistra, dove due donne sulla quarantina hanno disposto nel mezzo alcuni dolci, Blancmange e Baklava, acquistati in uno degli innumerevoli ristorantini, falafel che popolano la strada.
Certamente è colpito dall’eleganza delle due signore, ma è la loro disinvoltura ad attirarlo, per i gesti con cui accompagnano le parole, per la semplicità dell’atto di mangiare una cosa su una panca in un giardino, semplicità rivestita di abiti di marca e calzante scarpe di lusso. Le osserva per un tempo infinito prima di avere come un presentimento di non essere solo. Con la coda dell’occhio ha infatti percepito, al termine di una diagonale che attraversa lo spiazzo, una presenza, concentrata come lui sulle donne, ma per altri motivi, in una prospettiva totalmente diversa dalla sua. Non sa dire se l’altro se ne sia accorto, per quanto, per un breve istante, abbia avuto l’impressione che i loro sguardi si siano incrociati tipo a metà strada, in campo neutro; l’assoluta perseveranza del suo alter ego aveva però dissolto ogni dubbio a riguardo e ne aveva dedotto che della sua presenza non se n’era affatto reso conto.
Una cosa però ora sa di certo; l’attenzione che aveva fino ad allora totalmente dedicata alle due amiche – la confidenzialità che la vicinanza dei corpi trasmetteva faceva pensare a un’amicizia di lunga data- era stata distolta e dedicata ad altro come se la triangolazione in atto tra lui, l’altro e le due donne, al pari di una catena di Sant’Antonio non si potesse rompere e trasformarsi in un accerchiamento. Così Franck osserva i pensieri e i movimenti dell’altro con meticolosa concentrazione, quasi convinto del fatto che qualcun altro stia osservando lui, e quello, a sua volta, sotto gli occhi di un altro ancora come del resto stava già accadendo alle due donne che non lesinavano affatto, tra una battuta e l’altra, una risata, occhiate ai passanti, specie se prestanti o da insicure donne accompagnati.
Ci sono due modi di vedere le cose, le persone. Si possono contemplare, ammirare, riconoscendone un valore superiore, quasi una possibilità di riscatto interiore in quella esperienza di bellezza o di sublime manifestazione di una presenza tanto inattesa quanto catartica, nei fatti; perché uno si sente migliore quando la bellezza diventa un viatico imprescindibile come le parole di un amico prima d’intraprendere un viaggio; lo sguardo allora si lascia fagocitare e allo stesso tempo nutrire e l’estasi indurre a un’immobilità per certi versi feroce dei muscoli se non si avvertisse dentro un movimento frenetico – il battito accelerato del cuore, il freddo alle ginocchia, le vertigini. Diverso è lo sguardo del predatore perché anticipa un movimento, una sequenza ripetuta mentalmente, un piano d’azione che non lascia adito al fallimento, non ammette sconfitta. In realtà esiste un altro modo di guardare ma si tratta piuttosto di un non vedere, come in effetti accade alle due donne sedute sulla panchina molto prese nella conversazione.
Al punto di non accorgersi affatto del topo che dopo averne registrato le pause, i movimenti, la durata delle distrazioni dai dolci- generalmente dopo averne preso uno dal vassoio e per buona educazione attendere la fine della frase prima di portarlo alla bocca- con una mossa del cavallo e un salto da dietro alla panca ne afferra quello più sul bordo, e per quanto grande, ben più grande del muso sgattaiola via sotto alcune lamiere di un cantiere in corso. Certamente Franck è colpito dalla rapidità del roditore ma è soprattutto l’agilità quasi felina del topo ad attirarlo, la precisione dell’azione tutta svolta nel silenzio e con una tale sapienza che le due signore non si sono rese conto di nulla. Franck abbandona la sua posizione dirigendosi verso di loro. Non ha voglia di dirglielo, avvisarle, non vuole interrompere il sodalizio che la giornata di sole, la freschezza del giardino ornato con piante di fico, una pausa pranzo dal lavoro, una certa spensieratezza ha reso possibile.
Ma quando se le ritrova quasi di fronte e ne nota lo stupore di non ritrovarsi uno dei dolci – il numero pari delle porzioni, calorie da spendere in parti uguali, dopo il furto, era ormai decaduto – gli viene un sorriso, lo stesso che la lettura di un’inserzione su Libèration poco prima gli ha provocato:
Cercasi scrittore. Vitto, alloggio, rimborso spese, gettone. Durata un anno. Disponibilità a trasferirsi.
Seguivano indirizzo mail a cui inviare la candidatura e referenze richieste. Franck non ha dubbi adesso. Sarà sa part de gateau.
Le journal
I
Un giornale che nel 1973 annuncia la sua nascita reclamando la restituzione della parola al popolo. Sartre, Mauriac e Serge July sono seduti al tavolo con altri e immagino il numero di posaceneri, le nubi di fumo che si aprono un varco attraverso larghe finestre che danno sulla rue de Lorraine, per raggiungere le acque immobili del canal de l’Ourcq. Libération dagli anni ottanta abita in un garage al numero 11 della rue Béranger, a una manciata di minuti dalla Marianne de la République.
Ci lavora Marongiu, alle pagine culturali, e Franck che di fatto è un musicista prestato al mondo delle lettere, tiene per lui dei corsi di fisarmonica, per arrotondare. Jean Baptiste, d’origine sarda, una volta alla settimana lo accoglie nella rue d’Alésia, estremo sud della città, per passare un’ora – generalmente la sera dopo aver consegnato il suo pezzo al compositore del giornale- sui tasti in madreperla di una vecchia Meister rossa acquistata al marché aux puces della Porte de Montreuil per pochi franchi. Quando Franck lo chiama, Jean Baptiste è in redazione, sta sorseggiando un caffé ed è convinto, sulle prime, che la telefonata abbia a che fare con il suo corso d’accordéon.
– No, Jean Baptiste, non ci sono problemi per il corso di domani, almeno per me; ti chiamo per un’altra ragione.
– Spara! Mentre lo dice tira fuori una sigaretta dal pacchetto per fumarsela dopo il caffé
– Sai l’annuncio uscito ieri sulle pagine cultura?
– Quello dell’isola? Non dirmi che anche tu! I centralini sono letteralmente impazziti; o qui sono diventati tutti scrittori o non ci ha una lira più nessuno. Lo sapevo che sarebbe finita così ma era un annuncio a pagamento e la mia nota di accompagnamento serviva soltanto per creare un effetto di rêverie.
– E ha funzionato. Infatti se ti ho telefonato è stato solo per via della tua nota
– Tra musicisti ci si capisce, no?
Franck sorride. la velocità con cui l’amico trova una battuta felice, è davvero sorprendente. Così prende fiato e riparte all’attacco quando Jean Baptiste gli chiede: e allora?
– Niente, pensavo che magari, chissà, potrebbe essere una buona idea per sbarcare il lunario…
– Da musicista desideroso di riapprendere a suonare mi guarderei bene dal dare al mio maestro una dritta che me lo porti via ma, c’è un ma; visto che su quell’isola ci passo tutte le mie vacanze, e che il maestro è un bravo scrittore, sai che ti dico?
Franck è sorpreso. Raramente gli ha sentito pronunciare la frase “bravo scrittore” ed è sicuramente per questa ragione che le sue recensioni sono molto seguite dai lettori, temute dagli scrittori per una sua etica inamovibile in materia. Pur frequentando molti autori nessun affetto, peraltro giustificato in certi casi da una vera condivisione e intimità, avrebbe interferito con la sua attività di critico.
– Dai dimmi
– Tra meno di un’ora passano quelli dell’annuncio per firmare un documento che avevano dimenticato di contrassegnare. Se ti precipiti da me ci parli direttamente e en plus ti faccio da garante.
– E in cambio ti pago un couscous chez Omar.
Franck non abita lontano dalla redazione di Libé. C’è un autobus diretto dalla rue Monge e se si dà una mossa- per Franck darsi una mossa equivale a una decisione tanto grave quanto imprescindibile- in una ventina di minuti dovrebbe arrivarci. C’è stato due volte in quella redazione; una per discutere con Jean Baptiste del corso e una seconda in occasione dell’uscita del suo libro che aveva voluto recapitargli di persona. Per accedere ai piani alti bisogna percorrere una rampa a spirale di quelle che in genere si trovano nei parcheggi. Più che un giornale è un’officina delle idee e per quanto lo stampino a St Denis e che al posto delle macchine da scrivere ci siano comodi computer da tavolo, si sente l’odore d’inchiostro, lo stesso che ti lascia le dita sporche di grasso come quelle dei meccanici. Lo accompagna una strana euforia mentre raccoglie curriculum, riviste, una rassegna stampa e un paio di copie salvate dal macero e dagli editori.
La commission
II
La sala riunioni della cultura è al quinto piano. Jean Baptiste abbraccia Franck con il solito aplomb da isolano. Alla profonda calma con cui si eseguono convenevoli e gesti consueti di benvenuto, generalmente, corrisponde nell’uso continentale una tale maniera, un tale grado di formalità che diventa difficile nelle metropoli determinare quanta benevolenza ci sia davvero in chi ti accoglie. Franck segue l’amico e con la consueta maldestraggine quasi trascina dietro di sé il portapenne di uno dei colleghi di Jean Baptiste che con prontezza riesce ad evitare il peggio agguantandolo prima che rovini al suolo. Franck vorrebbe fermarsi almeno per scusarsi ma è proprio questo a fargli segno di andare in fretta visto che i due assessori di Piana se ne sarebbero andati via di lì a poco.
– Bene, è appena arrivato l’amico di cui vi dicevo. Come scrittore posso dirvi che è tra i migliori che io conosca; come lavoratore – è il mio professore di fisarmonica, aveva aggiunto per inciso e con un certo orgoglio- ha il rigore di noi isolani, e per finire non è francese ma italiano, il che dovrebbe superare ogni diffidenza che è legittimo provare verso chi non è delle nostre terre solo per uno strano gioco del destino, ma che per carattere e indole sarebbe potuto essere un vostro compagno di scuola o di scorribande.
– La juste distance- aveva aggiunto quello che dei tre era sicuramente il più importante. perché era più anziano, e si sa quanto l’età conti su un’isola nella fabbricazione delle gerarchie, ma soprattutto perché, come aveva notato Franck entrando nella saletta era stato il primo ad alzarsi quasi prevedendo che a lui per primo Jean Baptiste avrebbe rivolto la parola. Cosa sapeva Franck della Corsica? Niente. Ne aveva vista solo la silhouette, il bianco delle scogliere di Bonifacio, dalla torre spagnola di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna durante un viaggio reportage con il suo compagno di collegio Marco Murgia, di Cagliari. Più giusta distanza di quella, sinceramente, non poteva immaginarlo.
– Certo, quel mix di appartenenza e di estraneità che dà allo sguardo la possibilità di vedere oltre e soprattutto meglio il bene che vive in un luogo per fare in modo che chi vi abiti non abbia più dubbi sul proprio stare al mondo. Perché proprio quello è il migliore dei mondi possibili indipendentemente dal fatto che quelle radici non si siano scelte, ma soprattutto da quanto sia magnifica o terribile quella che i più con una certa enfasi dicono essere: terra mia.- aveva concluso Marongiu.
Alla parola radici Franck associa immediatamente l’immagine dell’enorme fico secolare che si trova nel jardin accanto alla Place des Vosges. Le braccia che si diramano tentacolari filo terra gli erano sembrate dalla prima volta in cui l’aveva scoperto, dei rami-radici, staccati da terra, aerei, sospesi. Il vice sindaco- perché al momento delle presentazioni era stato svelato l’incarico del più importante- ad ogni frase di Marongiu annuiva come per apporre un sigillo di verità ad ognuna delle affermazioni. Fisicamente somigliava un po’ al Gino Cervi di Peppone e Don Camillo, tanto più che il più giovane, l’assessore alla cultura aveva una vaga, molto vaga somiglianza con Fernandel che del prete manesco era riuscito a dare una rappresentazione quasi più fedele di quella contenuta nell’opera del Guareschi.
– Ha detto bene, Jean Baptiste – il tono confidenziale aveva suggerito a Franck che i due condividessero più di una striscia di mare- allora proverò a spiegare al suo giovane amico di cosa si tratta.
Si mise a sedere pregando Franck di fare lo stesso intorno al tavolo di cristallo che rifletteva tra gli incartamenti il cielo e i tetti del Marais rifratti dalle vetrate dei finestroni.
– Come vecchio vice-sindaco conosco la storia meglio di chiunque altro. Posso dirle ogni cosa dell’allora sindaco, delle sue gesta, della generosità con cui ha governato la Commune facendo in modo che non mancasse nulla ai suoi concittadini. E quando dico nulla mi riferisco non soltanto alle cose materiali ma anche, e soprattutto, ai valori che danno lustro a una comunità o la piombano nella cattiva reputazione. Sindaco dal trentasei fino al novantanove. Può immaginare allora quanta acqua è passata sotto ai ponti, almeno quelli che non furono fatti saltare in aria. Ma il motivo per cui siamo qui, la ragione dell’annuncio che ha potuto leggere ha a che fare solo in parte con il sindaco Angelini. Nel ‘69, infatti con l’unica rivoluzione che abbia veramente cambiato la nostra vita ovvero quella delle quattro ruote e della diffusione delle utilitarie può immaginare di quanto e con che grado di mortalità aumentarono gli incidenti sulle nostre strade. Strade che come avrà modo di vedere con i suoi occhi si arrampicano su per falesie regalando ai passeggeri viste mozzafiato, su cui la cautela deve essere massima e dove basta davvero la minima disattenzione per precipitare in mare senza che le cinture di sicurezza possano evitare il peggio.
Alla parola cinture i due accompagnatori del vicesindaco avevano avuto la medesima reazione di stupore, di quella meraviglia che precede una grassa risata ma che fu soffocata ancor prima di nascere in quella circostanza.
– Così Angelini Mario, di professione sindacalista e sindaco, (in italiano) ma a questo gioco di parole i francesi a differenza di noi corsi e italiani non ci possono arrivare, s’è inventato la storia del morto.
Alla parola morto Franck, completamente preso dal racconto, per lo stile che il vice sindaco riusciva a trasmettere con pause, sguardi, ritmo della parola, aveva chiesto: quale morto?
– Il morto non morto, per essere precisi nemmeno vivo se è per questo. Eravamo insieme proprio durante quei terribili sopralluoghi insieme alla stradale per recuperare una famiglia intera da un dirupo, sulla strada che da Piana porta a Girolata, quando gli è venuta l’idea. Mi aveva prima offerto una emmeesse, a proposito le fanno ancora in Italia? alla vecchia maniera sa? Con un colpetto, facendola scivolare dal pacchetto morbido e dopo averla accesa a entrambi, con una certa aria grave aveva esordito dicendomi: questa storia deve finire. In realtà ci sarebbe un modo e credo che ci si debba mettere all’opera subito. Hai presente il tornante? Certo gli avevo risposto. Non le solite nostre maledette curve, no no, dico le grand tournant quello della strada che porta da Piana a Sartène, sulla D355. Gli avevo fatto segno di aver capito. Con piglio deciso mi ha detto: Domattina ci si va con il necessario e gli uomini giusti e ci inventiamo il morto, il primo vero morto di questa rivoluzione sull’asfalto. Al che gli avevo obiettato che seppure finto un nome doveva pur avercelo, al che aveva ribattuto Ferrari, un genovese sarà perfetto. Costruiamo un’edicola, non un chioschetto mi segua, Vinciguerra – così Franck aveva appreso anche il cognome del suo maggiore interlocutore – e assicuriamo che ci siano sempre fiori, magari si mette a libro paga una delle nostre vecchiette o uno anticu, in modo che ci sia sempre qualcuno a onorare il morto. Sulle prime, le confesserò caro Franck che l’idea mi era sembrata un po’ bislacca, poi me ne convinsi e quando anno dopo anno cominciammo ad avere i primi risultati, u miraculu, ovvero meno incidenti mortali, raggiunsi la certezza che “il Morto” sarebbe riuscito a mantenere non poca gente in vita. La questione è che avremmo voglia di onorare il morto adesso, a trent’anni di distanza dalla costruzione dell’edicola. E onorare il nostro non più vivo sindaco, nella stessa occasione. Però può ben immaginare come sia difficile onorare qualcuno se il qualcuno non è mai esistito. Questo sarà il suo compito Franck – Franck si rese conto solo in quel preciso momento che il posto era suo- raccontare la vita di Paolo Ferrari, della sua famiglia, da quando sbarcò da Genova come dominatore fino al momento della sua morte. Se per lei va bene potrebbe cominciare anche domani.
E gli porse il bigliettino da visita. Ottavio Vinciguerra, vicesindaco. E così conosceva anche il suo nome, adesso
Hortus
III
Prepararsi a fare le valigie, chiudere casa, partire. Delle tre la più difficile è la casa, perché non la chiudi mica come una valigia e di certo non puoi portartela appresso. La casa abbastanza piccola e spoglia che l’unica cosa che sia davvero d’ingombro è molto probabilmente solo Franck, fisico imponente, andava lasciata a qualcuno. ma a chi? E poi se le cose non fossero andate nel migliore dei modi lì in Corsica come riprendere casa adesso che non ha nemmeno più uno straccio di busta paga in grado di assicurare agenti immobiliari e soprattutto i proprietari. Un anno non è un semplice tempo, è una durata, un concetto a cui Franck, da anni non è più abituato; la sua vita, e per vita si intende la sua esistenza, non è mai andata oltre la mesata, l’affitto da pagare, le varie scadenze amministrative e soprattutto i corsi da piazzare qui e lì dove e quando possibile. Certo c’erano i gatti e le piante. Da quando è andato a vivere da solo Franck ha sempre vissuto in quella che ama definire la catena Darwin, senza sapere se fosse una decisione legata alla salvaguardia della specie, la sua specie, o per non essere solo. La pianta è un partner ideale, un esercizio della cura da compiersi in silenzio e i gatti , due gatti trovati nel quartiere, figli ideali cui destinare le carinerie spesso ricambiate al momento dei pasti.
I gatti allora all’amico anarchico portoghese Mani e le piante a Fiammetta e Fortunato. Perché Fiammetta, che ha un laboratorio di ceramica poco distante, ha le mani d’oro e una perizia botanica da giardiniera provetta. Il passaggio da Mani che adora i gatti al punto di portarseli in boîte alla Java che gestisce da sempre è sempre costellato da frasi felici che nessun romanziere sarebbe in grado di sfornare, generalmente in piedi, tra una cosa e l’altra. L’arrivo di Franck alla Java è salutato da Christine con la simpatia che li lega da sempre e dunque senza particolari cerimoniali se non la luce degli occhi e un caldo abbraccio, cose da riservare a pochi, da distribuire con parsimonia altrimenti si rovinano. Sempre.
Mani è nella grande sala a seguire il lavoro dei due operai che stanno rimettendo il parquet e devono assolutamente finire entro le venti all’arrivo dei musicisti. Mani ha appena liberato il più giovane dal peso dell’auto rimossa dalla polizia municipale. Ha chiamato il deposito, pagato la contravvenzione in tempo reale e offerto al carpentiere gli estremi per il ritiro. La gratitudine accresciuta dal gesto si esprime nell’estrema diligenza con cui Mani gli indica come eseguire il lavoro. Perché le lamelle di betulla sembrano a un certo punto piegarsi à banane, e sfuggire all’allineamento. Mani osserva da vicino e dopo un attimo di silenzio dice:
– Sai, sono orbo da un occhio e per questo posso dirti quando le cose sono veramente allineate.
Mani ha perso un occhio da ragazzo, un incidente, ma ha una visione delle cose soprattutto della vita infallibile come quando ha risposto a Franck che gli chiedeva se frequentasse più i suoi amici ballerini:
– Vedi Franck, si cambia amici quando si cambiano le droghe.
Mani conosce i due gatti di Franck. Era già capitato in passato di occuparsene come del resto all’amico italiano quando durante la chiusura della Java Mani e Christine se n’erano partiti per lunghi viaggi in moto.
– Allora che ne dici di questa storia?- gli chiede mentre l’amico gli serve un calvados dal bar.
– Dici la Corsica? Beh ci mancherai, vuol dire che la sera farò un po’ di chiacchiere con loro per non abituarmi alla tua assenza. Tu droghe non ne prendi.
– Ma sei sicuro per la durata? Prima che mi sistemi per bene, di capire se me li posso portare sull’isola passerà almeno un mese.
– Non ti preoccupare, vorrà dire che te li portiamo noi e così ci faremo un po’ di mare.
Stanno per salutarsi quando l’amico anarchico gli porge un libro, pregandolo di leggere la dedica.
– Ma Mani, è la tua copia di quand’eri a scuola, sei sicuro?
– Luís Vaz de Camões ormai ce l’ho dentro. Leggilo, è il nostro Dante e poi il tempo non ti mancherà. Questa invece – intanto era uscito da dietro al bancone per recuperare dalla borsa accanto al casco una partitura- te l’ha presa Christine; l’ha trovata d’occasione su una bancarella e visto che ti mancava ha pensato bene di fartene omaggio.
Il commiato da chi si vuole bene è sempre un momento difficile soprattutto quando l’incertezza del tempo a venire non permette di determinare una data di ritorno.
Da Fortunato e Fiammetta accade lo stesso. Franck ha un numero di amici equivalente alla quantità di parole che riesce a mettere insieme, da sobrio, in una conversazione. Con Fiammetta sono andati all’Hortus della Rue des Rosiers.
– Cosa ci suonerai di bello?- gli aveva chiesto, dando un’occhiata ai fogli che aveva in una mano.
– Cage, Piano works 1935-1948. Dream. Questo è il pezzo che cercavo.
– Un amico spagnolo diceva: El anarquista del silencio. Come te, no?
– Sai Fiammetta, il nostro, per me che suono, per te che lavori con la scultura, non è mai silenzio, è risonanza. Ci sono strumenti, forme d’arte in cui la nota, un gesto muoiono nel momento in cui l’azione si arresta. Prendi una nota di piano, il disegno. Invece per la fisarmonica come per te la terra o la ceramica, si muovono, persistono, vivono, risuonano appunto e a lungo dal momento in cui li abbiamo toccati.
– Ributtano! – aggiunge Fiammetta infilandosi in uno dei sentieri che portano alla piccola serra e cogliere della cicoria ben cresciuta.
– Sai, pensavo alla storia del fico che c’è qui nell’area del sottobosco. Ai rami che sembrano radici. I fichi ributtano come gli ulivi, mi hai detto…
– Quando la pianta sembra essere morta, su un lato, prepara sull’altro la sua rinascita. A proposito visto che c’è Jocelyn, – da lontano sopraggiunge l’addetto comunale al verde pubblico, che nel giardino si occupa della parte a carico della Mairie lasciando il resto alle associazioni di cui si occupa tra l’altro Fiammetta – perché non gli chiediamo da quanti anni c’è il fico?
Jocelyn ha la tuta da lavoro e qualche attrezzo per le pulizie. Un grande sorriso e soprattutto una disponibilità totale verso quei volontari della terra, sempre alla ricerca di consigli utili o di precise diagnosi in caso di cattiva crescita o di funghi come quelli che avevano devastato una buona metà dei meli distesi lungo il muro a rami incrociati.
– Jocelyn, il fico da quanto c’è?
– Son trent’anni che lavoro qui e ai Blancs Manteaux, e c’era già. Ti ho detto del cassettone del compost?
– No, ho appena chiuso una buca che un porcospino s’è scavato per fare colazione coi vermi.
– Porcospini? No, Fiammetta sono topi, e non di taglia modesta. Da un mese a questa parte padroneggiano nel quartiere. Bisognerà fare attenzione ai cassettoni. Il vostro, per esempio va riparato.
Lo sguardo di Franck è assente, preso dall’eleganza delle quattro betulle i cui tronchi bianchi si stagliano contro il cielo. Ha appena ripassato a memoria il cartello informativo che c’è ai piedi del fico. Si dice che la creazione di quel sottobosco ha permesso il proliferare di un certo tipo di fiore, di pianta, d’insetti e perfino il ritorno dei trogloditi mignon.
– Jocelyn cos’è un troglodite mignon?
– Un passerotto, vivace. E se mai ve ne fossero ancora a mio avviso farebbero bene a tenere gli occhi aperti per non diventare un boccone prelibato.
– Per i gatti?
– No, per i topi
– I topi?
Ferry-boat
IV
Dalla Gare Maritime di Nizza ad Ajaccio ci vogliono circa sei ore. Quando la nave si stacca da terra il mare l’accoglie digrignando i denti, sferzando l’aria che è schiuma di fiocchi. C’è in questo mezzo di trasporto qualcosa di ancestrale quasi più di un vecchio carro, perché la naturalezza con cui un corpo può lasciarsi portare dalla corrente qui si ripete, nonostante l’artificio del ferro, delle ancore, dei motori. Franck ha trascorso le ultime ore parigine in compagnia di Fortunato, alla libreria. L’amico gli ha offerto il caffè, bien serré, spingendo la capsula nella macchinetta. Gli ha perfino regalato una cartina della Corsica per raccapezzarsi; nella mail il vicesindaco gli ha scritto che verranno a prenderlo in macchina a Bonifacio. Poi escono un attimo, lasciando Fabrizio alla cassa, per fumarsi una sigaretta. Franck gli racconta quello che è appena successo in metropolitana.
– A un certo punto è salito su, un pazzo, cioè mezzo matto, un matto gentile però; era ben vestito, da hipster, con barba e occhiali, e incollando la faccia al vetro delle porte appena chiuse ha cominciato un soliloquio dove era questione di gatti, di gatti e bambini. In realtà non era un soliloquio, non è mai un soliloquio, in questi casi, ma una conversazione in cui esiste un interlocutore anche se non si vede; è invisibile agli occhi di tutti come dio nelle preghiere di chi ci crede. Ora, lo sai Fortunà, il tono interlocutorio di solito è dato dalla maniera di formulare le frasi, dal loro rimontare verso il punto interrogativo della fine, no?
Fortunato ascolta, fuma, ne asseconda quel desiderio di parlare che in persone taciturne come Franck ha sempre qualcosa di sorprendente, quasi miracoloso, e sa che quando capita è perché il credito di parole, il loro peso dentro è al limite della sostenibilità e deve allora liberarsene.
– Invece questo ragazzo, ti assicuro, dai modi gentili, un po’ sopra le righe, perfino violento quando tagliava le frasi, come una litania ripeteva, dis-donc, e subito dopo, si chiedeva ma quasi ripetendo la domanda del suo interlocutore – qualcosa aveva suggerito però a Franck che si trattasse di una donna, tipo la sua donna- come si scrive? di i esse di o enne di ci.
– Non mi è mai capitato di sentire una cosa del genere- aveva replicato Fortunato
– Capisci? A che pro chiedere di ripetere la parola lettera per lettera, domandare come si scrivesse visto che il piano di scambio pareva tutto costruito sull’oralità e invece quella frase, quella richiesta pareva venire da qualcuno che stesse prendendo nota; e in quella strana domanda c’era una grazia, un’attenzione che faceva di quell’essere invisibile agli occhi dei più, una presenza benevola e consolatrice.
– Melogrammatica?
Franck era scoppiato a ridere. Con Fortunato condivideva tre grandi amori: il silenzio, che era d’oro, la buona letteratura, l’argento, e che di fatto gli dava da campare e un buon bicchiere di vino la mirra, quest’ultima solo per comporre tutta l’epifania laica del loro incontro.
Ora che la città vista dal ponte gli si stava disgregando a contatto con la distanza non un pensiero, non un ricordo, un pezzo di frase, un’immagine, un affetto lo tratteneva dalla partenza; le piante e il gatto erano in salvo, in buone mani e davanti a sé, oltre all’isola c’era una storia di cui non sapeva assolutamente nulla, e solo lo confortava il fatto che nessuno ne sapeva niente. Per fortuna il suo giubbotto di salvataggio ancora una volta era tutta in quella frase, per di più in latino appresa da ragazzo sui banchi dell’università. Fingunt simulque credunt, mutuata da un libro di Carlo Ginzburg, citata da un’opera di Gian Battista Vico. Frase che aveva mandato a memoria anche nella traduzione dello storico: quel che avevano immaginato, credevano dappoi.
Franck si guarda intorno. Il vento gli sferza la faccia e si alza il collo del cappotto per non esporre la gola a cedimenti. Adesso che è solo non rimpiange affatto, come invece gli era capitato fino al momento dell’imbarco, di essersi portato dietro la fisarmonica. L’enorme custodia la rende invisibile anche se non è tanto difficile indovinare dalla foggia di che strumento si tratti. Uno strumento da zingari diretto in un’isola di banditi. Gli ingredienti per un romanzo criminale c’erano tutti. Prende posto nell’enorme sala che c’è al primo piano. I televisori sospesi negli angoli fanno in modo che dovunque si giri la testa gli occhi ne verranno come stregati. Dagli altoparlanti si informano i viaggiatori della rotta di navigazione, delle condizioni del mare, di quelle metereologiche. Lui decide di cacciare lo strumento un po’ per fargli prendere aria, un po’ per controllare che nei vari passaggi, treno, nave, sia tutto a posto; ma forse lo fa perché nessuno abbia a temere che nasconda qualcosa di brutto, un’arma? una bomba? Da metà degli anni novanta, dall’attentato a St. Michel basta poco per farsi delle strane idee. Però ci piace pensare che Franck lo voglia mostrare per dare un volto al proprio amico del cuore, quello che se anche non si vede c’è e che quando si mette a parlare, quando libera i suoni dai bottoni di madreperla, li soffia, si resta sempre incantati.
Poi dà un’occhiata fuori dai finestroni. Un’altra nave, ma da crociera, enorme quasi li affianca. Gli pare di scorgere in quella silhouette la Vlora, la nave dolce che un mattino d’agosto apparve all’orizzonte di Bari con ventimila anime a bordo.
La bibliothèque
V
Corsica, anello tra le due nazioni. Così la definisce Nicolò Tommaseo che all’isola aveva dedicato le sue migliori energie e i versi che sono su un manifesto all’entrata della biblioteca:
L’ ombre ne’ miei pensier: vedrò ’l pallore
Umile e altero delle Corse donne
Percotermi nel cuor più che d’ amore,
Udrò simile alla cirnea vendetta
Urlar tra i sassi e le ulivete il vento,
E per le selci la levata fiamma;
E il Vócero che cupo a passo lento
Segue l’ombre de’ morti, e chiama sangue.
E te pur penserà, che dalla forte
Terra in cui l’adulato esule nacque,
Mandi del canto l’ospital saluto
Franck si aggira tra le sale lettura per trovare un posto tranquillo dove stare. Cécile, la responsabile della sezione manoscritti l’ha presentato al collega Alberto che gli ha già preparato una pila di libri da consultare. Sono passate poche ore dall’arrivo a Piana e già si sente uno di casa. La casa in cui starà ha una vista su più orizzonti. Dalle finestre della cucina si vedono le cime dei monti mentre dalla camera da letto letteralmente si sprofonda nella vista sul mare. I calanchi di Piana ce li avrà sotto al sedere ma non per questo non dormirà sonni tranquilli. Ci sarà una signora a sbrigare le faccende di casa due volte a settimana e con un piccolo supplemento, gli è stato detto, potrebbe perfino preparagli da mangiare. Franck deve abituarsi al lusso che il destino gli ha servito su un vassoio d’argento in un momento in cui non c’erano vassoi in casa a Parigi, ma soprattutto non c’era l’argent. Accade sempre in situazioni come queste che ci si senta come impostori, come dei clandestini – questa sostituzione della parola vita con destino non poteva essere più appropriata- a meno che non si incorra in quello strano computo, nella sequenza causa-effetto inesorabile per cui se ci succede qualcosa di buono ora tale fortuna verrà pagata poi. In questi casi però Franck aveva elaborato una sua strategia che consisteva nel fare inversione di successione e giustificare il bene inaspettatamente ricevuto per tutto il male subito fino a poco prima. La Corsica ha due grandi biblioteche, una ad Ajaccio e l’altra a Sartene, nel Couvent Saint-Joseph. Ci lavorano cinque persone e la direzione è affidata a Cecile. Il fondo manoscritti è assai ricco e i primi titoli che Franck ha sotto mano sono:
Storia succinta delle rivoluzioni dell’isola di Corsica
Storia delle rivoluzioni dell’isola di Corsica e della esaltazione di Teodoro I al trono di questo stato
Scintille di Nicolò Tommaseo
Relazione della Corsica di Giacomo Boswell scudiere, trasportata in italiano dall’originale inglese.
Journal of a landscape painter in Corsica di Busch.
Fotografa man mano le pagine che potranno servirgli per la sua saga tutta inventata. Vuole fare proprio il motto che uno storico aveva ripetuto ad una recente conferenza di uno storico italiano, Carlo Ginzburg all’Istituto di Cultura di Parigi. A un certo punto la direttrice aveva chiesto allo storico se nella sua idea di secolarizzazione, ovvero occupazione da parte dello stato degli spazi un tempo destinati al potere religioso vi fosse stato un qualche riferimento all’opera di Carl Schmitt . Il magister aveva avuto come un sussulto, un rigurgito intellettuale e aveva ribattuto assai stizzito che del pensatore nazista – il richiamo ideologico ovviamente era stato intelligentemente evitato da parte della sua interlocutrice- se ne sopravvalutava l’opera tanto a destra che a sinistra e che, comunque sia, ben prima di lui e di certo meglio, altri avevano ben descritto tale ” dinamica”, a partire dagli antichi e continuando con i moderni come Machiavelli e Hobbes. Degli antichi Carlo Ginzburg aveva inoltre ben spiegato la formula chiave, la formula di Tacito che dice: “credevano in ciò che avevano appena immaginato” . “Fingunt simulque credunt”, che tra l’altro Giambattista Vico avrebbe riportato in primo piano nella sua rifondazione delle scienze storiche. Franck aveva così immaginato che se si fossero trovati a un importante colloquio internazionale di medicina e sentito un ipotetico moderatore proporre all’invitato una relazione tra quanto appena detto e le scoperte di Mengele, probabilmente l’intero pubblico in sala avrebbe reagito come lo storico in questione. Allora perché questa differenza di trattamento? Lui comunque avrebbe sicuramente inventato e per quanto riguarda il crederci questo non era contemplato nel contratto. Di certo la cosa più importante era che i lettori vi credessero, ovvero appassionarsi alla storia della famiglia del tale che con la propria morte, con l’incidente in uno dei tornanti e la costruzione della piccola edicola a futura memoria aveva salvato tante vite. Ma allora da dove cominciare non gli era affatto assai chiaro. Certo a Franck sarebbe piaciuto mettersi sulle tracce, almeno nello stile di uno scrittore morto da poco in Sardegna, Sergio Atzeni che con la sua ultima opera, Passavamo sulla terra leggeri, aveva reinventato i miti fondatori dell’isola. Franck però non aveva questa ambizione; il suo sarebbe stato un racconto picaro, qualcosa di più simile a un romanzo d’appendice che a un poema epico. Sull’esempio di una delle storie che Alberto il bibliotecario gli aveva portato, avrebbe riassunto quindici secoli di storia in una ventina di pagine, magari ammantate di mistero, fino alla dominazione genovese e raccontato con più dovizia di particolari le rivoluzioni che tra settecento e ottocento avevano infuocato l’isola. Più o meno tra il trattato di Versailles e la nascita di Napoleone l’inizio per poi continuare con l’ottocento degli anarchici e il novecento dei fascisti. Mentre si lascia andare col pensiero a tutte queste riflessioni si è fatta ora. A cena sarà ospite del vice sindaco. Non vuole presentarsi a mani vuote e così si fa dire da Cécile dove acquistare del buon vino, del vino importante.
La femme de ménage
VI
Franck si muove con circospezione nella villa messa a sua disposizione; la vista sulle calanche ha in sé qualcosa di struggente e l’aria è talmente pura che rischia di farsene un’overdose, con tanta purezza. Pensa ai gatti lasciati a Parigi e alla loro felicità quando verranno a stare da lui. Il giardino è immenso e regolare ed è forse per questo che la villa l’hanno chiamata u pratu ; l’erba è forte e i muretti di cinta a proteggere la proprietà dai cinghiali gli ricordano le trincee della prima guerra mondiale visitate in Trentino anni prima. La signora che si occupa di lui si chiama Rosa. Quando l’ha incontrata in mattinata sulle prime era rimasto un po’ sorpreso; s’aspettava una donna vestita di nero con fazzoletto in testa, dalla faccia segnata dal sale, dalle braccia larghe e di poche parole, una signora. Invece Rosa è giovane, ha un paio di jeans strappati sulle ginocchia, stivaletti neri da pirata e una camicetta la cui scollatura lascia intravedere un reggiseno che ha l’aria di essere il pezzo di sopra del costume. Una ragazza che ama nuotare.
Mentre bevono in terrazza, immersi nel sole di pieno mattino, la curiosità di lei verso quell’uomo forestero è concentrata soprattutto sul suo lavoro; farsi pagare per immaginare storie, inventarsi le cose ecco questo non poteva capirlo. Non solo. Trova perfino ingiusto che si possa fare; in realtà Rosa ama leggere, scrivere, cantare come le capitava fino a poco tempo fa in un locale tenuto da una cugina e che d’estate si riempiva di gente per lo più turisti in cerca di qualcosa di veramente esotico quando nulla poteva esserlo su un’isola di un posto tenuto da sole donne; eppure lei non riesce a sedare la propria sete di risposte, con quanto Franck a volte imbarazzato, per lo più impacciato, le serve insieme alla birra ghiacciata. Franck ne è affascinato. La giovane età? Lo sguardo che occhi liquidi rendono invincibile, il potere di trascinare ogni cosa in chissà quali abissi dell’anima, e che allo stesso tempo come sospeso alle parole, ai gesti, diventa quello di una creatura perduta, perduta e sola, alla maniera di una ragazzina che avesse perduto per via delle correnti l’orientamento e al ritorno da una nuotata non riconoscesse più casa tra le file degli ombrelloni. In questo sono sicuramente simili, però se a salvare Franck è la musica, la fisarmonica, in lei, invece, è la rivolta, il seme della disobbedienza, a farle da angelo custode proprio quello che a Franck mancava e avrebbe sempre desiderato possedere perché qualcosa crescesse in lui.
– Continuo a non capire…- ha aggiunto lei rientrando in casa. Si siede su una delle poltrone e aggiunge – comunque le prometto che mi spiegherò meglio la prossima volta. A proposito, prima di entrare ho sentito che stava ascoltando Janis Joplin
– Little girl blue
– È la mia preferita
– A proposito della fatica, cioè del lavoro che non capisce come si possa definirlo tale, in un certo senso la capisco. Anche a me quando dico che mi guadagno da vivere così in genere il mio interlocutore mi ribatte che deve essere molto figo fare qualcosa che si ama fare, in cui può capitare perfino di divertirsi e in più essere pagato per questo
– Riassume bene la cosa, questo che mi dice – ha aggiunto lei.
– Però in realtà tutti dovrebbero campare facendo le cose che si amano, no?
– Per lo più non è così
– Infatti nemmeno per me, e faccio la fame
– Un po’ sciupato lo è, se posso permettermi.
Solo in quel momento Franck realizza quanto siano differenti. Lei ha la pelle abbronzata, i tratti distesi e naturali. Perfino la leggera arrossatura sotto il labbro ha un suo perché come una mela acquistata a peso d’oro in un mercato bio del quinto arrondissement. Le sue mani levigate dai saponi sanno di terra e per la prima volta sente il desiderio di prendergliele tra le sue per poterne sentire le screpolature, alleviarne la durezza ma si trattiene dal passare all’atto. Si sono appena conosciuti e in più lei ora lavorerà per lui.
– Sa che faccio? Ingrasserò capitolo dopo capitolo e quando sarò bello panciuto vorrà dire che sarò abbastanza voluminoso e pronto per andare in stampa.
– Tanto lo sa che cucino io
– Comunque mi ha dato un’idea
– Cosa?
– Domani vado in un caccia pesca e tutto sport e mi compro un paio di pesi per polsi
– Cosa?
– Sì quelli in piombo che usano i sommozzatori
– Per andare a fare immersione?
– In un certo senso, però sulla pagina. L’ho sentito dire a Ferdinando Camon in una conferenza a Parigi, al Pompidou
– Chi? Cosa? – Rosa sembrava non seguirlo affatto ma il sorriso che aveva fatto seguire alla raffica di domande aveva una leggerezza e una sincerità che sembravano assecondare la voglia di parlare di Franck più che stabilire una distanza, quella rovinosa per cui la gente non si capisce.
– Camon uno scrittore del nord est figlio di gente che lavorava i campi. Raccontava che aveva cercato di vincere la vergogna della propria emancipazione dalla fatica costringendosi a scrivere mettendo ai polsi i braccialetti da sub e far provare alle mani dello scrittore la stessa fatica dei padri contadini.
– Se vuole la accompagno io. L’unico negozio che c’è in paese è di mio zio, il Buonarroti
– Lo scultore?
– No, l’anarchico, ma non per questo senza il martello
Les Innocents
Cap.VII
Per descrivere una passeggiata ci vogliono scarpe buone.
Franck non ricorda affatto in quale libro e per bocca di quale autore abbia sentito per la prima volta questa frase; eppure risuona in lui dalla mattina presto in cui la sveglia del mondo con una buona mezz’ora d’anticipo su quella digitale, l’ha tirato giù dal letto.
E insieme alla frase si ripete a mente l’incontro in municipio delle undici con il libraio dell’Adelfia, Cossu Giovanni che con Castellani in Place de la Fontaine si divide la piazza dei libri. Glielo ha presentato lo zio di Rosa, il Buonarroti della chincaglieria dove accompagnato dal vicesindaco si era recato poco prima per procurarsi i pesi per i polsi.
Lo aveva in verità un po’ sorpreso l’indifferenza con cui i due ospiti avevano accolto quella sua richiesta; il fisico da sub di certo non lo aveva, né tanto meno del culturista ma allora a che pro comprarsi quegli attrezzi? L’unico a esserne sorpreso, ma anche un po’ lusingato per la stranezza cui aveva voluto cedere, sembrava proprio lui mentre ne pesava la massa, passandoseli da un palmo all’altro delle mani, e controllato l’aderenza al polso. Se li era fatti regolare dal vicesindaco che sembrava più avvezzo all’uso; di certo adesso Franck poteva solo immaginare in che modo avrebbe influito sulla sua scrittura, quali movimenti condizionato nel battere le frasi al computer visto che se ne avesse mimato sul posto i gesti l’avrebbero rispedito nella capitale con un TSO. Il libraio, alto, leggermente claudicante e con forti labbra da isolano – la barba invece rada e brizzolata sulla faccia scura sembrava tradurre i segni di un mestiere di mare, di navigazione o di porto – si era subito portato disponibile a dare una mano per le sue ricerche d’archivio sciorinando tutta una bibliografia mentre l’anarchico Buonarroti seguiva tacendo e con pochi cenni del capo i consigli del letterato.
– Conosco bene l’Italia; a Firenze; ci ho lavorato a lungo negli anni settanta e animato perfino una comune insieme ad altri pazzi. A me e ai due sardi, di Porto Torres, ci chiamavano gli “incontinenti”
– Non aveva l’aria di essere un complimento- aveva detto Franck posando i pesi sul bancone e preparandosi a pagare
– In un certo senso sì; in quel gioco di parole c’era un sottile apprezzamento per l’intraprendenza di uno dei due, l’architetto e di riflesso la nostra, per semplice natura isolana. Mi ha detto Vinciguerra che ti ispirerai alla crociata dei fanciulli per far cominciare la dinastia del nostro eroe dei tornanti
– Sì, il primo Ferrari, in realtà l’ho immaginato come il figlio di Ugo Ferro uno dei due mercanti che s’era venduto come schiavi i ragazzini al Sultano imbarcandoli a Marsiglia con la promessa di condurli in Terra Santa
– Jolie famille!
– Il punto però è che lui non è come il padre, anzi farà di tutto per riscattare il nome. Sarà la sua personale crociata anche se la storia della famiglia sarà per i secoli a venire segnata da quella maledizione.
L’anarchico negoziante gli aveva lasciato il resto dei cinquanta franchi sul banco. S’era ritirato nel retrobottega per tornare con un libro: una vecchia edizione della Crociata dei fanciulli di Schwob, quella curata da Borges per Franco Maria Ricci. La copertina azzurrina faceva pensare alla carta da zucchero. Franck non conosceva quella edizione. Gli sarebbe tornata utile anche perché all’inizio non era chiaro ai committenti se le puntate della storia sarebbero state in francese o in còrso, salvo poi decidere più o meno all’unanimità che l’avrebbe scritta in italiano e in un secondo momento tradurle nelle due lingue, mttendo sullo stesso piano lingua dei dominatori e dei dominati. “La lingua di Paoli!” aveva sentenziato il vicesindaco alla fine della discussione.
Quando Franck torna a casa la prima cosa che avverte è la presenza di Rosa. Ne cerca ogni traccia di passaggio – la prima cosa che aveva notato era che avesse rifatto il letto nonostante vi avesse provveduto prima di uscire. Ogni stanza sapeva di Javel, e la lavanda sulla mensola della cucina si lasciava portare dalle correnti per coprire l’odore metallico di varichina. La lavatrice era ancora in funzione e sul ripiano aveva trovato una nota, stringata, della ragazza:
“ Ripasso nel primo pomeriggio per stendere i panni. Spero le convengano i detersivi che ho usato. Per strada ho raccolto della lavanda. Non so perché ma pensavo che potesse corrisponderle come profumo. A dopo, comunque. ”
Franck si avvia sul terrazzo grande come per sottrarsi a lei e sistema il tavolino bianco da giardino in modo da poterci appoggiare il computer e i primi libri recuperati in biblioteca e utili per cominciare il racconto. Ha già in mente il titolo, Le tournant, così in francese. Perché la parola suggerisce un luogo, quello per cui è stato chiamato a scrivere, e un personaggio che di colpo ritorna sulla scena per raccontare se stesso. Ferrari, Arturo Ferrari sarà il Revenant. Ha già una fotografia. L’ha trovata sulla rivista che aveva consultato in Biblioteca, una pubblicazione curata dall’associazione Ràdiche. Rappresenta il poeta corso irredentista Santu Casanova. Non sa se l’ha scelta per il nome o effettivamente per la faccia, poco elegante, estremamente ordinaria.
Quando avvicina la sedia in metallo al tavolo ha già indossato i pesi da immersione ai polsi. La prima impressione è di vigore, e quando una volta preso posto comincia a scaldarsi le dita sulla tastiera, non ne ravvede alcun impedimento ma ne percepisce lo sforzo fisico, quello inseguito da Camon e ora da lui realizzato. A penna su un post-it ha scritto due frasi veloci ripensando al bigliettino della lavatrice:
vederti a fior d’acqua lasciarti portare dalle correnti
come quando da bambini impariamo a fare il morto
Per immergersi ha bisogno di una spinta che lo faccia tuffare nel magma di voci e suoni che diventeranno parole, poi pagine, un libro. Tra i vari appunti contenuti in una cartellina rosa pastello emerge all’improvviso la stampata della voce Corsica di wikipedia.
Separata dalla Sardegna dal breve tratto delle Bocche di Bonifacio, emerge come una grande catena montuosa ricca di foreste dal mar Mediterraneo, segnando il confine tra la sua parte occidentale, il mar Tirreno ed il mar Ligure.
Ne ammira la precisione geometrica, la sintesi di una descrizione così concreta. Si chiede chi sia il compilatore ma anche se saprebbe rintracciarne il nome, visto che ha un amico registrato proprio come contributor, in realtà ad interessarlo è proprio la vita del tipo che per ragioni che gli sono oscure ha dedicato alla voce Corsica un periodo della sua vita ma soprattutto la sua eleganza di scrittura. La prima nota con sottolineatura gialla riguarda invece il compare di Hugues Ferro, ovvero Guglielmo Porco.
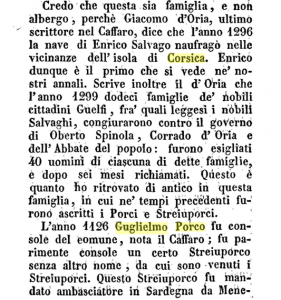
Certo, l’idea di un naufragio a pochi anni di distanza dall’eccidio del 1212, che coinvolgesse il figlio di Ferro poteva funzionare e la cosa gli suonava talmente bene che per un attimo pensò al fatto che evocasse l’acqua di vite di terra sarda il filu ‘e ferru.
La stesura
Cap.VIII
Franck non si è accorto del tempo che è trascorso da quando ha cominciato a scrivere le prime dieci pagine del suo memoriale. Non si è reso conto nemmeno del peso ai polsi tranne quando in una delle pause sigaretta infilando istintivamente la mano in una tasca della giacca per tirarne fuori l’accendino poco mancava che ne strappasse il tessuto. Così mentre si porta la sigaretta alle labbra ha seguito la parabola del braccio come intento in un esercizio fisico e non l’ha sentita entrare preso com’era dall’osservazione del corpo che a questo punto non gli sembrava nemmeno più il suo – una tale estraneità l’aveva provata quando dopo una partita con i suoi amici a Vincennes si era storto una caviglia e costretto a inventarsi un modo di camminare diverso s’era sentito espropriato delle sue gambe. Il profumo di lei lo spinge voltarsi e a coglierla prima nell’atto di chinarsi sulla bacinella ricolma di panni appena lavati e a seguire in quello di stendere il primo dei capi sul filo di ferro teso da un capo all’altro del terrazzo. È una camicia bianca che porta le cifre di suo fratello Geppi. Ne distende le maniche con cura e l’immagine che ne ha è la stessa di una maestra di ballo intenta a mostrare all’allievo prediletto la posizione delle braccia. Per eseguire quell’operazione Rosa ha disteso le braccia e Franck rimane come turbato dall’aureola di peli radi che sotto le braccia nude si mostrano in tutta la loro naturalezza. Distoglie lo sguardo da subito come se provasse vergogna di essersi messo a guardare, invece di vedere l’amica nel suo insieme di presenza e ospite, violando il tempo e lo spazio della ragazza. La saluta con garbo per divenire d’improvviso presente. Rosa si volta e gli sorride per ricambiare.
– Rosa, grazie mille per tutto
– Lei lo sa che sono pagata per questo, no?
– Sì, ma non di farlo con la cura che le ho visto dedicare alle mie quattro cose. E comunque, lo sa che siamo in perfetta sincronicità? Sono anch’io alla mia prima stesura
– E allora? Soddisfatto?
– Non so ancora, però…- mentre le sta parlando nota come lo sguardo di lei si sia posato sui polsi inghirlandati dal piombo- ah, dimenticavo di ringraziarla per avermi indicato il negozio di suo zio
– Le stanno bene, sa, se fossi in lei li terrei anche per uscire la sera. Le danno un’aria da galeotto e su un’isola come la nostra è un punto a favore
– Potrebbe essere la mia fuga dai piombi. Intanto signorina le presento il mio protagonista, Casanova 
Rosa ha preso la fotografia in mano dopo essersela asciugata sui jeans e con aria interessata ha chiesto come facesse di nome
– Santu, Santu Casanova, uno dei vostri più illustri poeti
– Io non ho poeti miei. Quelli che amo appartengono a tutti; per lo più esuli e rivoluzionari.
– Le posso chiedere una cortesia?
– Mi dica pure, però sappia che le toccherà parlare mentre continuo la mia stesura. Come diceva una signora buona da cui lavoravo, i panni appena lavati dopo un minuto muoiono se non li stendi e infatti perdono ogni profumo e puzzano di morte
– Ah già, scusi. Comunque volevo solo chiederle se potevo leggerle le prime dieci pagine del romanzo. La lettura ad alta voce è il primo esame da superare per una scrittura. Se non funziona te lo dice la voce. Però farlo da solo mi annoia; posso prenderle in prestito un orecchio? Non si preoccupi, non le chiederò se le piace
– E perché? Non si fida delle mie orecchie?- per dirglielo s’era voltata e l’aveva fissato tenendosi le orecchie con le mani e piegandole come fanno i bambini quando si trasformano in mostri.
– Allora se vuole, prenderò in prestito anche la sua anima.
– E in cambio?
– Cosa posso darle? Non ho niente
– Ho visto la fisarmonica in camera. Mi piacerebbe sentirla suonare, un’aria, quella che vuole, quando avrò finito il lavoro e chiaramente quando avrà terminato la lettura.
– Affare fatto.
Franck ha recuperato i fogli del primo capitolo e mettendosi a sedere poco distante comincia a leggere il manoscritto. Si è tolto i pesi e solo allora si rende conto dalla pelle arrossata quanto stringessero. L’attacco è perentorio:
“ A nessuno è dato di sapere il giorno, il mese, l’anno preciso in cui la piccola nave che salpata da Marsiglia fece naufragio lungo la costa occidentale della Corsica, da Capo Còrso a Capo Pertusato. Se una tempesta non si fosse abbattuta sul convoglio avrebbe proseguito lungo la Sardegna prima d’inforcare la Ruta de Las islas. Che tra i pochi sopravvissuti vi si trovasse in ceppi Martin Ferru, figlio legittimo di Hugues, nemmeno il padre lo venne mai a sapere e fu un bene per le cose che sarebbero in seguito successe(…)
Mentre dice il testo, assecondandone il passo, la falcata, nei momenti di maggiore enfasi e il suo oscillare tra nature e paesaggi incontaminati, attraversati dalla fatica dei personaggi, di tanto in tanto solleva lo sguardo per cogliere in un’espressione del volto di lei un segno, per quanto minimo di consenso o di perplessità magari di non comprensione di un passaggio o di indifferenza alla storia. E invece non solo in certi momenti Rosa si fermava come per capire meglio e riprendere subito dopo la molletta di legno per fissare un pantalone o una mutanda, ma rideva con gusto dove Franck avrebbe voluto che il lettore ridesse o corrugava la fronte quando l’eroe sembrava perduto come quando nella scena dei lupi il povero Martin si salva dal branco grazie al provvido intervento di un cinghiale gigante.
A un certo punto ha perfino colto in una contrazione del volto di Rosa, quel non so che di orientale che l’aveva colpito dal primo incontro.
Quando legge l’ultima frase si alza dalla sedia e rivolge alla ragazza la domanda che darà alla ragazza la possibilità di esercitare il diritto che spetta stipulato dal principio, l’inalienabile diritto di ogni lettore.
– E allora? Soddisfatta?
La bacheca
Cap.IX
Sulla Place de la Fontaine ci sono la Mairie, il café de la Mairie, L’Eglise de Sainte- Marie, e la libreria Adelfia. Qualsiasi cosa si voglia fare, dovunque si voglia andare, mare o montagna, che si abbia in testa di percorrere a piedi nudi la lunga spiaggia di Arona o rimanere in religioso silenzio sulle calanche rosse e chiedersi come fare per raggiungere la caletta che s’intravede, è da li che si deve passare. Franck ha approfittato della bella giornata per farsi accompagnare fin lassù da Rosa. La segue nei discorsi, nelle descrizioni e nelle storie che racconta molto più vive di quelle un po’ alla volta ricostruite attraverso i libri della biblioteca e le ricerche in rete. L’acqua è sicuramente l’elemento che domina ogni cosa. L’acqua e la pietra. Tanto più conosce meno sa Franck di quest’isola che gli avevano detto – perché l’aveva letto? Perché in Francia così si diceva di questa strana gente? Di tutti i popoli d’Europa gli isolani di Corsica sono i soli che siano nati per essere continuamente infelici. Eppure a Franck, per quanto cosciente del privilegio che gli era stato accordato per quel suo nuovo lavoro, i Corsi gli sembravano tutt’altro che infelici. Anarchici sicuramente, e altrettanto certamente consci della propria storia rivoluzionaria, memoria alimentata da elementi mitici capaci di tenere insieme giganti come Napoleone o bislacchi monarchi come lo fu Theodor Stephan von Neuhoff, detto anche Teodoro I di Corsica, che per nove mesi tentò in pieno settecento di liberare l’isola dal dominio dei genovesi. Un re improbabile pieno di debiti. Ma è l’acqua che affascina Franck più di ogni cosa e a un certo punto lo dice a Rosa che un’acqua così non l’aveva vista mai.
– L’ochji sò d’acqua- ribatte lei tenendosi un po’ distante dalla ringhiera a strapiombo sul mare come chi soffra di vertigini mentre Franck ci tiene i gomiti appoggiati mentre parla. È alto, molto più alto di lei e seppure abbia poco più che quarant’anni in realtà ne dimostra una trentina. Da quando le ha suonato l’indifférence ha un solo desiderio ed è che lui le insegni a suonarla.
– Cosa vuol dire?
– Che quel che vedono i nostri occhi non è infallibile
Franck si è voltato verso di lei quasi a contraddire quanto appena detto. Potrebbe essere sua figlia e Franck non ha figli. Potrebbe essere però un’amica importante e poiché di amici ne avrà bisogno per un anno, bisognava pur cominciare da qualche parte. Così girandosi verso di lei voleva solo dirle che a lei, lui credeva e che se questo era stato possibile lo si doveva di certo agli occhi di lei, per come sembravano dire più di quanto la parola potesse, ma anche i suoi che ne avevano indovinato la profondità.
Rosa si è fatta avanti tirando un bel respiro come di chi debba vincere una paura sottile del vuoto e indicandogli un punto imprecisato della spiaggia deserta gli dice:
– Lì, vedi, alla baia d’Arone, grazie a un sommergibile sbarcarono le armi per la Resistenza. 450 mitragliatrici e 60 000 cartucce.
– E come si chiamava ?
– Michel Bozzi
– No, chiedevo il sottomarino
– Casablanca
– Nulla in quest’isola è lasciato all’immaginazione
– E ancora non sa nulla
Quando sono ritornati nel pomeriggio in paese Franck non si aspettava di trovare un capannello di persone davanti alla bacheca esterna del municipio. Man mano che si avvicinava il presentimento che la cosa lo riguardasse sembrava dopo aver preso piede cominciato a battere in segno di vittoria. Il che non era affatto cosa nuova per Franck. Come tutti coloro che escono di rado dal silenzio, che non si lasciano erodere l’anima dal linguaggio, dalla voce, dal vento delle parole, anche lui s’era dotato d’una grammatica dell’ascolto e del sentire che lo aveva reso granitico nelle convinzioni premonizioni e che per lo più si rivelavano vere. Non aveva nemmeno attraversato la piazza che un paio di loro, fino a pochi minuti assorti nella lettura, di un comunicato? Un annuncio del sindaco? Lo avevano raggiunto per complimentarsi con lui.
Franck faceva finta di aver capito annuendo e tendendo la mano a chi protendendo la propria ne richiedeva la stretta. Solo quando il vice sindaco Vinciguerra quasi sottraendolo alla foga, per quanto benevolente dei suoi concittadini, lo prende sottobraccio, gli rivela l’arcano; di come avesse deciso in mattinata, poco dopo aver ricevuto il primo capitolo di stamparlo e affliggerlo in bacheca.
– Affliggermi?
– Affliggere? Ma no, cosa ha capito, affiggere, afficher, affissà a historia nant’à i muri.- aveva replicato facendosi una grassa risata
– E allora ?
Nel giro di poche ore per ben tre volte si era trovato davanti al muro di quella domanda. Chiunque abbia avuto l’occasione di fare qualcosa che non solo pretendesse un interlocutore, per sua natura, ma che dovesse a questi per forza piacere per onorare un contratto, sa bene quanto pesante possa essere quel tipo di domanda, pesantezza da cui soltanto la risposta insindacabile e positiva del committente poteva liberare. Il primo capitolo della sua storia, della storia di un’isola di cui non sapeva nulla, di cui non possedeva alcun ricordo o memoria poetica, cui non lo legava nulla, e di cui, ne era certo, mille altri avrebbero potuto molto meglio di lui dire, era piaciuta. Non poteva di certo sapere Franck se la decisione del vicesindaco di metterla in bacheca fosse legata a una sua incertezza, a un non sapere dire se quanto iniziato fosse nella giusta direzione, dunque prigioniero anche lui di un e allora? Oppure l’avesse messa proprio per dare lustro all’impresa che lui per primo aveva architettato per la città di Piana.
– Lo sa che nel nostro paese di Porcu e Ferro ne trova quanti ne vuole?- dice facendo riferimento ai due mercanti che s’erano venduti i ragazzini delle crociate al sultano
Sono entrati nel café de la Mairie e Franck non ha potuto rifiutare il moresque che gli è stato appena offerto. Per la prima volta si trova a faccia a faccia con lui. Ne scorge la barba ruvida, la pelle segnata dal sole come la frusta di vento fa con la sabbia senza farla sanguinare. Ne sente il tabacco delle emmeesse, inconfondibile come l’incenso in chiesa, e prova una profonda invidia per quelle mani che pesano il doppio delle sue anche se le dita agili quando stringono il baffo sinistro o accarezzano il bicchiere sembrano quelle di un pianista.
– Lo so, Vinciguerra, ma forse quello che nessuno sa è che questa è un’isola abitata da fanciulli. E aggiunge- fanciulli felici.
–



 di Pierangelo Schiera
di Pierangelo Schiera

 Due anni più tardi, da una diversa città nordeuropea, mi aggrego a una carovana di tekno traveler, incurante del fatto che potrei non trovare da tornare indietro in tempo per il mio volo. Ora, costoro possiedono effettivamente un soundsystem ma ben presto scopro che sono soprattutto dediti all’acquisto in stock di sostanze e alla rivendita delle medesime in occasione di teknival e feste varie. Salendo sul loro camion mi ritrovo a correre per le strade spoglie dell’est Europa, a schivare pattuglie sgarrupate e sonnolenti posti di blocco, a dormire in appartamenti occupati alla periferia di Tallinn, mi ritrovo un giorno nella casa del guardiano di uno zoo ceco.
Due anni più tardi, da una diversa città nordeuropea, mi aggrego a una carovana di tekno traveler, incurante del fatto che potrei non trovare da tornare indietro in tempo per il mio volo. Ora, costoro possiedono effettivamente un soundsystem ma ben presto scopro che sono soprattutto dediti all’acquisto in stock di sostanze e alla rivendita delle medesime in occasione di teknival e feste varie. Salendo sul loro camion mi ritrovo a correre per le strade spoglie dell’est Europa, a schivare pattuglie sgarrupate e sonnolenti posti di blocco, a dormire in appartamenti occupati alla periferia di Tallinn, mi ritrovo un giorno nella casa del guardiano di uno zoo ceco.