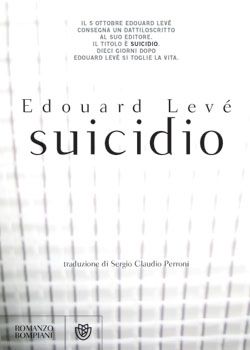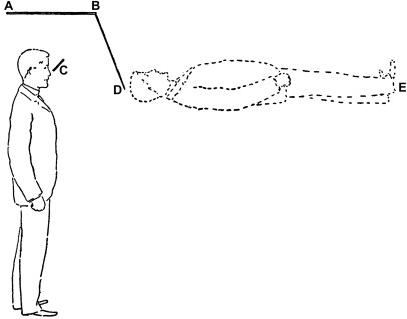Care lettrici, cari lettori,
dopo ore d’angoscia, abbiamo avuto conferma che stanno bene Andrea Inglese, Jamila Mascat, Giacomo Sartori, Silvia Contarini, Francesco Forlani, Ornella Tajani, Giuseppe Schillaci – i membri di Nazione Indiana che vivono o gravitano su Parigi.
Vive la liberté, égalité, fraternité!
Il rabdomante e il tribunale
di Nicola Fanizza
Vitantonio Ruggeri era un individuo oltremodo stravagante, era un folle particolare, un matto che diceva il vero. La madre, piccola di statura, era una donna colta e intelligente, aveva studiato e sapeva declinare a memoria tutti gli articoli del codice civile. Uno sviluppo esteriore modesto caratterizzava anche il figlio, il quale aveva ereditato dalla madre la mania per la lettura. A differenza di quest’ultima, però, non rivolgeva la sua attenzione al passato, bensì al presente. Era attento alla vita, era attento a tutto ciò che resisteva alla morte, ai flussi di energia che animavano le forze in campo, agli equilibri instabili e coglieva in ogni attimo il non ancora. Ogni istante per lui conteneva una sorta di potenza, una potenza che non si esauriva mai completamente nell’atto.
Ruggeri si guadagnava da vivere facendo il rabdomante. Si era accorto di avere la capacità di avvertire la presenza dell’acqua nel sottosuolo allorquando, improvvisamente, sentì una scossa proveniente dal basso. Raccontò questo episodio a suo padre, il quale lo invitò a individuare una vena d’acqua nel fondo di famiglia.
L’aspirante rabdomante impugnò i lembi laterali di un ramo d’ulivo che aveva la forma di Y e attraversò per diversi giorni in lungo e in largo il podere di circa tre ettari. Si fermò solo quando si convinse di aver trovato il punto in cui aveva avvertito più volte un flusso di energia che aveva spostato la bacchetta verso l’alto. Si dice, però, che in quell’occasione non doveva essere molto convinto di aver trovato l’acqua, poiché invitò suo padre a reiterare l’esperimento. Il padre impugnò la bacchetta biforcuta …, ma asserì di non aver avvertito alcun flusso di energia. Nondimeno quest’ultimo di lì a poco si convincerà che Vitantonio era un autentico rabdomante. Fece scavare il pozzo proprio nel punto che gli era stato indicato dal figlio e trovò una ricca vena d’acqua.
E’ accaduto allo scrivente di riflettere non tanto sulle presunte doti dei rabdomanti, quanto sui luoghi che essi indicavano per scavare i pozzi. Ebbene, questi luoghi si trovavano sempre a monte e mai a mare: ossia sempre nella parte più alta dei poderi e giammai nella parte bassa. I rabdomanti sceglievano tale punto poiché era congeniale per l’irrigazione del fondo medesimo. Dalla cisterna, alimentata dalle norie e coestensiva al pozzo, l’acqua poteva arrivare, attraverso appositi canali, in qualsiasi parte del terreno!
Allo stesso modo in cui fiutava la presenza dell’acqua, Ruggeri prefigurava gli eventi che in un futuro più o meno prossimo avrebbero riguardato il suo Paese. E quando ciò accadeva, avvertiva l’esigenza e, insieme, l’obbligo di dire il vero agli altri. Tuttavia Ruggeri viveva in un mondo che da tempo aveva consumato la sua rottura con la verità del discorso profetico. Si esprimeva con delle oscure profezie che la sua città – Mola – non era disposta a recepire. Per i molesi non aveva che parole di sdegno e ricorreva nei loro riguardi allo scherno e all’invettiva. Diceva che non credevano alle sue profezie, avevano la capa tosta, erano troppo sensibili alle sirene del potere di turno.
Dal suo fascicolo personale* – conservato presso il Casellario politico centrale –, apprendiamo che tre mesi dopo l’entrata del nostro Paese nella seconda guerra mondiale, Ruggeri andava dicendo in giro che l’Italia avrebbe perso la guerra e profetizzava la fine del fascismo. Per di più nella notte del 12 ottobre 1940 scrisse sulla fontana monumentale, che signoreggia al centro della piazza del paese, alcune frasi disfattiste e denigratorie nei confronti del regime fascista.
Sulla scorta delle soffiate dei delatori, il giorno dopo Ruggeri fu arrestato. I dirigenti dell’Ovra di Bari si resero subito conto che non ci sarebbe stato bisogno di una perizia per sincerarsi in merito alla sua fragilità mentale. Ciò nondimeno, nascondendo la sua pazzia, lo denunciarono al Tribunale speciale per difesa dello Stato per «disfattismo politico», ossia con l’accusa di «aver tracciato iscrizioni antinazionali e disfattiste su una fontana pubblica».
Tre mesi dopo si tenne a Roma il processo a suo carico, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il reato di cui Ruggeri era stato accusato era oltremodo grave, poiché prevedeva molti anni di carcere. Nondimeno il tribunale accolse solo in parte le richieste dell’accusa. Ecco qui di seguito il dispositivo argomentativo della sentenza: «Il Tribunale, in considerazione della menomata responsabilità dell’imputato (…) dimostrata da attestazioni mediche e da testimonianze a discarico, ha ritenuto – accogliendo la richiesta del P. M. – che nelle circostanze del fatto si integrassero gli estremi del reato meno grave di propaganda sovversiva, applicando il minimo della pena in mesi sei di reclusione». Di fatto quel Tribunale fu più crudele dell’Ovra poiché, pur non nascondendo la follia dell’imputato, lo ritenne comunque colpevole di un reato minore.
Il giorno dopo la sua condanna, Ruggeri chiese di poter tenere la corrispondenza con i suoi genitori e solo a partire dal mese successivo gli fu consentito lo scambio epistolare. Il Nulla Osta fu concesso solo quando le autorità di polizia appurarono che i suoi genitori erano «di buona condotta morale e politica, immuni da precedenti pendenze penali, di razza ariana e di religione cattolica». Questi ultimi cercarono in tutti i modi di ottenere le libertà del loro figlio e in questo senso si attivarono per rivolgere un’istanza di grazia al Tribunale speciale. Ma il 30 marzo 1941 il Ministero degli Interni respinse l’istanza di grazia in merito alla residua pena, tenendo presenti sia le «risultanze degli atti» sia il «parere contrario concordemente espresso dall’Autorità di P. S. e dall’Arma dei Carabinieri Reali».
Le dinamiche che portarono all’arresto e alla successiva condanna del Ruggeri le troviamo ottant’anni prima anche nella rivolta che ebbe luogo a Bronte nell’agosto del 1860, dopo lo sbarco dei Mille in Sicilia. Una jacquerie che Giovanni Verga ricostruisce, insieme alla successiva repressione, nella novella Libertà, mettendo in atto, però, una vera e propria mistificazione letteraria.
Ecco il passo della novella da cui questo particolare vien fuori: «Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che gliene fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono». Abbiamo messo in corsivo il nano: poiché è questo il punto.
Qui lo scrittore siciliano trasforma il matto, fatto fucilare da Nino Bixio dopo un processo sommario, in un ridicolo nano. Leonardo Sciascia dice che Verga non voleva turbare la sensibilità del lettore scrivendo «il pazzo»; e scrisse «il nano», dissimulando così in una «minorazione fisica la minorazione mentale». Eppure Verga sapeva benissimo che non si trattava di un nano ma di un pazzo: il pazzo del paese, un innocuo pazzo colpevole di aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto tricolore profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura ai galantuomini e la fine del regime borbonico. I delatori lo avevano denunciato, proprio perché era un folle, era il più debole e, pertanto, correvano meno rischi.
Le motivazioni che spinsero i delatori a denunciare «il nano» sono – come abbiamo già visto – in larga parte identiche a quelle che porteranno ottant’anni dopo a promuovere l’arresto e poi la condanna del Ruggeri. In ambedue i casi ci troviamo di fronte alla medesima mistificazione messa in atto nei confronti del folle che dice il vero e, insieme, nei confronti di chi è più debole.
Ciò che sappiamo con certezza è che, dopo la fine della guerra, nessuno chiese conto ai giudici del Tribunale speciale in merito alle loro nefaste sentenze. Sappiamo altresì che uno di quei giudici, Gaetano Azzariti, che era stato Presidente del tribunale della razza, divenne nel 1957, addirittura, Presidente della Corte costituzionale.
I delatori che avevano denunciato Ruggeri continuarono a spiare i potenziali sovversivi non più per conto delle istituzioni fasciste, bensì per conto delle istituzioni repubblicane.
Per quel che riguarda Ruggeri, sappiamo che, dopo aver scontato la pena, tornò nel suo paese. Negli anni successivi – finita la guerra e caduto il regime fascista – continuava a rammaricarsi per il fatto che, benché dicesse il vero, nessuno credeva alle sue profezie!
* Vedi Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, Ruggeri Vitantonio, busta 4488.
Ieri & Oggi. 1992.
di Michele Fianco
[inediti, da: La Confezione]
forse quell’angolo maledetto
tra la parete che rientra le
tue intensità dove la sco
pa non passa, non passa proprio o
una misurazione altra al
tre orologerie la lampa
da spenta che spegne anche me la
lampada accesa che accende
anche me o sugli autobus che
mi vanno verso di te poi tor
nano indietro poi di nuovo
intanto che provo la profondi
tà di un pensiero almeno set
te/otto centimetri sotto il
livello del mare a isola
re a spostare la composizio
chimica del tempo la rea
zione il reagente (a propo
sito di me reagente di te)
e mi fa allergia la marea
la teoria memorìa e un lun
go discorso d’amore che si af
faccia sul mare (una frazione
di secondo appena) e si al
larga la macchia del tempo e re
sta qualche riferimento sparso
una voce esaurita dagli
anni un cuore il cuore un cuo
re che si stempia e tracce d’affet
to fin nelle urine e la geo
grafia dei gesti che si ri
compone e ininterrotta vo
ce e la luce rotta una voce
per voce solipsista e si ac
cende e si spegne dentro l’impianto nervo
so dei nervi la terra la fret
ta la terra riorìgina ri
mugina rinvàgina non esi
ste non è questo non è terra e
fuoriuscirsi è forse più fa
cile oppure non so da uno
spiffero di luce che batte il
tempo che a proposito di tem
po non batte più sul ticchettìo
regolare delle ore si spac
ca un silenzio si scopre l’ulti
mo nervo quello matto che parla
urla gratta la gola che ninna
nanna bestemmia dentro i passi […]
[continua, continua, ma non poteva, / non poteva tutto ora. Si ferma.]
Pasolini, ragazzo a vita
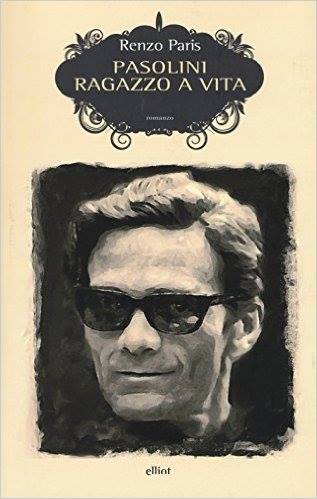 di Gianfranco Franchi
di Gianfranco Franchi
Pasolini è diventato un totem, nelle patrie lettere. È uno dei due totem della vecchia Scuola Romana: oggi, forse, è diventato più carismatico e influente di quanto fosse mai stato in vita; tanto che forse ha finito per surclassare il totem primo, Moravia. Il professor Renzo Paris, l’irrequieto cane sciolto dei sessantottini, è sempre stato il biografo, e per certi aspetti l’irrisolto erede, del totem Moravia: un Moravia sentito come una figura paterna a rovescio, sentito come una misura di grandezza inconciliabile con certi aspetti del nostro tempo. Adesso, simbolicamente e direi inaspettatamente, Paris si mette a raccontare Pasolini: succede nel memoir Pasolini ragazzo a vita (Elliot, 2015), un libro di ricordi, di meditazioni, di evocazioni negromantiche e di pellegrinaggi laici, una restituzione di atmosfere rivoluzionarie studentesche e borghesone e borgatare romanesche, un saluto al totem pasoliniano che non sconfina nell’agiografia e non rimastica il pettegolezzo, non sprofonda nella paranoia e tendenzialmente non cede ai nostalgismi. Cosa s’è ricordato di ricordarci, Renzo Paris? Che non dobbiamo dimenticare che c’è qualcosa di Pier Paolo Pasolini che continua a fare spavento, e che dobbiamo sforzarci di tenere presente, quando rileggiamo i suoi versi, i suoi scritti corsari, i suoi romanzi giovanili, il suo incompiuto Petrolio. Non è soltanto la sua morte truculenta, maturata in un contesto allucinante, per dinamiche perverse: è la sua doppia anima, quella che il totem odierno sta finendo per oscurare e rinnegare, è il Pasolini notturno, aggressivo, prepotente, violento, quello che probabilmente aveva sconcertato il giovane poeta Dario Bellezza per il suo estremismo. Quello che probabilmente non aveva nessuna intenzione di essere raccontato o riconosciuto pubblicamente. Ma proprio nessuna. “Hai presente San Sebastiano, crivellato di frecce? Ecco, Pier Paolo oscilla tra la croce e le frecce”, spiegava Bellezza a Paris, prendendo una certa distanza dal suo mentore. L’adorato cugino Nico Naldini aveva parlato chiaro nel suo “Come non ci si difende dai ricordi”: “Da tempo Pasolini aveva adottato il sadomasochismo anche con rituali feticistici: le corde per farsi legare e così immobilizzato in una sorta di scena sacrificale farsi percuotere fino allo svenimento. Non ne aveva mai fatto mistero, sia nelle ultime poesie, sia in quelle giovanili dove si era raffigurato come Cristo-giovinetta nel martirio della Croce”. Oscillava tra la croce e le frecce. Oscillava.
“Io qui sto parlando di un uomo che, se era estetizzante e un po’ dannunziano nell’opera, nella vita era tutto il contrario, spaccato in due, il borghese diurno e l’amante notturno, travestito da borgataro, ‘ragazzo a vita’” – scrive Paris. Il borghese è il Pasolini cittadino, letterato di chiara fama e ripetuti scandali, incontrato da Paris nel 1966, quando lui era ventiduenne e il poeta friulano aveva più del doppio della sua età. “Non che il borgataro dei romanzi ‘Ragazzi di vita’ e ‘Una vita violenta’ non mi interessi. Mi piaceva di quei libri l’atteggiamento materno del narratore in terza persona, nei confronti dei suoi ragazzini”. Il Pasolini borghese aveva impressionato Renzo Paris per via dei suoi ripetuti silenzi, della sua esibita estraneità. “Di Pasolini ce n’erano almeno due, quello amicale e socievole della teppa di borgata e quello silenzioso dei salotti borghesi. Bellezza sosteneva che il salotto era l’ambiente borghese dove Pier Paolo recitava la parte dell’intellettuale, del poeta, del cineasta, del critico, dove, in giacca e cravatta, non si sarebbe permesso mai di uscire fuori dal seminato. Meglio tacere il vero pensiero che gli passava per la testa. E infatti tutti a esclamare: ‘Ma com’è dolce e buono Pier Paolo, parla poco e niente e invece…’. Tutt’altra cosa era Pasolini quando lasciava gli amici artisti e correva a cercare le marchette di Termini. E qui Dario rideva di gusto. ‘Quando lo vedo compunto a casa delle Madame Verdurin romane e poi lo confronto con l’omosessuale in azione, mi confondo e penso che sono due persone diverse, diversissime. La madre non dorme più, tutte le mattine lo aspetta, guardando se ha i segni delle botte sul corpo, le macchie di sangue sulla camicia”. Forse il totem sta oscillando. È questo che la nostra epoca trova difficile da decifrare, da accettare, da metabolizzare: questa schizzata ambiguità, questo comportamento autodistruttivo, questa metamorfosi etica ed estetica. Questa segreta cattiveria: si può dire che Pasolini menava? Si può accettare come idea che un poeta fosse così aggressivo e rude? Si può pensare che, come altrove ripete Bellezza, con i figli del popolo fosse, in quelle sue nottate feroci, “pedagogo alla rovescia”? Quando ero molto giovane – sono nato comunque tre anni dopo la morte del poeta Pier Paolo, e la sua assenza, a via Fonteiana e dintorni, si sentiva forte, lancinante, irrisolta – ho potuto parlare con qualcuno degli ex ragazzi di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, per domandare perché di Pasolini mi sembrava non si potesse parlare troppo, nel quartiere, o comunque perché si faticava tanto a riconoscergli quella grandezza che certi suoi versi e tanti suoi scritti critici chiaramente raccontano. La risposta di quasi tutti loro, a parte uno, era nervosa, qualche volte proprio parecchio rabbiosa, molto simile, in certi accenti e per certi aspetti, ma con molta meno educazione, a quella che il poeta Dario Bellezza dava, negli anni Settanta, a Renzo Paris. Io questa cosa non sono mai riuscito compiutamente a metterla a fuoco. Non l’ho mai trovata possibile, non aveva linearità. La accetto, o meglio ne ho preso atto, ma non la capisco. “Pasolini ragazzo a vita” va spesso a sbattere addosso a questa risposta qui, come una falena su una lanterna: senza nessun intento di profanazione, senza nessun giudizio morale, si capisce, perché anzi questo libro è, sin dall’incipit, non soltanto un atto di profonda amicizia e di memoria, ma un’evocazione negromantica: Paris va sulla tomba del poeta, nel suo adorato Friuli, a Casarsa, e sulla tomba trova segni e simboli di chi cerca di richiamare alla vita uno spettro. È uno spettro carismatico, ma molto più complesso e contraddittorio di quello che potevamo sospettare. È un ricordo autentico, durissimo.
“La memoria è tutto, mi dico” – scrive Paris. “Ma ci sono nomi che non mi vengono in mente nemmeno sotto tortura. Ed era gente con cui ho passato diversi anni della mia vita, gente con cui ho condiviso le lotte. Quando incontro uno di loro in transito nel mio quartiere, svicolo. Poi mi accorgo però che anche quello sembra svicolare. Forse è dovuto all’idea dell’immortalità, di cui ci si nutre in gioventù. Con la vecchiaia quell’idea si frantuma e dunque crolla anche il nome di chi doveva rimanere eterno. Da bambini la vita era una pagina bianca tutta ancora da scrivere. Da vecchi quella pagina, tutta scritta, si cancella a poco a poco”.
Cos’altro c’è di notevole in “Pasolini ragazzo a vita”? C’è un discreto coraggio nello schierarsi, a distanza di tempo, con la stessa ostinazione e la stessa naturalezza, da certe parti. Ci si schiera con gli studenti contro tutto, ci si schiera con Nuovi Argomenti contro il Gruppo 63, ci si schiera a fianco di Laura Betti nonostante tutto (e soprattutto, nonostante “Qualcosa di scritto”, lettura che Paris tiene ben presente), ci si schiera contro Pasolini per la sua tirata reazionaria di Valle Giulia, ci si schiera contro i fascismi e contro i fascisti di ogni ordine e grado, con il lessico d’antan; ci si schiera contro la nostra epoca che sta trasformando il poeta Pier Paolo in un’icona pop, ridotta a due battute o giù di lì, a un amuleto, a un passepartout. Ci si schiera contro la degradazione della memoria, contro la corruzione della memoria. Ci si schiera contro l’ipocrisia di non ammettere che certi comportamenti erotici pasoliniani, certe sue amicizie ragazzine, oggi sarebbero considerate disastrose. Ci si schiera contro le semplificazioni cretine di intelligenze tanto complesse, e contraddittorie.
E ogni tanto, a disorientarci parecchio, appare il Totem. “Lui non fumava neppure le sigarette, e io mi chiedevo come faceva a scrivere e filmare così tanto, senza una spinta. Elsa Morante si imbottiva di psicofarmaci, invece, per scrivere. Pasolini era, come Moravia, un igienista e un salutista di vecchio stampo. Voleva scandalizzare con le sue opere. La sua musa non lo abbandonò mai, neppure per un istante. Scriveva versi di getto, poi quelli che pensava di pubblicare li riscriveva più volte. Le sue gloriose terzine, con il passare del tempo, erano diventate pura prosa, come nella migliore tradizione del secondo Novecento. E la prosa era sempre più legata al diario delle emozioni provate nei suoi continui viaggi all’estero. Titolava ‘Comunicati all’Ansa’ i versi del suo diario di viaggio. Voleva sporcare di prosa la sua poesia, fino a renderla irriconoscibile, voleva renderla ‘pratica’”. Così.
C’è un’ultima cosa che vorrei riferire. Questo libro è così profondo, come scavo nella memoria e sondaggio nell’inconscio, che finisce per restituire frammenti intensissimi del movimento studentesco che fu; c’è una scena in cui Paris racconta di una biglia, scagliata dai neofascisti, che gli spacca gli occhiali, poco prima un banco ha spaccato la schiena a qualcuno, c’è nell’aria una normalità della violenza, delle ferite e della morte che sconcerta, c’è un freddo da guerra civile che per la mia generazione è irragionevole, mai sperimentato. Ma qualcosa è successo anche a me, mentre leggevo certe scene e ritrovavo certe considerazioni di Paris, certi strascichi polemici e così via. Ho rivisto papà. Mio padre, caro Paris, aveva praticamente la tua età, era del 1945. Si chiamava Sergio Franchi, studiava Filosofia alla Sapienza, aveva gli occhiali, somigliava a Mastroianni, si definiva vigliacco praticante ma aveva le sue idee. Nella sua adolescenza, e in giovinezza, era comunista. Era sessantottino, era dalla tua parte. Probabile che vi siate conosciuti. Leggendo il tuo libro, a un tratto, mentre pensavo al sangue – perché questo libro è pieno di sangue – mi sono ricordato una scena di quando ero ragazzino, tredici anni. Papà stava nel suo studio, un pomeriggio, circondato da buste e bustoni. Stava buttando via un sacco di cose. “Papà, che fai?” “Lascia stare”. “Dimmi che stai facendo”. “Non voglio, non è il caso”. “Cosa fai?” “Butto via cose che tu non devi vedere, cose che non dovrai mai trovare. E le butto adesso, che ancora non capisci”. “E che cose sono?” “Sono le cose del mio Sessantotto. Lettere. Giornali. Ritagli. Cazzi miei. Cose che tanto tu non potrai mai capire”. “Aspetta, dai…”. “Lascia stare. Non ti immischiare. Non ti riguarderanno mai. Tu non puoi capire”. C’ero rimasto male, me n’ero andato dietro la porta e ogni tanto tornavo a controllare cosa faceva. Smaniava, sbuffava, fumava come un turco e buttava via di tutto. Ricordo però un bastone nero che si apriva e aveva una strana punta acuminata. Ricordo un’agenda con su scritto “1968” con diverse macchie di sangue sulla copertina. Non ricordo altro. Non ho potuto guardare quelle carte. Non ho potuto aprirle, non mi ci sono mai potuto confrontare, di certe cose mio padre, Sergio, non ha mai voluto parlare. Non s’è mai laureato in Filosofia, la Sapienza la considerava un luogo di sventura, invecchiando è diventato borghese, ha lavorato per un accordo storico tra Democrazia Cristiana e comunisti, è stato sindacalista tutta la vita. Quanta complessità, quanto riserbo, quanti silenzi. Quanti rimpianti. Quanto sangue.
Filippo Tuena racconta i «Memoriali sul caso Schumann»

Esce oggi Memoriali sul caso Schumann (il Saggiatore), il nuovo libro di Filippo Tuena. Ne pubblico un estratto per gentile concessione dell’editore. Lo precede una Lettera sullo stato del romanzo inviata dall’autore.
***
LETTERA SULLO STATO DEL ROMANZO
Filippo Tuena
Caro Davide,
la scorsa estate facemmo una chiacchierata al bar della Casa del Cinema a Roma a proposito dello stato del nostro modo d’intendere la parola romanzo. Fu una conversazione teorica, basata su quel che bolliva in pentola, sulla nostra officina privata. A quattro mesi di distanza la teoria è diventata pratica e il mio ‘Memoriali sul caso Schumann’ (il Saggiatore) è in libreria. Dunque torno sull’argomento, perché questo libro è strettamente legato a quei discorsi da caffè che facemmo allora.
Parafrasando Dürrennmatt, ‘Memoriali’ è il mio requiem per il romanzo, inteso come l’ho inteso io negli ultimi quindici anni di lavoro. Chiude il discorso iniziato con ‘La grande ombra’ e proseguito, via via, con ‘Le variazioni Reinach’, ‘Ultimo parallelo’ e ‘Stranieri alla terra’. Ovvero una meditazione sulla narrativa biografica, e la ricostruzione – attraverso i meccanismi della narrazione e lo stile – di figure storiche ed eventi reali. Dopo la follia di Schumann, che qui si rappresenta, non credo che affronterò più questo genere di narrativa. Altre cose mi premono, più personali, autobiografiche, minimali. Dunque con questo libro termino un periodo lungo e, per quel che mi riguarda, fecondo. Ma lo chiudo perché credo d’aver toccato la radice del problema. E, proprio per questo motivo, il libro è molto più feroce e spietato di altri che ho scritto.
‘Memoriali’ è il mio requiem per il romanzo,
inteso come l’ho inteso io negli ultimi quindici anni
In queste pagine si dà voce a sei testimoni del precipizio nel quale scivolò Robert Schumann negli ultimi anni di vita. Come al solito ho lavorato su documenti, testimonianze dirette, ascolti musicali. Credo d’esser andato vicino alla soluzione, d’averla sfiorata, forse inconsapevolmente, forse con determinazione ma, appunto, l’ho sfiorata. Mi accorgo, a fatica terminata, sfogliando il libro fresco di stampa, che neppure le sei voci trovano la soluzione al quesito: perché Schumann si rinchiuse nella follia, e di chi era la responsabilità di quell’evento. In realtà queste voci non trovano comunicazione in alcun modo. Falliscono le situazioni affettive, falliscono le soluzioni artistiche, mancano il bersaglio anche quelle più fantastiche.
Senza rendermene conto mi sono affidato a personaggi che manifestano un’impossibilità affettiva, imperfezioni fisiche e caratteriali o, si potrebbe altrettanto bene dire, il meccanismo affabulatorio ha preteso voci balbettanti, per il ruolo di testimoni.
Questi personaggi imperfetti, incompiuti, reticenti – per impossibilità più che per volontà – informano, comunicano, forniscono al lettore le coordinate, ma non mettono la parola fine alla questione. Né dal punto di vista stilistico, né da quello storico. In breve, focalizzano il problema ma manifestano la loro impotenza.
Da dove nasce questa impotenza? Me lo son chiesto mentre lavoravo all’ultimo memoriale del libro, quello che attribuisco a un Johannes Brahms senile che, seguendo le teorie del suo medico curante, Joseph Breuer, prova a dar libero corso ai suoi ricordi, ai suoi rimorsi. L’ho scritto praticamente di getto e mi sono accorto che era in questo scrivere per associazioni che il libro trovava la sua conclusione formale e una soluzione inaspettata, ancorché parziale. E’ stato lo svolgersi della scrittura a offrirmi uno spiraglio, non la schematicità del genere romanzo.
Del romanzo tradizionale ho rinunciato agli orpelli – in questo libro c’è un solo luogo descritto più volte: il giardino del manicomio di Endenich; pochissimi discorsi diretti; e invece un frequente ricorso al genere epistolare e diaristico o al soliloquio. Dunque, è in questa direzione che sto andando, poiché mi sembra più sincera, più diretta, più efficace. L’estensore di un epistolario conosce perfettamente il destinatario dei suoi scritti. Sa quali sono i suoi punti deboli, sa come colpire, sa come blandire. Il diario o il soliloquio – chiamalo se vuoi monologo interiore – riguardano esclusivamente colui che scrive o che bisbiglia. Rinunciano a spiegare, chiudono la comunicazione col mondo esterno. In cambio, si può procedere nelle profondità. Il lettore può inserirsi in queste pagine, può osservare, ma spesso deve ammettere la propria impotenza quando si parla di cose a lui ignote. Percepisce l’accadere di eventi ‘altri’ ma ne è irrimediabilmente escluso.
Così accade sovente allo scrivente di rendersi conto che non scrive per il lettore ma per il rispetto della pagina, non altro. E quella pagina deve contenere solo quel che serve, non mai tutto quel che lo scrivente sa. Diceva Voltaire – cito a memoria – ‘Vuoi annoiare qualcuno? Raccontagli tutto.’
Il lettore che legge i diari, i memoriali, gli epistolari qui ricostruiti si trova sempre a margine. Nulla gli è veramente spiegato. Ma può ricostruire la sua versione dei fatti, mettendosi in gioco, beninteso.
Questa narrativa procede per sottrazioni; anzi, trae persino origine dalle sottrazioni. In alcuni casi è sottrazione anche dalla sintassi, dal bel periodare. Nei ‘Memoriali’ ce ne sono diversi esempi.
Ora si potrebbe obiettare: se il risultato è non arrivare alla soluzione, hai sbagliato. L’architettura che hai messo su non consente né ai personaggi, né al lettore di soddisfare la propria ricerca di verità.
E se invece fosse proprio questo l’obiettivo finale della scrittura:
NON arrivare alla verità?
Dissento. E se invece fosse proprio questo l’obiettivo finale della scrittura: NON arrivare alla verità e questo libro lo dimostrasse? Che la presa d’atto dell’impotenza e del fallimento fosse una splendida vittoria? La mia formazione di storico d’arte mi porta ad accettare anche questo come un risultato positivo. Ammetto che una soluzione del genere mi appagherebbe, vedrebbe soddisfatte le mie aspirazioni di narratore e magari dimostrerebbe che le privazioni che mi sono imposto nella stesura del libro conducono più in profondità lettore, personaggi ed autore. Toccano il nocciolo della questione.
Tempo fa, in un’altra chiacchierata, pubblica questa, mi venne spontaneo affermare che ‘lo scrittore è uno che rompe le cose’. Più specificatamente, ‘che rompe il romanzo’; più specificatamente ancora, ‘che accosta tra loro i frammenti del romanzo nel quale s’è imbattuto’. Insomma: è uno che spacca le cose per vedere come son fatte e poi racconta questo romperle e cercare di rimetterle assieme.
Ripeto, a cose fatte, mi accorgo che è successo questo. Ed è per questo motivo che il libro termina con uno sberleffo, rivolto a me, più che agli altri artefici della vicenda.
Sarà il lettore a dissentire o condividere la mia analisi, ma con tali premesse è evidente che ‘Memoriali sul caso Schumann’ porta alle conclusioni la mia riflessione sulla scrittura narrativa. Non sul mio scrivere.
Stai bene. Grazie dell’ospitalità.
Filippo
***

MEMORIALI SUL CASO SCHUMANN
Johannes Brahms
Carissima signorina Leser,
da tempo ricevo lettere appassionate che mi chiedono informazioni circa la triste stagione di Düsseldorf, il mio incontro con Schumann, la reciproca esaltazione e il suo precipizio nella palude orrenda della malattia.
Per molti anni ho conservato gelosamente la memoria di quel tempo, condividendola con l’amatissima Clara e, anche dietro suo suggerimento, ho sempre mantenuto la più grande riservatezza. Ora vedo che quei giorni tornano prepotentemente alla superficie e, nonostante i miei sforzi, finiranno per emergere particolari che preferirei rimanessero nascosti. Il corso degli eventi va in una direzione opposta ai miei desideri e temo grandemente che quei tristi casi saranno maneggiati in maniera impropria da chi volesse immergervisi.
Il vostro memoriale – che mi è giunto pochi giorni dopo il mio rientro qui a Vienna – e la circostanza della malattia di Clara (che soffrirebbe terribilmente del riacutizzarsi di quella ferita) mi convincono a recedere infine dal mio intento di riservatezza e a stilare per voi la mia versione dei fatti. Che essa corrisponda alla verità non so. Ma il mio punto di vista, voi lo sapete, è quanto di più vicino agli eventi, e preferisco svelare segreti per mio conto piuttosto che lasciare siano altri ad arrogarsi questo diritto formulando illazioni o, peggio, pettegolezzi.
Mi trovo in una stagione dell’esistenza nella quale ho smesso di creare e penso piuttosto a correggere gli errori della vita che ho vissuto e della musica che ho composto. Quelli della vita mi sembrano ormai definitivi, privi di possibilità di appello. E dunque esercito il rimorso o poco di più, ed è un contrappasso terribile. Ma la musica ancora mi concede qualche possibilità. Questo desiderio si esplica soprattutto nel particolare, mi verrebbe da dire. Mai più grandi composizioni, mi sono imposto. Mai più orchestre ricche di suono. La voce umana e pochi strumenti. Miro a questo. Se fossi uno scrittore passerei il mio tempo a spostar virgole nelle molte pagine che ho scritto. E anche questa lettera – che presumo sarà lunga – sarà soltanto un migliorare la punteggiatura o, musicalmente, un mettere a posto accidenti e annotazioni di uno spartito assai complesso che è già stato quasi del tutto scritto. Non ho più la forza per esercitarmi con le strutture articolate. Non sopporterei il cimento. E, come dicevo, agli errori commessi, a quelli fatali e definitivi – se si tratta di errori e non di obbedienza al Fato –, non è possibile porre rimedio.
È strano. Sto facendo come lui. Comincio a dedicarmi agli altri. Ho piacere a rendere felici le persone che hanno talento. E cerco di farlo senza commettere errori, quegli errori che hanno segnato il suo tramonto. E forse contagiato anche la mia vanagloria. Ma la gioventù è spietata. Me ne accorgo ora. C’è così tanta energia e a volte è mal indirizzata. Correggo questa stortura, ma quel che è fatto è fatto. Non posso porvi rimedio, voi comprendete? Posso solo spiegare a me, e a voi, quel che è accaduto.
Vi avessi incontrato in questi anni forse avrei avuto il coraggio di dirvelo a voce. Ora mi trovo costretto a scrivere, a mettere in bella il flusso dei pensieri e dei ricordi. Ed è cosa dolorosa, immagino lo sappiate.
Ecco, poco sopra ho appena sfiorato l’ombra cupa sotto la quale vi scrivo. La malattia di Clara. Lo sapete, è il colpo apoplettico che l’ha ferita poche settimane fa e che, dati gli strapazzi della sua vita, le sofferenze e le ansie e i lutti, difficilmente riuscirà a superare. È nell’anticamera della morte. Non posso non accennarvi, anche se m’ero ripromesso di non parlarne, di non scriverne, tanto è il dolore che m’accompagna costantemente. Ma forse proprio per questa consuetudine costante è riapparso qui, dove l’argomento è piuttosto Robert o, meglio ancora, io visto da Robert o, se volete, Robert visto da me. Ma è certo che da qualunque parte la osserviate, la questione fu nelle mani di Clara. Fu lei a disporre i contendenti – perché uso questa parola agonistica? Molto s’è detto circa la sua apparente fuga dalle responsabilità. L’aver abbandonato Robert, l’aver abbandonato Ludwig, l’aver sovente lasciato i figli per seguire le sue tournée, i suoi impegni musicali. Posso assicurarvi che ha sofferto questi abbandoni in maniera terribile: non voleva nascondere il viso alle difficoltà, ma pensava di poter essere di maggior aiuto altrove che non accanto a loro. Ha esercitato una dolorosa volontà; credo abbia percepito il suo affetto come pernicioso e s’è risolta a tante privazioni per non aumentare il peso degli addii che inesorabilmente avrebbe dovuto affrontare, procurando dolore a sé e ai suoi cari. Altrettanta inflessibilità ha mantenuto nel silenzio circa i suoi casi più dolorosi – e voi l’avete sperimentato anche di recente.
Uno degli ultimi atti che ha compiuto è stato quello di distruggere. Mi riferisco agli ultimi brani per violoncello e pianoforte composti da Robert. Io li ho letti. E ne ho parlato a lungo con lei. Per certi versi concordo con la sua decisione, per altri me ne rammarico. È musica disarticolata. Priva di eleganza, sprezzante, violenta. Ma che altra musica avrebbe potuto scrivere nelle condizioni in cui si trovava, sull’orlo del baratro nel quale precipitò? So che Clara avrebbe voluto stracciare anche il concerto per violino scritto per Joachim, (nel secondo movimento appariva, seppur brevemente, quel tema) ma la partitura era nelle mani del violinista e Joachim, per quanto richiesto, s’è sempre rifiutato di consegnarla. So che non ha mai eseguito in pubblico quel concerto – salvo le due esecuzioni che fece allora per gli Schumann – ma dubito che lo distruggerà. Manterrà l’impegno che s’è preso con lei – ero presente io stesso – nel non eseguirlo, ma non lo distruggerà. Parlai della questione più recentemente con lei e con la figlia Eugenie, e Clara fu categorica: il concerto non dovrà mai essere pubblicato. Tuttavia è probabile che prima o poi qualche filologo finirà per riesumarlo. Forse per i nostri anni e per il nostro senso dell’equilibrio è un concerto irrisolto, ma non dubito che nel tempo a venire troverà la sua giustificazione e che gli ascoltatori del futuro sapranno apprezzarlo.
E poi, alla mia età e con la mia esperienza comincio a credere che un artista giunto a un certo punto del proprio percorso debba anche considerare l’opportunità di mandare in frantumi la bella forma. Anche soltanto per arrivare al cospetto del problema, alla sua radice. Non sto forse facendo lo stesso in queste righe? Vorrei portare in superficie il meccanismo che ha annientato il nostro amico e posso farlo soltanto rompendo la maschera che lo nasconde. Foss’anche la mia.
Anteprima Sud Anni Ottanta: Ingo Schulze
Sono molto lieto di condividere, in anteprima, con i lettori di Nazione Indiana il bellissimo testo di Ingo Schulze, magnificamente tradotto da Stefano Zangrando, dedicato alla caduta del muro di Berlino e che si potrà leggere sul numero di Sud in uscita il 15 Novembre. A settant’anni dalla prima uscita della storica rivista fondata da Pasquale Prunas e a cui parteciparono Anna Maria Ortese, Luigi Compagnone, Raffaele La Capria, Francesco Rosi, Gianni Scognamiglio e tanti altri giovanissimi intellettuali, il nostro numero extra sarà dedicato agli anni Ottanta e a Renata Prunas (ma non glielo abbiamo ancora detto) che ci ha permesso di mantenere ben teso le fil rouge che ci unisce a quell’esperienza. effeffe ps Le fotografie che accompagnano il testo sono di Rino Bianchi (sx) e Philippe Schlienger (dx). La mise en page è di Marco De Luca.
Viviamo di rimozione
di
Ingo Schulze
traduzione di Stefano Zangrando
Dov’ero il 9 novembre 1989: è la domanda che mi fanno più spesso. Di regola chi me la pone assume un’espressione gioiosa, come se in quel modo procurasse un piacere anche a me. In questa data, infatti, si possono combinare felicemente, chiamandole in causa entrambe, la dimensione personale e quella storica. Quando io poi ammetto che quella sera d’autunno andai a letto presto e che perciò posso solo dire: «Quando mi svegliai, il muro non c’era più», la delusione è palpabile.
Alle domande ulteriori mi piace rispondere che il vero crollo del muro era già avvenuto con l’apertura dei confini ungheresi il 10 settembre. E che ovviamente il crollo del Muro di Berlino mi sorprese, certo, e ovviamente mi fece piacere, come potrebbe essere altrimenti? Tuttavia, quando di lì a poco vidi la gente in coda davanti all’«Ufficio circondariale della polizia popolare» per ottenere il timbro che autorizzava a visitare legalmente l’Ovest, mi preoccupai: se adesso vanno tutti nell’Ovest, chi verrà più alle nostre manifestazioni di piazza?
Ma perché sono diventato così recalcitrante a parlare del 9 novembre? Forse perché non ho nulla da raccontare? Perché nell’Ovest ci andai per la prima volta solo alla fine di novembre di quell’anno? O perché c’erano cose più importanti?
Il crollo del Muro è senza dubbio una cesura storica. Nella memoria ufficiale esso copre e domina l’intero autunno 1989 e persino gli altri 9 novembre, quelli del 1938 e del 1918. Il crollo del Muro appare così chiaro e inequivocabile! Le persone si riversarono da Est a Ovest, dalla dittatura verso la libertà. E si sa bene in cosa sfociarono i cambiamenti. Sottinteso: doveva andare così. E ancora: così si è voluto.
Per me il crollo del Muro fu un evento eclatante fra altri. E non ebbe niente, assolutamente niente a che fare con considerazioni di tipo nazionale. Un cammino comune, addirittura un’unificazione di Repubblica Democratica e Repubblica Federale? E come? Ridicolo!
Preferirei di gran lunga che mi si chiedesse del 9 ottobre. Non soltanto perché in quel caso avrei qualcosa da raccontare. Ma già a questo punto bisogna spiegare: il 9 ottobre fu il giorno in cui forse si decise tutto, quel primo lunedì dopo il 40° anniversario della DDR (il 7 ottobre), quando gli ospiti di Stato se n’erano ormai andati e su Lipsia incombeva la minaccia di una «soluzione cinese». Nonostante i tentativi di intimidazione, 70.000 persone manifestarono per le strade del centro. Per la prima volta non c’erano agenti in uniforme a bloccare il percorso e far disperdere i dimostranti. E per la prima volta fu percorso per intero l’anello intorno al centro cittadino. Solo a partire dal 9 ottobre fu messo in pratica da entrambe le parti l’imperativo «Niente violenza!». Anche se a uno non venivano in mente le parole di Goethe – «Da qui e oggi comincia una nuova epoca della storia del mondo e voi potete dire di esserci stati» – tuttavia quella che si provava era una sensazione di questo tipo. Qualunque cosa fosse successa, avremmo potuto competere con il 17 giugno 1953.
Già il lunedì 2 ottobre, quando i pochi striscioni erano ancora piccoli, così da poter essere arrotolati e portati sotto la giacca per poi passare di mano in mano sopra le teste, girava il motto Visafrei bis Shanghai!, «senza visto fino a Shanghai». Fin dall’inizio si trattava del mondo intero! E dell’ammissione del Neues Forum e dei nuovi partiti sulla scena politica, e dell’accesso ai media, e di libere elezioni, e soprattutto di democratizzare il proprio mondo. Il motto decisivo era: «Noi siamo il popolo!». Si trattava davvero di riprendersi in mano il paese. In fabbriche, scuole, università, in teatri e istituti si iniziò a eleggere in posizioni direttive coloro che godevano della fiducia della maggioranza. Era questa la vera rivoluzione. Chi ci avrebbe più fermato? Giorno dopo giorno la realizzazione di un «socialismo dal volto umano» sembrava sempre più inevitabile.
Delle manifestazioni di Lipsia, questo atto di sovranità, ci sono pochissime immagini, e queste poche sono scure, confuse e per nulla spettacolari. Proprio come le immagini della Tavola rotonda in Polonia o delle riforme in Ungheria. Le immagini dei rifugiati nelle ambasciate della Repubblica Federale o della gente che balla sul Muro, invece, le conoscono tutti.
Passando oggi in automobile davanti al Museo Storico Tedesco di Berlino, si vede la copia di un manifesto assai tardo, che mostra i contorni delle due Germanie assieme allo slogan: «Noi siamo un popolo».
Non ricordo con precisione quando questo motto, scritto in origine su un adesivo della CDU occidentale, sia penetrato nelle manifestazioni, ma fu nelle prime settimane dopo il crollo del Muro. L’espressione «un popolo» era fatta per revocare la dichiarazione di sovranità e con ciò la stessa rivoluzione. «Noi siamo il popolo» contro «Noi siamo un popolo». Non che uno abbia sostituito l’altro, fu invece una lotta fra i due per prevalere nelle manifestazioni. E il museo mostra il vincitore.
Nella settimana che precedette le elezioni del 18 marzo 1990, Helmut Kohl batté la Germania orientale in un’instancabile tournée elettorale. La sua mossa vincente fu quella di stringersi al cuore la CDU orientale, che era completamente caduta in discredito: se votate lei, votate me. Eccola, la traccia di melassa occidentale. Il suo successo fu strepitoso, la nostra sconfitta assoluta. 2,9% al Neues Forum, 48% all’alleanza elettorale messa in piedi da Kohl, di cui ben il 40,6% ai Blockflöte della CDU, ossia i «flauti dolci», com’erano chiamati i cosiddetti «partiti di blocco» o alleati del partito maggiore nella Repubblica Democratica. Adesso era chiaro in quale direzione si sarebbe andati. La maggioranza aveva deciso. Non era quello che avevo sempre voluto?
Nel febbraio 1990 avevo fondato con degli amici un foglio settimanale che accompagnasse la democratizzazione del Paese (ognuno al proprio posto). Scrivevamo ancora, con gran rombo di grancassa, che, se proprio non si fosse ottenuta un’autonomia, si sarebbe almeno giunti a un’unificazione dei due stati, e non all’adesione di uno all’altro. Sarebbe stata anche un’occasione per l’Ovest, che avrebbe così potuto riformare il proprio sistema. Ma anche questo rimase fuori discussione. Quel che aveva fatto l’Ovest era giusto, quel che aveva fatto l’Est era sbagliato. E da allora in poi si sarebbe fatto soltanto quel che era giusto. Potevamo star contenti di aver superato lo scoglio dell’unificazione monetaria senza dover dichiarare fallimento come tutte le grandi aziende della città di Altenburg. Un anno dopo il magnifico autunno, il nostro giornale lottava per la sopravvivenza. Invece di battermi per la democrazia o per il «diritto al lavoro» che si era estinto con l’adesione alla Repubblica federale, presto mi ritrovai a bazzicare soltanto nuovi mobilifici e concessionarie d’automobili. Dovevo infatti cercare di soppiantare la cosiddetta concorrenza, gli altri giornali e fogli commerciali che sgomitavano come noi per pubblicare annunci, e che avevano persino assunto la nostra segretaria e quindi possedevano il nostro portafoglio clienti, mentre noi sentivamo la mancanza sia dell’una che dell’altro. Li odiavo tutti, quei «concorrenti», perché puntavano a minare la nostra esistenza professionale, anzi la nostra esistenza tout court – come noi la loro. Nell’autunno 1989 avevo fatto esperienza di come rivendicazione e prassi potessero combinarsi. Si trattava, come ho detto, del volto umano della società, quindi della dignità di noi tutti, di un mondo migliore. Ma che aspetto aveva il mio volto, adesso? Deformato dalla rabbia? In preda al panico? Perplesso? Braccato? Quel che facevo giorno dopo giorno non era forse contrario a ciò che ritenevo buono e giusto? Mi ero mai contorto davanti a un funzionario come facevo adesso davanti al proprietario del più grande mobilificio della regione?
Parlare e scrivere di questo mi sembra necessario soprattutto perché, in seguito al 1989, sono sorte in tutto il mondo nuove condizioni che consideriamo ovvie, naturali, e che forgiano il nostro presente. E siccome le consideriamo naturali non ne parliamo più, le diamo per scontate, come se le cose non fossero mai state diverse. È naturale che debba esserci crescita (ormai perfino il fatturato stimato nel contrabbando di droga e sigarette viene conteggiato all’interno del PIL), è naturale che i ricavi nell’economia privata siano l’ultima ratio. Non conta ciò di cui vi è bisogno, ciò che rende possibile una sopravvivenza ecologica, economica, sociale ed etica. Se il 60% della devastazione ambientale causata dagli svizzeri avviene all’estero (e nel caso dei germanici non sarà molto diverso), questo significa che viviamo di rimozione nel vero senso della parola. Ormai è praticamente impossibile andare a far spese per una settimana senza commettere una qualche porcheria che, se ne fossimo immediatamente consapevoli, ci farebbe orrore. Solo le cifre virtuali e le entità dei capitali finanziari sono completamente inaudite, e quindi assurde. E benché abbiano perduto da un pezzo qualsivoglia copertura reale, l’imperativo del continuo incremento esponenziale che le contraddistingue continua a decidere delle buone e cattive sorti dell’umanità.
Per molto tempo fui convinto di poter parlare con fiera convinzione goethiana del 1989 e delle sue conseguenze. Oggi però sento molto più affini l’incertezza e la confusione del giovane Fabrizio del Dongo, protagonista della Certosa di Parma di Stendhal, che aggirandosi sul campo di battaglia di Waterloo chiede: «Ho veramente partecipato a una battaglia?». Poiché solo oggi, un po’ alla volta, inizio a comprendere ciò che hanno provocato i mutamenti di allora.
cinque testi da “elsamatta”
di Alessandra Carnaroli
(IkonaLíber, collana Syn, 2015:
http://www.ikona.net/alessandra-carnaroli-elsamatta/)
quarant’anni fa a mia zia rosella
gli ha tirato un sasso o una pietra non ricordo
gli ha rotto il labbro la guancia il vestito bello
lei ancora c’ha il segno
l’elsa matta a lei non gli è rimasto niente
c’ha la memoria corta la gonna
che è corta strana nocome una che lo fa per
bellezza ma proprio
cosí
è un dettaglio dei matti
se ti squadra
se gli viene il nervoso hai fatto
meglio che fuggi
Appunti per una replica al trattatello
Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui, quello di Andrea Inglese qui, quello di Michele Zaffarano qui, quello di Italo Testa qui.
di Massimiliano Manganelli
Caro Andrea,
ho letto il tuo «brevissimo trattatello» e mi è venuta voglia di replicare; perciò ti invio alcuni appunti sparsi, altrettanto brevi.
Andrea Tarabbia, «Il giardino delle mosche»
di Antonella Falco
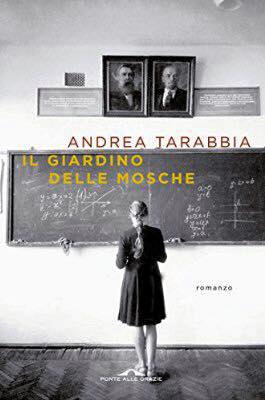
Raccontare l’orrore dal punto di vista del mostro. Entrare nella sua testa, scandagliare le sue pulsioni più profonde e indicibili, ripercorrere a ritroso la sua vita, i traumi e le umiliazioni subiti, compiere un viaggio all’origine delle sue ossessioni, sforzarsi di guardare il mondo con i suoi occhi. Non per giustificare le sue efferatezze, ma perché il male riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso, e perché il compito della vera grande letteratura non è quello di fornire visioni edulcorate e consolatorie del reale ma quello di focalizzare l’attenzione sulle zone d’ombra, sul lato oscuro dell’essere umano, sulla sua capacità di essere al tempo stesso una creatura che, come afferma Pico della Mirandola, partecipa sia della natura dei bruti che di quella degli dèi. E ancora perché la letteratura deve fare i conti con la complessità, le sfumature, le contraddizioni dell’essere umano, e deve essere disturbante nella misura in cui ci costringe a prendere atto che la suddivisione manichea in buoni totalmente buoni e cattivi totalmente cattivi, in neri da una parte e bianchi dall’altra, non trova riscontro nella realtà e che l’uomo è al contrario un amalgama di grigi, un groviglio inestricabile di chiaroscuri. Ragion per cui il mostro non è un alieno ma l’uomo della porta accanto, anzi, potenzialmente, quello che abita nei nostri vestiti.
È questo ciò che tenta di fare Andrea Tarabbia (già autore de Il demone a Beslan, dove ha toccato punte altissime di perizia narrativa e di pathos) nel suo nuovo libro, Il giardino delle mosche. Vita di Andrej Čicatilo, pubblicato da Ponte alle Grazie: un romanzo che ha tutte le carte in regola per poter essere definito un capolavoro. A ben vedere i due romanzi sono strettamente imparentati non solo per la qualità della scrittura ma anche perché formano un vero e proprio dittico sulle vicende che hanno segnato la storia russa del Novecento e dei primi anni Duemila e sul male che gli uomini possono fare ad altri uomini. Il demone a Beslan, infatti, ricostruisce la strage avvenuta nella scuola di Beslan, in Ossezia, ad opera di un commando di separatisti ceceni (la mattina del 1 settembre 2004 un commando di 32 terroristi ceceni entra nella scuola n. 1 di Beslan, dov’è in corso l’inaugurazione dell’anno scolastico, e prende in ostaggio 1.200 persone. Oltre agli allievi quel giorno sono presenti anche i loro genitori e altri parenti. Dopo tre giorni le forze speciali russe fanno irruzione nella scuola. Il bilancio finale è di 334 vittime, molte delle quali bambini) attraverso il racconto dell’unico terrorista sopravvissuto. Il giardino delle mosche racconta invece la storia di Andrej Čicatilo, il cosiddetto Mostro di Rostov, un serial killer che tra il 1978 e il 1990 commise cinquantasei omicidi. Le vittime, dopo essere state adescate, venivano torturate, stuprate, mutilate, e in alcuni casi Čicatilo mangiava piccole parti del loro corpo. Il libro è il resoconto romanzato della confessione che Čicatilo rilasciò alle autorità russe che lo arrestarono nel novembre del 1990 per poi eseguirne la condanna a morte il 14 febbraio del 1994.
La narrazione è suddivisa in tre parti, nella prima, intitolata La morte per fame (1936-1978), Čicatilo racconta l’infanzia durante gli anni della seconda guerra mondiale – quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica – le privazioni, le violenze perpetrate dagli invasori nazisti, il rapporto con la madre, avara di gesti affettuosi e sempre pronta a punirlo in modo severo e a umiliarlo pubblicamente per i frequenti episodi di enuresi notturna, il ricordo del padre che tornato a casa dopo la fine della guerra e la prigionia nei campi nazisti viene bollato come vigliacco e collaborazionista (era questa, nella Russia di Stalin, la sorte dei prigionieri sopravvissuti), il fantasma (fin qui solo metaforico) del fratellino maggiore ucciso e mangiato dai vicini di casa durante la grande carestia dei primi anni Trenta. Questa sezione si chiude con il suo primo omicidio, quello di una bambina di nove anni della quale Čicatilo vuole abusare e che uccide quasi “per sbaglio”. È però questo il momento in cui l’uomo, da sempre impotente, scopre che uccidere gli procura la più intensa eccitazione sessuale della sua vita. La seconda parte si intitola Dissoluzione (1978- 1990) e in essa Čicatilo ripercorre i suoi innumerevoli omicidi e, soprattutto, espone le deliranti ragioni che lo hanno mosso e che lo hanno indotto ad autoproclamarsi «dio della carne» delle sue vittime. L’ultima sezione, Il supplizio e la festa (1990-1994), è invece raccontata dal punto di vista di Issa Magomedovič Kostoev, l’ispettore che lo ha arrestato, dopo avergli a lungo dato la caccia, e ne ha raccolto la confessione.
Čicatilo uccide spinto da due grandi ossessioni. La prima è il sesso, o meglio l’umiliazione che prova a causa della propria impotenza, che chiama «la mia più grande mutilazione». Solo uccidendo riesce a sublimare l’atto sessuale che non è in grado di compiere e a esercitare il ruolo di dominio che nella vita quotidiana gli è negato: «Un uomo è completo quando dà la vita e quando dà la morte: solo così un uomo è un uomo. Io, nonostante la mia debolezza, avevo avuto due figli. Ma mi era sempre mancata la morte. Mi era sempre mancata e adesso ce l’avevo: ce l’avevo! Avevo il più grande dei poteri! Avevo la morte!»
L’altra ossessione è legata alla sua incrollabile fede nel Comunismo e in tutto ciò che l’Unione Sovietica, specie quella di matrice stalinista, ha rappresentato. Proprio per questo si sente investito di una “missione”: ripulire la società di tutti quegli elementi deviati (prostitute, vagabondi, emarginati, sbandati) la cui stessa esistenza rappresenta il fallimento della grande Idea comunista, il sintomo di una dissoluzione imminente che avrebbe travolto l’utopia del socialismo reale.
Čicatilo sente che la propria vita è collegata a quella del Paese, e lo scrive a chiare lettere nella domanda di grazia inviata al presidente El’cin il 18 luglio del 1992. Pertanto attraverso la sua storia si può raccontare la storia dell’URSS dagli anni della seconda guerra mondiale fino al suo epilogo, nei primi anni Novanta, col tramonto del socialismo reale e l’affiorare delle grandi contraddizioni che attraversavano carsicamente l’Unione. Emblematico di tutto ciò è un capitolo che si colloca quasi a metà del libro (posizione non casuale) e racconta di un sogno fatto da Čicatilo il quale nottetempo viene condotto da Konstantin Ustinovič Černenko, segretario del Partito Comunista, all’interno del Mausoleo di Lenin. Qui, «nell’unico posto di Mosca dove nessuno li può sentire», Černenko confida a Čicatilo i suoi timori circa il futuro dell’URSS: la sempre più probabile ascesa al potere di Gorbačëv e con lui l’avvento dell’economia di mercato, la fine della censura, l’inizio della democrazia, ossia di qualcosa a cui nessun cittadino dell’Unione Sovietica è abituato, qualcosa che nessuno, nemmeno chi è più anziano, conosce. È una riflessione sul ruolo di coesione che il comunismo ha svolto nei territori dell’Unione dopo la fine del potere degli zar. Senza il comunismo tutto è destinato a disgregarsi, il Paese andrà allo sbando. Il corpo spolpato e rinsecchito del Padre della Patria, che «vestito sembra integro a tutti gli effetti», rivela nella sua nudità – che Černenko mostra a Čicatilo – un inquietante sentore di decomposizione incipiente. «Stanno spolpando la nostra Unione Sovietica, compagno […] ci trattano come trattano la mummia del nostro Padre più grande. Presto non rimarrà più nulla!», dice Černenko, ed esorta Čicatilo a «continuare la sua opera […], a tenere pulita l’Unione…»
È il vaneggiamento estremo di Čicatilo, la sublimazione della sua impotenza in un farneticante delirio di onnipotenza che travalica la componente sessuale e si trasfonde nella sfera politica. È qui che la ricostruzione della biografia di Čicatilo diviene metafora sociale, politica e storica di un’intera epoca: il fallimento esistenziale di un uomo assurge così a simbolo del fallimento di un Paese, di una ideologia, di un progetto politico che aveva dato l’illusione di poter dominare il mondo. Un’operazione che riesce magistralmente all’autore, ma non bisogna dimenticare che l’intento principale di Tarabbia è un altro, ossia, come si è detto, la riflessione sul Male che si annida nell’uomo. In questo contesto assume rilevanza la figura di Issa Magomedovič Kostoev, l’ispettore che incarna a tutti gli effetti il doppio di Andrej Čicatilo: anch’egli ha alle spalle vicende personali dolorose che si intrecciano con la storia russa, e anch’egli, per il lavoro che svolge, ha la possibilità di disporre della vita e della morte di altre persone. Ma questo non gli dà l’ebbrezza del potere bensì un senso dolente della legge e del tempo in cui si trova a vivere: quello del crepuscolo di un’Idea alla quale anch’egli, come Čicatilo, aveva appassionatamente aderito.
Kostoev, almeno il Kostoev letterario che Tarabbia ci restituisce, è un funzionario che non può fare a meno di interrogarsi sul proprio ruolo, sulla legittimità del potere e della legge di cui si trova, volente o nolente, ad essere esecutore. È lui, nel suo fare da contraltare alla figura di Čicatilo, a farsi portatore di un’istanza di umanità. Čicatilo è l’uomo che ha deciso di essere «dio della carne» per le sue vittime, colui che dice di sé «io sono l’indice e il pollice che schiacciano la mosca». Kostoev è invece l’uomo che dopo aver catturato il mostro, e dopo che questi è stato condannato a morte, si china davanti a lui, un attimo prima che la condanna venga eseguita, e gli sfila le scarpe, accogliendo l’estrema richiesta del condannato. «È questo che deve fare un dio: lavare i piedi», è il fantasma di Stepan (il fratellino di Čicatilo ucciso e mangiato dai vicini durante la carestia) a dirlo nel corso del romanzo, è Čicatilo che lo sussurra adesso, in punto di morte. Forse come ringraziamento. Forse perché nell’estremo momento della sua vita ha capito. Forse perché un postremo germe di pentimento è balenato nella mente del mostro. Non possiamo saperlo. Il libro si chiude su questo interrogativo. Lasciandoci il dubbio, lasciandoci pieni di domande su Čicatilo, che sono poi domande su noi stessi, sulla nostra natura, sul male e sul bene che siamo capaci di compiere. Tarabbia non dà risposte. Forse perché, come tutti, non le possiede. Forse perché il compito della letteratura – e dei bravi scrittori – non è quello di dispensare certezze ma di instillare dubbi e suscitare quesiti. Di spronare alla riflessione, sempre.
Materiale d’importazione ~ da DUDE MAG
di Eric Lundgren
Il database dell’editore deve essere vecchio di decenni, perché mi hanno chiamato in ufficio.
«Abbiamo un manoscritto», hanno detto.
«Naturalmente», ho risposto. «Ne avrete sì, ne avete sempre».
«Ci serve una prefazione. Possiamo farle avere un manoscritto con le macchie di caffè originali».
M’interessava, purtroppo.
«La mia prefazione sarà fuorviante», ho avvisato.
«Lo sappiamo», ha risposto l’editore. «Sappiamo tutto di lei».
Da “L’OSPEDALE”
di Maddalena Vaglio Tanet
1.
L’accettazione
Sedute con le mani in grembo
le ginocchia strette, i capelli raccolti
nel vestibolo di un ospedale americano,
noi insieme diffidenti l’una verso le altre
e loro di più ancora: Niente paura
signore ossa, I is on your side.
Nel giardino di Saint John due uccelli,
gazze a giudicare dalla coda,
si contendono qualcosa, la nebbia
gonfia il cielo tra i margini dei tetti,
violagrigia, macchiata di rosa in certi punti
(ossidi forse, polveri).
Amsterdam Avenue tira una riga
dritta fino al fiume, sul fondo
si sono accesi i fari,
bianchi e rossi si slargano, bagnati.
Il condizionatore soffia piano sulla faccia,
aspettiamo ancora ostili, ferme
tra il tavolino e il davanzale,
ma non può durare e presto
stiamo come bambine
con le ginocchia sbucciate, chine
sul nido di sterpi e fili d’erba impastati
dove dorme la piccola bestia pelosa
nel bozzolo precario del suo calore.
4.
Ci guardiamo. Qualcuno svia gli occhi
a lato, ci sono gli ingorgati,
i lattiginosi, i salmodianti. Una alla fine
tiene in bocca pezzi di ghiaccio
per dissetarsi. Non succhia, li spinge
uno alla volta appena contro il palato.
Con gli altri, i gentili e gli arrabbiati,
ci diciamo: nemmeno io sono venuto
per restare su questo giaciglio
che è un palcoscenico e un ripostiglio.
6.
Fa buio intanto, la terra è scura e quando
nella stanza è difficile vedere,
le ombre crescono come strani fiori
si allungano dagli steli delle cose
e sui muri e il pavimento pendono
le loro grandi corolle spaventose,
finalmente preme sul cuore l’idea
del mondo ulteriore, quello che ci seguirà.
C’è chi si abbandona, chi ringhioso si ritrae,
chi salva tutto: le vergogne dell’infanzia,
distese di mais da qualche parte,
un arcobaleno liquefatto in rivoli di nafta
vicino alla carcassa di un furgone,
prugne come grosse uova bluastre
appese al picciolo striminzito.
Passano stagioni intere, anni,
dalle narici dilatate, dallo sguardo
che diserta la stanza, punta la finestra
A debita distanza
Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui, quello di Andrea Inglese qui, quello di Michele Zaffarano qui.
di Italo Testa
Dicono che l’asserzione sia il gioco linguistico centrale. Forse non l’essenza del linguaggio. Forse il linguaggio è fatto di molti quartieri. Ma l’asserzione, il gioco degli enunciati dichiarativi, tenderebbe a occupare il centro di questo spazio. E la poesia, o quell’insieme di pratiche che chiamiamo poesia, sarebbe inevitabilmente assertoria. E così i poeti. Apofantici. Come tutti.
Édouard Levé, Suicidio
di Francesca Fiorletta
Dire che tu ballassi non sarebbe esatto. Anche quando la musica ti avvolgeva, trascinando i corpi nel vortice del ritmo, non riusciva a penetrarti. Accennavi qualche passo, ma più che ballare era mimare il ballo. Ballavi da solo. Quando uno sguardo incrociava il tuo, sorridevi come chi viene sorpreso in una situazione assurda. 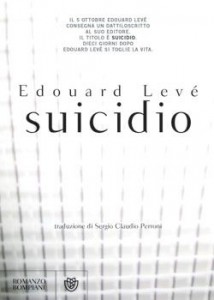
Questo è un libro che mima il suicidio, e che lo anticipa. Un libro che non racconta semplicemente, ma che è, esso stesso, una situazione assurda.
( fotografie di E. S. Curtis ) e altri inediti
di Simone M. Bonin
Goldenrod Meadows – Piegan 1911
Una ti squadra la fronte con gli occhi, l’altra
ti avvolge la guancia, chiede “Che ci guardi a fare con quella macchina?”
Avranno sì e no quindici o sedici anni e i volti di chi cresce in fretta.
Parlano una lentezza che non mi appartiene più.
Stringono mazzi di foglie di tabacco dentro i palmi e la pelle
è dello stesso colore dell’erba secca.
Sono rughe delle grandi pianure, rese gialle
dal frantumarsi dei giorni – 1911 dice l’insegna-
Pikani, Piedi Neri il nome di quelle genti, e senza
un nome queste donne
parlano di esistenza e mi fissano gli occhi ora e mi dicono
parole tanto grandi che tutto ciò che sono oggi
non basta a tenere il passo dei loro sguardi.
Nunivak – Nunivak Island, Alaska, 1928
Quando il giorno tramonta
cade tra le acque dell’Alaska e la notte è un parka
che scende pesante e ti avvolge fino alla testa.
Lo sguardo si alza e trapunge la faccia
che la palpebra stringe stretta
e quel poco di corpo che sbuca
racimola l’aria e prega
inarcando le labbra, credo, parla.
Lodge Interior – Piegan – 1911
E se tanto ci tiene distanti tanto si stende
annegato di terra e polpa di tuberi e stracci
intatto ai nostri occhi
il reale si scopre senza più vesti e vedo quanto
è visto ai vostri occhi
che senza mai vesti il reale scopre
nomi e ricordi tra resti di fiori e stracci rotti

( Timisoara – Romania )
I
Un mattone dopo l’altro, fra guance ungheresi
e ciglia moldave – pelli di croste di pane – un mattone
dopo l’altro, a coprire e scoprire il passato
quando elefanti di Ferro aprono il fango
e lingue latine si scontrano
con gli ultimi rimasugli dell’inverno
II
Intagli di Sole su garze di duro cotone
avvolgono il capo di vecchie donne con gli occhi gialli e le gonne
a fiori ]
E alle spalle di case squamate, di pietre austriache e vetrine sporche,
fiori di neve rompono l’estate.
III
Più ti scrivo e più le vedo quelle folle il dicembre dell’89
a esplodere virali nelle piazze / mento in alto contro palle di cannone/
“fai veloce a dire le preghiere” / “mangia il pane” /
e fra le dita gridaci il tuo nome trapungilo di AMEN / pelle
a scaglie che si toglie / l’occhio
è fibra muscolare / racimolo memorie dentro folders / colpi
di esistenza sulle case /
IV
Una donna dipinta di fumo
si affretta distratta con gli occhi
a ritmiche cieche di Majakovskij.
Tra i tavoli storti
il cielo è un foglio privo di versi.
*
Tutti i testi di Simone M. Bonin sono inediti. Le fotografie sono di Edward S. Curtis.
Do you remember Marilyn?
Quando registrammo la Marilyn di PPP con Laura Betti
di
Luigi Cinque
La generale di “Una disperata vitalità” di PPP era già iniziata. La prima sensazione, quando entrai in teatro, camminando nel buio lungo la parete, fu la precisione con cui Laura, tra versi e canzoni, attraversava il testo. Era in scena da sola, coraggiosamente obesa, tirata, livida, sotto quegli occhi e il nasino dispettoso da bambolotta. Tre quattro persone in platea con il regista Mario Martone. Rimango in piedi.
Che Laura fosse soprattutto la sua voce, lo sapevo già. L’avevo conosciuta, dal vivo, molti anni prima, frequentando alla Sapienza un corso di cinema e letteratura tenuto da PPP. In una delle quattro straordinarie lezioni lei era venuta a leggere e cantare dei versi. Lo stesso PPP ne aveva esaltato le doti di interprete. Ma provo lo stesso fastidio di allora quando esibisce quella risata sguaiata romanesca da straniera, da emiliana, un po’ forzata, in quel suo cantare certe volte alla maniera della Ferri cogliendone solo ingenuamente il verso senza andare al profondo della tuttità romana, di quell’insieme inimitabile di“altoalto e bassobasso” che è la canzone popolare ebreo/romanesca. Ora avrei voluto dirle: – “guarda che “la Toppa” o lo sai cantà o non la sai cantà! Inutile che ce fai… e poi te manca la periferia, che voi capì dar salotto de nonna ( così Laura chiamava Moravia, me lo aveva detto Carmen sua organizzatrice dello spettacolo e nostra comune amica ).
Mi siedo in platea. In terza fila a destra del palco. Lei è un tutt’uno con quel leggìo ancora troppo alto, e grande, da direttore d’orchestra, e l’insieme, da giù, con le sbavature di luci ancora da sistemare, dà l’idea di una botte scura al centro del palco con sopra una faccia e i capelli annodati in un ciuffo in su che “facevano pensare allo spruzzo di una balena o al pennacchio di un ananas psicotico” ( sto citando a memoria il particolare dal bel romanzo di Emanuele Trevi “Qualcosa di scritto”). Sono previste le riprese televisive. L’aiutoregista – le chiede, in una pausa, se si terrà così i capelli o magari avrà un cappellino di qualche colore. – “ No tesoro…proprio così…biondo mignotta… “ – gli risponde dal palco, e si morde sul labbro una risata infame. Laura non lo sopporta, mi dice Carmen. E guai a cadere nelle sue grinfie. Poteva essere terribile. Sapevo anche questo. Riprende a provare.
Nel canto, meglio ancora, nel recitarcantato, nello sprechgesang, la sua voce, giocava in casa, aveva un’intonazione naturalmente perfetta. Sembrava esserci nata in quell’ espressionismo popolare. Riempiva la parola di straordinarie microintonazioni. Nessuna ansia dello scorrere del tempo musicale. Le bastava parlare per esserci, in musica s’intende. Respirare per prendere il tempo. Le grandi voci sono grandi per questo, perché danno l’idea di parlare mentre cantano e modulano.
Laura con la sua voce, rauca, fumosa, budellare, gelida, razionalBrecthiana, mirava direttamente al cuore e questo era anche dovuto al fatto che – avrei dedotto più tardi – era perfettamente – “cattivamente” – onesta con se stessa e con gli altri. La voce recitarcantante non perdona. E’ un elemento di rilevazione primario. Ti espone. Non ti permette di fare alcuna poesia, racconto, canzone, senza un rapporto risolto con te stesso, quantomeno con la tua di verità. Non giudica. Ti fotografa e stampa fuori come una vecchia Polaroid. Se l’anima esiste è certamente nel suono della voce. I civilissimi aborigeni australiani – quelli che inventavano il boomerang quando noi eravamo alla ben più terrena e violenta ruota – sostengono che se fai perfettamente il verso di una rana o altro animale sei quell’animale.
Comunque nel nostro caso non c’era bisogno di cercare chissà quale animale. Laura era laura perché faceva la voce di Laura. Per questo comunicava quel senso di precisione. Tranne, ripeto, per quell’accentazzo romanesco che assumeva in alcune canzoni e che la rendevano ridicola; che, come diceva PPP, la inchiodavano “ alla qualità di fossile con la sua maschera inalterabile di pupattola bionda…a mostrare il sadismo di una provinciale che giunta al Centro dove abitano gli idoli si traveste goffamente da nativa per mitizzarli, profanarli e dissacrarli meglio”.
A metà della filata Laura si ferma. Ha bisogno di una pausa. La segretaria di produzione annuncia a tutti i trenta minuti. Carmen mi accompagna nel camerino. Dobbiamo accordarci per la Marilyn di PPP da musicare e registrare per una compilation di canzoni pasoliniane in occasione del ventennale del suo assassinio.
Si sta cambiando abito. Faticosamente. Ci fa entrare. Ha un problema con il vestito. L’elastico, credo. Guardo altrove. Scruto un palazzo antico che si vede dalla finestrella. Alla fine si accende una sigaretta e mi dice – “ciao”.
Credo che con lei valesse una specie di energia animale immediata per cui: o come se ci si fosse sempre conosciuti oppure…oppure niente. Detestava qualsiasi tipo di presentazione. Nel caso, poteva reagire anche male. Mi accoglie come uno che conosceva. Non so. Fu molto gentile con me. Una questione di odori oppure che la musica la intimidiva. Ovviamente non ci fu modo di parlare del lavoro. Avrei capito a breve che non ne voleva sapere. Restammo d’accordo che con Carmen saremmo passati da lei in via di Montoro vicino Campo de Fiori. Faccio per uscire. “ Pierpaolo amava molto questa poesia “ – mi dice. Già, Pierpaolo. C’è una sottile linea di confine a Roma oltre la quale puoi ancora trovare quelli che parlano del poeta chiamandolo Pierpaolo e non Pasolini. Dacia, Piera, i Citti, Ninetto e qualcun altro. Nel tempo mi è capitato di incontrarli. Di sentirli che lo chiamavano così. Segnavano un appartenenza. Un codice. Ma Laura quel nome lo pronunciava in un modo “più” speciale. Assoluto. Primitivo. Infantile. Esclusivo.
Due giorni dopo mi presentai a casa sua. In via di Montoro, Campo de Fiori. Avevo preparato uno schema. Un primo aleatorio nel quale accogliere il testo e la voce a suo piacere. Dovevo solo verificare con lei un paio di appuntamenti sonori, del tipo: incontrarci tutti al riff e fare insieme quel pezzo di melodia in quattro che avevo pensato. Ho con me nello zaino una tastierina giocattolo. Tanto per non dover cantare. E pure il sax, il soprano. Non c’è l’ascensore o non lo trovo. Faccio le scale a piedi. Appena arrivato, sulla porta, Carmen mi chiede sorridendo: Sai fare le iniezioni?. Beh, Si! – dico. Entra in scena Laura, non mi saluta, ha una vestaglia da basso impero Mogul, fiori blù su fondo rosa. Mi dice: – non sarai una fighetta che s’impressiona e sviene? –
Mi indica una busta di plastica poggiata sullo sgabello. Dentro due siringhe e una dose di pennicillina gigante. Mi lavo le mani. Preparo il tutto. Siamo ancora nell’ingresso. Ho la siringa pronta in mano e lo zaino ancora in spalla. Confesso subito che non mi viene bene a fare le iniezioni in piedi. Preferisco il paziente sdraiato. Laura si avvia verso una stanzetta con un letto singolo. – Perfetto – dico –… e se poi abbassi un po’…”
Lei si stende e mi dice serissima: non è che me te voi fà…?” La pugnalo con la siringa.
Passiamo la serata di giugno in terrazza. Mi piaceva moltissimo quella terrazza, così non tanto grande. Fuori da ogni sguardo. Siamo a un centinaio di metri in linea d’aria dal fiume. Decine e decine di gabbiani entrano ed escono nel cono dell’interno condominio, silenzioso, mezzo deserto/barocco e mezzo abitato, galleggiano in cima, perlustrano con un’occhiata e riprendono l’onda gridando.
C’è un vino bianco di marca e un piatto raffinato di pesce e pasta fredda. Non parliamo ovviamente del brano da registrare. Si capisce che non c’è nessuna intenzione di farlo. Anche per un fatto artistico, mettiamola così. Come si suole, diciamo, tra improvvisatori. Dico l’improvvisazione come l’arte sublime della performance. La poetica del mettere le mani sulla materia in tempo reale. Laura ne fa un breve accenno. Colgo al volo. Da qui il discorso devia, un po’ tra l’altro, ma non tanto, quando parte con tutta la sua vestaglia in una risata secca. Ce l’ha con i poeti stonati che leggono le loro poesie con “quella bocca che sembra un culetto e gli occhi sulla pagina scritta e mai a fuoco con il microfono”. E se poi c’è la musica e il ritmo la cosa si fa persino imbarazzante. “Non lo sanno, le zoccolette, che la poesia si fa con le orecchie? Che l’intonazione è tutto per un poeta. Fuori e dentro. E poi non hanno un briciolo di rabbia, solo la posa dei leccaculo, questo sì.” Qualche tempo prima, l’avevano portata a un premio di poesia. Quell’avanguardia vecchia che si sa con Pierpaolo ce l’aveva a morte. Un astio, in molti casi, ingiustificato, da far pensare che non gli perdonavano il successo e la vitalità, che non sapevano davvero cosa voleva dire essere “un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno…ma almeno con sei delle sue sette vite davanti “. Il bello è che quelli odiavano pure Sandro Penna che non si può dire avesse tutto questo seguito popolare.
E a proposito ci racconta della Morante ( che invece ne capiva tanto, dice ) che una sera a casa, sentendo un gran rumore di clacson e torme urlanti slogan incomprensibili chè forse la Roma aveva vinto il derby, commentò dicendo: “ deve essere perché Sandro Penna ha preso il premio Strega e lo stanno festeggiando… “.
Infine qualcosa me la dice a proposito della Marilyn. Capisco che lei ama questo testo. Aggiunge: – “che non si perda mai un lontano odore di jazz. Ma nello stesso tempo sarebbe ridicolo farne un brano jazz. Tutto solo sulla sfumatura…sulle intenzioni…niente accordini e terzinati pùmpapa pùmpapa… niente fighettate da solisti”-
Non volle ovviamente sapere la formazione che avrei portato in sala. Meglio così. Non avrei saputo cosa rispondere. La registrazione era fissata al giovedì della settimana dopo.
Le parti erano pronte. Ma servivano a poco, c’era invece da organizzare più che altro un’emozione discreta e univoca che fosse in grado di contenere la “belva”. Chiamai tre vecchi amici con grande esperienza di real time, come si dice, di interplay che poi in ultima analisi vuol dire di sana capacità di ascolto ancor prima che di emissione di suono. Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Massimo Coen al violino.
Il giovedì di registrazione cominciò con una piece teatrale di gesti e rumori degna del miglior Becket. Siamo in una via del quartiere Prati. Una traversa tra due arterie cittadine. Un via decisamente stretta considerando che ci passa il bus. Il portone di un palazzo di solido stile umbertino che dà in un ampio cortile circolare con diverse saracinesche aperte e vetrine con attività varie. Ricordo un parrucchiere per signora. Giù in fondo, al centro, proprio di fronte al portone, l’ingresso dello studio di registrazione. Noi, da buoni turnisti, eravamo già lì con i nostri strumenti. Alle dieci Laura era in forte ritardo. Apparve dopo mezz’ora. La vedemmo entrare nel cortile, gelida, gli occhialoni da sole tondi e grandi, livida, con le labbra serrate, un borsone portatutto con dentro sicuramente la bomba, una camiciona celeste che la conteneva alla meglio. Non aveva tempo di salutare. Si ferma davanti al produttore ch’era lì con noi. Lo brucia con uno sguardo e platealmente fa cadere la chiave dell’auto dentro una grata ch’era sotto i nostri piedi. La cosa sul principio non ci impressionò ma subito dopo percepimmo che la signora aveva parcheggiato in seconda fila e la sua Golf già bloccava l’autobus e una fila infinita di automobili.
Furono momenti di panico. Laura se ne frega. Nessuno osa parlarle. Entra in sala, chiede al fonico qual è il suo microfono e si siede in postazione. Fuori arriva trafelato il portiere dello stabile armato di una grossa barra di ferro. Insieme al produttore, ( reo di aver dimenticato di andare a prendere la furiosa a casa, da qui la punizione ), ed altri tre o quattro, riescono a sollevare la grata. Siamo invasi dal suono di un’orchestra di clacson. Massimo il violinista mi dice che è il miglior Cage che abbia mai ascoltato. Il gruppetto infine raccoglie nel secco di fogliame e carte la chiave. E sarà il produttore stesso che rischia la vita ( per espiare evidentemente! ) uscendo a spostare la Golf tra una folla di automobilisti e passeggeri inferociti. Entrammo e ci mettemmo ai nostri posti. Dopotutto la furiosa aveva ragione. Quel suo special di teatro del dispetto era l’unica possibile reazione verso l’insensibilità e grossonalità, mista a finta gentilezza, del produttore Si capiva da lontano che quello era al posto sbagliato. Che era il tipo di persona che, anche inconsapevolmente, impedisce che si stabilisca un patto importante tra artisti e pubblico.
In sala, Laura parlava solo con me. Quando ci mettemmo le cuffie e tutti ci ascoltavamo in interfonico mi toccò la ridicola parte di tradurre dall’italiano all’italiano le sue indicazioni. Non conosceva il pezzo. Alla fine chiese solo di avere gli attacchi chiari. Si era improvvisamente ammorbidita. Ora, la furiosa, era a suo agio. Attentissima. In grado di cogliere ogni spostamento di intonazione e ritmo. Ubbidiente al flusso di note. Reattiva.
Dopo una prima passata per regolare meglio gli ascolti registrammo l’unica versione del brano. Un solo take. Laura era della vecchia scuola. Del tempo in cui il nastro era prezioso. Nessun vezzo, si usava così. Si riascoltava e se non andava si cancellava e se ne faceva un altro. Comunque lei approvò già il primo e per noi andava bene.
Ho riascoltato diverse volte la Marilyn. C’è qualcosa di intrigante nella dinamica parola suono. Un piccolo teatro nascosto. Laura comincia stranamente con un’intonazione separata che la pone, in disparte, con un’altra impedenza elettrica, in altorilievo rispetto alle costellazioni sonore che componiamo via via. Si mantiene sempre una terza minore sotto il galleggiamento atonale del brano. Lo fa per istinto, si capisce. Per pigrizia, forse. O, per mantenere dispettosamente la sua di intonazione. Si contrappone. Brechtianamente si estrania. Ma nello stesso tempo depensa. Esce dalla ragione di interprete. Si fa medium. Laura non credo lo sapesse (non faceva parte del suo bagaglio ) ma fanno lo stesso i cantanti di Druphad, l’antichissimo e straordinario canto sanscrito indiano. Riescono a giocare con la vibrazione molecolare della base uscendo e rientrando dalla consonanza e regolando in questo modo, tra intonazione e disintonazione, l’effetto drammatico della voce e, di conseguenza, il rilievo poetico della parola.
Laura era, da questo punto di vista, una sorta di modello originale e non aveva niente da invidiare, nell’essenza vocale, a Carmelo Bene, per esempio, e alla “carmelobenica” del tempo. Aggiungo, faceva istintivamente e con l’esperienza straordinaria che aveva, quel che altri coprivano, velavano, vestivano, machistamente, di superbe e fumose teorie prima di rivelarsi. La sua vocalità riusciva ad essere esibizione, aggressione e dall’altro interiorità manifestata: andava dall’interiore all’esteriore legando continuamente due esistenze. In questo senso, per dirla proprio alla Bene, Laura era il capolavoro. Così grossa e sformata ormai era una piccola Marilyn.
Nella seconda strofa si avvicina sempre più all’intonazione complessiva degli strumenti. Entra più dentro. Cessa di essere un altorilievo. E diventa soprattutto una voce ritmica. Il tutto dentro un normale parlato. Gioca naturalmente, al servizio dell’insieme e delle parole soprattutto, sul battere e levare, dialogando magistralmente con il basso e il pianoforte. Nelle sfumature dunque. In una condizione non assertiva. Per frammenti che sono piccole implosioni di jazz, webernismo, oral poetry. E’ straordinario infine come nella terza strofa faccia suo l’andamento swing del basso pur restando tranquillamente nel testo. In realtà, in apparente monotonia, Laura, sotto, canta continuamente qualcosa e in questo senso – rifacendomi a Paul Zunthor e il suo bel saggio “La presenza della voce “ – dico che la vocalità della Betti, in questo piccolo brano, è parola senza parole, ha un tratto sciamanico. Una voce che le parole vengono ad abitare, ma che veramente non parla e non pensa, ma ripercorre e fa sopravvivere la memoria della primaria mancanza sensoriale in ognuno di noi”.

Marilyn
Del mondo antico e del mondo futuro
era rimasta solo la bellezza, e tu,
povera sorellina minore,
quella che corre dietro i fratelli più grandi,
e ride e piange con loro, per imitarli,
tu sorellina più piccola,
quella bellezza l’avevi addosso umilmente,
e la tua anima di figlia di piccola gente,
non ha mai saputo di averla,
perché altrimenti non sarebbe stata bellezza.
Il mondo te l’ha insegnata,
Così la tua bellezza divenne sua.
Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro
era rimasta sola la bellezza, e tu
te la sei portata dietro come un sorriso obbediente.
L’obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite,
il darsi agli altri, troppi allegri sguardi
che chiedono la loro pietà! Così
ti sei portata via la tua bellezza.
Sparì come un pulviscolo d’oro.
Dello stupido mondo antico
e del feroce mondo futuro
era rimasta una bellezza che non si vergognava
di alludere ai piccoli seni di sorellina,
al piccolo ventre così facilmente nudo.
E per questo era bellezza, la stessa
che hanno le dolci ragazze del tuo mondo…
le figlie dei commercianti
vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra.
Sparì come una colombella d’oro.
Il mondo te l’ha insegnata,
e così la tua bellezza non fu più bellezza.
Ma tu continuavi a essere bambina,
sciocca come l’antichità, crudele come il futuro,
e fra te e la tua bellezza posseduta dal Potere
si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente.
La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime,
impudica per passività, indecente per obbedienza.
Sparì come una bianca colomba d’oro.
La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico,
richiesta dal mondo futuro, posseduta
dal mondo presente, divenne un male mortale.
Ora i fratelli maggiori, finalmente, si voltano,
smettono per un momento i loro maledetti giochi,
escono dalla loro inesorabile distrazione,
e si chiedono: «È possibile che Marilyn,
la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada?»
Ora sei tu,
quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso,
sei tu la prima oltre le porte del mondo
abbandonato al suo destino di morte
versione della poesia tratta dal film La rabbia – I parte (1963), scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini;
Sul corpo della poesia di ricerca
di Antonio Loreto
La prima edizione del Premio Pagliarani è stata vinta per la sezione della poesia edita da Soffiati via di Vito M. Bonito: un bel libro di un autore importante, niente da dire.
Rifletterei però sull’indirizzo del Premio, che il nome di Elio Pagliarani e alcune indicazioni abbastanza chiare mostravano vòlto a valorizzare opere di ricerca, mentre Soffiati via non sembrerebbe essere tale. Perché? Che cosa si deve intendere per “ricerca”?
Due anni fa, in occasione di Poesia13 – Cantiere aperto di ricerca letteraria (a cura di ESCargot), ci ritrovammo a Rieti in diversi e vari, critici e poeti (ogni poeta presentato da un critico), a leggere, ascoltare, commentare e infine, quasi a margine, a tentare della ricerca una definizione, senza che – assortiti come eravamo – un’idea concorde riuscisse a scaturire. Il discorso rimase sospeso, lasciando l’impressione che la parola “ricerca” fosse nella disponibilità di qualunque esperienza che aggirasse le scritture poetiche non sperimentali.
A mio avviso non si trattava allora né si tratta in generale di negoziare una definizione, di stabilire democraticamente qualità essenziali, magari un’ontologia. Il punto è che la poesia di ricerca nominalisticamente esiste, ed esiste da tempo, saturando il dominio semantico – nel contesto della letteratura poetica – della parola che la specifica. Esiste nel corpo delle opere e delle attività molteplici – il sito gammm.org, l’antologia Prosa in prosa, i convegni Ex.it, il progetto editoriale Benway Series, il dialogo costante con la ricerca anglofona e francofona attraverso la collana Chapbook dell’editore Arcipelago, per esempio – di un gruppo di autori aperto, come lo è stato, ancora per esempio, quello della neoavanguardia cinquant’anni addietro. Non omogeneo, certo (così stavano felicemente insieme Balestrini e Pagliarani, per dire, con Manganelli e Arbasino), e come dicevo aperto, ma riconoscibile.
Si capisce, mi auguro, che non coltivo follie monopolistiche né puristiche e conservatrici: la poesia di ricerca la faccia chi vuole (e smetta chi vuole di farla) e senza porsi in maniera epigonale, se possibile. Solo vorrei suggerire, ripetendomi, che l’espressione “di ricerca” non può riferirsi alla proprietà di essere non tradizionale, in qualunque modo purché sia: non può più a questa altezza cronologica, perché essa ha storicamente (per una storia breve, ma questo non rileva troppo), ha storicamente preso a indicare un corpo. Il suo corpo storico è lì, e come tutti i corpi consiste in un processo, che accoglie qualcosa come propria fase e rifiuta qualcos’altro come qualcosa d’altro; non secondo una famiglia di dogmi (Corrado Costa ne ha disfatti almeno due, di dogmi avanguardistici – quello del montaggio e quello dell’antireferenzialità – pur rimanendo nella sensibilità condivisa un avanguardista) bensì secondo criteri di riconoscibilità.
La riconoscibilità è una questione di scopi, e dunque pragmatica: se il mio scopo è lavare l’automobile, posso riconoscere come acqua il contenuto del secchio che ho riempito anche se vi finisce dentro un corpo estraneo, che magari la renda non potabile ma che non impedisca l’operazione e non rovini la carrozzeria; se il mio scopo è bere, il contenuto del bicchiere verrà da me riconosciuto come acqua qualunque sia l’azienda imbottigliatrice (e qualunque la composizione organolettica), a patto che non si verifichi un fatto come il discioglimento di qualche piccolo granello di arsenico, nel qual caso dovrei riconoscerlo come Acqua Tofana – anche se solo dopo aver constatato l’effetto. Sia chiaro che gli scopi, in letteratura, non hanno a che vedere con l’intentio auctoris; vanno rintracciati specularmente proprio negli effetti, che sempre eccedono eterogeneticamente gli scopi che li creano (l’autore si dia pace, non gli chiederemo niente: può anche morire se gli piace).
A questo punto dovrei forse dire qual è l’effetto, quali sono gli effetti della scrittura di ricerca, e quali i diversi, incompatibili effetti di una scrittura come quella di Soffiati via. Ma non credo serva: lo hanno detto in questi anni, certo parzialmente e non sempre lucidamente, i discorsi critici di una teoria di lettori (e autolettori – forse soprattutto loro: questo certamente complica le cose).
Rimarrei piuttosto al discorso principale, perché essere riconoscibile non significa necessariamente essere riconosciuto, né nel senso della distinzione né nel senso dell’ammissione. Poesia13 e Premio Pagliarani – considerato il novero e le inclinazioni dei lettori giurati (di cui ho fatto parte) e il novero e le inclinazioni dei poeti candidati, per una porzione non irrilevante (legittimamente) restii alla più sporadica frequentazione della poesia di ricerca – rendono in effetti palmare il fatto che la nostra comunità letteraria, perlomeno quella in tali sedi rappresentata, nel complesso non la riconosce. Riconosce tuttavia l’appeal dell’etichetta nei galleggiamenti discorsivi: ciò che espone una parte della comunità in parola a una tentazione che provo a esemplificare politicamente (ovvio: senza voler istituire alcun parallelo di ordine assiologico).
Quello della sinistra è un corpo culturale riconoscibile: coloro che lo riconoscono ma non vi si riconoscono posizionano sé stessi altrove, in formazioni culturali già date o da darsi, configurando uno schieramento tradizionalmente diversificato. Coloro che non lo riconoscono possono dar luogo a una formazione più o meno eterogenea che tenti di appropriarsi, risemantizzandola, della sua insegna in certo modo percepita come vantaggiosa; che finisca per sovrapporsi con il proprio corpo all’altrui, nel rischio quando non nell’intenzione di sopraffarlo, neutralizzarlo, estinguerlo – e se va bene assorbirlo. È una dinamica che di questi tempi vediamo chiaramente nelle logiche che governano alcuni partiti, e nelle società che esprimono e negli strumenti (il vecchio giornale gramsciano, per esempio) che utilizzano.
Può essere utile arretrare rispetto al presente, che è tempo sempre fertile di polemiche e militanti (oltre che etimologicamente paradossali) presbiopie, e al contempo ritornare all’ambito letterario. Provo a immaginare Tristano di Balestrini e Tempi memorabili di Cassola in un premio per il romanzo tout court e in un premio per il romanzo sperimentale. La vittoria di Cassola (siamo nel 1966, Balestrini non gode ancora del riconoscimento di cui godrà) non avrebbe lo stesso significato nei due casi: nel primo, saremmo semplicemente al cospetto della consueta minorità degli sperimentalismi (di quelli non storicizzati, perlomeno); nel secondo, se l’esito fosse accettato senza obiezioni, quello della minorità sarebbe il meno indesiderabile dei problemi: con conseguenze di qualche serietà si darebbe una rinegoziazione delle categorie di riferimento. Alcune di queste – in quanto ideologiche, politiche, estetiche e quindi ideologiche e politiche – si collocano nella storia: se le rendiamo troppo fluide, le stiracchiamo troppo (non dico: le rovesciamo), diventano inefficaci o inservibili, mentre sono gli strumenti con cui ci orizzontiamo nel nostro tempo, e lo costruiamo.
“Una lapide in Via del Babuino”
di Emanuele Trevi
[dal “convegno online” dedicato a Mario Pomilio, su vibrisse]
Una rosa incendiata alla fiamma della forma.
( una lettura del testo inaugurale dell’Inferno minore di Claudia Ruggeri)
di Giovanni Palmieri
Abstract
Poesia d’apertura della raccolta Inferno minore, il Matto I (del buco in figura) Beatrice è un ermetico manifesto della nuova poetica inaugurata da Claudia Ruggeri proprio con questa poesia. Il nuovo stile si mostra qui per la prima volta celebrando se stesso e giustificandosi in forma di barocca apoteosi. Si tratta, però, di un “manifesto” in cui è obbligatorio leggere, sovrainciso e cifrato, anche il decisivo discorso del male e del dolore di chi scrive. Leggiamo infatti subito che è dalla “dispersione” di questo male profondo che nasce la nuova maniera poetica e solo il male, giunto al culmine, potrà rendere al poeta la sua “rosa”…
Del resto se un poeta – come è occorso alla Ruggeri – si identifica (o è venuto identificandosi) totalmente nel suo scrivere, se tra sé e il tempo ha messo una barriera di libri e quaderni, parlare di se stessi e parlare della propria poesia nel testo poetico diventano la stessa cosa. Invocare allora sic et simpliciter la consueta nozione di metapoesia è certamente un errore.
La figura dedicataria del testo è, non a caso, la Beatrice del Purgatorio, cioè colei che agli occhi di Dante ha superato la prima Beatrice, quella stilnovistica. Dunque nel Matto I il livello poetico e quello metapoetico s’intrecciano in modo indirimibile come le facce del nastro di Möbius, venendo a costituire due piani che il critico, per virtù esegetica, dovrà distinguere nella loro simbiosi isotopica, ma che il lettore dovrà infine riunire… dimenticando il critico. Ma questo, il lettore, dovrebbe sempre farlo.
Il testo
il Matto I (del buco in figura)
Beatrice[1]
“vidi la donna che pria m’appario
velata sotto l’angelica festa…” (Pg. XXX-64)
come se avesse un male a disperdersi
a volte torna, a tratti
ridiscende a mostra, dalla caverna risorge
dal settentrion, e scaccia
per la capienza d’ogni nome (e più distratto 5
ché sempre più semplice si segna ai teatri,
che tace per rima certe parole…).
Ma è soprattutto a vetta, quando buca,
dove mette la tenda e la veglia
tra noi e l’accusa, se ci rende la rosa 10
quando ormai tutto è diverso che fu
il naso amato l’intenzione, che era
la pazienza delle stazioni e la rivolta… e la beccaccia
sta e sta sforma il destino desta l’attacco l’ingresso disserta
la Donna che entra e fa divino ed una luce forsennata 15
e nuda, e la mente s’ammuta ne la cima
e la distanza è sette volte semplice e il diavolo
dell’apertura; ecco, chiediti, come il pensiero sia colpa
ma cammina cammina il Matto sceglie voce
sa voce, e sempre più semplice chiama, dove l’immagine 20
si plachi sul tappeto, se dura, se pure trattiene
stranieri nuovi e quanto altro
s’inoltrerà nella carta fughe falaschi lussi
Ordine innanzi tutto o la necessaria Evidenza che si di
verte nella memoria al margine ambulante alla soglia 25
acrobata, che si consuma; ché infine
veramente il Carro
avanza, che sia sponda manca porge
il volto antico, che si commette (non la cosa
è mutata ma il suo chiarore; ma a voi che vale, 30
come si conclude la Figura
dove pare e non usa parole né gesti né impulsi;
come, smisurata, passa, dove l’altro richiamo
nel viluppo della palude festina; e come
per tutto si slarga e frastorna e nulla è mite 35
(ma voi li turereste mai li nostri fori ?)
Il soggetti grammaticali e logici del testo
I primi due versi della poesia presentano un’ingannevole anastrofe, cioè una figura retorica tipicamente barocca molto amata dalla Ruggeri. Bisognerà perciò leggere: “come se avesse a disperdersi, un male a volte torna”, con “male” soggetto e anticipazione sintattica. Non c’è dunque alcun “lei”, soggetto sottinteso del verbo “avesse” come sembra ad una prima lettura. Il “male” rimane soggetto sottinteso sino al v. 10. Si tratta di un inganno retorico che, però, cela la verità: è infatti davvero il poeta che è vittima d’un male che ritorna… ecc. Per nessuno come per Claudia Ruggeri, del resto, valgono i celebri versi dell’Autopsicografia di Pessoa:
Il poeta è un fingitore.
Finge così completamente
che arriva a fingere anche
il dolore che veramente sente.[2]
Al v. 10 compare per la prima volta come soggetto logico l’autore in terza persona (“tra noi e l’accusa, se ci rende”). Compare cioè la voce narrante, da identificarsi in chi scrive, che ritroveremo in dialogo col lettore al v. 18 (“chiediti”) e poi ai vv. 30 (“a voi”) e 36 (“voi”) dove il lettore diventa collettivo.
Altri soggetti logici o grammaticali, tra quelli animati e semanticamente decisivi, sono poi “la beccaccia” (v. 13) e la “Donna”. Un simbolo, la prima, e un’allegoria, la seconda, da identificarsi entrambi nella nuova maniera poetica.
Alla fine della prima strofa compare “il Matto” (v. 19), la carta dei tarocchi simbolo in questo caso del destino incognito e imprevedibile che può assumere tutte le forme. Auspicio o speranza.
Il male e lo stile
Nei versi d’esordio si può leggere che per disperdersi, cioè per attenuare i suoi effetti perniciosi, un male talvolta ritorna per mostrarsi (in poesia). Ma “a mostra” vale anche latinamente “per prodigi” e “a tratti” è in evidente simmetria paronomastica col successivo “a mostra”. Il male risorge da dove era stato sepolto (la “caverna”, voce dantesca con significato freudiano) grazie ad una luminosa guida celeste. Con “settentrion” (septmen triones) Dante intende infatti (Pg, XXX, 1-sgg) l’insieme dei sette candelabri che aprono la processione sacra che introdurrà Beatrice. I candelabri hanno però anche il valore simbolico della costellazione guida dell’Empireo: le sette stelle dell’Orsa.
Questo male, convertito e disperso catarticamente in un nuovo stile poetico, respinge da sé (“scaccia”) i lettori per eccesso di polisemia (“capienza d’ogni nome”). Claudia Ruggeri era ben consapevole del proprio ermetismo e certamente doveva soffrire per le accuse d’illeggibilità che le venivano mosse da più parti. Il fatto, poi, che spesso recitasse i propri testi a teatro spiega i versi successivi in parentesi: il male poetico/stile viene spesso vòlto ad altro uso (“distratto”) e si semplifica maggiormente quando viene messo in scena dove il gesto e il tono vocale possono aiutare la comprensione del senso. Curatissima come sempre la tessitura sonora: segnalo solo l’assonanza triadica tra “sempre“, “semplice” e “segna” (v. 6).
Che poi questo stile taccia certe parole, fa riferimento alle frequenti ellissi che la Ruggeri segnala graficamente nei suoi testi con evidenti spazi bianchi. La nota d’autore riferita a questi “blank” testuali recita: “Nella Vita Nuova Amore dice a Dante: ‘Voglio che tu dichi certe parole per rima, … come tu fosti suo tostamente da la puerizia’.”[3]
Dunque quello che Dante afferma di dover dire per volere di Amore dittatore è proprio ciò che la Ruggeri, con spostamento semantico metapoetico, tace. Non dice cioè che sin dalla prima giovinezza le era appartenuto quel nuovo stile (ma pure quel male!) che solo ora si è pienamente manifestato. Ciò viene confermato anche dall’epigrafe dantesca preposta al testo che fuori dal significato allegorico prestatogli significa tel quel: adesso mi appare chiaramente quella maniera poetica (la “donna”) che m’era apparsa anche prima ma soltanto velata…
Il male, il vertice e la Donna
Il male/stile si manifesta (“è”) soprattutto al suo culmine, quando sfora, dove si accampa come nomade solitario (non si accasa) e dove mantiene viva l’accusa (di illeggibilità) rivolta all’io narrante (vv. 8-10). Ma si manifesta solo “se” effettivamente restituisce al poeta la “rosa”, cioè il massimo esito poetico. Dopo “tenda” (v. 9) si trova la seguente nota d’autore: “E Dio più volte nella Bibbia ‘si attenda’ sulla terra”. Effettivamente nel Libro secondo di Samuele (VII, 5-6), rivolto al profeta Natan e in merito al progetto di re David di costruire un tempio, Dio afferma: “Non ho certo abitato in una casa dal tempo in cui feci uscire i figli d’Israele dall’Egitto sino al giorno d’oggi. Invece sono andato sempre errando sotto una tenda e sotto un padiglione”.
Del resto tutto è ormai cambiato nella vita di chi scrive: l’uomo amato (il “naso” sarà il simbolo freudiano del fallo e poi per metonimia l’uomo), il desiderio di fuga, la coazione ai viaggi compulsivi (“la pazienza delle stazioni”) e lo spirito di “rivolta” (vv. 10-13). Tutti temi della passata maniera poetica… va osservato.
Si notino le antitesi baroccheggianti quali “vetta” vs “buca” ed “è” vs “fu”. In felice rapporto paronomastico “tenda”, “veglia” e “rende”. E poi “intenzione” e “stazioni” in quasi rima interna.
In seguito (vv. 13-18) i nuovi soggetti, che però tendono ad identificarsi, sono la “beccaccia” e la “Donna”. In antitesi verbale – a distinguere il passato dal presente – “era” (v. 12) e “sta” (v. 14). Quest’ultimo verbo reiterato per significare la definitiva fissazione d’un orizzonte poetico. La beccaccia, che sa penetrare il terreno in cerca di cibo sino al punto di dilatare il becco anche sotto terra, sarà qui l’emblema, il simbolo, del nuovo stile che sa scavare sino a raggiungere le più assolute profondità. Ecco che il “buco” diventa allegoria della vetta poetica, del vertice artistico.
La beccaccia, cioè la nuova maniera poetica, è anche in grado di opporsi al destino (“sforma”) e risvegliare così un nuovo inizio (“attacco”), o l’inizio di una nuova vita, mentre la Donna, cioè un’allegorica Beatrice, discute (“disserta”) qui del suo “ingresso” nel nuovo mondo poetico. In una precedente redazione letta in pubblico e poi trascritta, in luogo di “disserta” si leggeva “disserra”.[4] Anche qui si osservino le allitterazioni presenti in “destino”, “desta”, “disserta” (v. 14), e “ingresso” (v. 14).
Al suo ingresso, in un’apoteosi iperbolica, la Donna (Beatrice domina cioè “padrona”) divinizza e illumina tutto con una luce fortissima e chiara (“nuda”). Si noti però che “forsennata” (v. 15) in senso etimologico significa “fuori di senno” e qui l’aggettivo mantiene certamente anche questo significato. In conformità col topos dantesco dell’incomunicabilità dell’esperienza mistica, la mente, a tali altezze poetiche, si smarrisce e ammutolisce (“ammuta” è voce dantesca in Pg, XXVI, 68). Il sintagma “nella cima” (v. 16), cioè nell’ascesi poetica, riprende poi sotto altre forme la dura salita di Dante al monte del Purgatorio, l’antico Eden, e da lì all’Empireo. Sette sono i gironi del Purgatorio che portano alla sua sommità e sette sono i doni del “settemplice” spirito divino (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio), richiamato qui dal sintagma “sette volte semplice” (v. 17).
All’ascesi poetica servono dunque sia i sette doni dello Spirito santo, prima citati, sia, in antitesi, il “diavolo”, cioè quel male che consente l’apertura, il buco, l’al di là del nuovo stile. Come, del resto, era stato detto sin dall’inizio.
Al v. 18 troviamo un appello al lettore e un’orgogliosa rivendicazione del proprio ermetismo che per la Ruggeri altro non è che pensiero concentrato (confronta i vv. 4-5) come, del resto, intende dimostrare la presente analisi.
Il Matto, i temi e il Trionfo di Beatrice
Nella seconda strofa del testo (vv. 19-26), il Matto, cioè la carta del destino e del destino poetico, avanza e chiama il poeta perché ormai sa cosa dire e come dirlo in un modo sempre più essenziale (“semplice”). Il Matto chiama nel luogo in cui l’immagine (poetica) può finalmente placarsi sulla carta. E qui l’isotopia chiama in causa anche il gioco cartomantico dei tarocchi dove realmente si allineano le carte su un tavolo o su un tappetino. Il destino poetico, inoltre, coinvolgerà nuovi lettori (“stranieri nuovi”) e tutto quanto avverrà sarà anticipato dalle carte di cui il Matto stesso (o il fato) determinerà la comparsa. Come appunto nella pratica d’interrogazione dei tarocchi.
Ma cosa comparirà nelle nuove carte ? Quale mosaico narrativo esse andranno a comporre, quale destino? Fughe (la nevrosi dei viaggi di cui soffrì la Ruggeri), paludi,[5] cioè, more simbolico, stati depressivi, e infine lussuose distrazioni, forse gli eccentrici e costosi vestiti che la Ruggeri tanto amò e sfoggiò. La triade “fughe falaschi lussi” (v. 23) evoca da vicino, ma senza edonismo e anzi con confesssione “bipolare”, quella presente nell’Invitation au voyage di Baudelaire: “Luxe, calme et volupté”.
Tra ciò che “si inoltrerà” nelle carte, cioè nel discorso poetico ma anche nella vita della poetessa, vi sarà una logica ferrea (“Ordine”) ma anche la “necessaria Evidenza” che poi sarebbe, con bella e indiscutibile metafora, la Morte. E qui si ricorderanno le gravi perdite subite dalla Ruggeri: dalla scomparsa prematura del padre, alla morte di tanti giovani amici. La morte entrerà nel discorso poetico anche perché tale pensiero si allontana (“si di verte”) e si “consuma” nel ricordo danzando da acrobata su un margine e su un confine mobile. Le immagini – che sono quelle dell’orlo di un precipizio e della corda sospesa del funambolo – ricordano visivamente la scena della danza macabra nel capolavoro di Bergman Settimo sigillo.
Insomma: il nuovo esercizio poetico, il nuovo stile, come elaborazione del lutto ma con qualche profetico dubbio sulla sua riuscita.
Come accade nel Purgatorio, Beatrice arriva infine alla vista di Dante “in su la sponda del carro sinistra” (Pg, XXX, 61), cioè sul lato sinistro del carro, come del resto ricorda al lettore una nota che la Ruggeri appone dopo “sponda manca” (v. 28). Si ricorderà che il “lato manco” di Cavalcanti e in genere la sinistra simboleggiavano nel Medioevo l’esiziale sindrome melanconica. Il Carro, però, è anche uno degli arcani maggiori dei tarocchi e precisamente (guarda caso) il settimo. Nella simbologia cartomantica, esso rappresenta il mutamento, la trasformazione della realtà e l’azione; oppure la vittoria, come risulta evidente nella figura del re condottiero che lo guida. Simboleggia anche la stabilità emotiva e il successo determinato dall’azione individuale che vince il fato. Un auspicio, per la Ruggeri, limitato dal fatto che la sponda del carro da cui si affaccia il nuovo stile, cioè la Beatrice di questo testo, è una sponda “manca”. Di più: il testo non afferma, come in Dante, che Beatrice appare dalla sponda manca del carro, ma afferma che è Beatrice, cioè il nuovo stile, quella sponda manchevole. Dice infatti: “che sia sponda manca” e cioè “pur se è, benché sia, un sostegno debole”, ecc. A questo proposito si notino le ossessive iterazioni anaforiche della struttura pronominale “che si” e “che sia” ai vv. 24, 26, 28 e 29. Un vera invocazione ad essere… Si noti anche la quasi rima interna (“avanza… manca”) del v. 28 che dal punto di vista semantico rappresenta un imperfetto ossimoro. Prezioso segnale formale delle antinomie strutturali (male vs bene, purgatorio vs inferno, esaltazione vs depressione, successo vs fallimento, colpa vs redenzione, parola vs silenzio, Matto vs ordine, vita vs morte ecc.) sulle quali è articolato tutto questo straordinario testo che definirei ciclotimico.
Tornando ora alla guida dantesca della poesia, il “volto antico” di Beatrice (il vecchio stile) si congiunge (“si commette”) proprio dove appare (“pare”) cioè sulla superfice testuale della stessa poesia. Prima però c’è una parentesi non chiusa in cui, rivolgendosi ancora al lettore, l’io della Ruggeri afferma che nel nuovo stile non sono i referenti poetici, (la “cosa”) a essere cambiati ma è solo la loro intensità (“chiarore”). Del resto – prosegue cifrando il proprio dramma – a voi lettori che importa conoscere quale sia la mia vera realtà, cioè la “cosa” nascosta sotto alla mia allegoria (“come si conclude la Figura”)?
La nostra Beatrice si mostra ma non dice nulla, non grida, non compie gesti eclatanti né si agita. Semplicemente nella sua enormità accade e passa (vv. 32-33). Qui, esegeticamente, si potrebbe decifrare, decrittare molto di più, ma si correrebbe il rischio di distruggere con effetti di luce troppo violenti l’affresco poetico. Non vale la pena, non va fatto. La macchina di Turing non è per la poesia.
Dunque Beatrice accade e passa ma si dirige, ahimè, anche “dove l’altro richiamo / nel viluppo della palude fèstina”. Se c’è infatti un richiamo alla vita, testimoniato proprio dall’esaltata parusia e dal “trionfo” barocco del nuovo stile, purgatoriale e dunque potenzialmente salvifico, v’è però anche “un altro richiamo”, un’altra pulsione che si muove velocemente (!) (“fèstina”) nel groviglio del “male” e cioè nel viluppo di quella “palude” che è evidente emblema della depressione melanconica. Quest’altro richiamo è senza mezzi termini una consapevole pulsione di morte ed è perciò che la Figura si espanderà dappertutto, ridonderà addirittura e nulla in lei ormai sarà “mite”.
Epilogo “a parte”
Il verso finale ricorre in realtà quando la poesia è già finita ed infatti è messo tra parentesi. Si tratta dunque di una “coda” costituita da un’ultima domanda retorica rivolta “a parte” ai lettori… A quei lettori che la poetessa aveva già ammonito chiedendo loro al v. 18 di domandarsi in qual modo nei suoi testi il pensiero potesse essere una colpa.
Per comprendere il significato di quest’ultima frase, dobbiamo però ricorrerere alla sua fonte. Nella Coscienza di Zeno, il protagonista scrive verso la fine del suo “memoriale” che se considerassismo la vita e i suoi disagi una malattia (il che, peraltro, è nicianamente verissimo), non potremmo in alcun modo curarla: “Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati”.[6]
Analogamente, la Ruggeri, attraverso un’interrogativa retorica a risposta negativa, afferma che non si devono “turare” i suoi “fori”, i suoi profondi squilibri, perché è da quelli, cioè dal suo male, che provengono quei risultati poetici che sono la sua stessa vita. Curarli vorrebbe dire dunque uccidere lei. Lei che – come ha scritto in un folgorante e consapevole distico – “a la fiamma della forma ha incendiato / la forma della rosa”…[7]
[1] Claudia Ruggeri, Inferno minore, a cura di Mario Desiati, peQuod, Ancona 2006, pp. 85-86.
[2] Fernando Pessoa, Una sola moltitudine, a cura di Antonio Tabucchi e Maria José de Lancastre, Adelphi, Milano 1979, vol. 1 , p. 165. Tr. it. modificata.
[3] Gli esatti versi di Dante (Vita nuova, XII, 7) sono i seguenti: “voglio che tu dichi certe parole per rima, ne le quali tu comprendi la forza che io tegno sopra te per lei, e come tu fosti suo tostamente da la tua puerizia”.
[4] Vedi: htpp://www.musicaos.it/testi/maggio/matto2.htm.
[5] Per metonimia da “falaschi” (v. 23).
[6] Italo Svevo, La coscienza di Zeno, ed. rivista sull’originale a stampa a cura di Giovanni Palmieri, Giunti, Firenze 1994, p. 417.
[7] Claudia Ruggeri, Inferno minore, cit., p. 127.
Riscritturine per Pier Paolo Pasolini
di Ferdinando Tricarico
E dopo Marylin
E dopo di te Marylin
bellezza morta del mondo antico
uccisa dalla crudeltà del mondo futuro
mentre i fratelli più grandi
erano distratti nel tombino a spiare
il sorriso al vento della gonna
nessuna è stata più bella.
Rifatte e strafatte
vincitrici del concorso truccato
a Miami come a Casoria
violentate
dalla frigidità delle cose presenti
dal mondo futuro senza futuro
nessuna è stata più posseduta
dall’ impudicizia divina
di sorellina.
Colombella d’oro
qui le dive sono oche di botox
e i tuoi fratelli più grandi
guardoni di pixel.
* * *
Lucciole fasciste
Sono ricomparse le lucciole
seriali informatiche virtuali.
Se ne stanno a lucciolare
per i social patchwork
al riparo dal buco dell’ozono
dove day by day cadono
le speranze di sopravvivenza degli
antropologicamente mutati.
Sono ricomparse luciferanti
per abbagliare la famiglia in mutande
che può toccare la luce digitale
una magia con sede nella Silicon Valley
il cimitero del reale.
Quando nella campagna zigzagavano
c’era il fascismo fascista
mentre si smorzavano nell’industria
c’era il fascismo democristiano
e son sparite nel vuoto del potere
del fascismo non aggettivato.
Sono ricomparse
per la nostra felicità costituzionale:
globalizzate democratiche fasciste!
* * *
Io so
Io so di non sapere
e non cerco le prove
di ciò che siamo
scannatori scannati
dagli opposti monoteismi
del Kapitale.
Io so di non sapere e
non posso cercare le prove
della mia complicità
della mia servitù volontaria
del silenzio degli intellettuali
che non dicono più contro
che nemmeno si contraddicono
che nulla dicono
della crociata contro i corpi
borghesi e proletari.
Io so di non sapere
che siamo cose di cose
merci alla mercè di marci
col culo abbronzato
che c’indebitano sovrani
per sogni e bisogni inventati
e che sanno e hanno le prove
della nostra impotenza
di questa solitudine di folla
che non si pensa mai
moltitudine di folle gioia.
Io so di non sapere
e per questo cerco le prove
della mia ignoranza.
L’assedio
di Cristiano Denanni

Mentre fuori spiove.
E ogni volta che nel mondo è giovedì.
Mi siedo al pianoforte.
E suono.
Avevo preso lezioni da bambino, mi mandava mia madre da una signora che aveva fatto il conservatorio e per vivere faceva la parrucchiera e poi insegnava a suonare il pianoforte a casa sua, naturalmente allora non me ne importava nulla, ma siccome a scuola avevo risultati sconsolanti, una soddisfazione, una qualunque, una a caso dovevo pur dargliela a mia madre. La musica mi pareva la forma più alta, e la più bella, di ciò che in seguito imparai a chiamare compromesso. Solfeggiare mi risultava cosa ripetitiva quanto noiosa, però una volta innanzi ai pesanti tasti bianchi e neri e a quei strani eppure misteriosi segni sul pentagramma tutto prendeva aria, e capivo che da qualche parte si poteva volare.
Volare.
Già allora, inconsapevole dei dolori di poi e di alcune delle mattine incandescenti d’amore che sarebbero venute, intuivo che non è vero che tutto nasce e muore rimanendo sempre solo coi piedi al suolo.
Già allora.
Mia madre non lo sapeva, o almeno credo, ma mi aveva dato in pasto a una conquista.
Il peso dei tasti, dicevo. Il peso dei tasti è stato motivo sempre di piacere nel confrontarmi con il pianoforte. E’ come sentire, fisicamente, sotto la pelle, un corpo, il corpo che ti darà appagamento, la musica.
Il peso.
Il peso delle cose è ciò che distingue un giocattolo da una cosa seria. Una tastiera da un pianoforte. La massa d’aria che ci si trova a smuovere. Il valore che diamo ad azioni comportamenti parole, distillandone profondità, o al contrario scostandole distrattamente come fossero pioggia da un parabrezza, moscerini dal viso.
Il pianoforte.
Fra le innumerevoli sue peculiarità, possiede questa lignea profondità. Il primo timbro che ne ascolti, tu che suoni, è quello del tasto che scende sotto la pressione delle dita, il secondo quello del martelletto sulla corda che produce la nota.
Il timbro.
L’esatta, univoca voce di una nota prodotta da uno specifico strumento, sia esso la voce umana o un violino, un tuono, un uccello, un frusciare intimo di vento, oppure quella gonna, ora nell’armadio, quando l’avevi indosso, o la fiamma quando prende, gli odori della notte nel bosco, quando tutto deve ancora accadere, o la calma dell’onda sulla battigia oscura di pochi spilli di stelle.
La calma.
Quella che possiedo, o devo possedere, per suonare sapendo di non raggiungerti, se non con il pensiero sensibile della musica. Quella che perdo, o devo perdere, per suonare sapendo tutto ciò che so di noi.
Noi.
Eri bambina quando mi accorsi d’essere un uomo migliore, perché tuo padre. Mi colorasti una vita che per quanto avessi amata e non poco odiata mi pareva sazia. E invece, invece di tutte le questioni aperte e mai chiuse, quali nella vita in gran parte se ne incontrano, tu risultasti dalle prime ore la più prodigiosa. Quando mamma se ne andò, quando allora, nella calca dei fatti mi accorsi che un altro uomo e un altro paese del mondo non erano un omicidio ma in fin dei conti una delle tante eventualità delle cose, e attorno alle cose delle persone, e attorno alle persone dei sentimenti, e attorno ai sentimenti del tempo che trascorre e a noi piacendo o meno evolve, temetti un olocausto fra il respiro e la spina dorsale del mio essere semplicemente un uomo nel mondo. Ma così non fu. Rimanemmo in due, dal due ch’ero assieme a tua madre, al due che siamo noi. Noi. Rimanemmo tu e io, Andreja del tempo e di giorni che non avrei voluto pensare di te senza, in due, per i motivi che ora conosci perfettamente, imposti da mamma, vissuti da noi.
Due.
Il primo numero dopo l’uno dal quale si può cominciare a vivere più a lungo che della propria vita, evitando l’abbaglio della solitudine. L’unico modo, ad esempio, affinché un libro possa essere scritto, e letto. Da persone che non siano la stessa. L’unico modo, insomma, di dargli un senso, dargli una vita.
I libri.
Ce n’erano oltre un milione e mezzo alla Biblioteca Nazionale e Universitaria della Bosnia Erzegovina di Sarajevo, la Vijećnica, e c’erano centocianquantacinquemila edizioni rare e preziose, assieme a quattrocentosettantotto manoscritti, quel giorno d’agosto del 1992, il 25, quando la storia, la nostra storia, e quella più grande, quella con la maiuscola, la Storia, s’incepparono. Eri coi tuoi amici, eravate a studiare e a giocare, a parlare, a vivere, probabilmente ad amare, quando dalle colline i serbi spararono le prime bombe, e per tre giorni non smisero, fino a che di Vijećnica non rimasero che uno scheletro spettrale e malinconico, e tutti quei calcinacci. Ti unisti anche tu ai vigili del fuoco, a cittadini, volontari, bibliotecari per mettere al riparo libri e parole, memoria e cultura, le maestranze più strenue che possiede il mondo, al servizio della vita contro la morte. Aida morì, Aida Buturović, una delle bibliotecarie, colpita da una scheggia di granata, aveva 32 anni, so come e quanto la ricordi, ma tu quel giorno non facesti in tempo a vederla al suolo, quando un’altra scheggià colpì alla testa anche te. Non ti uccise, nulla è riuscito a farlo mai, figlia mia, ma quando arrivasti in ospedale eri già in coma, e così rimanesti per oltre un anno. Soltanto Sarajevo stette in coma più a lungo, sotto quell’assedio, quell’assedio infinito.
Il coma, Andreja.
Quello stato di incoscienza durante il quale il mondo, per te, scompare. Del tutto? Fino a che punto? E tu cosa capivi, cosa sentivi, cosa desideravi? Sognavi? Fu infinito quell’assedio, Andreja. Infiniti sono i giorni nei quali la vita viene centellinata, e scappa. Fugge un poco alla volta, e fa paura, e per tutto il tempo nel quale assisti a vite dopo vite che ti abbandonano il terrore s’ingigantisce, il terrore di vedere svuotarsi una città, di vederla spogliarsi, come faceva Sarajevo, come facevi tu, pregando che almeno una esistenza resistesse, una luce rimanesse accesa, per non morire, Sarajevo, Andreja, amore mio. Ma non moristi. Non moriste.
L’assedio.
Quello su Sarajevo durò oltre quaranta mesi, il più lungo nella storia moderna, un’infinità, una tortura, una condanna. Quello su di te durò anni, da quel giorno d’agosto nella Biblioteca Nazionale a quando tornasti a poter compiere sognare costruire una vita normale. Attraverso giorni, mesi, anni di fisioterapie, esercizi di resistenza, di morale, di carattere, di vita. Perché è lì che risiede la questione, l’esercizio alla vita. L’assedio bellico e quello morale. Fosti una donna accerchiata, ti furono negate le vie d’avvicinamento e d’allontanamento ai sentimenti, agli abbracci, agli aiuti, alle parole, agli sguardi. Ti vennero precluse le azioni e le speranze, eppure non cedesti, eppure fosti tenace, eppure ti ergesti, a mò di città che s’illumina nelle tenebre all’ennesima notte di distruzione, perché consegnasti alla tua indole la mappa della fuga, e quella della conquista. Il destino proprio, l’architettura dell’esistenza, questa la tua conquista. Alla Vijećnica si andava per vivere, chissà di questo, oggi cosa rimane. Si andava per ripararsi dal freddo, per tutte le persone che non avevano riscaldamento in casa. Si andava a gareggiare, chi aveva letto più libri? In biblioteca si andava a cercare i collegamenti, quelli di cui abbiamo necessità per comprendere, o almeno tentarvi, cosa siamo rispetto ciò che siamo stati, dove siamo rispetto dove siamo partiti, dove le nostre premesse sono cominciate. I collegamenti, Andreja. Quelli che tu cercavi, e mai hai smesso di fare. Attraverso l’esercizio strenuo e proficuo della resistenza, attraverso l’indagare quelle connessioni, attraverso l’indole, la morale, la fiammella riparata nel tuo cuore, ti sei salvata. Lo sai, figlia, non dovrai chiedere permesso, concedere compenso, rischiare compromessi con alcuno, alcuno che non sia tu stessa.
Una fiammella.
Per molto tempo non v’è rimasta che quella. Per centinaia di giorni non abbiamo potuto che riparare il tuo cuore dai suoi acerrimi nemici, bombe, freddo, batteri, virus, infezioni, odio, codardìa. Ma tu ti chiami Andreja, non codardìa. E questo ti è sempre stato chiaro, ci è sempre stato chiaro. Noi tutti sappiamo cosa significhi il nome che porti, noi tutti abbiamo assistito all’incarnazione che ne sei divenuta, alla sua epifania.
Il tuo cuore.
Quello che ti ha permesso di crescere, e divenire donna. Anche su quel letto crescevi, anche quando tutto pareva fermo, in te e attorno, anche quando ci dicevano della tua presenza nel mondo soltanto delle macchine e dei segnali elettronici, tu, Andreja, crescevi. Nel tuo corpo fermato, nel tuo fisico stremato, nelle lievi deformazioni che un letto di mesi causa a un essere umano, attraverso crepe e spiragli che solamente tu rintracciavi, crescevi. Concedesti a scampoli di luce di filtrare, permettesti a rantoli di respiro di annuire o rifiutare, riconoscesti la forza e la separasti dalla vigliaccheria, nutristi ogni singola tua cellula con motivi di vita e mai ti confidasti alla morte, e in qualche modo componesti una musica, una partitura complicatissima e contorta, e certo, una sonata rispettosa di silenzi e di corone sulle note consolanti, e quell’armonia, allora, ti diede tempo e modo di mettere per lungo istanti che potevano apparire spenti o vuoti, ma che così non furono mai. Fu la tua melodia, Andreja. La musica di una forma di vita che cresce nel mondo in profondità, in un luogo preciso del pianeta Terra, come radici di un albero, come la pianta che sa, e non scorda per un momento, che la sua fermezza è la sua potenza, che il suo movimento è quello delle stagioni e dei viventi che le ruotano attorno. Crescesti anche allora, e forse, in qualche anfratto della tua partitura come una cartografia, crescesti più di sempre, più che mai. Fino a liberarti.
La tua libertà.
Quella che ti permise di sfidare le mani atrofiche della morte e dei giudizi, e di prepararti finalmente a partire, un giorno. Che arrivò. Così andasti. A raggiungere il motivo per il quale studiavi, e per il quale rischiasti di morire, sotto quelle bombe, con quei libri nell’abbraccio delle tue mani. La costruzione di una scuola nella Repubblica del Congo. L’insegnamento. La radice quadrata della nostra virtualità. Là, dove vivi ormai da anni, tento di perderne il conto, tento di non decifrare. Da dove qualche volta mi scrivi, raccontandomi poche righe di te ma tante tracce di vita, l’ultima lettera è di due mesi fa, la tua grafia è ferma sulla carta: “Papà, stai bene? Non è solo una domanda, lo sai, vero? Io sì, sto bene. Il clima, come sempre, è impegnativo, ogni volta che mi sembra d’averci fatta l’abitudine, mi accorgo che me la ero inventata! I bambini sono in gamba, alcuni appena imparato a scrivere l’alfabeto riempiono intere pagine di quaderno con le lettere una dietro l’altra, a caso! E non ti dico se li faccio venire alla lavagna!… Suoni sempre? Suona sempre, la musica dice più di tutto il resto. E non far finta di niente, attendo che mi rispondi una buona volta che hai conosciuto una donna. L’amore è l’unica cosa possibile, sempre. Smettila di andare a piedi per il mondo, va bene? Ti allego una fotografia che mi son fatta scattare assieme alla mia classe di mostriciattoli che si mangeranno il mondo, santo cielo se lo faranno! Io sono quella al centro, dietro tutti quanti. Sì sì… quella lì… tua figlia, ti ricordi di me?, ah ah!.. Ti mando un abbraccio con cui puoi farci tutto quello che vuoi. Mi piacerebbe però che ci entrassi dentro, fra una cosa e l’altra. Ciao papà, Andreja”.
Andreja.
Il tuo nome in slavo significa coraggiosa. Non avremmo potuto battezzarti in modo più consono, tua madre ed io. Sei tu. Sotto assedio, tu lottasti. Quando pensavo fosse perso tutto, tu resistesti. Durante le notti e i giorni di coprifuoco, nelle lungaggini dell’agonia, tu respiravi. Lentamente, ostinatamente, ritmicamente, rabbiosamente, respiravi. Negli istanti in cui pensavo fosse insensato persino sopportare, prima ancora che combattere, tu respiravi. Mentre l’intorno moriva, tu respiravi. Dove le bombe cadevano, negli interstizi tra le raffiche dei cecchini, tu e Sarajevo respiravate. Negli istanti in cui la storia e la Storia impietrivano, tu, caparbiamente, dolcemente, sinuosamente, silenziosamente, respiravi. Ti sedusse, l’eternità, ma tu respiravi. Andreja, mia figlia, figlia mia, contro di te la morte non ha avuto scampo. Il coraggio implica la paura, come la musica il silenzio, ma dall’antitesi genera una bellezza necessaria al mondo dei vivi. Ci sono persone, in questo mondo non in un altro, che hanno corso con dei libri fra le braccia sotto le bombe, erigendo memoria e civiltà all’altezza delle proprie vite. Fra queste persone ci sei tu.
Coraggio sinonimìa con donna. Quello che ti condusse, come una marea, a quel giorno di settembre del 1993, il 16, un giovedì.
Di giovedì.
Ti risvegliasti, guardandoti attorno come l’ultimo cucciolo rimasto in un nido da cui tutti han preso il volo. Ci vollero ore perché potessi gemere di gioia al suono della tua voce, spenta da oltre dodici mesi. Ma poi giunse, quella goccia che spacca il silenzio come in una cava tenebrosa, e dicesti “dove siamo, papà?…”, e in quel plurale mi abbracciò la conferma della vita, e nella vita dell’amore, e nell’amore della resistenza, e nella resistenza della fragilità, e nella fragilità di una luce, prima striscia di sole sopra la neve. Ti strinsi la mano, contemplando il tuo viso gonfiato ma con gli occhi rimasti giocosi, aggrappati all’albero maestro nella notte dell’uragano. Guardai fuori, e difatti spioveva. Tornai a casa, quella sera, e per la prima volta dalla dismissione della mia adolescenza, da prima dell’assedio della vita, suonai il vecchio pianoforte a muro che acquistammo mamma ed io, chissà se di terza o di quarta mano, da un vecchio artigiano in una viuzza nella parte ottomana della città. Pensavo a Vedran Smailović che suonava l’adagio di Albinoni col suo violoncello fra le macerie della Biblioteca Nazionale, appena l’anno prima, ogni giorno, per ventidue giorni consecutivi, in memoria dei ventidue civili uccisi mentre facevano la fila per il pane. Pensavo a lui ma non volli cercare le note di Albinoni, e la prima anima che mi venne alla mente, dopo la tua, Andreja, fu quella di Bach. Faceva già freddo, nonostante fosse solo settembre, ma la lenta e incessante musica tua e quella di Bach mi scaldarono. E così, da allora non ho più smesso.
Mentre fuori spiove.
E ogni volta che nel mondo è giovedì.
Mi siedo al pianoforte.
E suono.
(foto di iva_keser, da pixabay)