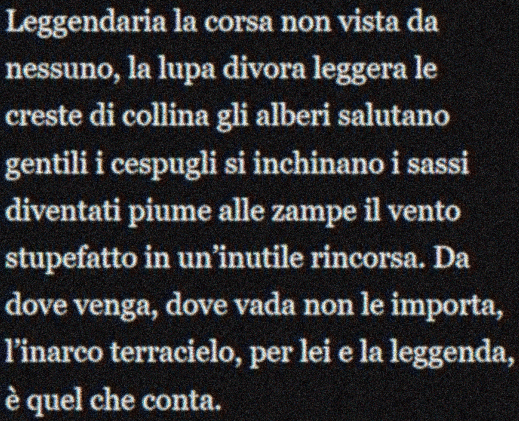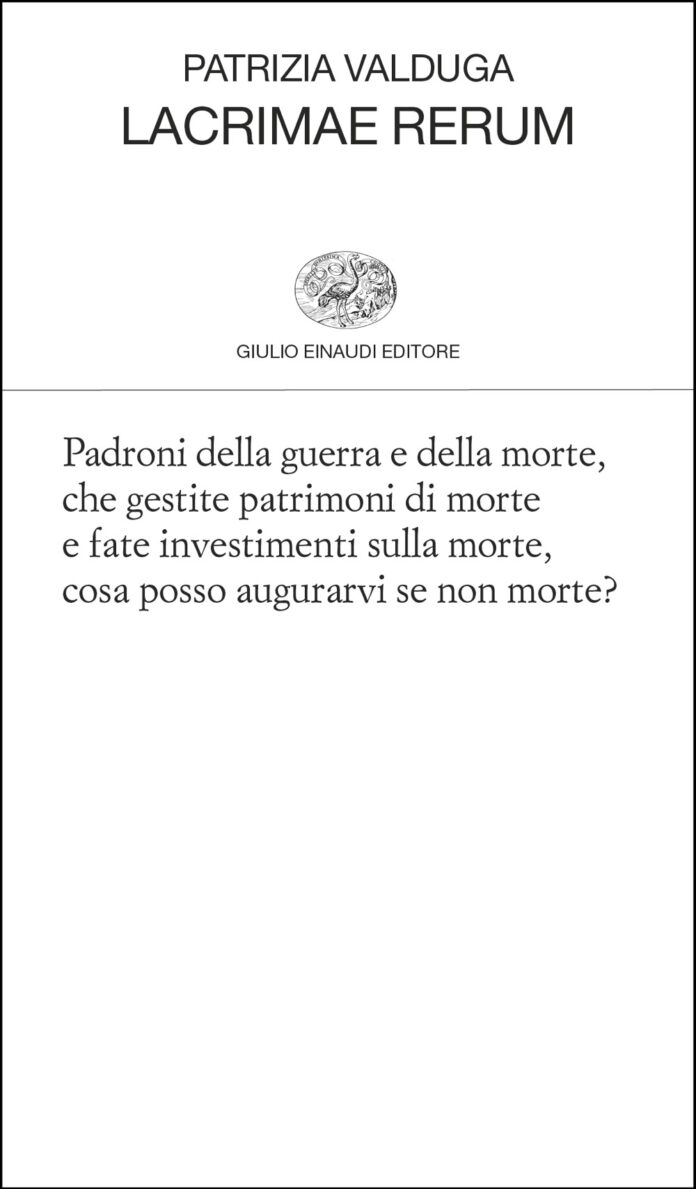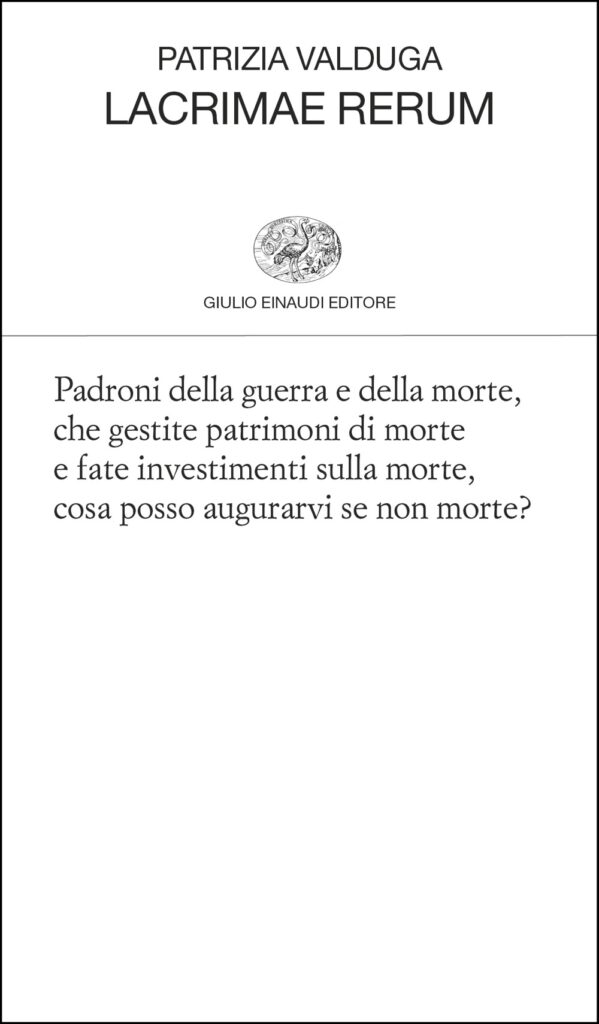di Fabio Moliterni
[Pubblichiamo uno stralcio dell’introduzione al nuovo volume di saggi critici di Fabio Moliterni, Il possibile contro il necessario. Poesia e dialettica nel Novecento (e oltre), Mimesis, 2025. Contro l’ordine del reale che si vuole ineluttabile e necessario, prendere partito per il possibile è anche prendere partito per il lavoro di certa poesia novecentesca (e oltre). Da Caproni a Scotellaro, da Fortini a Mesa, l’autore esplora nella parola poetica “la dislocazione dell’io lirico e l’ostensione che ne deriva di tracce organiche e inorganiche, di oggetti, lingue e soggetti di storia marginali, liminari, infra-ordinari, rimossi, non egemonici”.]
“Non è letteratura rivoluzionaria se non quella che è in relazione al sapere rimosso del proprio tempo”.
(Gianni Scalia)
Se la critica sembra aver perduto il suo carattere geneticamente moderno, il suo statuto euristico che storicamente nasce proprio nel corso della modernità letteraria, è perché ha smarrito quel suo presentarsi come discorso strabico e anfibio, che secondo un detto di Walter Benjamin la legittimava allo stesso tempo come strumento di diagnosi della realtà e come telescopica mira verso il futuro. I suoi margini d’azione oggi risultano forse irrimediabilmente dischiusi dalla serialità e dalle leggi del consumo, che appunto informano le “innervazioni collettive”, così le chiamava Benjamin[1], l’inconscio politico che presiede alla superfetazione algoritmica dei prodotti destinati al mercato culturale. Anziché demistificare il contemporaneo e traguardare verso un divenire possibile, la critica finisce talvolta con il mitizzare zone sempre più vaste di un presente ancora immerso nella cronaca, ovvero asseconda ciò che già nel corso degli anni Settanta Fortini indicava come la deriva del pensiero critico nelle forme del nichilismo o del “surrealismo di massa”[2]: corre il pericolo di precludersi a uno sguardo dialettico nei confronti del passato, chiude i conti con la pensabilità del futuro o del conflitto.
Non solo i modi di produrre cultura nel nostro contemporaneo, ma persino le nostre forme di vita compongono il quadro malinconico di una condizione asservita ai circuiti della competizione e della valorizzazione del profitto. L’aura dell’opera d’arte è rinvenibile ormai nella sola forma della merce, della novità a tutti costi, dietro cui si nasconde il volto del “sempre uguale”. Dovremmo concludere che rischiamo di essere insieme artefici e vittime dell’equivoco esiziale di un eclettismo metodologico senza dialettica, di un declino della responsabilità etica e civile del lavoro critico, testimoni passivi dell’abbaglio di una libertà non della ma dalla critica. E che anche il contenuto politico radicale dell’opera letteraria, in versi o in prosa, corre il pericolo di essere soggetto al rischio dell’omologazione (del marketing) nell’ambito dell’industria culturale: al rischio, insomma, di diventare merce[3].
Se le cose stanno così, risulta oggi più che mai necessaria una verifica delle tesi espresse nel Discorso su lirica e società da Adorno[4]: il quale, come sappiamo, reclamava per la poesia moderna un compito di antagonismo sociale, configurandola come “una forma di reazione alla reificazione del mondo, al dominio della merce sull’uomo”[5]. Il superamento del nichilismo e del dominio della merce si dà nella poesia in quanto forma sociale (l’arte come “antitesi sociale della società”)[6]: è una tesi paradossale se restiamo aggiogati alla sensazione di marginalità sprotetta della lirica, che vive in un deserto confinante con le logiche di mercato, da una parte, e con il rifiuto e la negazione, dall’altra. Le posizioni di Adorno andrebbero arricchite e problematizzate alla luce delle teorie di Pierre Bourdieu, le cui applicazioni nel campo poetico del Novecento risultano a mio parere uno degli acquisti più rilevanti nel dibattito critico contemporaneo (mi riferisco in particolare a certi scritti del compianto Riccardo Bonavita e a quelli più recenti di Stefano Ghidinelli)[7]. E mi piace ricordare qui anche gli studi sul “mercato delle lettere”, sulle connessioni tra i processi di produzione e distribuzione culturale, tra i meccanismi interni dell’industria editoriale e l’organizzazione del lavoro intellettuale – del lavoro del poeta, per richiamare il titolo di una prosa di Vittorio Sereni – che ha compiuto in questi decenni Gian Carlo Ferretti, scomparso nel dicembre del 2022[8].
Individuare – iuxta propria principia – le dinamiche editoriali, le strategie di potere e il sistema di interessi che sottendono il funzionamento del campo poetico del Novecento (nell’editoria istituzionale, indipendente e di ricerca, così come nei territori della rete)[9], costituisce non un corollario o un mero aggiornamento, ma una indispensabile integrazione ai discorsi che Adorno conduceva sulla poesia moderna da intendere come forma simbolica inscritta per principio nella dimensione soggettivista e individualista dell’io borghese, e tuttavia in grado di “esprime[re] [e dare forma al] sogno di un mondo in cui le cose”, sono sue parole, “stiano altrimenti”[10]. Nonostante l’attitudine tendenzialmente narcisistica, a-sociale e idiosincratica della lirica moderna, intesa come genere dell’“individuazione senza riserve”, la poesia può ancora presentarsi come “meridiana della filosofia della storia”, in quella dialettica aperta di passato, presente e futuro della quale scriveva Benjamin: essa, la poesia, “diventa qualcosa di sociale per la propria posizione contraria alla società, e tale posizione essa la ricopre soltanto perché autonoma. Cristallizzandosi in sé come qualcosa di proprio, invece di assecondare le norme sociali vigenti e di qualificarsi come ‘socialmente utile’, essa critica la società con la propria mera esistenza. […] Ciò che è asociale dell’arte”, scriveva Adorno, “è negazione determinata della società determinata”[11].
Il contenuto di verità (il “carattere doppio”) delle opere d’arte risiede nel loro destino di enigma e di paradosso[12]. Tra ironia e negazione, nel loro essere non conciliate, nella rivendicazione della propria autonomia, “con la propria mera esistenza”, le opere poetiche mostrano il proprio elemento sociale in quanto forma, costruzione, convenzione, cerimoniale[13]. La paradossalità specifica del prodotto lirico, vale a dire la soggettività che si capovolge in universalità o in totalità (Lukács), è legata al predominio della riconfigurazione linguistica e simbolica che la lirica compie per statuto nei confronti della realtà del proprio tempo[14]. Il primato della lingua nella poesia (la lingua intesa sia come prodotto sociale sia come stile individuale) costituisce la premessa del passaggio dalla soggettività all’oggettività: il suo “feticismo magico” – in altre parole la sua natura esoterica perché a-sociale, altamente individualizzata, che è implicita nelle sue radici storiche – sfugge in qualche misura al feticismo della merce[15]. “Nell’inutilità stessa dell’opera d’arte, nel suo sottrarsi anche al valore di scambio, sta il suo valore di verità. La partigianeria, che è la virtù delle opere d’arte non meno che degli uomini, vive nella profondità”, scrive Adorno, “ove antinomie sociali diventano dialettica delle forme: è nell’aiutarle a venire al linguaggio attraverso la sintesi della creazione, che gli artisti svolgono socialmente la propria parte”[16].
[…]
La linea (plurale) che ho cercato di individuare tra i testi della poesia italiana del Novecento e contemporanea tiene insieme con Adorno la propria natura di “antinomi[a]” e proiezione sociale in una dialettica delle forme tra antico e moderno: non vive solamente dentro un regime di opposizione con il passato, ma perseguirà invece con la tradizione ricongiungimenti, riconfigurazioni e negoziazioni in modi gradualmente e storicamente distinti e diversificati, mediazione dopo mediazione, conflitto dopo conflitto. Svicola dalla falsa alternativa tra la difesa del prestigio della tradizione ufficiale e la resa alla cultura bassa prodotta dal mercato. Contesta (ancora Adorno) non la letteratura del passato, ma in linea con la spinta euristica del moderno – il pathos dell’avanguardia – si oppone alla mercificazione del presente.
Lo sguardo rivolto alla tradizione del passato è qui uno sguardo carico di futuro: il futuro indicato dalla poesia si dà ancora una volta come scarto, rifiuto e critica del presente, non cessando mai di rimettere in scena e di reinventare il passato[17].
Emerge nei testi presi in esame, tra primo e secondo Novecento, in particolare in Caproni, Sereni e Roversi, un nuovo regime di relazione con l’antico, da intendere come proposta di un nuovo regime di storicità[18], che rilegge la tradizione in uno spazio testuale inedito[19]. Una nuova fenomenologia del reale, una nuova “partizione del sensibile” (Rancière), un nuovo storicismo, eretico e non allineato, che a partire dalla coappartenenza degli opposti dà forma a una dialettica senza sintesi, un intreccio di passato, presente e futuro, di immanenza e trascendenza, di materialismo della visione e promessa di futuro (una metafisica concreta[20], una nuova antropologia o storiografia poetica). E sempre in questa dialettica aperta tra tempi “altri” – tra la tradizione, il valore arcaico e rituale delle opere poetiche e la ricerca intorno a una lingua adoperata come strumento di resistenza o protesta contro un presente inospitale – si muovono alcune esperienze di scrittura che attraversano il campo letterario contemporaneo: e ridisegnano, ampliandoli, i confini di visibilità di soggetti, voci, oggetti e questioni che vengono ridotte ai margini o al silenzio dalle politiche (dalle estetiche) dell’iper-moderno.
Nelle opere di Bufalino, Giudici e Scotellaro, Fortini, Pusterla, Cattafi, Inglese e Mesa si intravedono i lineamenti di una poesia sociale – una politica della letteratura – che dà voce a un’esperienza insieme individuale e collettiva, esistenziale e relazionale, storica e metastorica. Non una profezia disarmata, ma una pratica di scrittura che parte da un’inaggirabile istanza conoscitiva, generativa, processuale e non consolatoria: dare forma alla “pienezza del reale”, una realtà latente, animata o inanimata, che è stata estromessa, rimossa e resa subalterna dal dominio della merce e dalle logiche di potere che dalla modernità arrivano al contemporaneo.
A sommuovere le microstrutture dello stile di questa linea poetica, dalla sintassi alle modalità enunciative, è un’idea debitrice della rilettura che Lukács e poi Fortini compiono intorno al concetto di totalità (di estensione del visibile o del sensibile), che era stata privilegio della civiltà classica secondo il pensiero del romanticismo e di Schiller[21]. Una poesia sociale o totale che riguadagna all’intellegibilità l’esistenza di ciò che è privo di voce e cittadinanza, perché è qualcosa che resiste e pulsa nel fondo tragico della vita, nel rimosso del nostro inconscio politico, come qualcosa di autonomo e di differente – nella dialettica delle forme della poesia – rispetto alla mercificazione della vita.
È in questi intrecci poliedrici tra il classico e le avanguardie, tra “il dialetto di chi scrive”, lo stile individuale e “la lingua di tutti”[22], tra la dimensione rituale del poetico e la sperimentazione del linguaggio, in questi andirivieni di arcaico e contemporaneo, insomma, tra mito, logos e Storia[23], che operano a mio parere alcune tra le esperienze letterarie più rilevanti del nostro tempo. la Storia ha schiacciato e sommerso”, ridotto al silenzio – senza far leva su facili giochi empatici o sulle derive apocalittiche e nichiliste: sulle richieste del mercato[24].
(…)
Se si vuole pensare a un tempo ulteriore, a un eventuale “ripristino dell’aura”, ovvero a una sopravvivenza nel futuro del potenziale sociale o comunitario della poesia, forse l’unico modo possibile è quello a cui Benjamin allude in un appunto steso mentre lavorava all’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, dove ne dà una nuova definizione: “aura è anche capacità di levare lo sguardo”. Lo sguardo a cui Benjamin pensa è quello con cui “l’oppresso risponde allo sguardo dell’oppressore”. È lo sguardo “di chi si è svegliato da ogni sogno, in cui ogni lontananza è cancellata” [26]. Scrive Giuliano Mesa: “questo silenzio che sentiamo insieme, / adesso – è adesso che sappiamo, / in questo momento che divide // ti lascio qui”.
È un nuovo sguardo da rivolgere in prima istanza nei confronti di quella “storiografia ultima” che è da sempre la poesia secondo Andrea Zanzotto: dentro e fuori del testo, il campo poetico moderno e contemporaneo allude a una storiografia ultima, perché “dà l’essenza vissuta dei tempi”, scriveva Zanzotto, “quale fu sofferta negli animi di singoli che diedero così voce anche ai molti” (riattivando ancora una volta il nesso tra soggettività e universalità, apocalisse e nuovo inizio)[27]. È l’analogo gesto “contropelo” del critico letterario che con il suo sguardo strabico e anfibio, secondo la definizione di Walter Benjamin dalla quale siamo partiti, rinviene nel passato l’allusione a un futuro inadempiuto, e nelle rovine dei tempi presenti scorge le tracce di un “che fare”: il possibile contro il necessario.
*
[1] W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936). Dopo la prima pubblicazione in “Zeitschrift für Sozialforschung”, edita a Parigi da Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin stesso, questa versione è stata criticata come “censoria” da Rosemarie Heise per alcune manipolazioni del testo da parte di Horkheimer, in particolare per l’eliminazione della Premessa al saggio (cfr. R. Heise, Un ignoto lascito di Walter Benjamin, in “Carte segrete”, n. 9, gennaio-marzo 1969, pp. 23-37). Il saggio ha avuto cinque stesure (l’ultima nel 1939), che sono state tutte tradotte a cura di F. Desideri e M. Montanelli: W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Donzelli, Roma 2019. Per tutto questo rimando all’ottimo Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera d’arte, a cura di M. Montanelli, M. Palma, Quodlibet, Macerata 2016.
[2] F. Fortini, Il movimento surrealista, a cura di L. Binni, Garzanti, Milano 1977. Vedi anche F. Fortini, Insistenze. Cinquanta scritti sui nostri dilemmi: memoria difficile e oblio organizzato, anarchia conformista, dissenso e reazione. Gli imperi e noi, Garzanti, Milano 1985. Per un’analisi sui discorsi di Fortini intorno alla metamorfosi del surrealismo da corrente d’avanguardia ad alfabeto generico della comunicazione di massa: D. Balicco, Fortini, la mutazione e il surrealismo di massa, in Studi in onore di Romano Luperini, a cura di P. Cataldi, Palumbo, Palermo 2010, pp. 467-487.
[3] Cfr. L. Boltanski, A. Esquerre, Arricchimento. Una critica della merce, tr. it. di A. De Ritis, Il Mulino, Bologna 2019; G. Lipovetsky, J. Serroy, L’estetizzazione del mondo. Vivere nell’era del capitalismo artistico, tr. it. di A. Inzerillo, Sellerio, Palermo 2017. Ma per una sintesi dei cambiamenti sociali e storici decisivi per una analisi possibile del presente nel tardo capitalismo, come “tentativo autenticamente dialettico di pensare il nostro presente dentro la Storia” (Jameson), restano imprescindibili i lavori di F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, tr. it. di M. Manganelli, Fazi, Roma 2007; M. Fischer, Realismo capitalista, trad. it. di V. Mattioli, Nero, Roma, 2017 (“Vale la pena ricordare che anche quello che oggi va sotto la voce di ‘realistico’ fino a non molto tempo fa era ritenuto ‘impossibile’”, p. 52).
[4] T.W. Adorno, Discorso su lirica e società, in Note per la letteratura. 1943-1961, Einaudi, Torino 1979, pp. 46-64. Il saggio di Adorno (Rede über Lyrik und Gesellschaft), pubblicato nel 1957 e poi nel primo volume di Noten zur Literatur del 1958, risaliva a una trasmissione radiofonica del 1956. Si rimanda anche a T.W. Adorno, Teoria estetica, nuova edizione italiana a cura di F. Desideri, G. Matteucci, Einaudi, Torino 2009 (ma qui si citerà dall’edizione Einaudi del 1977: T.W. Adorno, Teoria estetica, a cura di G. Adorno, R. Tiedemann, tr. it. di E. De Angelis). Sulle tesi di Adorno ho tenuto presente: P. Zublena, Il paradosso (o i paradossi) della lirica secondo Adorno. Riflessioni su poesia e politica a partire dal Discorso su lirica e società, in “L’Ulisse”, n. 22, 2019, pp. 95-100.
[5] T.W. Adorno, Discorso su lirica e società, cit., p. 49.
[6] Id., Teoria estetica, cit., p. 15; “L’estraneità al mondo è un momento dell’arte; chi percepisce l’arte altrimenti che come cosa estranea, non la percepisce affatto”, ivi, p. 308.
[7] Cfr. R. Bonavita, Traduire pour créer une nouvelle position: La trajectoire de Franco Fortini de Eluard à Brecht, in J. Meizoz (a cura di), La Circulation internationale des littératures, in “Études de lettres”, nn. 1-2, 2006, pp. 277-291; Id., La fatica dell’eresia. Franco Fortini, “Il Politecnico” e la Guerra fredda, in N. Novello (a cura di), La sfida della letteratura. Scrittori e poteri nell’Italia del Novecento, Carocci, Roma 2004, pp. 13-152; A. Baldini, M. Sisto (a cura di), Lo spazio dei possibili. Studi sul campo letterario italiano, Quodlibet, Macerata 2024; P. Casanova, La République mondiale des lettres, Seuil, Paris 1999, tr. it. di C. Benaglia, La repubblica mondiale delle lettere, Postfazione di F. Moretti, Nottetempo, Milano 2023. All’interno del gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano che dà vita all’annuario “Tirature”, diretto fino al 2020 da Vittorio Spinazzola, vedi, in particolare per il campo poetico del Novecento: E. Gambaro, S. Ghidinelli (a cura di), Come circola la poesia nel secondo Novecento. Mappare il campo da vicino e da lontano, Ronzani, Vicenza 2023.
[8] Si veda, almeno: G.C. Ferretti, Il mercato delle lettere. Editoria, informazione e critica libraria in Italia dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, il Saggiatore, Milano 1994². Rimando a I. Piazza, Gian Carlo Ferretti. Un’eredità raccolta e una mancata, in “Oblio”, XIII, dicembre 2023, pp. 205-212.
[9] Cfr. F. Guglieri, M. Sisto, Verifica dei poteri 2.0. Critica e militanza letteraria in Internet (1999-2009), in “Allegoria”, n. 61, 2010, pp. 153-174.
[10] T.W. Adorno, Discorso su lirica e società, cit., p. 49.
[11] Id., Teoria estetica, cit., pp. 376-377.
[12] “L’immagine enigmatica dell’arte è la configurazione di mimesi e razionalità. Il carattere di enigma è un carattere derivato. Dopo la perdita di ciò che in lei doveva una volta esercitare una funzione magica, poi di culto, resta l’arte. […] Per questo il carattere enigmatico delle opere non è la loro ultima parola ma ogni opera autentica propone anche la soluzione del suo insolubile enigma. In suprema istanza le opere d’arte sono enigmatiche non per la loro composizione ma per il loro contenuto di verità. […] La forma estrema in cui il carattere di enigma può essere pensato è se il senso stesso ci sia o no. […] Esigendo la soluzione, l’opera rimanda al contenuto di verità”, ivi, pp. 215-216.
[13] Sul negativismo dialettico insito nell’estetica di Adorno, tra natura inconciliata dell’arte e resistenza al reale (nelle opere di Joyce, Kafka e Beckett), cfr. T. Perlini, Attraverso il nichilismo. Saggi di teoria critica, estetica e critica letteraria, Aragno, Torino 2015.
[14] “La forma […] è l’antibarbarico dell’arte; attraverso la forma l’arte partecipa alla società civilizzata, che con la propria esistenza critica. […] La forma tenta di far parlare il singolo attraverso il tutto”, T.W. Adorno, Teoria estetica, cit., pp. 242-243.
[15] “[L’arte] può superare il mondo disincantato, cancellare l’incanto che il mondo produce mediante il prepotere della propria manifestazione, mediante cioè il carattere feticistico della merce. Le opere d’arte, esistendo, postulano l’esistenza di un non esistente ed in tal modo vengono a conflitto con la reale inesistenza di questo. […] Poiché è vero solo ciò che non si adatta a questo mondo”, ivi, p. 100.
[16] Ivi, p. 311, p. 387 (mio il corsivo).
[17] Cfr. J. Rancière, La partizione del sensibile. Estetica e politica, DeriveApprodi, Roma 2022, p. 35. E cfr. T. Eagleton, How to Read a Poem, Blackwell, Oxford 2007, p. 16: “The slogan of a radical literary criticism, then, is clear: Forward to antiquity!”.
[18] Anche nel significato che ne dà F. Hartog, Chronos. L’Occidente alle prese con il tempo, tr. it. di V. Zini, Einaudi, Torino 2022. Cfr. anche R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, trad. it. di A. M. Solmi, Clueb, Bologna 2007.
[19] “La posizione dell’arte a noi contemporanea nei confronti della tradizione […] è condizionata dal mutamento stesso all’interno della categoria tradizione. […] La riflessione estetica non è indifferente nei confronti dell’intreccio di vecchio e nuovo […]. Quando si verificano corrispondenze col passato, ciò che torna diventa qualitativamente altro. […] Ad un’umanità liberata dovrebbe toccare, purificata, l’eredità del proprio passato. Ciò che una volta è stato vero in un’opera d’arte ed è stato smentito nel corso della storia, può tornare ad aprirsi solo quando sono mutate le condizioni per causa delle quali quella verità dovette essere cancellata: tanto profonda è in estetica la compenetrazione del contenuto di verità e di storia”, T.W. Adorno, Teoria estetica, cit., p. 36; p. 39; p. 62; p. 70.
[20] Sulle connessioni tra “l’Impossibile” che deve accompagnare “il Possibile” e “il Reale”, tra conoscenza, immaginazione (utopica) e divenire, in una cornice teoretica evidentemente più ampia che interroga i rapporti tra filosofia e scienza sulla scorta di Pavel Florenskij (Allo spartiacque del pensiero. Lineamenti di una metafisica concreta), cfr. M. Cacciari, Metafisica concreta, Adelphi, Milano 2023.
[21] Cfr. R. Bonavita, L’anima e la storia. Struttura delle raccolte poetiche e rapporto con la storia in Franco Fortini, a cura di T. Mazzucco, Prefazione di L. Lenzini, Premessa di G. Benvenuti, Biblion, Milano 2017, p. 352: “[Un’idea di poesia come] aspirazione a un ordine, […] tensione verso una forma che […] ha un significato che va al di là della sua sostanza letteraria, e rappresenta l’ultimo cortocircuito tra etica, storia, politica e ricerca estetica”.
[22] E. Testa, Pietre di sosta. Poetica e poesia, Manni, Lecce 2024, p. 62.
[23] “La via storica dell’arte […] è la via della critica del mito, e, allo stesso titolo, la via verso la salvezza del mito: ciò di cui l’immaginazione si ricorda viene da questa rafforzato nella sua possibilità. […] L’inarrestabile movimento dello spirito verso ciò che gli è sottratto parla in arte in favore di quanto antichissimo è andato perduto”, T.W. Adorno, Teoria estetica, cit., p. 201.
[24] P. Zublena, Il paradosso (o i paradossi) della lirica secondo Adorno. Riflessioni su poesia e politica a partire dal Discorso su lirica e società, cit., p. 99. Vedi anche F. Muzzioli, Teoria e radicalità. Una rassegna non rassegnata tra le posizioni letterarie attuali, in “Moderna”, n. 1, 2002, pp. 29-44.
[25] “Il momento storico è costitutivo delle opere d’arte: le opere autentiche sono quelle che si affidano senza riserve al contenuto materiale storico del loro tempo e senza la presunzione di essere al disopra del tempo. Esse sono la storiografia, a sé stessa inconscia, della loro epoca […]. Il contenuto di verità delle opere d’arte è storiografia inconscia, solidale con quel che fino ad oggi è sempre di nuovo soccombente. […] [Il] carattere […] [del]l’arte […] [è] di essere storiografia inconscia, anamnesi di ciò che è stato sconfitto, rimosso, e che forse è possibile”, T.W. Adorno, Teoria estetica, cit., pp. 307-322; p. 431 (miei i corsivi). Fino all’interrogativo col quale terminava la sua Teoria estetica: “Ma che cosa sarebbe mai l’arte come storiografia se scotesse via da sé la memoria del dolore accumulato?”, p. 434.
[26] “La stessa decadenza dell’aura finisce per essere misurata all’interno del discorso di classe; Benjamin affida infatti alla lotta di classe il compito di ristabilire quella lontananza – carica di conflitto – da cui si genera l’esperienza dell’aura”, D. Gentili, La politicizzazione dell’arte. Individuo, massa, mercato, in M. Montanelli, M. Palma (a cura di), Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera d’arte, cit., p. 150.
[27] A. Zanzotto, In questo progresso scorsoio. Conversazione con Marzio Breda, Garzanti, Milano 2009, p. 58.



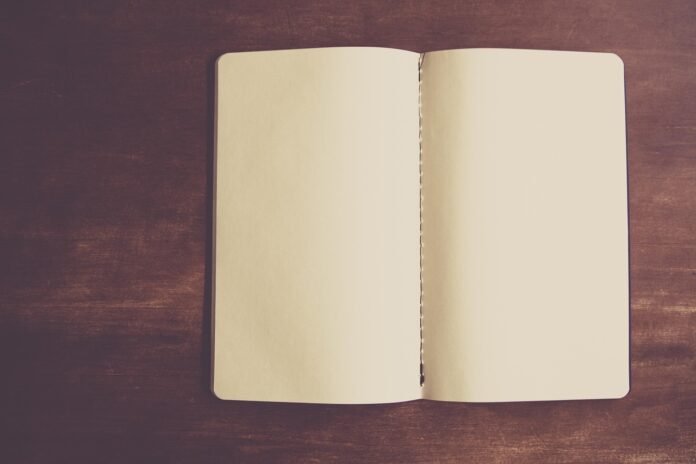
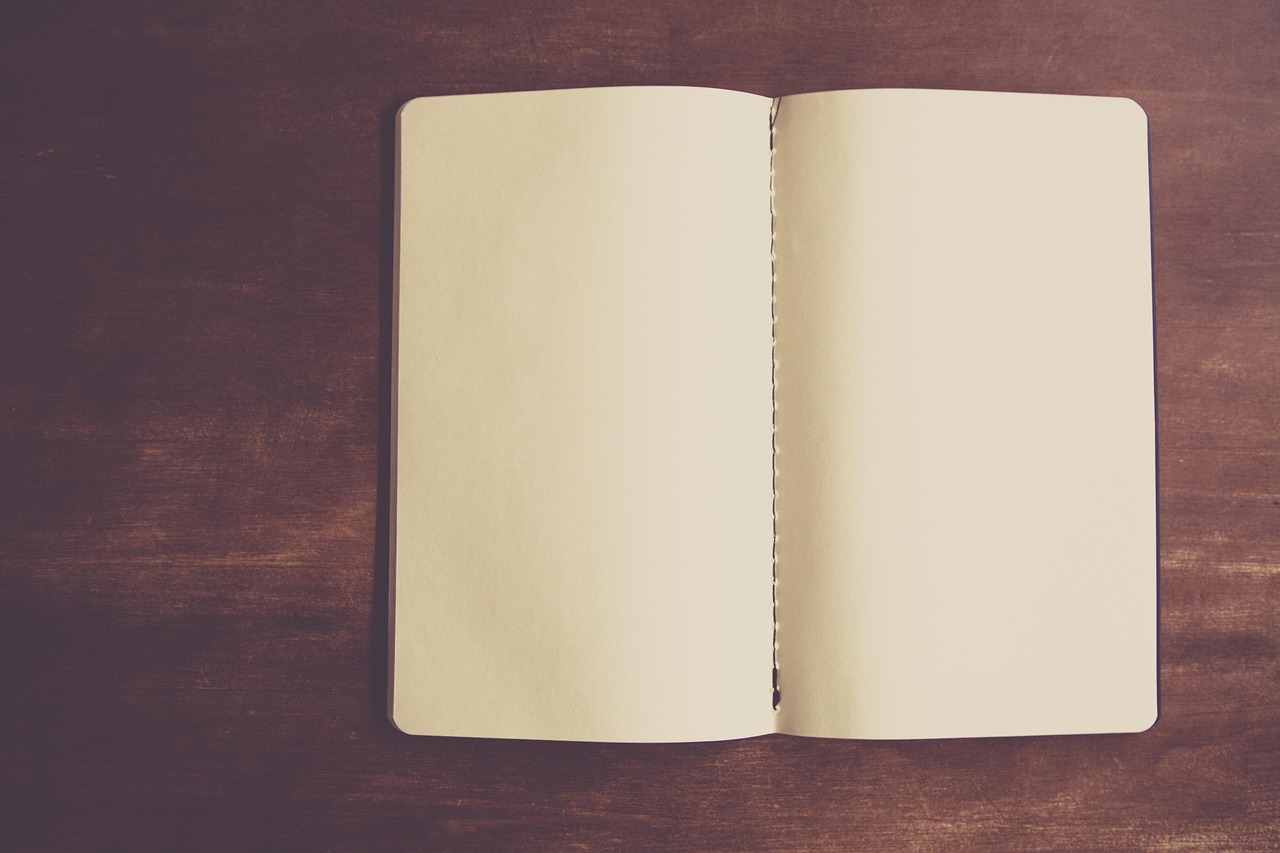










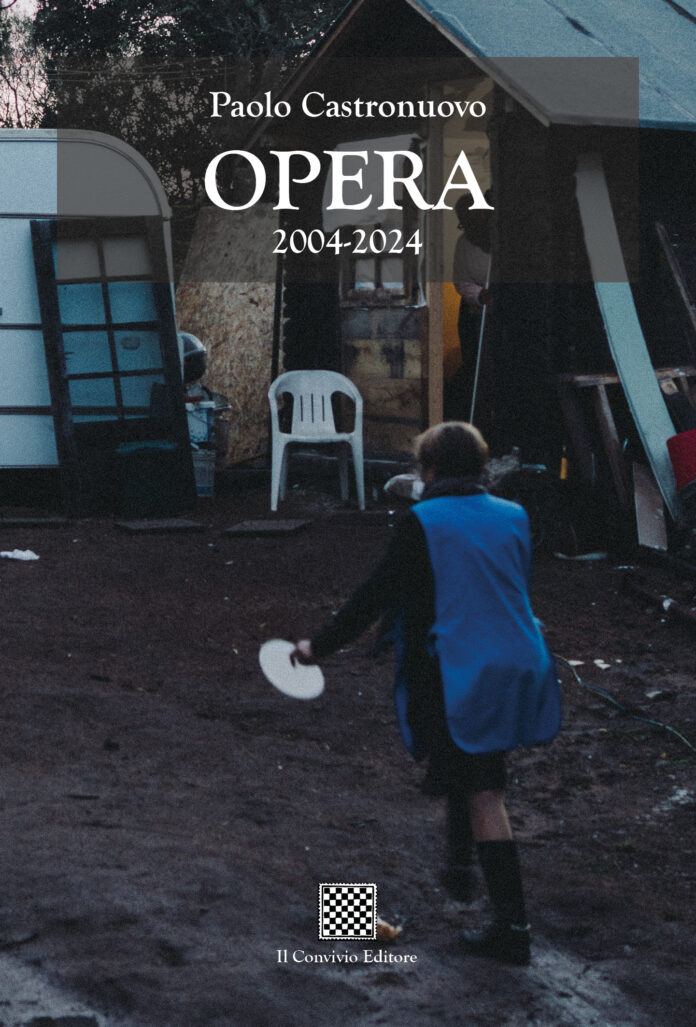


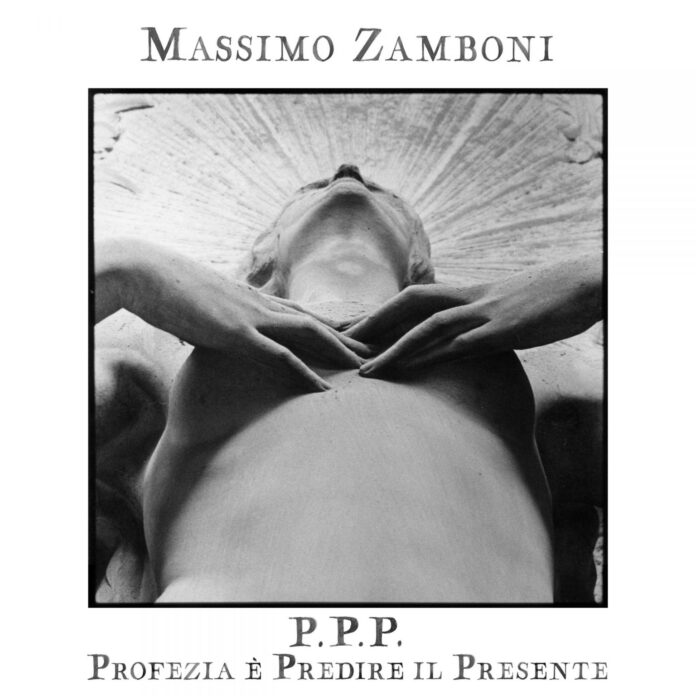
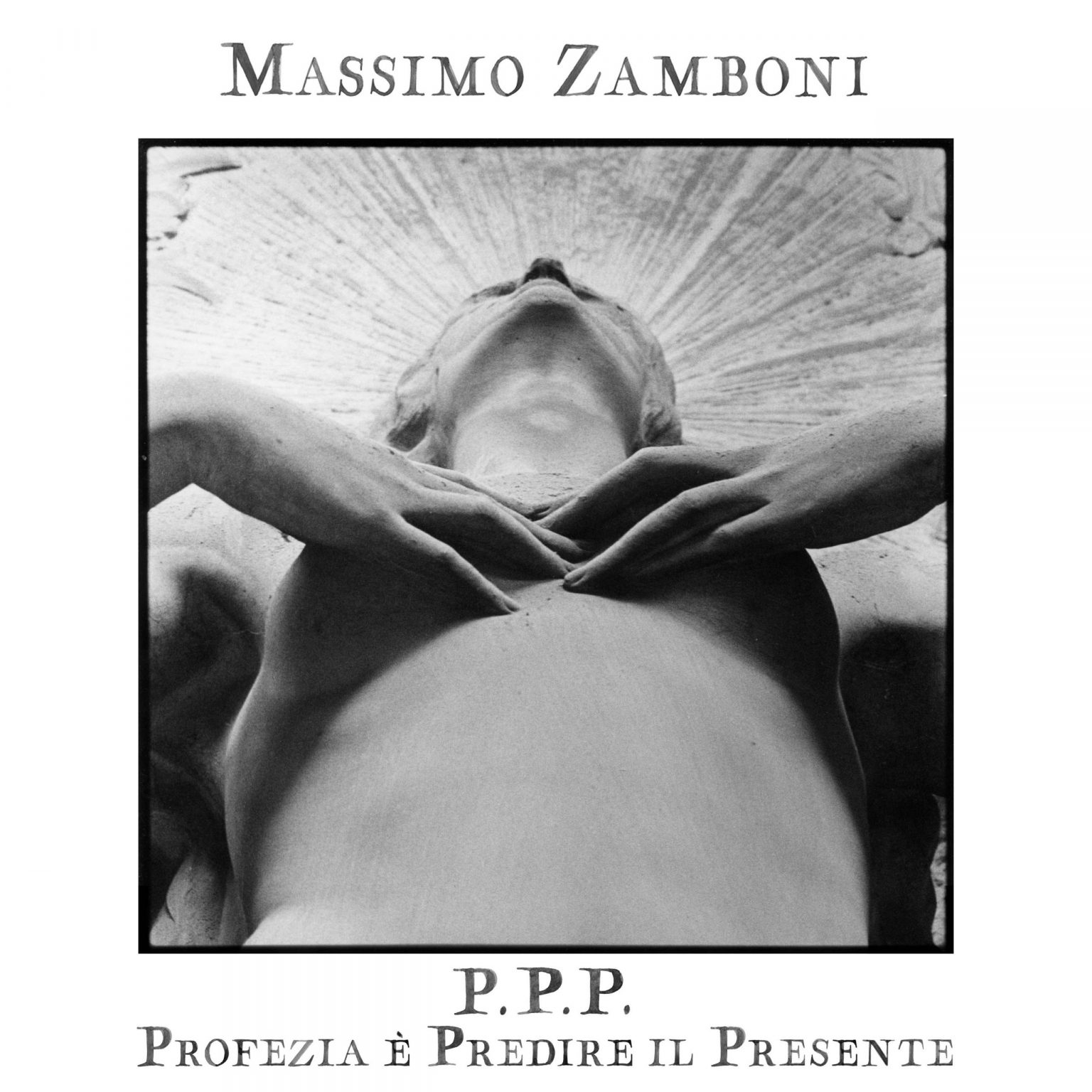 di Francesco Memo
di Francesco Memo Ma torniamo allo spettacolo P.P.P e a Massimo Zamboni. Il secondo movimento, quello centrifugo, prende la forma di una rilettura pasoliniana del proprio repertorio. È come se Zamboni guardasse alle proprie canzoni come si guarda a pianeti sconosciuti, perché illuminati in maniere inedita dalla luce riflessa della stella-Pasolini. Qui il cantautore reggiano lascia affiorare quanto di pasoliniano – ed è molto – c’è nella sua produzione, selezionando da album vicini e lontani (si potrebbero aggiungere quelli con i CSI) una manciata di canzoni che rimandano a Pasolini sia direttamente sia indirettamente.
Ma torniamo allo spettacolo P.P.P e a Massimo Zamboni. Il secondo movimento, quello centrifugo, prende la forma di una rilettura pasoliniana del proprio repertorio. È come se Zamboni guardasse alle proprie canzoni come si guarda a pianeti sconosciuti, perché illuminati in maniere inedita dalla luce riflessa della stella-Pasolini. Qui il cantautore reggiano lascia affiorare quanto di pasoliniano – ed è molto – c’è nella sua produzione, selezionando da album vicini e lontani (si potrebbero aggiungere quelli con i CSI) una manciata di canzoni che rimandano a Pasolini sia direttamente sia indirettamente.