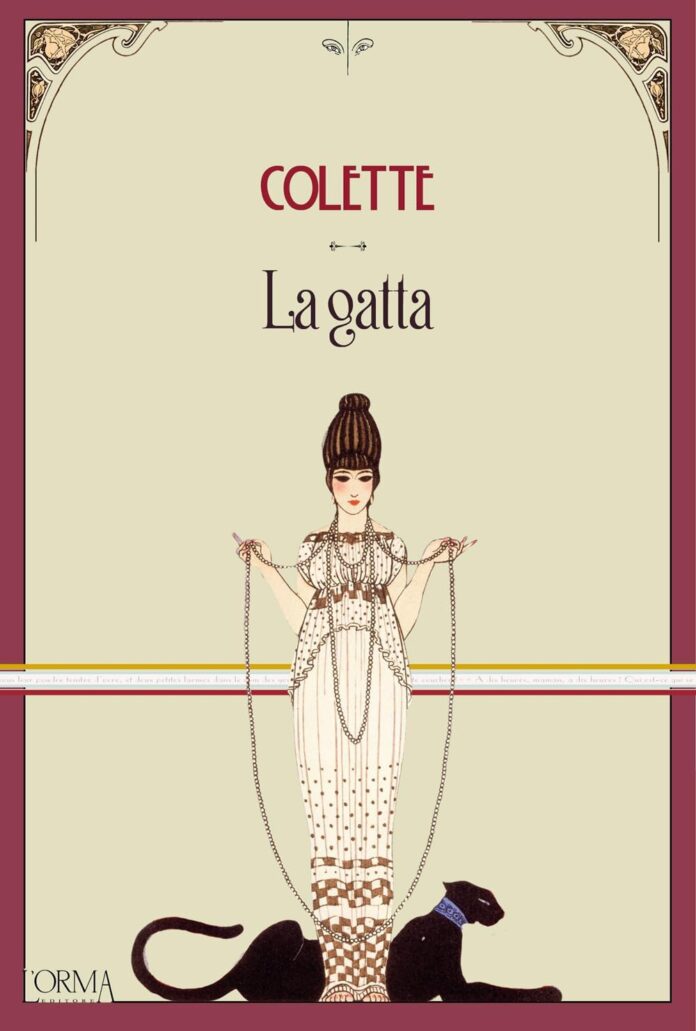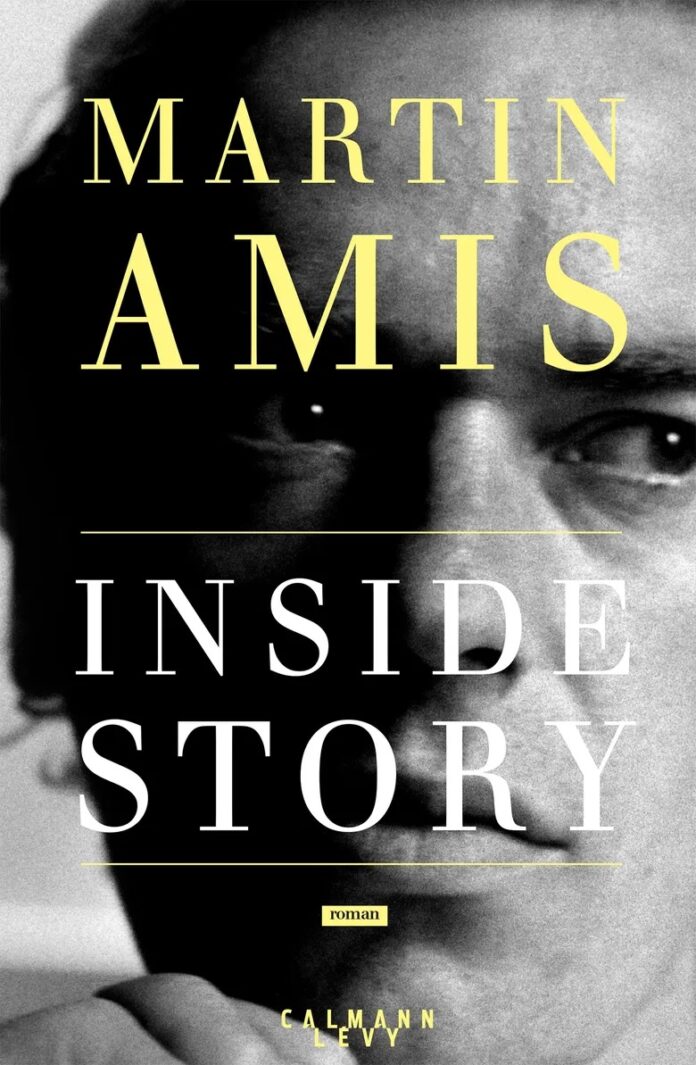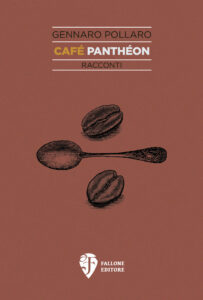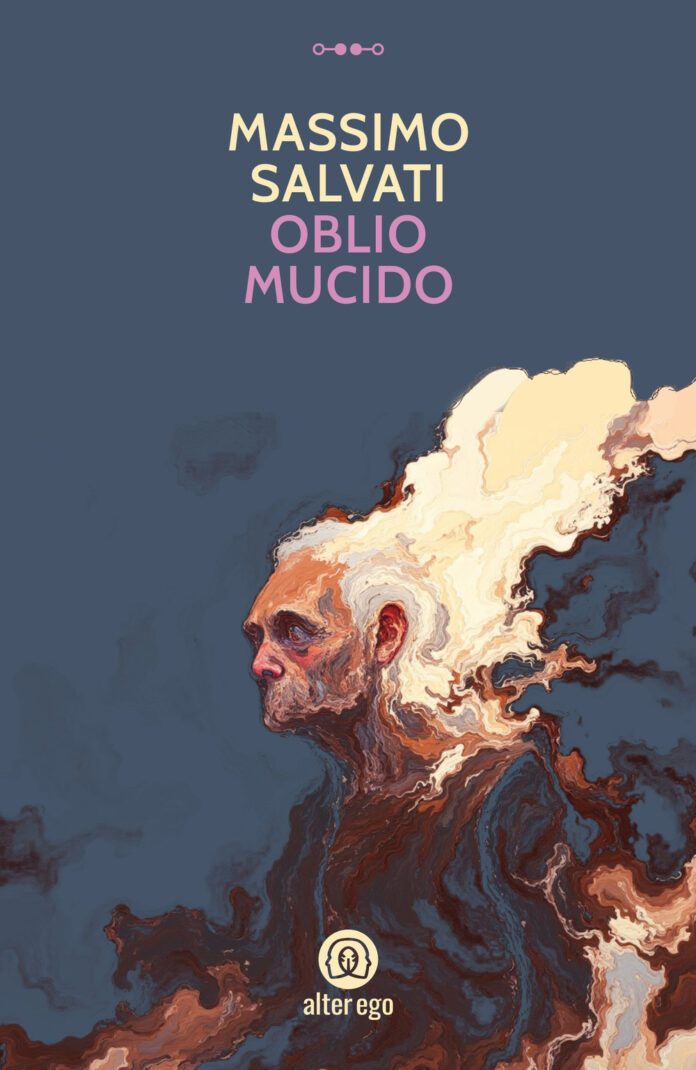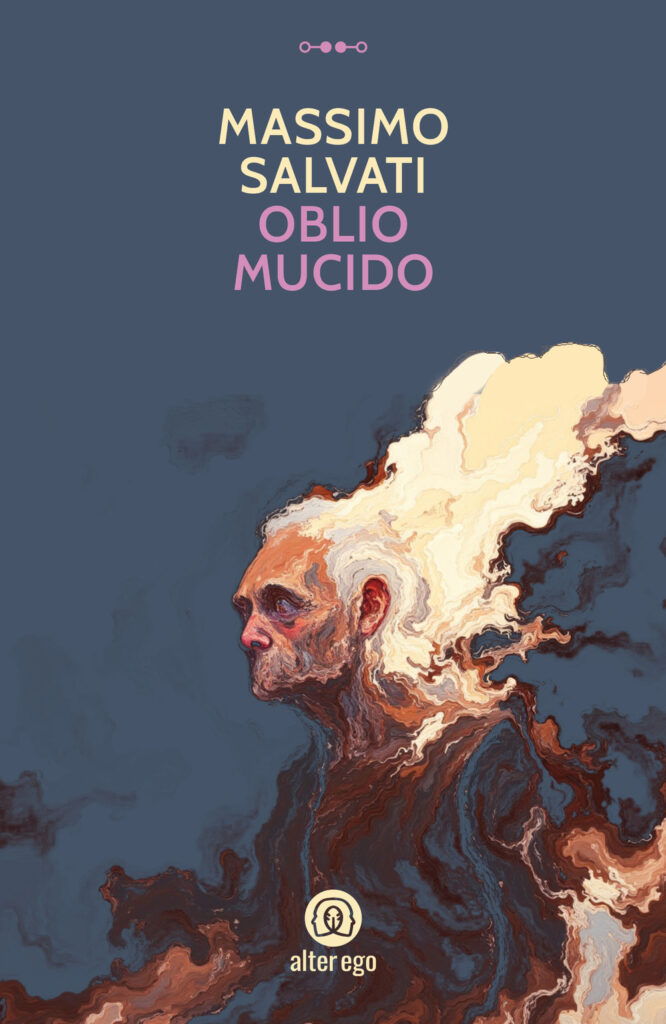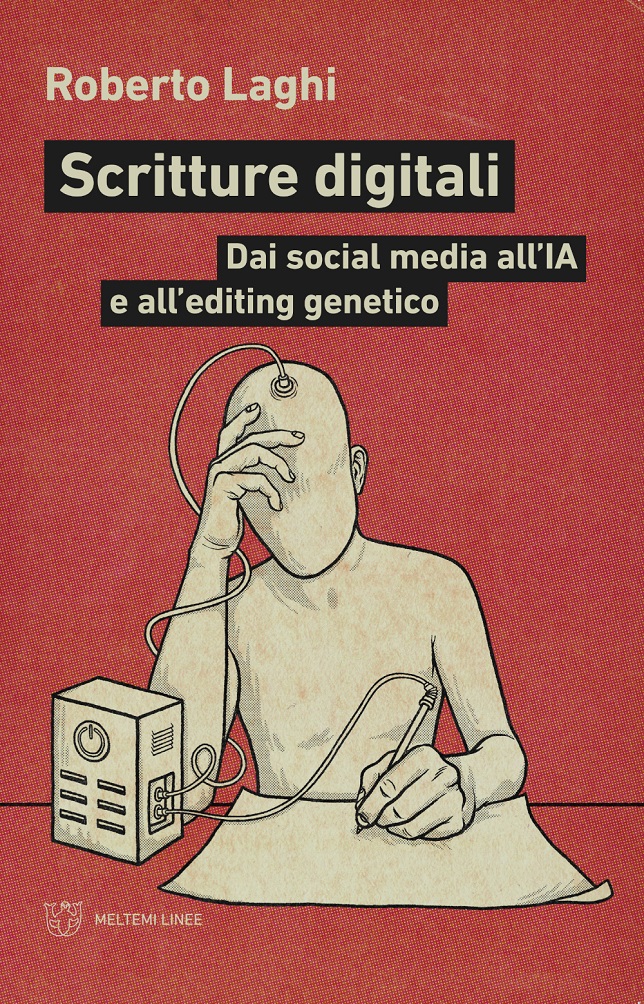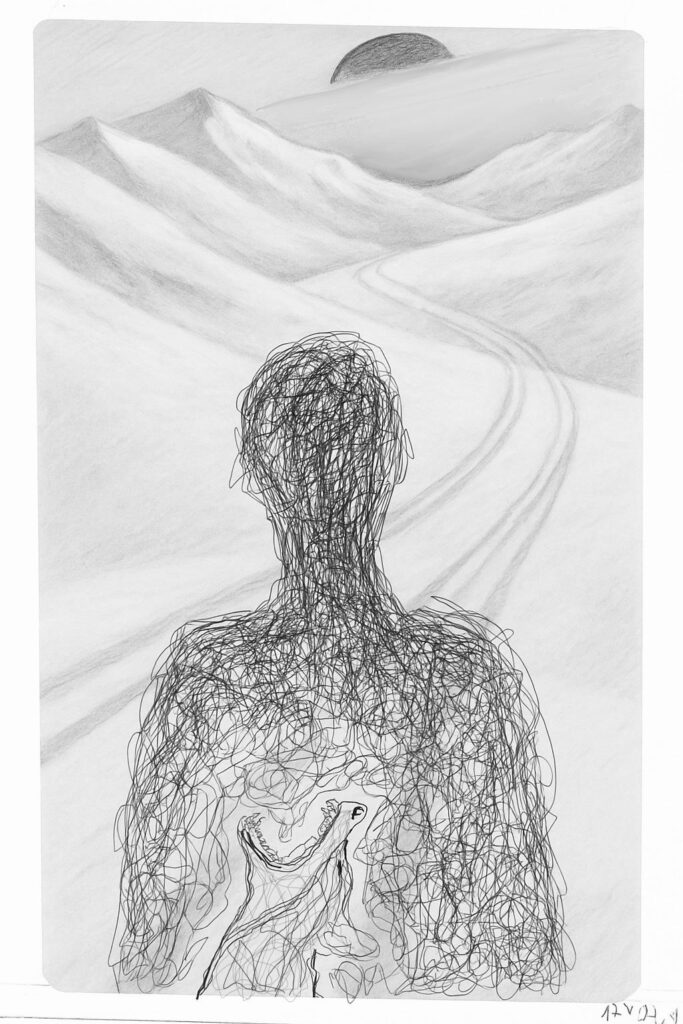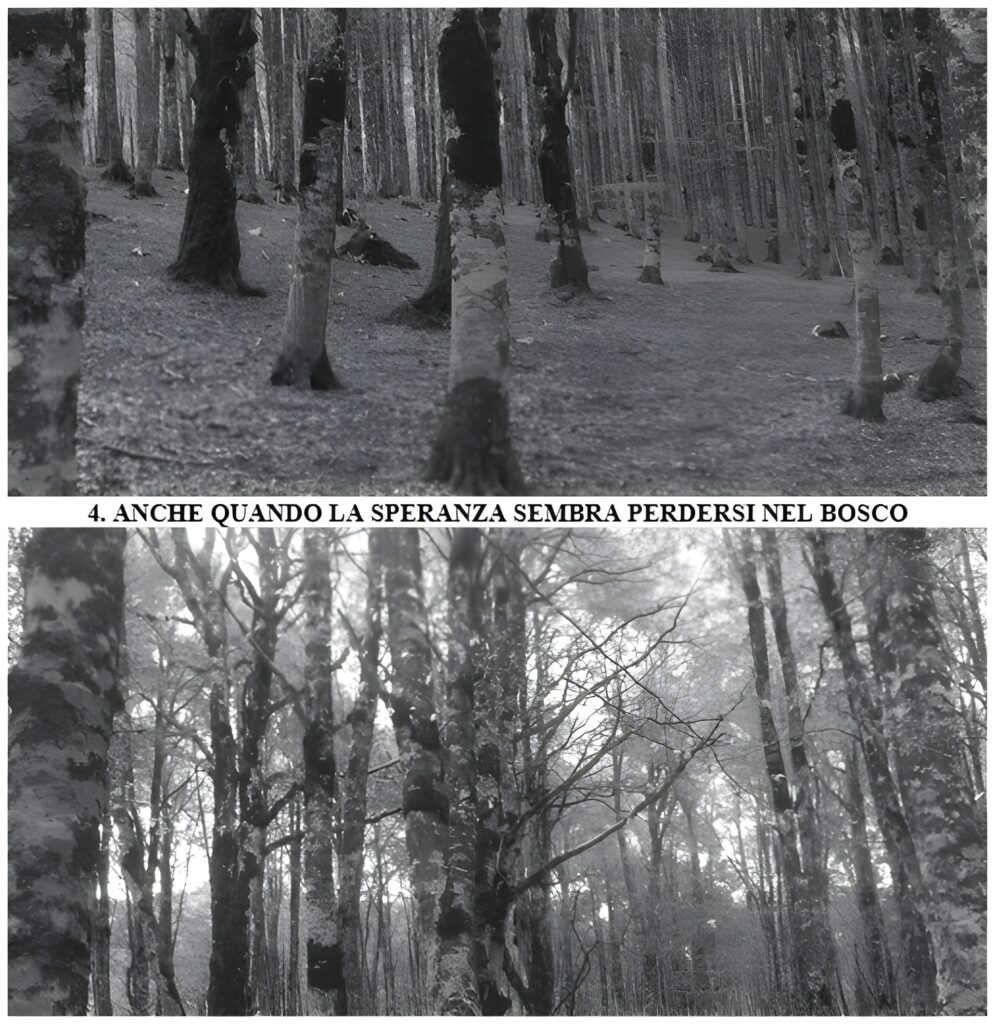di Francesco Ciuffoli
une lecture italienne de l’affaire
***
cronostoria degli eventi che hanno portato a questo articolo:
11 | 2008 – 09 | 2011 – 04 | 2018 – 10 | 2024 – 12 | 2024 – 02 | 2025 – 04 | 2025
7 date riportanti gli eventi descritti nel testo e quelli più nascosti, personali.
7 saranno anche le sezioni che comporranno dunque questo quasi-manifesto.
+ + + + + + + + +
indice in cui tradiamo già da ora quanto detto
Parte 1
Section 5. La questione rivoluzionaria è ormai una questione musicale
Section 6. Appendice #2. Ai fotografi
Section 10. Workbook
Section 1. 26 indici per un indirizzo
Parte 2
Section 8. Piccolo manifesto di una nuova estetica
Section 4. Appendice #1. Ai poeti
Section 2. Il punto di vista estetico
Section 3. Poesia, capanne, skené
Parte 3
Section 7. Un epilogo. A tutte le persone che amo
Section 9. A questa cosa mai accaduta, mai appianata
+ + + + + + + + +
Section 7. Un epilogo. A tutte le persone che amo
nella mia vita ho registrato – dai sedici ai ventisei – così poco di tutte quelle foto che ho fatto? nulla, sicuro non immagini
***



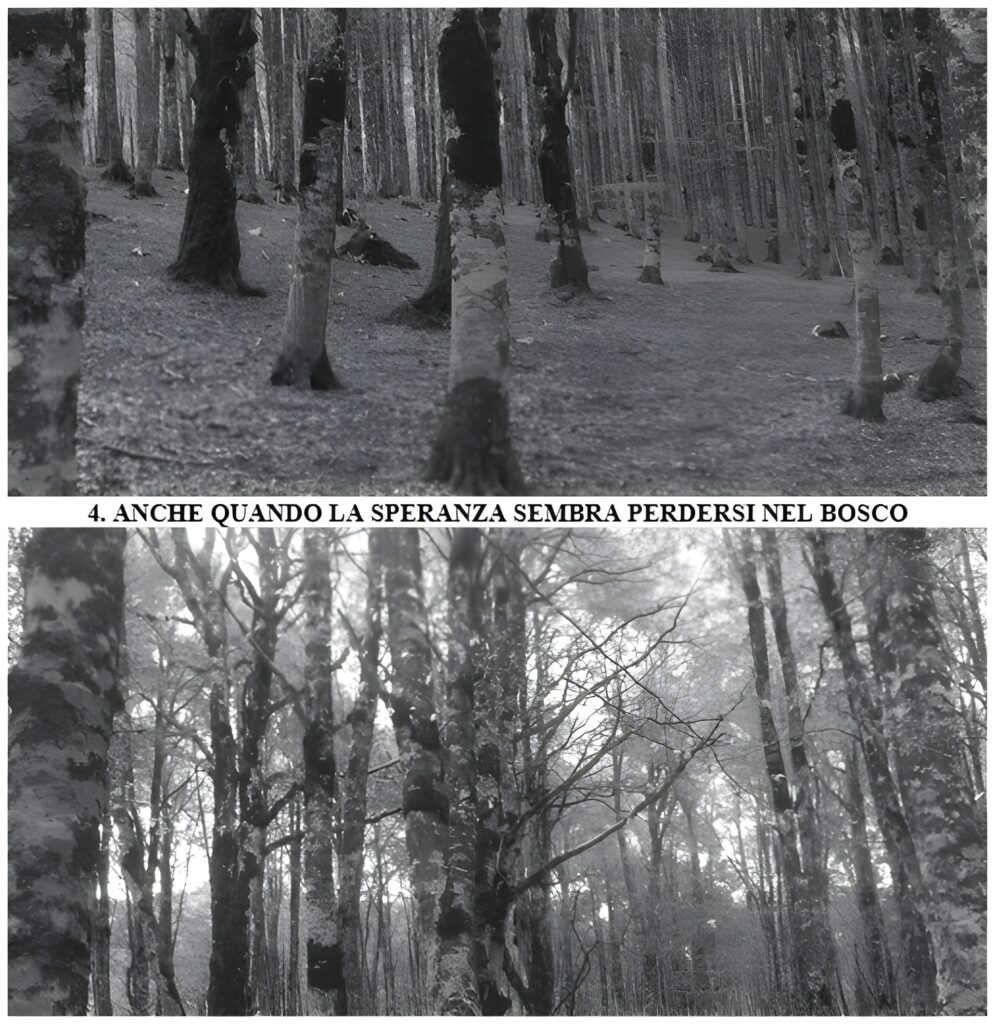

+ + + + + + + + +
Section 9. A questa cosa mai accaduta, mai appianata
da un libro che non è finito, da un titolo di un libro che ho letto
***
Il pacifismo funziona quando si muove parallelamente alla paura del governante.
Ogni protesta pacifica è stata sempre accompagnata parallelamente da una lotta.
Ci sono molti più feriti e morti dietro King, Mandela e Gandhi che dietro il 68’ o il 77’.
Il pacifismo non produce niente. La pace infatti l’hanno fatta Stati Uniti, Israele.
***
I
Tutto ciò che cerco è un’atmosfera familiare, sentirmi a casa,
rivivere ancora tutti quei momenti con qualcuno
tutti quelli che poi penso io-solo ho perduto
dove, come, oggi – mi chiedo –
perché a me perché
.
.
.
.
I tre libri fondamentali del buon reporter:
Gaia Scienza; Essere e tempo; Differenza e ripetizione.
A cui potremmo aggiungere: Messa in scena,
Ritmanalisi, Lefebvre.
.
.
.
.
oggi sento di non amarmi più come un tempo,
non che io poi ne sia mai stato in grado
non che l’abbia fatto
ma è questione (forse) anche qui per cui bisogna
esserne predisposti
guardarsi, attendere, sorridere (sempre)
non sembra?
.
.
.
.
Vedi. È come se certe volte
Affacciandoti su quanto accade nel mondo
Si potesse scorgere ogni dettaglio
Come se tutto fosse ripetibile
A quel punto è l’aura delle cose, nella loro disposizione
e in-disposizione che ci permette di
comprendere e analizzare, prendere la decisione giusta
nell’esatto momento
.
.
.
.
da quando la borghesia ha conquistato il sole
In questo infinito crescendo: emancipazione, lotta-
politik e resistenza,
estetica ≠ estetizzazione; l’estetizzazione è il problema
nella pratica; dovrebbe
essere come vivere; tra due mondi
nell’intersezione viva delle cose; in fondo è
l’in-mondo che ti permette di: unire i pezzi; provare
a cucirne le parti
.
.
.
.
Nel caos significativo delle cose
Oggi re-imparerai così a scrivere
poco per volta
Questo è lo stato del consuntivo
- Bilancio c. (o il consuntivo s.m.), rendiconto dei risultati di un dato
periodo di attività di un ente o di un’impresa; estens..
“fare il c. della propria vita”
- Attinente al consumo di godimento, in antitesi al consumo
riproduttivo.
“impieghi c.”
In somma, un giro di chiavi
che si divora (di continuo)
.
.
.
.
«No, il 4 non sto andando. Ho paura della DASPO, ho paura che con il fermo
mi giochi anche la possibilità di trovare casa, lavoro, per davvero.
.
.
.
.
Il riassorbimento simbolico –rappresentazionale e poi semantico è qui
sempre previsto dalla logica del valore astratto dal Capitale,
non ti far fregare. Non farti / fregare mai.
Te ne prego
.
.
.
.
La lotta non deve Essere, deve Passare
anche da questo. La lotta
come attraversamento
per il cambiamento
.
.
.
.
In fondo, non era Deleuze che diceva / affermare l’esistenza
solo nel movimento; da uno stato a un altro, il ripetersi dell’identico;
il mai più di ogni preciso momento che seppur confuso esiste ed è
esistito senza “se”, senza “ma”; l’annullamento
della dialettica (hegeliana), del turn
on / off
T flip-flop
.
.
.
.
Esistono numerose applicazioni dei flip-flop a T nei sistemi digitali, ne elenchiamo alcune di seguito:
Contatori: i flip-flop a T vengono utilizzati nei contatori. I contatori contano il numero di eventi che si verificano in un sistema digitale.
Memorizzazione dei dati: i flip-flop a T vengono utilizzati per creare una memoria che memorizza i dati quando l’alimentazione viene interrotta.
Circuiti logici sincroni: i flip-flop a T possono essere utilizzati per implementare circuiti logici sincroni, ovvero circuiti che eseguono operazioni su dati binari in base a un segnale di clock. Sincronizzando le operazioni del circuito logico con il segnale di clock utilizzando i flip-flop a T, il comportamento del circuito può essere reso prevedibile e affidabile.
Divisione di frequenza: viene utilizzata per dividere la frequenza di un segnale di clock per 2. Il flip-flop commuta la sua uscita ogni volta che il segnale di clock passa da alto a basso o da basso ad alto, dividendo quindi
la frequenza di clock per 2. Registri a scorrimento: i flip-flop a T possono essere utilizzati nei registri a scorrimento, che vengono utilizzati per spostare i dati binari in una direzione.
.
.
.
.
Nel presente di questa situazione
unisci il ricordo, l’emozione.
La funzione immaginifica fa miracoli.
*
II
Hai visto il morto? Mi dicono nell’atrio del condominio. Scopro così, il pomeriggio di quello stesso giorno, che sotto casa c’è morto, un uomo. L’hanno visto uscire dal palazzo affiatato, pazzo, correva ovunque, ha provato a rubare una bicicletta, poi l’hanno fermato, poco prima che si accasciasse da solo a terra, prima di morire di crepacuore. Io non ho visto o sentito niente, ero preso da altro, dal mio conflitto interno tra fare e dire.
Non ho visto nulla di ciò che era successo, né avrei neanche potuto dal lato del palazzo sui cui affaccio. Mi sono comunque, anche qui, disinteressato della faccenda, non mi interessa granché di questa storia. E poi, io non ho visto né sentito niente. Anche affacciarmi adesso, a posteriori, non mi interessa persino nel momento in cui mi sono trovato nell’atrio con il cadavere poco più in là, a cento metri, una volta usciti, avrei potuto osservare il corpo steso sull’asfalto, circondato magari dal nastro, dai poliziotti stessi, dalle auto della polizia.
No, non mi interessa. So solo che è stato coperto con un telo bianco a poche decine di metri dal portone, l’hanno visto su qualche servizio del tg locale. Ne hanno anche parlato al bar il mattino seguente.
.
.
.
.
da quando la borghesia ha conquistato il sole
«Non c’è modo di uscire dalla contraddizione»
Prendi l’esempio di Fisher, Kurt Cobain. CHE SUCCEDEREBBE SE
l’inquinamento luminoso fossero spie nel cielo
la città fosse come un corpo, senza organi
l’unico sforzo in-valido sarebbe
comunque quell’ultimo atto in-necessario.
A cosa servirebbe quindi vivere? Sopra-
sedere, vivere, per consumare e nient’altro?
.
.
.
.
Esco dallo schermo, sono al bar. Ritorno nel mio silenzio concatenato di pensieri su pensieri, nel mio silenzio, del mio cervello e forse di chiunque altro veda qui ciò che è successo ieri. Scambio perciò qualche parola, incontro un paio di persone e ci parlo senza staccarmi da quello che è successo. Si sente, lo avverto: un cambiamento sta arrivando, bisogna essere pronti, pronti a fare di ogni piano una postazione di tiro. Un giorno poi qualcuno rintraccerà in questa progressiva violenza, non ancora preparata alla guerriglia, la premessa di quel discorso molto più in là, per adesso. Dovremmo aspettarci presto in ogni caso l’ascesa di una sommossa, l’occupazione di luoghi simbolici di potere, a livello economico e politico, una seria degenerazione, i proiettili di gomma, quelli in piombo e ferro – penso.
*
Sono arrivato più o meno a ventiquattro ore dai primi video degli scontri apparsi su instagram. Solitamente controllo anche come si sia evoluta la partecipazione in rete, questa volta no, non me ne frega niente. Questo discorso che mi preme, vige su altre regole. Le azioni sono importanti, le azioni giustificano sé stesse. Tornando sul discorso fatto quella mattina con quella mia amica penso a quanto è ridicolo e insulso come, nel nostro caso, l’impulso democratico sia ancora del tutto arretrato. Qui siamo al Sud. Facendo rapidi calcoli sulla popolazione in provincia, una delle più grandi del paese, considerando anche la popolazione del comune, ci si dovrebbe subito rendere conto di come basterebbe, qui in città, anche solo una persona su mille pronta a scontrarsi con la bassa presenza di forze dell’ordine, in ventimila (circa un quinto della popolazione totale del comune), non ci si mettere più di un’ora a occupare ogni singola struttura di potere, dichiarare l’occupazione totale, la comune.
«C’è una teoria secondo cui affinché avvenga un serio cambiamento della società, detto rivoluzione, questo deve anzitutto basarsi non sulla totale assenza ma sulla scarsità di risorse [di alternative]»
.
.
.
.
Oggi mi dichiaro. Lo volevo e lo sono diventato
nemico di questo pianeta, sono nemico dell’umanità.
Vi detesto.
.
.
.
.
Sarà per questo: mi faccio schifo
il fegato manda segnali sulla pelle
sentirsi sulla pelle la città
lo schifo che c’è dentro
tutto quello che vorrei (e non-vorrei)
essere
e che purtroppo è / è che purtroppo sono
a volte, anche io
.
.
.
.
Ecco, adesso capisci? No, io -non-lo-capisco
questo dolore perenne dei genitori, la vendita della casa al Sud,
l’acquisto
di un bilocale a Nord, in prima periferia, l’attesa per potersi iscrivere
il lunedì sera
alla consegna dei pacchi del martedì, alla serata, quella prima della partita
di padel, di tennis, di calcetto, prima della palestra
del terapista
.
.
.
.
Se fossimo poi capaci, come ho già tentato in altri tempi, SI POTREBBE
persino sviluppare un algoritmo: una serie di: variabili umani; indici
demografici, economico-strutturali; pensieri malsani sull’uso di
alcune psicopatologie comportamentali. SI POTREBBE PER ESEMPIO
calcolare il grado / la probabilità con cui si possono presentare
in risposta a un dato evento (politico, climatico, finanziario)
crisi, rivolte e persino golpe e rivoluzione
il ritmo degli ordigni
.
.
.
.
Certo, questa è – e sembrerebbe – un’idea estrema.
Sicuramente, va detto: io non sono te
e tu non sei nulla
che il capitale non abbia già previsto. Tu sei
Kurk, commercializzato. Reso presente
– nella tua lotta – un prodotto,
ottimo per il mercato di controtendenza.
.
.
.
.
Credere l’essere umano un attore razionale è errato. Credere però che non sia possibile calcolarne il punto di rottura; la percentuale di disagio medio; il substrato necessario allo sviluppo di una certa propensione alla lotta o meno; il movimento –micro e –macro che compongono certi stati d’animo; è forse peggiore, quasi sicuramente anche più ridicolo.
.
.
.
.
A poche ore di distanza, si era già scoperto che era uscito dall’appartamento di fronte al mio, un bnb utilizzato saltuariamente da famiglie di stranieri, coppie, qualche escort. Da quello che dicono, di fronte al palazzo di casa mia, il giorno delle manifestazioni, l’uomo, è stato visto accompagnato da una delle due ragazze che alternandosi usano l’appartamento per lavorare. Ha assunto prima dell’incontro della coca, prima di prendere anche il viagra, che è stato costretto a calarsi visto che si sa, con la coca l’uccello non ti si alza come si deve. Il mix di sostanze, tagliate anche male, ha prodotto in lui una specie di reazione di asfissia, calore, eccitamento tale che il cuore gli è in sostanza scoppiato, dicono. È collassato subito dopo essere stato fermato da due agenti che si trovavano lì nelle vicinanze, accasciandosi a terra, rimanendoci così secco, stecchito. Io rido, dico che non ho visto niente e continuo a parlare con gli habitué della via, mentre ciò mi fa ragionare anche sulla distanza che si intercorre tra ciò che è per noi Reale, puro, anche se distante e ciò che comunque rimane sul piano del Virtuale, anche se così prossimo, concreto, vicino (persino se succede di fronte casa tua).
.
.
.
.
Sono passate forse dodici ore dalla manifestazione a milano, da quegli scontri, e io mi trovo seduto vicino l’università come sempre (da cinque anni a questa parte), guardando ancora quei video, analizzando tutte le possibilità che c’erano di riorganizzare la violenza, veicolandola meglio, farla finita con gli scontri a perdere. Stiamo entrando in guerra, anche se una guerra civile non c’è mai stata davvero in questo paese. Mi manca un pezzo però, lo cerco non trovandolo. Non c’è nessun materiale video, sembra, rispetto al momento in cui si è passati dagli scontri ai cancelli della stazione e sotto la metro, alla fase di arretramento a centinaia di metri fuori dalla stazione, lontani ormai dall’obiettivo, Centrale. Dovrei chiedere a DM, gli ho pure scritto alla fine la sera stessa: ehi ciccio, come è andata? come state? al di là di quello che si è visto. Vedo un messaggio scritto sempre in serata: ti racconterò. Domani serve una mano. Nel frattempo avevo scritto anche a SP: comunque direi ottimo! Poi voglio i vostri racconti, anche perché sta cambiando il discorso della lotta a Milano, si nota anche da fuori. Reazione con il cuore, poi più niente.
«Si parla di iper-globalizzazione quando un evento concretamente più vicino è per noi irrilevante, rispetto alla percezione di altro evento spazialmente lontano ma al contempo emotivamente vicino»
***
III
Anche se oggi potrei morire
da un secondo all’altro
ogni giorno: puntualità di pagamento
Sul rapido calcolo delle spese: tutto
quello che non c’è; tutto quello
che serve.
Sembra quasi impossibile uscirne. Sarebbe di conseguenza
come dire
così, improvvisamente, di smettere
di respirare
il fumo; sarebbe sicuramente deleterio per il fisico: cuore,
fegato e cervello
.
.
.
.
da quando la borghesia ha conquistato il sole
Il punto è non piangere. Nella cartella
del referto si può leggere
esofago regolare per morfologia. incontinenza cardiale. ernia
iatale da scivolamento. lago mucoso limpido.
tutto sommato – a voce – il corpo sembra reagire
bene
.
.
.
.
Anche se oggi si è rapiti dall’insensatezza
è tutto così nitido, così prevedibile che non
ha quasi più senso distinguere
ciò che potrebbe, da cosa poi si dirà essere
già successo.
.
.
.
.
In quel momento, sono immobilizzato, fermo davanti allo schermo come se attendessi di ricevere la notizia di un miracolo: i ragazzi a milano hanno occupato, a centrale hanno bloccato tutto, in migliaia si sono asserragliati dentro, la polizia è stata costretta a ritirarsi, i feriti, si, certo, non si contano più ma noi, noi tutti, abbiamo conquistato uno degli snodi nevralgici del paese, tutto rimane fermo finché non verranno accolte le nostre richiesta – penso. Sono ore che aspetto, sono qui a guardare instagram, a cercare di venirne a capo di quanto stia succedendo dalla parte opposta di dove mi trovo io, a lecce. Anche qui stanno manifestando però non ci sono andato, qui è un’altra storia, qui non c’è nulla che conti un cazzo, tutto è diverso. Faccio il giro di tutte le pagine di movimenti, associazioni e notiziari indipendenti lì sul posto. Guardo i video, li studio, ragiono, vagliando tutti gli scenari possibili in questo momento. Cosa si potrebbe fare, cosa succederà, come sarà se succedesse davvero. Esauriti i caricamenti fino a quel momento disponibili e nel frattempo che attendo di guardarne di nuovi o di leggere qualche nota di aggiornamento, mi capita, scrollando, di beccare anche un post che parla del libro di un amico lì a milano. Glielo condivido, mi risponde quasi subito: e io che pensavo soltanto a cercare di uscire vivo da centrale.
Ci scriviamo per pochissimo, uno scambio di battute a riguardo, poi più nulla. Non gli ho nemmeno chiesto come stesse, come fosse la situazione lì a centrale, in quel momento, non mi sembrava di sicuro il momento adatto per fare il giornalista, e poi sicuramente stava in mezzo al casino. Questa tortura però mi sta divorando, in certi momenti penso che non vorrei uscirne vivo sia da qui quanto se fossi in una situazione del genere, lì, a milano. Per distarmi dall’attesa, continuo con lo scrolling, e tra un riflesso dello schermo nero e un altro, noto che ci sono io seduto o steso sul letto, che esco e rientro più volte dalle diverse pagine, dallo stesso instagram. Si sta trasformando in un incubo, mi sto stremando. Cerco di analizzare ancora una volta ogni dettaglio dei nuovi video che vengono caricati. Per riprendere fiato, mi metto anche a stimmare: guardo le mail, anche qui niente di rilevante (come sempre).
«Durante il rituale sacro degli scontri, decade sempre l’importanza di altri aspetti della nostra vita. Ritenuta importante in qualsiasi altro momento, ogni cosa durante le proteste perde per noi interesse»
.
.
.
.
A cosa serve quindi – mi chiedo – migliorare nel tempo, seguire
le schedule? Fosse già, anche tutto questo previsto dal sistema?
COMPRESO la rabbia la ribellione la guerra, segue solo la rinuncia
la rabbia e poi il silenzio che segue dopo tutto questo,
di nuovo (ancora, prossimamente)
mi viene spesso una nausea a vederti lì in mezzo
credere davvero, fingere a te stesso di star producendo
qualcosa di in-utile. Io –non-posso-crederci.
.
.
.
.
Anche oggi si è rapiti dall’insensatezza
Anche oggi c’è bisogno di riappropriarsi in un certo senso
dell’estetica, innanzitutto, come forma
di riappropriazione, poi di
nomina, assimilazione,
accomodamento.
.
.
.
.
Ovvio [io] non so se tutto questo mi aiuta, migliora o peggiora la situazione, però voglio credere che sia giusto fare così. Mi serve.
.
.
.
.
Tu che non hai mai scambiato riso EU con pasta EU.
Tu non puoi dirmi un cazzo,
ancora io
rispetto la violenza
***
IV
morfogenesi del disimpegno:
a)
marcia dei quarantamila, caduta sociale dello statuto
del valore sindacale poi → legislazione [Thatcher, Raegan,
→ culturale [Sarkozy, Berlusconi
b)
G8 di Genova, la soppressione governativa della violenza inizia
dal basso (come una pistola di Cechov narrativa,
come quella pistola che ha sparato Carlo, per
sbaglio?)
c)
la mancata rielaborazione del trauma.
Il trauma collettivo, la paura di essere Carlo Giuliani
[se ne doveva parlare, non se ne è parlato]
La paura di perdere tutto ciò che si ha da perdere
durante una protesta all’improvviso [se ne doveva parlare,
non se ne è parlato]
Dalla lotta si passa al pacifismo, nessuno potrebbe
mettere più a rischio la vita per fare la cosa giusta
la lotta diventa in tutto e per tutto un atto perfomativo
d)
(mentre si continua a perdere tutto ma
piuttosto lentamente e progressivamente,
in forme comunque psicologicamente assimilabili)
i beni accumulati simbolici e economici dei genitori,
di quei 30 gloriosi, cominciano a consumarsi
nel discorso tra generazioni
Si vendono intere case per dei monolocali. Il potere d’acquisto
medio della gente scende, cala all’ultimo anche drasticamente
Grandi manager di gruppi aziendali e lo Stato assumono
il controllo, dividendo in porzioni più nette chi
deve possedere risorse e mezzi di emancipazione, libertà
e chi serve per estrarre e fornire questi mezzi
e)
Lo Stato poi interviene, agisce prima dei disordini,
dei pacifismi dei sit-in. Vietare rallentamenti è fondamentale
la restrizione del capitale procede inesorabilmente
e)
Neutralizzato il potenziale eversivo, si procede alla rimozione
dei suoi simboli. Lo smantellamento dei simboli sovietici
dopo la caduta del muro di Berlino, fa da perfetta analogia
Si deve colpire quindi i luoghi e i simboli
La rimozione storica di una carcassa, di una cultura morta,
che non sa più come opporre resistenza perché del tutto
inefficace, smilitarizzata, in loop all’interno del discorso
di sé stessa, della sua forma
un po’ come la fila alle poste. Il processo abbraccia l’ottica del tramonto
a occidente, del funerale, perciò si marcia insieme, si fa la protesta,
praticamente ci si raduna in questo discorso
prima di tornare, prima dell’aperol-spritz delle 20
davanti a noi, sempre
come in un’attesa del procedere, in forma di processione,
pronti alla carica, a farsi male
per espiare la colpa occidentale dell’urna da commemorare,
del reel da postare la sera
il giorno dopo
(faranno poi un attentato, l’Occidente ricomincerà a odiare
non importa chi è la parte lesa, l’importante è porsi mediaticamente
insieme alle vittime del sistema, farsi vittime senza esserlo
di conseguenza
non qui, non c’è stata nessuna guerra, nessun genocidio, solo sensi di colpa
in diretta dal festival del cinema di Venezia
Qui troviamo, il vero esercizio di dominio e di controllo fattuale
la chiusura dei simboli, del Leoncavallo
(tutti i vecchi movimenti sociali vengono smantellati
Muoiono le iniziative sul nascere, persino arte e musica
svuotate della loro capacità evocativa vengono regolate
con grande agevolezza, tutte le pedine seguono il gioco
contro i cari affitti e il DDL Sicurezza
I neolaureati in arte, lettere e comunicazione fanno domanda
di assunzione per lavorare presso centri, scuole, teatri dediti
all’intrattenimento, solo intrattenimento autorizzato:
spillando birre, promoviamo eventi a sfondo socio-culturale
(In fondo pur si deve mangiare! Pagare l’affitto e le bollette
non si può così facilmente rinunciare a vivere nelle grandi città
altrimenti poi chi le fa poi qui le proteste, i rincari sui prezzi
Tutti vogliono vivere nelle grandi città, tutti vogliono sentirsi di
«4 anni fa se ti avessero visto con la kefiah addosso, ti avrebbero sparato
Gli unici occidentali con la kefiah prima di questo erano soldati francesi,
americani, volontari (curdi), terroristi (ISIS), miliziani
adesso anche te
«Se volevo farla davvero la rivoluzione me rimanevo nel mio paese
a farmi massacrare, almeno qui posso socializzare condividere
il mio interesse nella causa, lo faccio per me stessa
e)
consumato il rituale, decostruito il valore degli oggetti
della rappresentazione (teatrale) del senso stesso
di un’appropriazione culturale vuota e inutile
ritornati nuovamente al punto zero di questo discorso
rimane ancora però la possibilità del corpo, della città e del suo ritmo
rinunciare a tutto per tentare il cambiamento, bisogna
rinunciare, rischiare tutto
straight edge,
nel nuovo ciclo di eventi, dovremmo essere tutti
contro tutti
armarsi a tutti i livelli, diventare inattaccabili
per attaccare
fare come San Francesco (il cristianesimo
è l’ultima guida rimasta
contro il Capitale e il mercantilismo) bisogna rendere
inattaccabile la militanza oppure di portarla su un piano successivo
quello nuovamente della lotta, della comune, della guerra civile.
Le due vie possono andare in parallelo
pars destruens e pars costruens
Serve organizzazione, recuperare gli strumenti
intellettuali
in primis Nessuno sa come si fa a combattere né a vincere
cosa fare?
(la soluzione quindi rimane ancora lontana, qui si parla ancora
La condanna è però feroce, nelle storie della gente la condanna è
più feroce, nei discorsi dei movimenti e persino dei capi di governo
la condanna deve essere feroce, senza che nessuno faccia niente.
Qualsiasi protesta diventi mediaticamente influente è destinata a essere
riassorbita dalla logica del Capitale, oggi la kefiah sostituisce lo smile
Nulla è cambiato, l’ordine nazionale e mondiale non è stato scosso
Neanche questa volta i consensi della destra sono scesi di mezzo punto
Mentre veniva fermata la flottilla a largo della costa palestinese
In Marocco continuano le proteste, con scontri anche violenti tra manifestanti e polizia,
in diverse città, a margine delle mobilitazioni…
[Abbonati per continuare a leggere]
Oscurati dal dibattito sulla libertà, la notizia arriva a cosa fatte (non prima)
Forse è così che si vincono le proteste. Hai visto che è successo in Madagascar?
In Italia il 2 ottobre è stata chiesta la dimissione del governo durante le pacifiche proteste
Stando ai sondaggi, gli italiani voterebbero
in caso di elezioni oggi, 29 settembre 2025.
Giorgia Meloni (guadagna lo 0,3% e sale al 30,5%).
Elly Schlein (che cresce dello 0,2% e arriva al 22,1%).
Giuseppe Conte (ora al 13,7%).
Alle spalle dei primi 3 partiti, tutto fermo.
La Lega rimane al 9%, Forza Italia non si sposta dall’8%.
In calo Verdi e Sinistra, che cedono lo 0,2% e scendono al 6,5%.
Più staccati Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,9%).
un’alternativa?
durante la Guerra Civile Spagnola, la percentuale di volontari comunisti tra le Brigate Internazionali è stata molto alta. Le stime totali parlano di circa 60.000 volontari nelle Brigate Internazionali, provenienti da tutto il mondo per combattere a fianco della Repubblica spagnola.
«Israele fascista! «Israele che non combatti ma manifesti
Dicendo che è ingiusto tutto questo
Poi le storie, i likes, che ricondivi, l’articolo per treccani, triennale,
Ti fai anche assumere da scomodo, dalla scuola, da una casa editrice
- f) francesco)
Il cambiamento arriva solo con l’affermazione di
una differenza
Nel concreto, l’irruzione di un Reale puro, un’utopia che si fa manifesta
oltre il piano del virtuale, del suo pensiero, del suo desiderio
Unisci i punti: Nietzsche, Deleuze, Lefebvre.
***
V
Tu vuoi aiutare per essere salvato dal tuo senso di colpa, dal desiderio
di te che vuoi cambiare il mondo, indisposto a rinunciare al tuo bene.
Tu non ti responsabilizzi davanti a niente, perché non serve, stai bene.
Tu fondamentalmente frigni, preghi e attendi che qualcuno faccia per te.
.
.
.
.
Si è giusto, se ci si crede veramente, finire in carcere.
.
.
.
.
Bisogna agire finché si ha tempo e risorse per farlo. Uscendo fuori dal pensiero in sé, dalle possibilità di futuri scenari sul conflitto, mi trovo poi a fare dei confronti tra un discorso e un altro (non tutti rispetto a questo tema). Non sarà di certo come il movimento del sessantotto. Il sessantotto è stato soltanto la forzatura di un ricambio generazionale tra vecchi e giovani piccolo borghesi. In più, a livello repressivo sarà sicuro peggio del G8 di Genova, il pericolo e la paura di un governo in fondo si mostra davvero quando cominciano a ammucchiarsi feriti e cadaveri – penso. Non so davvero quanto vorrei pensare una cosa del genere eppure sembra che ormai sia questo pensiero a avere la meglio sul resto, su di me. Mi trovo anche a parlare con un’amica rispetto alle manifestazioni a lecce, del suo ieri. Mi dice che c’era poca presenza, che certe cose qui non ci sono e che comunque però si è portato in piazza una rappresentanza, una rappresentazione utile del dissenso.
.
.
.
.
Anche oggi piovono bombe (d’acqua) dal cielo
tutto è cambiato, tutto è diverso
fedele solo a sé stesso, rimane
solo il movimento, il ripetersi
dell’identico, il Virtuale attendere di
un Reale così puro
– pensare di aver cambiato per un secondo
le regole, del gioco, realizzato
il sogno, disseminato il ruolo,
il senso di autodistruzione sarebbe quasi in-
evitabile
– la funzione della polvere e della cenere
potrebbe prendere
una città, in una sola ora, sommergerci
completamente
.
.
.
.
una guida pratica allo scontro per giovani antagonisti, maranza e anarchici
Equipaggiamento:
bandane, più di una. Una bottiglia di aceto e limone per bagnarla regolarmente;
cipolle, dicono, riduce l’irritazione del CS a occhi, naso e bocca;
occhialini da piscina, coprirne eventuali fori anti appannamento [usa colla o resina];
parastinchi, gomitiere, bandane e caschi;
puntatori laser potenti, alternativamente grandi torce;
ombrelli come scudi leggeri;
fuochi da artificio;
compensato, polistirolo, plastica o cartone, a più strati,
strati più sottili e numerosi = scudi più leggeri e resistenti;
tagliabulloni fino a 16 mm di spessore, oltre flessibile;
piede di porco per aprire o per sbarrare dopo le porte.
*
squadre anti-CS: per neutralizzare due metodi veloci:
statico: 2/3 persone: coprire e proteggere l’area con ombrelli aperti, poggiare al di sopra del candelotto un cono per il traffico stradale, versarci poi dentro 2/3 bottigliette di acqua, sabbia, fango.
dinamico: 2/3 persone: prendere con guanti molto spessi il candelotto, inserirlo all’interno di borse impermeabili (o altri recipienti resistenti alle fiamme e all’acqua), riempite con acqua, sabbia e fango. agitare la borsa per circa due minuti, anche tre o quattro se in movimento.
Per il coordinamento dei vari gruppi bisogna considerare per il futuro, che le forze d’ordine possano adoperare disturbatori di segnale, i cellulari sarebbero fuori servizio. Adoperarsi preventivamente aiuta.
Senza coordinamento non si può fare nulla.
«Ogni insurrezione, per quanto localizzata essa sia, comunica [esiste] al di là di sé stessa, contiene immediatamente qualcosa di mondiale. In essa ci eleviamo [pari] tutti insieme all’altezza dell’epoca»
(Ai nostri amici, Comitato Invisibile)
.
.
.
.
Ricorda
quando succederà / perché succederà
di non chiamare nessuno, di non dare mai
questo dispiacere
anche se, quasi sicuramente – trovandoti lì –
chiamerai anche tu qualcuno
Se non risponde, non pensare
Se ci pensi, non deve risponderti
Alla fine non è mai colpa di nessuno.
È fondamentale per crederci
cecamente
.
.
.
.
[08/11/2024 11:45]
Ogni tanto, però
ho paura di appropriarmi di un dolore che non è mio
[09/11/2024 10:39]
Mi sento soffocare, mi sento morire
[09/11/2024 10:42]
Di seguito, dall’obliò: un casello abbandonato, in rovina, la montagna
tagliata a gradoni, la torrefazione,
di un complesso: industriale: paesaggio in ombra, vegetazione viva, morta, lungo il profilo, paesaggio
[09/11/2024 10:43]
Attraverso
Si vedono persino
[09/11/2024 10:45]
alcune strutture arrugginite e il treno
che si piega per attimo su sé stesso come abbandonato
a un suo possibile deragliamento che però sparisce
quasi subito, insieme al resto. In prossimità
[19/11/2024 10:39]
Ctrl+C, Ctrl+V, tutto finito.
***
VI
Da quando la borghesia ha conquistato il sole
Partiamo dal fallimento: C’è da chiedersi cosa significa
sentirsi vivo, corre più veloce la volpe o il cammello?
Anche questa volta non è stata salvata la Palestina.
La Palestina è stata rasa al suolo prima, mentre e dopo le proteste,
adesso si farà spazio
sui cadaveri si costruiranno nuovi resort e pozzi di gas, di petrolio
(tutto ciò che era stato annunciato sui post di Trump verrà realizzato
veramente,
l’uso di immagini IA serve a abituarvi rispetto a uno scenario
che poi vedrete)
.
.
.
.
Non è questo il nostro tempo
Oggi è tornato l’inverno, il pacifismo è un cerchio piatto
Il pacifismo asseconda ancora
la logica dello status quo, dell’incertezza e del precariato
.
.
.
.
Quando tornerà, l’inverno sarà rigido.
All’interno di un cerchio
gireremo ancora intorno, senza trovare
il punto del discorso,
dello scontro
.
.
.
.
il pacifismo in Italia ha permesso per trent’anni alla DC di stare al governo
il pacifismo ha permesso la P2, Gladio, l’ingerenza americana, la morte di
giornalisti, procuratori e giudici, lo smantellamento progressivo del PCI.
La storia italiana con il suo pacifismo è una storia di guerre, sudamericana.
.
.
.
.
il 2 ottobre c’è stata la prospettiva di bloccare tutto.
C’era voglia di cambiare. Una certa tensione reggeva il mondo. La nostra vita
in quel cambiamento, era alle porte. Bastava attraversarle
Il 3 ottobre però
tutti, i vecchi pacifisti protestano per la pace
accanto a giovani propal: sindacati, pensionati, bancari, famiglie e politici.
È vietato agli antagonisti di scontrarsi, la protesta diventa manifestazione
Lo scontro viene riassorbito dalla logica del pacifismo, del capitale
interponendo questa pace qui, di chi ha casa, lavoro e pensione da salvaguardare,
Si afferma in tangenziale il pensiero dei vecchi protestanti a difesa della statale.
Va detto, almeno tempo addietro ci si limitava a dire:
«Né con loro, né contro di loro.
.
.
.
.
Da quando la borghesia ha conquistato il sole
Oggi chi siede allo stesso tavolo, senza aver mai patito
la guerra, l’incertezza, il precariato, la fame è da considerare parte
del sistema) parte del problema.
.
.
.
.
Indipendentemente dai colori, il vecchio social-democratico non vuole
rivolte, bisogna fare pace, anche con il sistema
accettare tutto quello che viene, ciò che ti è stato dato da mangiare anche
quando la pace è sempre una pace cartaginese
.
.
.
.
Vecchi protestanti da posto fisso fermano i giovani dallo scontrarsi
Impediscono ai giovani di farsi avanti, salvo poi far passare gli idranti.
Il social-democratico oggi vuole la pace, per poter tornare a consumare
tranquillamente, senza più i sensi di colpa per il suv e il monofamiliare.
.
.
.
.
Mi dicono dal comitato: la gente è stanca, la gente ha paura. Qui ci bevono.
l’occasione si perde, per veicolare, si generano preoccupazione da una parte
e rappresaglie (a posteriori) dall’altra.
.
.
.
.
Questo vettore verso il cambiamento però non deve consumarsi. Se qui si infrange
il sogno, sarebbe meglio essere morti che vivere la devastazione sociale che seguirà
nei prossimi mesi, anni, decenni.
Bisogna tornare a organizzarsi, prepararsi come una volta, a tirarci fuori dalla terra
Soffiare sulla polveriera
Se lo sforzo emotivo e fisico non porterà domani ai risultati ci giocheremo tutto, tutti!
È finita l’epoca dei nostri
padri, dei nostri sogni! Ci siamo svegliati
e la realtà è ci sembrata peggio dei nostri peggiori incubi.
***
VII
Perché siamo se vuoi, due: idee perfettamente diverse di cinema:
tornare a Tarnac, fissare nella pianura il proprio orizzonte; oppure
come fai te, provando a ridare vita a una macchina
gioiosa (e, con gioiosa, intendo libera).
.
.
.
.
da una conversazione con un poeta sia lirico che politico
[ciò che non significa la poesia civile]
Si chiama ansia.
Lo so fratello, lo so.
Terapia?
Soldi.
***
Poi mandami una foto dei pacchi alimentari
che avete
Perché
Voglio vedere se in questi anni hanno cambiato
packaging
Hahaha
[io] Non faccio Comida da un po’
.
.
.
.
Per cambiare poi, ovvio, si potrebbe. È solo che avrei bisogno
di un bene, un bene che non possiedo, uno che non conosco
minimamente, uno per cui potrei persino perdermi con te
e così sarebbe
.
.
.
.
Come dentro una lunga gonna nera, tu ti aprirai al mondo
Ti aprirai a quest’idea di cambiamento, all’idea che tutto possa
anche finire a un certo punto, improvvisamente.
Divincolati, se vuoi, per esistere davvero, considera
la tua posizione a partire dal fallimento
Guarda in altro, con una mano tirata verso il cielo,
l’inutilità del triste gioco a cui sei stato chiamato
e che continui
partecipando inesorabilmente
Inseguirai così, a partire da questo, un sogno
seppur minimo
Costruirai tutto dentro di te
ma al contrario
(solo così, inizierai a cambiare il mondo
al pari di come riuscirai a cambiare te stesso)
***
sulla chioma dell’albero, l’ordigno non è ancora esploso
corre contro il suo destino, un giovane ragazzo vestito da prete
 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi