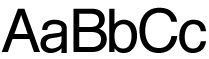di Marco Giovenale
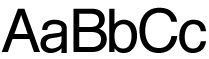
la poesia, se è vera poesia, è sempre di ricerca
la poesia, se è vera poesia, è sempre civile
la poesia, se è vera poesia, è sempre realistica
la poesia, se è vera poesia, è sempre astratta
la poesia, se è vera poesia, è sempre invendibile
la poesia, se è vera poesia, è sempre qualcosa che arriva al cuore
la poesia, se è vera poesia, è sempre poesia
la poesia, se è vera poesia, è sempre in abiti dimessi
la poesia, se è vera poesia, è sempre corale
la poesia, se è vera poesia, è sempre una consolazione
la poesia, se è vera poesia, sa sempre farsi notare
la poesia, se è vera poesia, resta per sempre
la poesia, se è vera poesia, è sempre alta
la poesia, se è vera poesia, è sempre vera
la poesia, se è vera poesia, è sempre autenticità
la poesia, se è vera poesia, è sempre l’autenticità
la poesia, se è vera poesia, è sempre autentica
la poesia, se è vera poesia, è sempre sperimentale
la poesia, se è vera poesia, è sempre nuova
la poesia, se è vera poesia, la rileggi cento volte e sempre ti sorprende
la poesia, se è vera poesia, è sempre la poesia del quotidiano
la poesia, se è vera poesia, è sempre una scaturigine originaria
la poesia, se è vera poesia, è sempre tradizionale
la poesia, se è vera poesia, è sempre attuale
la poesia, se è vera poesia, è sempre di qualcuno
la poesia, se è vera poesia, è sempre lirica
la poesia, se è vera poesia, è sempre tragica
la poesia, se è vera poesia, convoca sempre il lettore
la poesia, se è vera poesia, è sempre come una lettera d’amore
la poesia, se è vera poesia, è sempre violenta
la poesia, se è vera poesia, è sempre tutta da scoprire
la poesia, se è vera poesia, è sempre Milo
la poesia, se è vera poesia, è sempre in medio stat virtus
la poesia, se è vera poesia, è sempre elementare
la poesia, se è vera poesia, è sempre liminare
la poesia, se è vera poesia, è sempre elementale
la poesia, se è vera poesia, è sempre liminale
la poesia, se è vera poesia, è sempre parentale
la poesia, se è vera poesia, è sempre parenetica
la poesia, se è vera poesia, è sempre prenatale
la poesia, se è vera poesia, è sempre contro l’inquinamento
la poesia, se è vera poesia, sarà pure stata scritta da qualcuno
la poesia, se è vera poesia, è sempre preziosa
la poesia, se è vera poesia, è sempre
la poesia, se è vera poesia, è sempre presente
la poesia, se è vera poesia, è sempre numinosa
la poesia, se è vera poesia, è sempre pudica
la poesia, se è vera poesia, è sempre pomata
la poesia, se è vera poesia, è sempre un gesto
la poesia, se è vera poesia, è sempre una stretta di mano
la poesia, se è vera poesia, è sempre una legittima finanziarizzazione dell’immateriale
la poesia, se è vera poesia, è sempre possibile leggerla a salti
la poesia, se è vera poesia, è sempre come sorbire paracetamolo sul pigro divano
la poesia, se è vera poesia, è sempre cut-up
la poesia, se è vera poesia, è sempre un’installazione
la poesia, se è vera poesia, è sempre un’intuizione
la poesia, se è vera poesia, è sempre performativa
la poesia, se è vera poesia, è sempre installativa
la poesia, se è vera poesia, è sempre tonale
la poesia, se è vera poesia, è sempre orale
la poesia, se è vera poesia, è sempre iconica
la poesia, se è vera poesia, è sempre conica
la poesia, se è vera poesia, è sempre dodecafonica
la poesia, se è vera poesia, è sempre melodica
la poesia, se è vera poesia, è sempre posturale
la poesia, se è vera poesia, è sempre gestaltica
la poesia, se è vera poesia, dà i brividi
la poesia, se è vera poesia, è sempre a getto d’inchiostro, reattiva, neoconfessionale, baritonale, heideggeriana, liscia, festosa, mercuriale, neomitica, ciclotimica, tedesca, una frappa, in picchiata, occhieggiante, palliativa, agli ottavi di finale, scissionista, al sugo, riccia, posticcia, documentaria, testimoniale, meridionale, matriarcale, dadaista, porosa, un acroterio, smontabile, romantica, endoscopica, pariniana, milf, surrenale, sadica, alpinistica, tanata, piduista, speziata, relativa, antiglobalista, un campanello d’allarme, una voragine, una vertigine, puro canto, sudata, un vascello in balia della corrente, una corrente, una massa, per le masse, lallazione, fornicazione, una sfida, un fido, un pasto caldo, calviniana, placebo, gourmet, ripicca, nanoparticella, vibrante, valdostana, barocca, baricca, fededegna, monoblocco, neocatecumenale, meticcia, ovale, bombata, trobadorica, pongo, postmoderna, ammaliatrice, melanconica, melensa, una mela, satirica, rabelaisiana, bidonata, manesca, romanesca, rigida, lipofantica, antitaccheggio, eliotiana, in finto camoscio, imbustata, ovulante, centipede, al dente, fatata, una mulattiera, onanistica per deterrenza, un condominio, come una roccia, una scala ascendente, disneyana, doppia, truccata, fetusa, mobbata, tantalica, sciantosa, galattosemica, sregolata, in carriera, affettata, artaudiana, mitomodernista, brokeraggio, prostatica, sereniana, fortiniana, gommosa, cleptomane, iridescente, coprofilica, volpina, in garamond, bustrofedica, abrasa, serenamente classica, in padella, ciellina, lunare, ipercolesterolemica, perimetrale, sedentaria, foderata, dentata, cambogiana, raptus, soda tipo ikea, orientata verso Napoli, demiurgica, veterodadaista, spellata, dromomane, anarchica, istrionica, pangermanistica, farinosa, protestata, obesa, nativa, wittgensteiniana, mentolata, ospitale, della Marvel, chioccia, in cemento, azzimata, quantistica, nuda, a barre, un cioccoblocco, spaziosa, operettistica, fulminante, cerchiata, trappista, muscolare, una mail, commestibile, brasiliana, col parmigiano a scaglie sottili, col parmigiano a scaglie impercettibilmente meno sottili, comunista, ubertosa, sfiancante, girevole con un adulto a lato, gerontofobica, atea, passivizzante, sulla linea Maginot, medicamentosa, per bene, lambiccata, piantonata, pitonata, platinata, platonata, coibentata male, fungina, tellurica, al dativo, legiferante, deduttiva, spiccia, contropelo, bluastra, disillusa, reificata, albale, indicizzata all’inflazione, a zigzag, pugnace, derivativa, binaria, una dune buggy, roca, alcalina, indolente, ambidestra, corroborante, vecchia, bellica, casearia, un’anta, biscottata, al tratto, chiaroscurata, poliglotta, impanata, brutalista, oleata, un sintomo, un vagito, una tappa intermedia, open minded, googlata, egoriferita, frigorifera, pescosa, restia all’ingestione di alcolici a digiuno, un opale, schierata con Turati, medusea, karma, al tramonto, pervia, indecisa, serotonina, oca, laica, incorniciata, ricaricabile, un flap, una visione del mondo, una visione dell’io, una visione del linguaggio, una televisione, oro colato, lombrosiana, semisferica, di successo, supina, bohemienne, meccanica, pralinata, neolitica, con l’erre moscia, giroscopica, escheriana, Pat Benatar, crepuscolare, vintage, neomelodica, neometrica, signorile, sottoposta a ossidoriduzione, fecale, godibile, mescalinica, al lampone, fresata, pompier, gonadica, resecata al plinto, saponosa, un dodecaedro, politicamente esplicita, paludata, grata al tafanario, cristallina nei suoi enunciati, retró, un cambiavalute, impaurita dai servizi segreti, logocentrica, in lotta con le spalline del cappotto negli anni Ottanta, vaporwave, glicciata, grattata, una grattachecca, ominosa, Milo bis, aforistica, una scommessa, frenologica, geolocalizzata, diaccia, crapula, un inno al volo, un inno alla vita, un inno in generale, il draghetto Grisù, preghiera alla primavera, un candido cigno, Lou Ferrigno, sebo, brassicacea, una ninna nanna, filodiffusione in sauna, la trapunta a greche dell’ava, haiku, un portale aperto su mondi tutti seghettati, un allegro vibrione, aristocratica, Aristotile, al pantone, sospettosa, porosa, inevitabile, Rainer Maria, sportiva, love me tender, yamaha, echeggiante, angelicata, piezz’ ’e core, calibro 45, sudtirolese, senza parabeni, ortodontica, lialeggiante, militesente, d’arredamento, come un ciuffo sbarazzino, un apostrofo roseo tra le parole t’reno, mazziniana, un plettro fra i denti, trippa alla romana, come il dodo, pelle e ossa, fonte di speranza, a strapiombo, come un frutto maturo, rossetto sullo specchio, Vamba, paragonabile, un dirigibile, un testimone di geova imballato sull’A1, vedere le cose da una nube, venticinque minuti di tosse, Barthes fratto Borges, un susino, Pollenza, seminare una volante, Amazon, Batman legato sulle rotaie, Frate Indovino, Tarquinia, mezza scacchiera senza pezzi, tante care cose






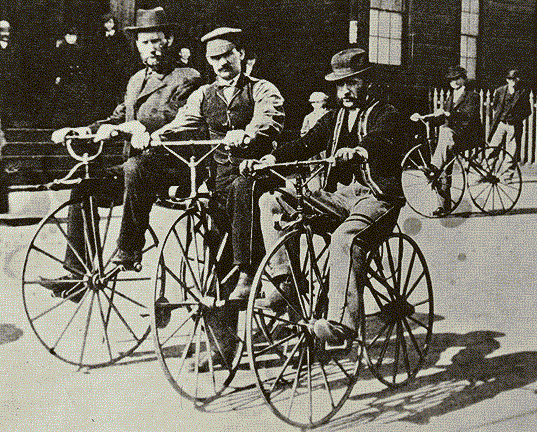 (San Francisco, 1870).
(San Francisco, 1870).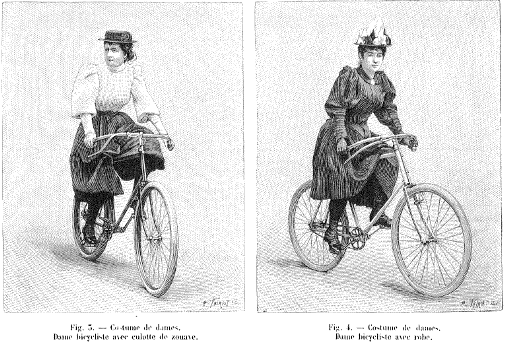 Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.
Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.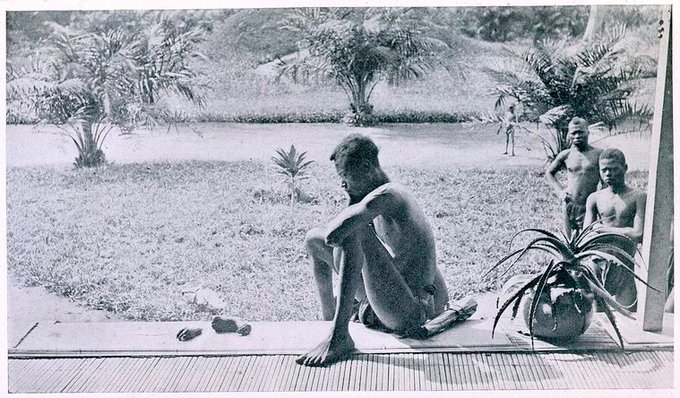




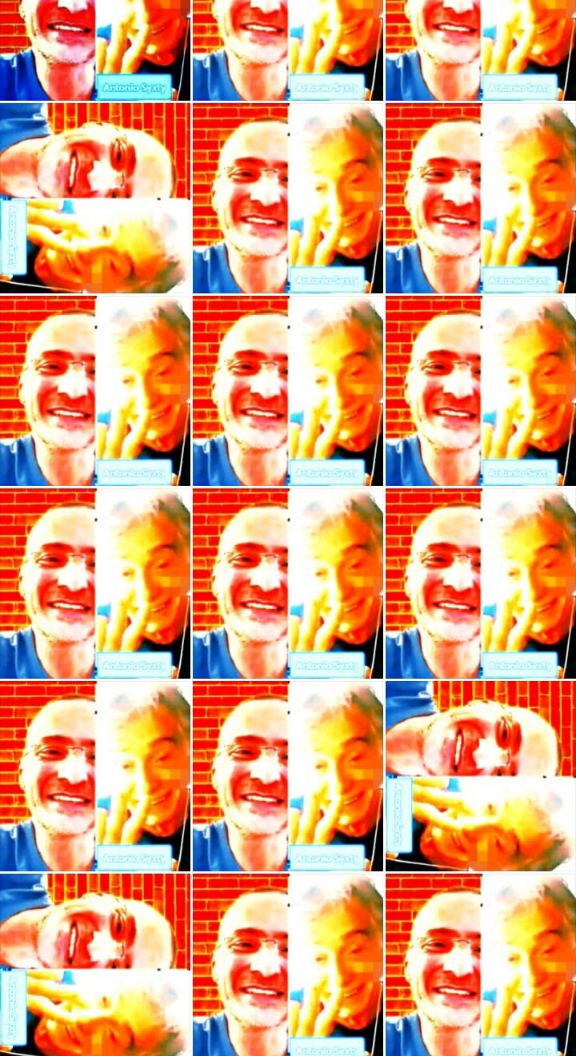



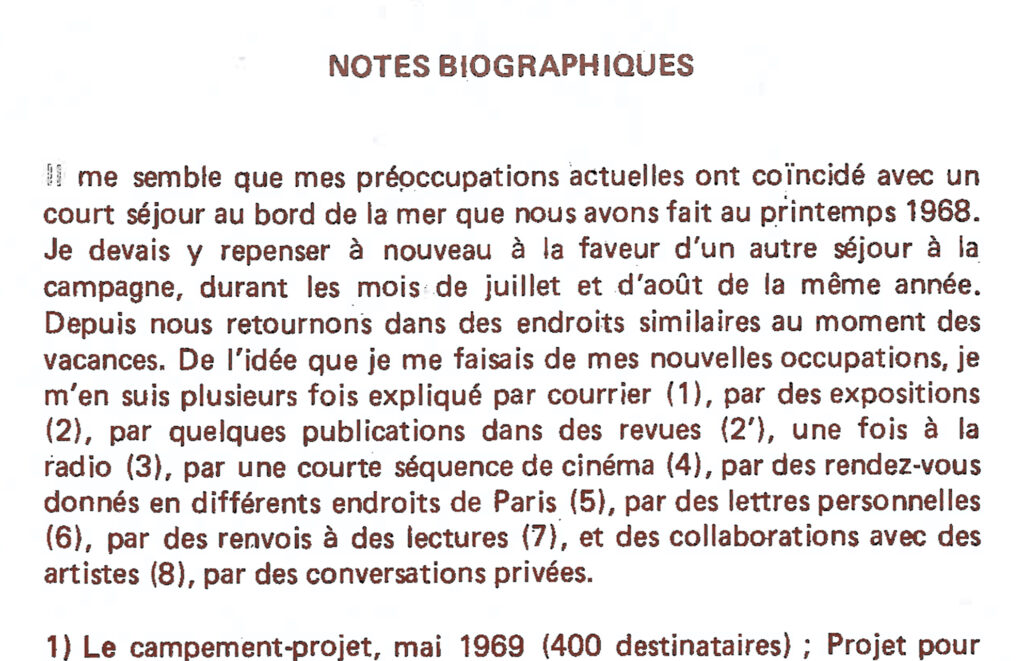
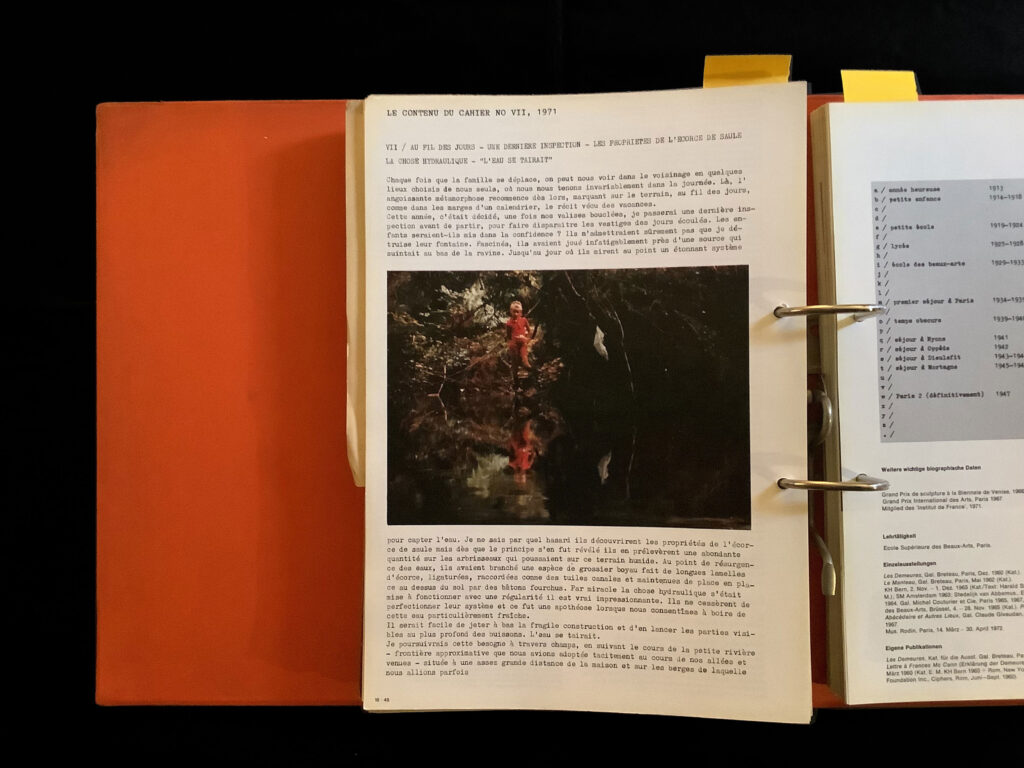

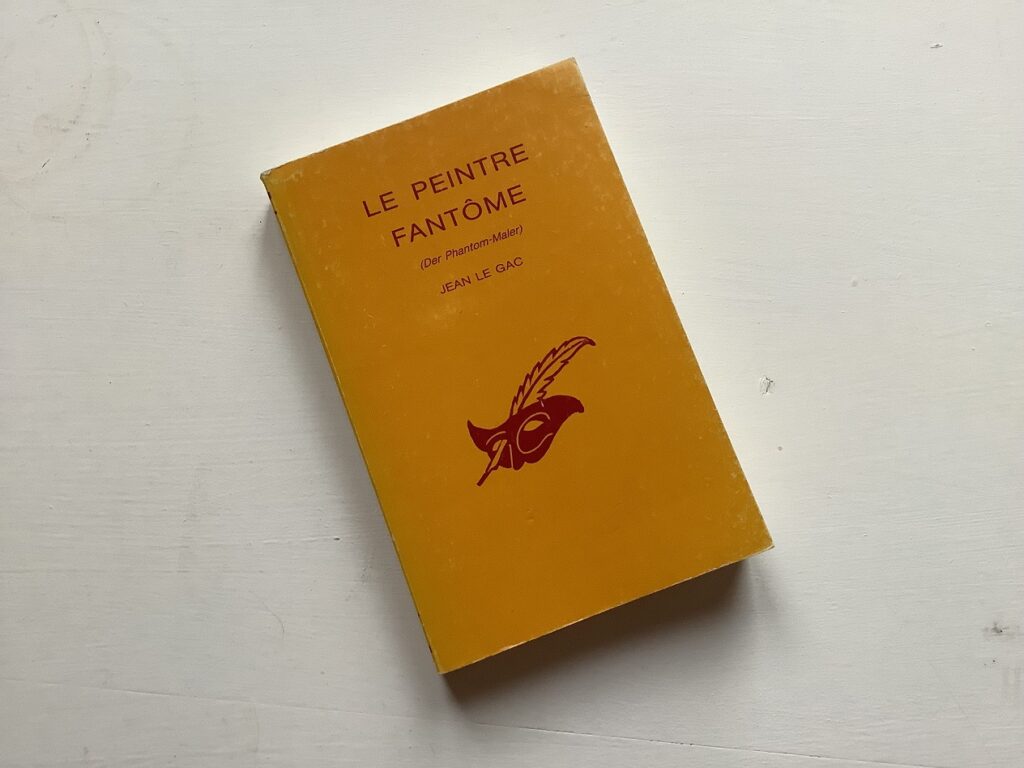


 AzioneAtzeni – Discanto Ventunesimo: Nadia Cavalera
AzioneAtzeni – Discanto Ventunesimo: Nadia Cavalera 

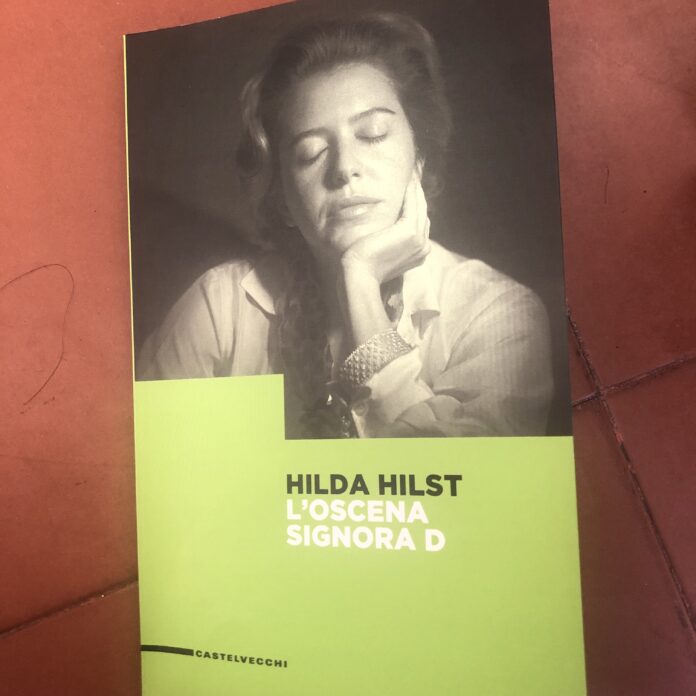
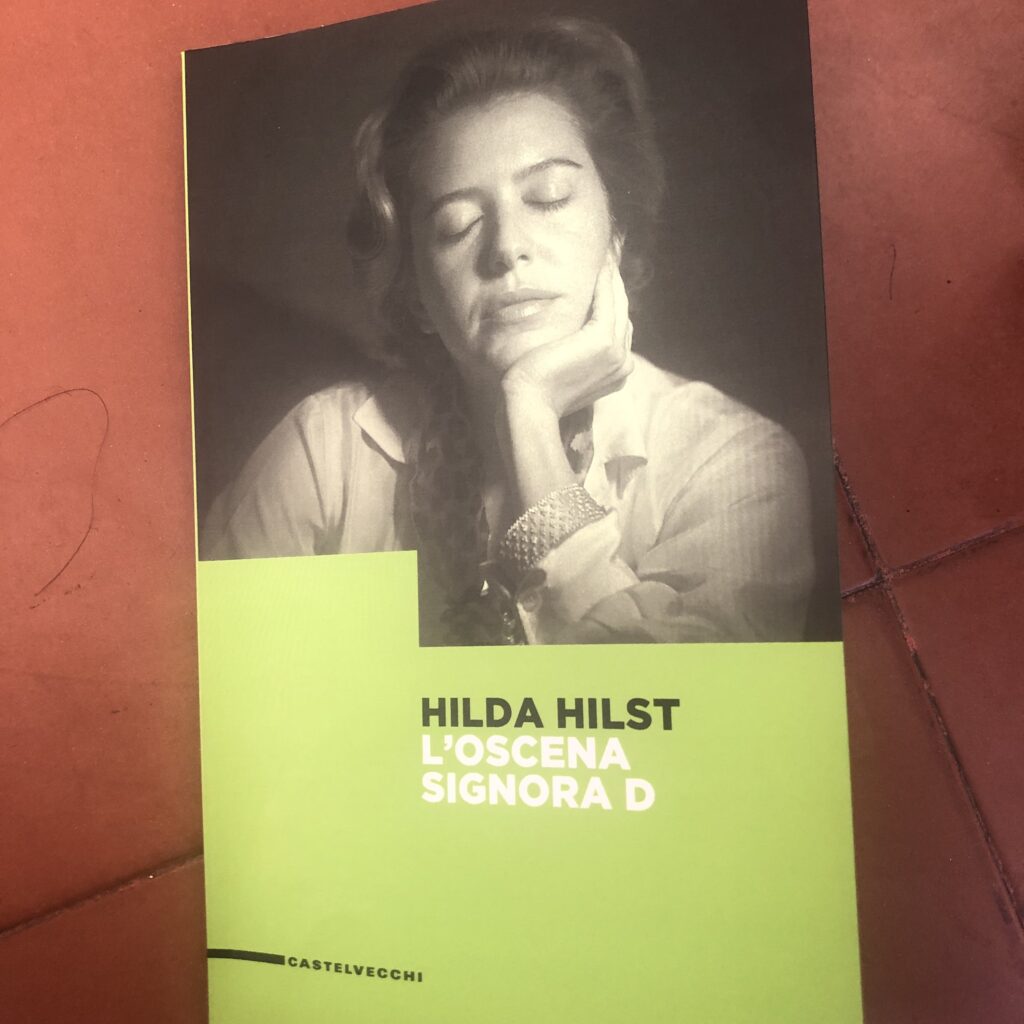

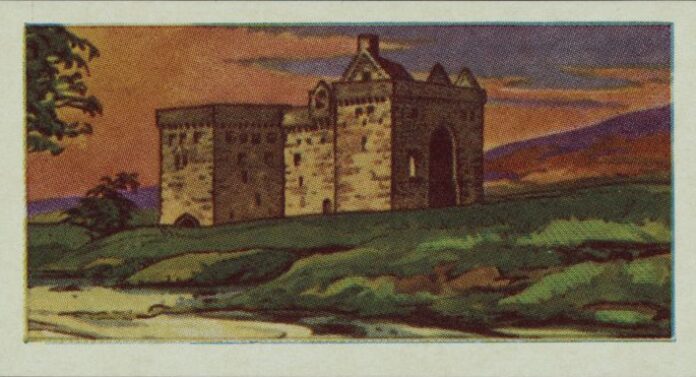
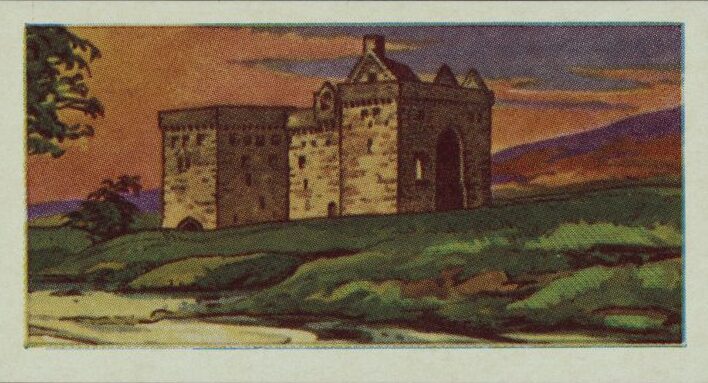
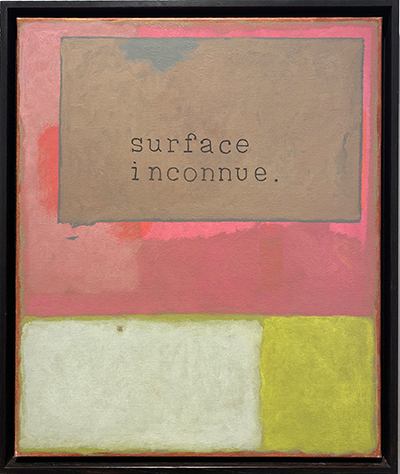

 Quello
Quello 

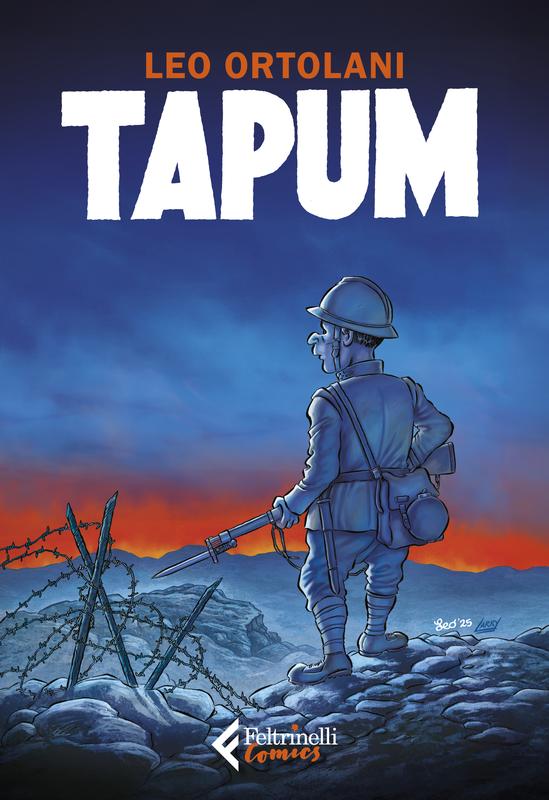


 La sola regola del successo in Letteratura
La sola regola del successo in Letteratura